|

In una società
in cui il commercio è parte preponderante delle relazioni,
spesso le azioni compiute dai singoli sono dettate dagli interessi
che altri vi ripongono.
Più le merci sono inutili e più è richiesta
la loro promozione, e nella società occidentale contemporanea
la stragrande quantità di oggetti e di servizi in commercio
non è necessaria.
Anche un piccolo artigiano ha interesse a vendere la sua merce.
Se egli è consapevole che il suo lavoro è importante
per la comunità in cui vive non ha necessità di
promuovere il suo prodotto; le persone andranno direttamente
da lui, senza bisogno di essere stimolate, in quanto il suo
lavoro è utile.
Il modello sociale contemporaneo è lontano da questo.
Da una parte preleva risorse naturali e sociali e dall’altra
immette nel mercato e stimola al consumo di una quantità
enorme di merci spesso inutili.
Il modello è governato da una continua proposizione di
merci, come se attraverso di esse si possa acquisire una nuova
condizione di vita inspiegabilmente migliore della precedente.
La felicità è una questione individuale ma la
condizione per esser felici dovrebbe essere la rimozione delle
comuni ragioni di infelicità. E troppi sono i motivi
per constatare che insieme non vi sono ragioni di felicità.
Troppi gli interessi che impongono altre priorità, troppa
l’attenzione alle merci, troppo scarso l’impegno nella
ricerca di un benessere individuale e collettivo.
Per lasciare libero lo spazio alla concretezza delle merci,
l’attenzione è indirizzata su valori alienati, estranei
alla comune soddisfazione.
Forse è opportuno ritrovare il senso della propria esistenza
in comportamenti di cui conosciamo il significato e la finalità,
nell’adoprarsi con mezzi che siano omogenei al fine, nel
recuperare un senso della società in cui ciascuno non
sia rappresentazione di interessi o di ruolo, ma di utilità,
per quello che sa effettivamente fare, di cultura, di tecnica,
di esperienza, di creatività.
Forse è opportuno consumare meno merci, per produrre
meno merci, per lavorare di meno; perché ad ogni azione
inutile, ogni merce inutile, corrisponde, da qualche parte,
miseria e devastazione.
Queste riflessioni si rivolgono a coloro che, nei paesi ricchi,
possono dire di non conoscere la povertà. Coloro i quali
hanno a disposizione una notevole quantità denaro (enorme
rispetto ai 4/5 del mondo, infinitesimale rispetto ai veri ricchi)
che spesso non risulta sufficiente per l’andamento del
quotidiano, proprio in ragione dello sperpero di merci a cui
partecipano.
Essi sono, anche inconsapevolmente, le colonne di sostegno del
mercato, coloro che acquisiscono maggiori quantità di
merci, quelli che manifestano maggiori necessità.
Essi possono, con i loro comportamenti, contribuire a rallentare
questo aberrante meccanismo produttore di infelicità,
limitandone il potere, riducendone l’ambito operativo,
sottoponendolo a visione critica.
Sfilandosi da esso, uscendo dalle sue consuetudini. Seppure
impercettibilmente, seppure con piccole azioni, ognuno di essi,
attraverso il proprio comportamento, attraverso la limitazione
delle inutilità, può ridurre la potenza del modello.
Comprando meno merci, dedicando più tempo al mantenimento
degli oggetti, alla preparazione del cibo, se possibile alla
sua produzione, muovendosi di meno.
Piccole azioni che non risolvono completamente i nodi del problema
ma che aiutano a ritrovare una consapevolezza sulla base della
quale conservare la propria autonomia culturale e permettere
una pratica meno infelice per noi dei paesi ricchi e per gli
altri poveri e dei paesi poveri.
Riflessioni che possono essere utili per cambiare atteggiamenti
e abitudini di cui si sono sottovalutati i negativi effetti
ambientali e sociali.
Molti sono i sostenitori inconsapevoli di un modello ingiusto,
incongruo, inefficiente che ogni giorno produce milioni di vittime,
che ogni giorno annulla cultura e valori di intere comunità
e ogni giorno porta violenza sugli oppositori, su coloro che
esprimono un giudizio critico.
Sostenitori per pregiudizio o per pigrizia più che per
convinzione.
Ma per coloro i quali non ritengono la sofferenza degli altri
un indispensabile corollario del proprio benessere allora per
costoro è possibile che sia stata solo una svista il
fatto di aderire indiscriminatamente a questo modello.
Spesso non si considera quanto attraverso le nostre azioni,
quelle quotidiane, quelle consuete, abitudinarie, apparentemente
innocue si sostengano interessi precisi, nocivi per l’ambiente
e l’umanità. E ciò avviene principalmente
perché le scelte quotidiane sono poste come non scelte,
ovvero come soluzioni normali senza alternative, perché
sono sottovalutate nella loro importanza. I consumatori, così
come possono creare un mercato lo possono distruggere. Ma questo
i consumatori sembrano non saperlo.
Non è necessario rimandare la ricerca e il raggiungimento
del benessere ad un mondo tutto da realizzare, diverso, successivo.
Un mondo cambiato dall’acquisizione del potere, dalla vittoria
elettorale, dalla rivoluzione sociale.
Un altro mondo è possibile anche oggi, anche comportandosi
in maniera diversa, dando così continuità tra
l’oggi e il domani, lavorando così nel presente,
per il presente e non solo per il futuro.
Un altro mondo già esiste nell’infinita diversità
degli uomini, nell’enorme capacità mostrata da parte
di popoli e individui di mantenere la propria cultura, la propria
autonomia dal modello vigente.
Molti sono i popoli che vivono al di fuori di esso, allontanati
o non raggiunti, ma molte sono le comunità e gli individui
che consapevolmente hanno preso le distanza da un modello fagocitatore
e vivono secondo criteri più appropriati al proprio piacere,
al benessere dalla comunità, alla gravità dei
problemi ambientali e sociali del pianeta.
E un altro mondo già esiste in queste persone che per
scelta e con lucidità hanno intrapreso esistenze “demercificate”
e stanno costruendo relazioni sociali, produttive, di scambio
fondate sulla maggiore qualità ambientale, culturale
e sociale.
Il modello che viene praticato nei paesi occidentali tende costantemente
a indurre la convinzione che questo criterio garantisce l’eliminazione
della fatica: ma, accanto a strumenti che oggettivamente e utilmente
eliminano la fatica (la lavatrice, p.es) ne introduce una mole
enorme che solo apparentemente produce questo risultato (v.
scopa elettrica, premiagrumi elettrico casalingo ecc.), ma che
risultano appaiati nella presentazione delle meraviglie della
tecnica. Il preteso riscatto dalla fatica, ognuno di noi può
dirlo, non ci ha riscattati dalla stanchezza.
Ognuna delle riflessioni che seguiranno suggerisce una piccola
variazione dei comportamenti e implica una “piccola fatica”
nel compiere azioni che abitualmente attuiamo e nel definire
comportamenti diversi dagli abituali.
È il recupero di questa piccola fatica che riduce il
campo del mercato sostituendo le merci prefabbricate con la
nostra diretta attività autogestita e non retribuita.
Questa piccola fatica (v.s.) diviene il parametro di giudizio
della convenienza a compiere azioni e ci aiuta a discernere
tra i bisogni effettivi e quelli indotti tra i piaceri veri
e quelli fittizi.
Essa diviene metro temporale su cui misurare quanto è
possibile fare in una giornata e quindi selezionare le azioni
e porre loro dei limiti, limiti che il solo consumo pone molto
lontano.
Ma questa piccola fatica (v.s.) è anche lo strumento
per mantenere la propria autonomia culturale e tecnica sia a
livello individuale che di comunità ed è dunque
mezzo per mantenere ciò che già c’è
e per contribuire nel presente ad un possibile altro mondo.
Sbucciarsi le patate
Prendere le patate, pelarle, lavarle, tagliarle, asciugarle,
cuocerle. Un’azione semplice. Che occupa poco tempo. Un
momento in cui le mani agiscono, si riconoscono le parti buone
e quelle cattive, si seleziona, se ne comprende e valuta l’appropriatezza
rispetto a quello che serve.
La conoscenza avrà ripercussioni sul nostro acquisto
al mercato dove selezioneremo le patate che ci soddisfano maggiormente
e avrà ripercussioni sul nostro cucinare scegliendo il
tipo di patata appropriato ai cibi.
Un’azione, sbucciare le patate, che mette a frutto la nostra
capacità creativa nella modalità, nella forma,
nelle dimensioni del taglio.
Un’azione che è tecnica e quindi culturale e che
lascia il tempo di pensare: sgombera uno spazio temporale dal
consumo e dalla produzione di lavoro e ci abitua a produrre
per noi direttamente.
La sostanza del cucinare è la capacità, creativa
e tecnica, di predisporre autonomamente prodotti direttamente
gestiti e consumati.
I cibi prepuliti, precotti, eliminano tutto questo. Riducono
il tempo di preparazione per lasciare tempo solo alla produzione
o al consumo di merci e di servizi.
Un atto piccolo, sbucciare le patate, preparare il proprio cibo,
casomai insieme con altri, per fare prima, per dividerlo, per
risparmiare.
È difficile da fare? Poco moderno?
Eppure…
 
Un sorso d’acqua
Gran parte delle città del nord del mondo è fornita
di una rete di distribuzione dell’acqua potabile.
Negli anni passati ciascun cittadino ha sostenuto, civilmente
ed economicamente, il peso della creazione di questo servizio
che consente alla quasi totalità degli abitanti di questi
paesi di avere a disposizione acqua potabile a basso costo nelle
proprie abitazioni.
Un diritto, più che un servizio, che conduceva fuori
la società dalla sudditanza ai venditori di acque e al
controllo da parte di pochi di un bene appartenente a tutti.
Eppure in pochi anni, volontariamente, i cittadini hanno preferito
l’acqua minerale in bottiglia a quella del rubinetto. File
al mercato, grandi pesi da portare, molti soldi da pagare, limitatezza
delle risorsa, rifiuti incontrollati, aumento del traffico di
veicoli commerciali, aumento del numero di incidenti stradali,
accumulo di profitti, privatizzazione dei beni comuni, nuova
sudditanza nei confronti di chi gestisce le acque. Nulla di
tutto ciò pare interessare l’acquirente delle acque
minerali, che guarda con disprezzo scorrere l’acqua dal
rubinetto perché ha “un sapore non buono”.
L’acqua, dall’essere risorsa e bene comune inalienabile
degli uomini, torna ad essere terreno di appropriazione, diventa
merce, rappresenta il segnale di un interesse del mercato verso
il controllo delle risorse primarie, quelle comuni, che comporta
di fatto la limitazione dell’autonomia degli individui
e delle comunità.
Sarebbe dunque giusto esigerne la buona qualità, insieme
con la consapevolezza che la gestione di questa risorsa primaria
è anche affidata a noi, alla nostra maniera di consumarne
e di utilizzarne: riducendone gli sprechi, aumentandone il recupero,
utilizzandola appropriatamente.
Un atto piccolo: non comprare l’acqua minerale, ma ambientalmente
e socialmente importante.
È difficile da fare? Imbarazza?
Eppure…

Una vecchia
automobile
Già questo: mantenere la vecchia automobile.
Poi vecchia quanto? Un po’. Un po’ di più di
quanto il piacere di avere un nuovo modello ci imporebbe. Basterebbe
questo per uscire da una dipendenza.
Con la nostra vecchia auto risparmieremmo dei soldi, potremmo
lavorare di meno, potremmo fare lavorare di più i meccanici,
ripartire quindi la ricchezza nel tessuto sociale, sottraendola
alla concentrazione del grande monopolio industriale.
L’industria delle automobili ha due obiettivi: vendere
nuove auto e fare consumare benzina. Per raggiungere il primo
obiettivo sostiene sia la dipendenza del modello insediativo
dalla mobilità privata su gomma, che facendo percorrere
più chilometri consuma le auto, sia il ricorso all’introduzione
sul mercato di modelli sempre nuovi, accattivanti, che inducano
all’acquisto. Per il secondo obiettivo produce macchine
che consumano molta benzina, aumentando (inutilmente, visti
i limiti di velocità imposti e la ragionevolezza dell’uomo)
le prestazioni in velocità e in potenza e aumentando
la grandezza e il peso del veicolo.
Per sostenere questi obiettivi organizza campagne di promozione
enormi che suggeriscono modelli di vita: è possibile
che ci siano alcuni che hanno fatto più figli solo per
comprare automobili più grandi?
Per l’industria dell’auto il risultato è soddisfacente,
tanto che nei paesi ricchi il capitolo di spesa afferente le
auto è il secondo dopo l’alimentazione come incidenza
sul bilancio della famiglia media; e non per un anno, ma per
una vita.
Ripetendo con insistenza che dall’industria dell’auto
dipendeva la sorte dell’occupazione di interi paesi, hanno
indotto a credere che l’esborso di denaro che veniva regolarmente
richiesto ai consumatori fosse anche una sorta di partecipazione
solidale alle sorti dei lavoratori.
Ma oggi non vi è relazione tra merce e occupazione: pochi
occupati possono fare molte merci e oggi non possiamo vantarci
di non avere disoccupati nonostante siamo abboffati di auto.
Comunque in Italia vi sono più forestali che addetti
al settore auto, eppure nessuno ci ha mai invitato a piantare
alberi per mantenere gli occupati.
Mantenersi la macchina vecchia, ridurre i chilometri percorsi.
È difficile farlo? È una libidine irrinunciabile?
Eppure…
Il mercato dei figli
I figli sono merce. Sono merce in gran parte del mondo perché
vendibili e acquisibili, ma sono merce nei paesi ricchi perché
ampliano il mercato e le sue potenzialità.
Ridurre il numero degli individui implica di fatto ridurre il
numero dei consumatori, e questo diviene preoccupante per il
mercato quando si raggiunge il massimo degli acquisti possibile
pro-capite.
Ma i figli, nei paesi ricchi, sono una delle condizioni di massima
concentrazione della domanda di merci: crescono, e quindi anno
per anno cambiano abitudini e quindi prodotti necessari, sono
sottoposti in modo massiccio alle pressioni delle mode e della
pubblicità, e quindi spessissimo diventano veicoli tenaci
della richiesta di prodotti di consumo.
La pubblicità stimola oggi più delle chiese e
degli stati alla procreazione. Maggiore è il numero di
figli e maggiore è il mercato, maggiore il numero dei
figli e più forte è uno stato, più grande
una chiesa, più potente un esercito. In questo si rilegge
la brama quantitativa che è alla base della nostra società:
di più è meglio che di meno.
Non è vero.
Tenere i figli fuori dal mercato, pensare al pianeta come una
collettività unica, diversa ma con alcuni grandi problemi
comuni.
È difficile farlo? Avere tanti figli è troppo
appagante? Com-prare merci per i propri figli e fare dei propri
figli una merce è soddisfacente? Sentirsi genitori solo
dei propri figli carnali è indiscutibile?
Eppure…
  
Un mondo che
non c’è
I settimanali, le riviste di moda, di costume, di critica,
i rotocalchi, sono pieni di immagini di uomini e di donne che
non corrispondono certo ai cittadini del mondo, ma neppure a
quelli dei paesi ricchi.
In una piazza, in un bar, in una stazione, al nord, al sud,
non ci sono gli uomini e le donne presenti nelle riviste, non
ci sono le loro espressioni, i loro usi, i loro problemi. Quello
che c’è dentro quelle pagine non c’è
fuori, e quello che c’è fuori non c’è
dentro.
Fuori di quelle pagine altra è la bellezza, altre le
attività, altra la ricchezza, altri i problemi, altro
il fascino.
Un mondo che non c’è ben separato da quello esistente
e di cui si testimonia la possibile realtà attraverso
le immagini costruite negli studi fotografici.
La concretezza paradossale è data dalla tendenza da parte
degli individui di apparire come quelle immagini e di uniformarsi
ad esse.
Sono infatti immagini a cui tendere, che servono a commercializzare
merci.
Gran parte dei rotocalchi è fatta di pubblicità,
a cui viene assegnata la pagina di destra, quella maggiormente
visibile, supportata da articoli di costume che non fanno che
confermare il messaggio indotto dalla pubblicità.
Dicono questi settimanali ben oltre quello che sostengono a
parole, dicono quanto essi siano strumento di supporto al mondo
delle merci. Dicono quando mostrano, dicono quando regalano
oggetti inutili, dicono quando vendono la pubblicità.
Non comprarle, non comprarne tante, leggerle usate riduce il
consumo di carta, non alimenta il mondo delle merci, riduce.
Si possono selezionare altre riviste, senza pubblicità,
o si possono stimolare gli editori a una maggiore attenzione.
È difficile da fare? È un passatempo irrinunciabile?
Eppure…
Un panino da casa
Un panino fatto giorni prima (fatto mesi prima?), con prosciutto
o formaggio addizionato, conservato, farcito con crema di ignoto,
immerso in un gas, chiuso in un contenitore di plastica etichettato,
presentato come per alimenti, riscaldato da un forno a microonde.
Decine di milioni di panini così invadono le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti, alcuni grandi nodi dove si concentrano
grandi quantità di potenziali fruitori distratti, indaffarati,
affamati, rapidi.
Anni addietro nei treni passavano venditori abusivi di panini.
Panini di giornata, con formaggio o salame, avvolti in carta.
Furono nel tempo guardati, panini e venditori, come segno di
sottosviluppo. Non garantivano la qualità. Erano plebei.
Certamente la sera riciclavano il formaggio non venduto. Ora
la qualità industriale è garantita.
Comprate le concessioni, perseguiti in termini di legge gli
abusivi (nelle stazioni hanno tolto anche le fontanelle per
evitare di ridurre il mercato delle acque minerali), vinta la
concorrenza di piccoli bar ed alimentari, l’alimentazione
nel mondo del viaggio è in mano a pochi gestori.
Ma l’alimentazione esterna alla residenza è in gran
parte gestione e quindi proprietà di pochi, che garantiscono
igiene ed efficienza ma non la qualità, né relativamente
ai cibi né per quanto riguarda gli effetti che questi
possono comportare.
Non andare nelle grandi catene di ristorazione, preferire il
piccolo artigiano.
Portarsi un panino da casa con la frittata (che ha un peso ambientale
minore del prosciutto) o con gli avanzi del giorno prima.
Portarsi l’acqua da casa, così da fare intendere
che togliere le fontanelle non vuol dire aumentare automaticamente
il mercato.
È difficile farlo? È troppo imbarazzante?
Eppure…

Una vacanza a casa
Le vacanze: altro modo di consumare merci, merci naturali.
Le vacanze vendono luoghi, paesaggi, ambienti intatti, società
ospitali. Vendono i luoghi trasformandoli in quello a cui servono:
infrastrutture, alberghi, autoveicoli, banche, impianti di risalita,
piste da sci, pontili, ombrelloni, bar, ristoranti, windsurf,
moto d’acqua, piscine, gatti delle nevi, negozi, trampolini,
piste su ghiaccio, residenze.
Ogni volta che un luogo diviene turistico si trasforma, perde
la sua naturalità, che è quello che lo ha reso
di interesse, e viene adattato all’immagine standard del
turismo globale.
Ogni volta che una persona va da turista in un luogo conferma
la necessità di quelle infrastrutture.
Per il proprio piacere destruttura, danneggia ambiti pregiati,
aumenta la dipendenza di quei luoghi da fattori esterni alla
sua caratteristica, esporta un modello la cui limitatezza è
evidente anche nei paesi più ricchi.
Attua una razzia.
E più il soggiorno è breve, più è
attuato in strutture organizzate ed aliene dal contesto, più
è lontano e maggiore è il peso ambientale e sociale
della sua presenza.
Ci si muove sempre di più. Sempre più breve la
permanenza, sempre più lungo il tempo della percorrenza.
Allungare le vacanze, stare nei luoghi più a lungo, conoscerli,
partecipare ad essi, contribuire alla comunità.
Non andare in paesi lontani, in luoghi incontaminati, in strutture
organizzate, per poco tempo.
È difficile farlo? È troppo angosciante lo stare?
Eppure…
Immersi negli oggetti
Un indiano Lakota non possedeva più di 200 oggetti,
inclusi gli attrezzi, componenti dell’abitazione, armi
e vestiti.
Noi viviamo immersi negli oggetti. Alcuni di questi hanno una
funzione, altri sono assolutamente inutili.
Il decimo orologio, il ventesimo accendino, la centesima penna
a sfera, il quarto cellulare, la terza televisione, il diciottesimo
elettrodomestico, le bomboniere, i pensierini affettuosi, i
ricordi di viaggio, i soprammobili, i servizi da caffè,
le attrezzature per i numerosi sport, le riviste, gli impianti
per la musica, le radio, i computer, gli attrezzi per i mille
passatempi, etc.
Tutti oggetti che noi compriamo, ci facciamo regalare, ci regalano,
mossi dal piacere di un attimo, dallo sfizio, del gusto irrefrenabile
del bambino viziato che vuole un gioco nuovo, lo usa pochi minuti
e ne cerca subito un altro.
A questi si aggiungono le promozioni commerciali, le “merci
gratis”: giornali, riviste, hamburger, salvagenti, pareo,
cd, film, libri, formaggini, etc.
Le case diventano sempre più piccole e il numero degli
oggetti diventa sempre maggiore, in una sorta di parossismo
collettivo.
Scegliere quegli oggetti che effettivamente rappresentano qualche
cosa, che ci possono accompagnare nel ricordo o nel piacere,
in un numero limitato. Lasciare le offerte e i regali. Andare
nei luoghi per vedere, capire, sentire ma non comprare.
È difficile farlo? Non vi sono antidoti al morbo dell’acquisto?
Eppure…
Uno strumento appropriato
Il grande sviluppo delle tecniche è sicuramente uno
dei dati caratterizzanti il nostro tempo.
Gran parte delle innovazioni sono dettate dalle caratteristiche
del mercato e dalla necessità di immettervi nuove merci
competitive, gran parte di queste merci è predisposta
per il consumo individuale. Telefoni cellulari, che nelle successive
evoluzioni divengono anche telecamere, registratori, strumenti
di scrittura, computer che trasmettono musica e immagini; computer
e televisioni sempre più connessi in una unica rete,
sistemi per ascoltare la musica sempre più sofisticati,
elettrodomestici elettronici, etc. sono alcuni esempi di un
apparato in cui la tecnologia è lo strumento principale
per fare vendere la merce.
Il computer con cui si scrive ha una potenza pari o forse minore
a quella che fu necessaria per mandare nello spazio i primi
satelliti, eppure per gran parte dell’uso che se ne fa
essi sono solo macchine da scrivere, calcolatrici o motori per
videogiochi.
Coglie serio il dubbio che lo strumento sia leggermente sovradimensionato
rispetto a quello a cui realmente serve.
Un autoveicolo di cinquemila di cilindrata che supera i 270
chilometri all’ora e raggiunge i 100 km in tre secondi
non è appropriato alla nostra necessità di movimento
urbano, dove la media è 15km all’ora; una grande
automobile fuoristrada, lunga più di cinque metri, con
delle ruote alte un metro e spesse quaranta centimetri, pesante
una tonnellata e mezza e con una portata di quasi una tonnellata
non è appropriata per andare a comprare una spesa di
venti chili; uno spremiagrumi elettrico di acciaio e plastica
che consuma un kw, che ha bisogno di essere montato e smontato,
pulito e ripulito prima e dopo l’uso, non è appropriato
a spremere un limone.
Forse non è necessario cambiare il nostro computer, l’automobile,
il cellulare, il lettore ogni tre anni per comprare il modello
più recente, più potente, con maggiore adattabilità
perché già quello che abbiamo non lo usiamo completamente.
Non solo la tecnologia è una merce ma i prodotti non
sono appropriati.
Rallentiamo la sostituzione. Manteniamo gli strumenti che possediamo,
facciamoli invecchiare, innoviamoli in ritardo. Rallentando
non diverremo noi stessi promotori del processo. Il mercato
è sensibile e rallenta l’innovazione delle merci
se non incontra un adeguato riscontro.
È difficile farlo? Non possiamo aspettare un po’
e vedere se possiamo farne a meno?
Eppure…


Un bicchiere di plastica
Un oggetto semplice, apparentemente inoffensivo ma che lentamente
sta sostituendosi ai bicchieri di vetro.
È più comodo, ovvero evita al gestore del bar
di utilizzare la lavastoviglie, al barista di pulire i bicchieri.
È più comodo, ovvero evita a casa di lavare i
bicchieri, si mantiene la cucina più ordinata e si rigoverna
con facilità.
Ma quanti miliardi l’anno di bicchieri di plastica si consumano?
Quante migliaia di tonnellate di plastica vanno a discarica
dopo un uso di qualche secondo: un sorso d’acqua, al massimo
un pasto.
E quant’è il costo ambientale del processo produttivo
e dello smaltimento del rifiuto?
Quanti operai ci vogliono per produrre questi miliardi di bicchieri?
Pochi, pochissimi, enormemente meno di quelli necessari a fare
altrettanti bicchieri in vetro.
E quanti baristi in meno servono visto che non hanno nulla da
lavare? Tanti, tantissimi.
Ed allora questo oggetto semplice, apparentemente inoffensivo,
comporta in realtà significativi effetti negativi nell’ambiente
e nella società.
Ed allora che cosa ci vuole a sciacquare un bicchiere di vetro,
usandolo per una decina di anni, e dov’è la difficoltà
a chiedere al bar una tazzina di ceramica, che si usa per decenni,
sapendo che si sta agendo per salvare il posto di lavoro forse
proprio all’infastidito barista? Che cosa ci vuole a non
consumare nei luoghi dove si serve solo nella plastica o in
contenitori monouso?
È difficile farlo? È troppo impegnativo?
Eppure...
Un gran caldo
Tra auto di cilindrata sempre più elevata e facendo
sempre più chilometri, utilizzando una quantità
di energia di origine fossile enorme e scaricando inquinanti
a tutto spiano, ansimiamo dal caldo.
È possibile che non si riesca a collegare l’uso
degli autoveicoli e dell’energia fossile al riscaldamento
del pianeta?
Una volta fatta questa connessione, fulminati dalla consapevolezza,
dovremmo scendere dalle nostre auto e abbandonatole dove sono,
muoverci a piedi, in bicicletta, sui pattini, a cavallo.
Ma ciò non avviene. Persone del tutto normali, pur consapevoli
del problema, nel momento in cui scelgono il loro autoveicolo
guardano la forma, la velocità, il prezzo, gli accessori,
la dimensione.
Gli autoveicoli con i loro motori a scoppio ma anche, seppur
in maniera molto minore, con le lamiere, sono dei riscaldamenti
mobili.
Eppure persone ragionevoli comprano autoveicoli di cilindrata
sempre maggiore, eppure persone ragionevoli ogni anno fanno
migliaia di ore in fila in macchina per andare a lavoro o peggio
per andare in vacanza, senza un dubbio, senza un’idea di
mezzo alternativo, eppure persone ragionevoli consumano energia
elettrica come se la sua produzione non avesse alcun effetto
nell’ambiente e poi sulla loro salute.
Fare meno chilometri con le auto, scegliere le cilindrate piccole
a maggiore efficienza, andare più piano (per consumare
meno), andare a piedi per piccoli percorsi, ridurre l’uso
degli elettrodomestici.
È difficile farlo? Siamo troppo dipendenti?
Eppure…
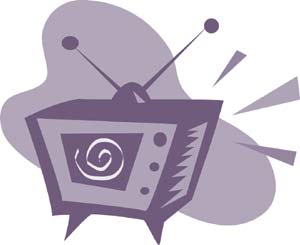
La conoscenza indotta
Il televisore è una macchina fantastica. Attraverso
di esso si vedono cose mai viste, ci si può rilassare,
distrarre.
Meravigliosa e incantatrice, la televisione ci mostra il mondo
e ce lo racconta senza che noi ci si debba muovere dalla nostra
poltrona; in realtà altera la nostra conoscenza e la
nostra capacità di relazione, modificandoci la cultura
e i criteri di osservazione, presentandoci contesti ignoti e
con i quali non possiamo relazionarci.
Definisce la nostra cultura impregnandola di fattori estranei
e arbitrari, non connessi alla nostra esistenza se non attraverso
la sua mediazione.
Passivi, persi in una quantità di immagini paurosamente
grande, delocalizzati, ci componiamo una conoscenza del mondo
attuata con una specie di “settimo senso”: una visione
molto più ridotta come estensione ottica dell’immagine
oggettiva, ma incui ci immedesimiamo di più che in qualunque
situazione oggettiva che comprenda tutti gli altri nostri sensi.
Alienati, in sintesi. Inquinati di immagini.
E proprio per questo la meraviglia e lo stupore, qualità
elette dell’uomo di fronte al mondo, sono quasi esclusivamente
utilizzati dalla televisione per veicolare merci e per sostenere
e normalizzare un modello insostenibile.
È possibile immaginare che non si comprino i prodotti
pubblicizzati?
È possibile immaginare che non si guardino programmi
e reti che si comportano in maniera ambientalmente e socialmente
scorretta, sostenendo o facendosi sostenere da merci e da comportamenti
aberranti e dannosi?
È difficile farlo? Siamo troppo assuefatti?
Eppure…


Un vestito usato
Il livello di spreco di un popolo si può desumere da
quanto le merci che esso butta sono ancora interessanti per
altri.
In gran parte del mondo una moltitudine di persone setaccia
le discariche alla ricerca di cibo e merci utilizzabili.
Anche noi bisogna incominciare a cercare nelle nostre discariche.
In primo luogo in quelle di casa, evitando di buttare materiali
ancora utilizzabili e prima ancora di acquisire merci che già
sappiamo non utilizzeremo a lungo. In secondo luogo mettendoci
nella condizione di essere disponibili all’uso di merci
che altri hanno buttato ma che rispondono alle nostre esigenze.
Queste non saranno forse esattamente uguali a quelle che avremmo
comprato ma adattarle alle nostre esigenze ed adattare le nostre
esigenze ad esse fa parte di una intelligenza operativa che
ha caratterizzato da sempre l’agire umano.
Armadi, specchi, automobili, libri, riviste, vestiti.
Nei numerosi mercatini domenicali affluiscono vestiti usati
dei paesi più ricchi di noi e di persone maggiormente
avvezze allo spreco.
Maglioni, camice, calzoni nuovi o praticamente nuovi colpevoli
di avere, al massimo, piccole macchie asportabili, scuciture
ricucibili, bottoni mancanti sostituibili, minuscoli buchi rammendabili.
Spesso merce di grande qualità che mantiene immutata
la sua efficienza ma è considerata importabile.
Forse è opportuno tralasciare i mercati dei prodotti
della nuova moda (chi sa perché la moda cambia di stagione
in stagione?) e recuperare almeno parzialmente mercati meno
frenetici connotati da quella capacita di adattare e di adattarsi
che rende minimo lo spreco.
Mantenere i proprio vestiti a lungo, comprare anche vestiti
usati e usare le merci smesse da altri.
È difficile farlo? È troppo da poveracci?
Eppure…
Condizionarsi l’aria
L’aria è il primo bene comune degli uomini, indispensabile
e uniformemente diffuso su tutto il pianeta.
La disabitudine della nostra civiltà a provvedere con
mezzi semplici alle diverse condizioni poste all’uomo dal
clima (scegliere abiti più idonei, isolare adeguatamente
le abitazioni, adattare i tempi del lavoro alle condizioni esterne)
e l’affidamento sempre più esteso alla tecnologia
per la risoluzione dei problemi, hanno fatto sì che anche
l’aria, in qualche modo, sia divenuta merce: riscaldata,
raffreddata, depurata, in una parola: condizionata.
Le temperature sono aumentate mediamente di pochissimo, un pochissimo
sufficiente ad alterare i sistemi naturali ma non ancora a danneggiare
gli uomini, specialmente quelli residenti nelle zone temperate.
L’aumento della temperatura ha fatto sì che in alcuni
giorni dell’anno essa sia pesante da sostenere. Ma questo
disagio, in realtà riferito a un periodo brevissimo,
ha indotto la collettività a ritenere che l’unica
soluzione sia l’installazione di impianti di condizionamento,
che però procedono a funzionare con il calendario, e
non con il termometro. E si assiste all’assurdo per cui,
per entrare in un supermercato o in un negozio, bisogna coprirsi,
mentre fuori c’è una temperatura invidiabilmente
mite.
La presenza diffusa di questi impianti fa sì che intere
zone, luoghi e strade prima vissute regolarmente, si siano trasformate
in fornaci insopportabili grazie alle emissioni dei condizionatori,
che, notoriamente, freddano dentro e scaldano fuori. Per di
più la fornace è rumorosissima e niente affatto
discreta visivamente.
La risposta ad un esteso disagio, ma ridotto nel tempo, invece
di portare ad una riduzione dei movimenti e quindi del lavoro
e dei consumi, invece di essere volta alla messa in opera di
sistemi passivi, ambedue soluzioni che riducono le emissioni
e il riscaldamento globale, per difendersi in quei pochi giorni,
è di acquisire apparecchi di condizionamento.
Milioni. Decine di milioni.
Ciascuno di questi rinfresca l’aria interna ma sputa fuori
calore: consuma energia e aumenta l’effetto serra, cioè
il maggiore responsabile dei disagi climatici.
Una risposta imbecille. Senza scusanti.
Rappresentazione del benessere fittizio individuale e menefreghista
che questo mercato produce.
Chiudere gli impianti di aria condizionata, ingegnarsi, per
esempio, con tende, vegetazione, aumento della coibentazione
di pareti e superfici vetrate per eliminare questa nuova e indotta
sudditanza.
È difficile farlo? Non riusciamo più ad adattarci
al variare delle condizioni ambientali?
Eppure…
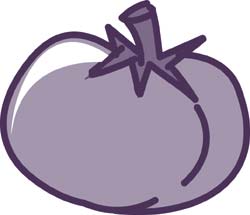   
Un amico coltivatore
Quando si mangia un pomodoro fa piacere sapere che esso è
stato coltivato senza l’uso di sostanze chimiche dannose
alla nostra salute, vicino al luogo dove noi lo consumiamo,
senza quindi essere trasportato con grande consumo di energia,
che è stato coltivato senza sfruttare nessuno, che è
stato colto al tempo giusto senza “svernare” nelle
celle frigorifere o negli impianti di maturazione a gas.
Fa piacere sapere che non è stato pompato di acqua e
di ormoni, che è cresciuto nel luogo adatto alla sua
crescita usando l’energia del sole, non forzato da serre
né da impianti per l’anticipazione della maturazione.
Fa piacere mangiare un pomodoro nel tempo dei pomodori e fa
piacere mangiare un pomodoro che è stato coltivato con
cura sapendo che chi lo mangerà avrà piacere a
mangiarlo perché riconoscerà la qualità
del lavoro svolto ed il piacere che un pomodoro, quel pomodoro,
sa dare alla nostra esistenza.
La merce pomodoro industrializzato questo non lo potrà
mai garantire.
Essa al massimo ci assicurerà di non avvelenarci immediatamente
ma non chenon abbia usato nei processi produttivi sostanze che
con il tempo ci danneggeranno. Tutto il resto è estraneo
al pomodoro industrializzato.
Allora per noi è importante connettersi a chi direttamente
produce per noi con la qualità che richiediamo e che
solo conoscendoci egli potrà garantirci.
Un amico che fa i pomodori.
Cercarli, sostenere le piccole produzioni. Fuori dal mercato
industrializzato, costruendo relazione dirette.
È difficile farlo? Non abbiamo più il piacere
di quel pomodoro?
Eppure…

Soldi da soldi
C’è chi fa soldi sui soldi.
In una società di merci il denaro assume un’importanza
smisurata. Il denaro stesso diventa una merce e il guadagno
maggiore è il guadagno sul denaro.
Perché investire nelle borse e cercare di arricchirsi
con esse? Non da un senso di irrequietezza l’eventuale
aumento dei capitali? Non ci viene in mente che proprio a quei
soldi possano corrispondere prelievi indiscriminati di risorse,
speculazioni scorrette con popolazioni, ed impoverimenti di
qualcun altro?
Per aumentare il totale del mercato hanno privatizzato e quindi
immesso nel mercato elettricità, acque, gas, petrolio,
foreste, pascoli, proprietà comuni, tutti beni dell’umanità
prima che di chiunque altro e solo attraverso di essi la quantità
delle transazioni è aumentata. E poi è aumentata
fittiziamente sull’aumento ottenuto.
Attraverso questo meccanismo si sono arricchiti i ricchi e impoveriti
i poveri, si sono svendute le risorse naturali e culturali,
si è speculato sul benessere immettendo sul mercato quelli
che erano servizi comuni.
Che ha a che fare con questo mondo un impiegato, un artigiano,
un piccolo imprenditore? Non lo governa, sa solo quello che
alcuni vogliono che si sappia e, attenzione, quando vogliono
che si sappia. Che abbiamo a che fare con questo mondo che si
astrae dalle necessità e dal piacere degli uomini per
traslare ogni interesse su un oggetto convenzionale come il
denaro e che pone a ragione fondante di ogni decisione la capacità
di produrre denaro?
Ma sono i ricchi a possedere il denaro e a produrre denaro con
il denaro, e applicare questo unico parametro è una iattura
per tutta l’umanità.
Ridurre il gioco sul denaro. Non utilizzare le carte di credito,
ridurre i servizi bancari, controllare dove vanno a finire i
nostri soldi (per esempio sarebbe bello che non finanziassero
le armi e le guerre), porre i risparmi in banca etica o in cooperative
sociali, non speculare in borsa.
È difficile farlo? Il nostro patrimonio finanziario ne
trarrebbe nocumento?
Eppure…
La panacea delle norme
Nello scombinamento prodotto dalla grandezza e dalla penetrazione
del mercato unico e dalla stravolgente quantità e tipologia
di merci, di azioni, di servizi in vendita, le norme divengono
una panacea.
Si regolamenta tutto e gli utilizzatori sono garantiti dall’applicazione
delle norme.
Ma le norme possono essere sbagliate. In particolare quelle
che riguardano le merci sono sbagliate in quanto definite appositamente
per garantire gli interessi delle grandi compagnie.
Così, ad esempio, in campo alimentare il fatto che i
cetriolini in salamoia debbano tutti essere dritti e simili
per peso e forma per rispondere alle norme di qualità
europee ha tolto di mezzo i produttori non industrializzati
che nonriescono a garantire quel livello di uguaglianza tra
i cetrioli. Così il gelato artigianale, o il salame tagliato
a mano, o il famoso lardo di Colonnata (per cui è stata
cambiata la norma) sono tutte merci fuori legge.
Le norme che afferiscono le merci hanno favorito e favoriscono
una visione del mondo, industrializzata e omogenea, che elimina
le tecniche locali e la cultura produttiva sostituendo tutto
con prodotti uguali, asettici, ma non per questo salubri. In
questo vengono favorite le grandi produzioni e il modello praticato
dalla concentrazione della produzione e dalla distribuzione
capillare dello stesso tipo di prodotto.
Questo apparato normativo non garantisce i cittadini. Bisogna
dunque controllare al di là delle norme ed essere critici,
diffidando, comprendendo le motivazioni da cui le scelte normative
sono derivate, cercando di sostenere le merci che mantengono
caratteri ambientali e sociali corretti.
È difficile farlo? È un’ulteriore fatica?
Eppure…

Il mito del progresso
Nella nostra cultura contemporanea il mito del progresso esercita
una grande capacità di attrazione.
Forse l’impulso dato dai movimenti sociali nati nell’ottocento
verso una fiducia nelle armi del progresso per il miglioramento
delle condizioni dell’uomo (fiducia che a tratti si è
radicalizzata in fede), forse il retaggio dell’illuminismo
che costruisce pragmaticamente l’affidamento alla scienza
e alla tecnologia per costruire un futuro migliore per l’uomo,
sono i motivi che hanno fatto sì che la nostra società
costruisse la sua immagine proiettata nel futuro: tutto ciò
che è nuovo è automaticamente buono, tutto ciò
che è moderno è di fatto migliore e preferibile
all’antico.
Questo dogma, mai palesemente espresso ma del tutto implicito
nel costume sociale, fa sì che il mercato, che è
l’espressione principale della nostra società, si
avvalga di continui e imprescindibili richiami al “nuovo”,
al “moderno”, al “tecnologicamente avanzato”
per incrementare le vendite e i consumi.
Il futuro, identificato con il progresso, viene anticipato anche
come immagine di riferimento, e la maggior parte delle persone
sembra adeguarsi a questa proiezione, cercando di somigliare
a quella immagine, come se essa fosse l’ineluttabile condizione
del futuro. L’ade-guamento passa, ovviamente, per l’acquisizione
di merci che di quella proiezione sono i tratti identificanti.
Sicché ci si sente moderni e anticipatori del futuro
se si possiede l’ultimo modello tecnologico di una certa
cosa. Sentirsi così equivale a sentirsi “adeguati”.
L’immagine del nostro futuro viene costruita nei laboratori
della pubblicità.
Naturalmente non ci viene detto, per esempio, che l’ultimo
modello di televisore in realtà è già ampiamente
superato dalla tecnologia, e che non ci daranno in pasto l’ultimo
modello finché tutti non avremo acquistato quello già
vecchio.
Potrebbe essere più interessante costruirci da soli la
“nostra” immagine del futuro, scoprire che potrebbe
non somigliare per niente a quella della pubblicità,
scoprire che potrebbe essere infinitamente più bella
e affascinante.
Rifiutare di assomigliare agli androidi della pubblicità,
sottrarsi alla mercificazione, sottrarsi ai comportamenti teleguidati,
scegliere un’altra via in cui riconoscersi e riconoscere
gli altri, esercitarsi ad inventare quello che potremmo essere.
È difficile farlo? È talmente gratificante sentirsi
adeguati al mondo che ci propongono? È quello il mondo
futuro che vorremmo?
Eppure…


Eppure…
sembrano atti alla nostra portata. E lo sono. Piccole azioni
quasi quotidiane che potrebbero modificare le relazioni tra
il sistema delle merci e gli utilizzatori e quindi modificare
il mercato con tutte le implicazioni ambientali e sociali che
ciò comporterebbe.
Il sistema di mercato è il tallone d’Achille della
nostra società, il punto di maggiore vulnerabilità.
Se i criteri che ci vengono proposti come modelli sociali ci
appaiono insostenibili, è necessario pensare che la loro
modificazione non è necessariamente affidata ad una titanica
ricostituzione di un modello diverso, ma potrebbe essere validamente
e concretamente avviata dall’acquisizione di comportamenti
diversi dai previsti, e che vadano ad incidere proprio sul lato
“debole” della struttura: il mercato. E riappropriarsi
così della dignità delle proprie scelte e della
libertà di compierle.
Per un gruppo di persone di un villaggio africano basta una
capra per modificare integralmente la propria esistenza, e non
per un tempo determinato ma per sempre. Forse per noi, abitanti
dei paesi ricchi, non basta così poco, ma sicuramente
abbiamo anche noi la nostra “capra” che modifica il
grande sistema in cui siamo inseriti e che oggi appare a molti
unico, insuperabile e come tale fagocitatore e senza alternative.
Oppure si ritiene che comunque ce la caveremo, che la specie
umana, grazie alla tecnologia, riuscirà a trovare soluzioni
atte a farci continuare questo cammino basato sullo sfruttamento
insensato di uomini e natura, per permettere a pochi privilegiati
di continuare il proprio standard di vita?
È possibile. Ma è proprio questo cammino, indipendentemente
dalle sue possibilità, che si vuole evitare di percorrere,
costituendo oggi, e non in un imprecisato e sempre posticipato
futuro, le condizioni per permettere la vita (e non solo la
nascita) delle persone.
E per fare questo non è possibile delegare ad altri o
al futuro il compito ma bisogna divenire parte attiva attraverso
il nostro corretto agire.
Vogliamo credere che si sia in molti a pensare che questo “modo”
non è possibile, che non è giusto, che non può
essere condiviso. Per questo abbiamo voluto con semplicità
riflettere criticamente sulla possibilità, attraverso
comportamenti più attenti, di non essere strumenti di
sostegno ad un modello che porta nel mondo miseria, sopraffazione,
danni all’ambiente, alle comunità e alla salute.
Perché non dovremmo esser attenti? Attenti come lo siamo
stati per millenni ai segnali della natura, attenti agli altri
uomini, attenti ai luoghi. Perché oggi dovremmo deporre
questa capacità di discernimento ed attenzione sulla
quale abbiamo sviluppato la nostra intelligenza e la nostra
tecnica? Porre attenzione alle cose che si fanno, capirne il
senso, considerarne gli effetti, l’efficienza, la correttezza.
La correttezza rispetto ad alcuni criteri sulla base dei quali
discernere quello che è congruo fare e quello che può
essere evitato. Criteri sulla base dei quali è possibile
esprimere un giudizio sui comportamenti.
Allora, ogni qual volta ci viene presentata una merce, sia essa
nuova o innovativa, sia essa necessaria o utile, le domande
che bisogna porci sono: qual è il suo impatto nell’ambiente?
Riduce l’urto imposto alla natura e al territorio rispetto
alla soluzione precedentemente adottata? Quanto la sua fabbricazione,
il suo uso, la sua dismissione migliora le condizioni dell’ambiente
rispetto a quelle attuali?
quante persone fa lavorare?
Si è ricorso a processi industrializzati a basso uso
di manodopera? Se è una merce prodotta in grandissime
quantità, quale è stata l’incidenza del lavoro
umano e quanto sarebbe stato possibile trovare soluzioni alternative?
quanti sono i beneficiari economici?
I profitti della produzione, distribuzione e commercializzazione
sono concentrati in pochi soggetti o sono distribuiti equamente
nella comunità?
Quanto esprime la cultura di una comunità?
Quanta tecnica specifica è conservata nella merce? Quanto
l’oggetto contribuisce a far permanere la conoscenza tecnica
nella comunità e la sua autonomia produttiva?
Ben sapendo che i problemi maggiori del nostro pianeta sono
collegati ad un ambiente depredato, alterato e distrutto, alla
mancanza di lavoro, alla concentrazione dei profitti, al depauperamento
culturale ed asservimento delle comunità, se una merce
ha un peso ambientale elevato, se la sua produzione fa lavorare
poche persone, se aumenta la concentrazione dei profitti, se
non esprime la cultura e la capacità propria di una comunità
non è una merce che ci possa interessare.
Essa è una merce che fa male, fa male ad altri uomini,
induce povertà e asservimento, fa male all’ambiente,
distruggendo gli ecosistemi, e proprio per questo non va utilizzata.
E proprio in questo non utilizzo è anche richiesto il
nostro discernimento.
Un altro modo è possibile.
|
 Questo
opuscolo
è stato prodotto da Antiglo
- antiglo@email.it Questo
opuscolo
è stato prodotto da Antiglo
- antiglo@email.it
Le
attività svolte da @ntiglo si propongono di contribuire
alla diffusione di alcuni temi, secondo noi importanti
per l’elaborazione di un modello critico nei confronti
dell’attuale momento storico, temi che, seppure fortemente
presenti in vasti ambiti della coscienza critica internazionale
e vivamente trattati e dibattuti, non sono ancora patrimonio
esteso della comunità.
La forma che abbiamo scelto di seguire nell’esporre
queste tematiche tende a sottolineare l’importanza
del comportamento individuale all’interno di una
dinamica più generale che mira ad opporsi ad un
“modello globale” di società quale è
quello che ci viene proposto o imposto, convinti che il
carico di iniquità, pericolosità e arbitrio
che implica per gli uomini e l’ambiente non può
trovarci in nessun modo concordi.
Azioni e comportamenti che suggeriamo sono caratterizzati
dal desiderio condiviso di non subire un modello ingiusto
e di ricercare soluzioni praticabili oggi, in presenza
del modello, senza rimandare il buon vivere a momenti
futuri. Per quanto possibile. Senza forzare le convinzioni
ma con la forza delle convinzioni, senza uso della violenza,
senza martiri né martirii. Fin quando sussiste
anche una minima possibilità di operare sul convincimento.
I materiali di @ntiglo sono fuori dal mercato. Sono, fin
quando rimangono copie, gratuiti, sono scaricabili dal
sito, sono riutilizzabili fin quando si vuole con la sola
richiesta di citare la fonte e gentilmente comunicare
dove si sono utilizzati.
Per contattare antiglo@email.it

Un
altro modo è possibile
Testi di Adriano Paolella e Zelinda
Carloni
Grafica di Paola Venturini
Supplemento
al n. 287 (febbraio 2003) della rivista mensile anarchica
A, direttrice responsabile Fausta Bizzozzero, registrazione
al tribunale di Milano n. 72 in data 24.2.1971, stampa
e legatoria Sap s.n.c. (Vigano di Gaggiano - Mi).
Editrice A, cas. post. 17120, I - 20170 Milano
tel. (+ 39) 02 28 96 627,
fax (+ 39) 02 28 00 12 71
e-mail arivista@tin.it
sito web www.anarca-bolo.ch/a-rivista
conto corrente postale 12 55 22 04
conto corrente bancario n. 107397 presso Banca Etica
filiale di Milano (abi 05018, cab 01600)
|
|

