Nel maggio ’68,
voi lettrici, voi lettori, eravate appena nati? La storia
dell’anarchismo non inizia con l’insurrezione
studentesca e gli scioperi operai di quella primavera, ma
un secolo prima, quando gli operai d’Europa e d’America
creavano le loro prime organizzazioni, i loro primi sindacati.
O quando Proudhon rivendicava il motto: se a regnare è
il vostro ordine, allora sì, sono un anarchico!
Agli anarchici piace raccontarsi leggende, inventarsi antenati
ed eroi. In questo non vi è nessun male: “senza
dio né padrone”, il culto di san Durruti, delle
sante Louise ed Emma, o di san Ravachol non sono dannosi,
le loro gesta finiscono in qualche canzone o sulle magliette.
Ma la storia dell’anarchismo è una storia di
uomini e donne in lotta, avidi di sapere e di cambiamento
sociale, di cultura e di ideale. È anche una storia
di errori e di sconfitte, di scontri e di successi, e di una
volontà che non viene mai abbattuta. Essere sfruttato
o oppresso non basta a fare un anarchico, bisogna voler farla
finita con il dominio e portare nel cuore un mondo nuovo.
La storia degli anarchici è largamente assente dai
libri di storia e solo recentemente si è aperta un
varco nel mondo universitario. Le righe che seguono ne danno
alcuni cenni, qualche frammento, linee di forza, scandite
da canzoni.
 Il garrotamento di Michele Angiolillo (1897)
in un'opera di Flavio Costantini
Il garrotamento di Michele Angiolillo (1897)
in un'opera di Flavio Costantini
 Contro il centralismo autoritario
Contro il centralismo autoritario
Ouvrier, prends la machine, prends la terre, paysan…
(1)
Quando i tipografi e gli operai edili scioperano a Ginevra,
nel 1868, giungono aiuti economici da diversi paesi d’Europa:
le casse di soccorso sono strumenti essenziali della solidarietà,
“nell’attesa che il lavoro salariato sia sostituto
dalla federazione dei liberi produttori”. A quell’epoca
non vi sono sindacati permanenti né solide istituzioni
operaie, ma soltanto sezioni dell’Associazione internazionale
dei lavoratori, l’AIT o “Prima Internazionale”,
che esiste da qualche anno. Quando gli sfruttati e gli oppressi
cominciano a organizzarsi, sanno di aver bisogno di contatti
internazionali per essere più forti, meglio informati:
la globalizzazione non è nata ieri.
Ai suoi inizi l’AIT riunisce in federazione tutte le
correnti autonome del movimento operaio, affermando che “l’emancipazione
dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi”.
Karl Marx e i suoi, però, vogliono farne uno strumento
della propria politica, subordinare l’organizzazione
operaia alla conquista del potere politico e, coerentemente,
esercitare un controllo sulle attività delle sezioni
dal Consiglio generale istituito a Londra.
Contro tale centralismo autoritario, Michail Bakunin e i suoi
amici della Federazione del Jura praticano il federalismo,
valorizzano l’esperienza della Comune di Parigi del
1871, danno forma poco a poco a quello che sarà il
movimento anarchico e anarcosindacalista. Non stupisce che
siano espulsi! A solidarizzare con loro sono le forze vive
dell’Internazionale, nella loro quasi totalità,
che appoggiano il congresso “federalista” convocato
a Saint-Imier, nel Jura svizzero, nel settembre 1872.
“L’autonomia e l’indipendenza delle federazioni
e delle sezioni operaie sono la prima condizione dell’emancipazione
dei lavoratori” dichiara il congresso, che propone la
conclusione di un “patto di amicizia, di solidarietà
e di mutua difesa tra le libere federazioni” che stabilisca
tra loro una corrispondenza diretta e una difesa solidale,
per “la salvezza della grande unità dell’Internazionale”.
La dichiarazione più nota del congresso, quella più
citata dalla tradizione anarchica, verte sulla “natura
dell’azione politica del proletariato”: è
qui che si afferma che “la distruzione di ogni potere
politico è il primo dovere del proletariato”,
che “qualsiasi organizzazione di un potere politico
sedicente provvisorio e rivoluzionario per portare a termine
tale distruzione non può che essere un ulteriore inganno
e sarebbe altrettanto pericolosa, per il proletariato, di
tutti i governi oggi esistenti” e che “i proletari
di tutti i paesi devono stabilire, fuori da ogni politica
borghese, la solidarietà dell’azione rivoluzionaria”.
Difficile essere più semplici, più chiari!
Il ramo federalista o antiautoritario dell’AIT ha avuto
importanti sezioni in Italia, in Spagna e in Svizzera, e gruppi
meno numerosi in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, in
Uruguay e in Argentina, così come qualche adesione
dalla Germania e dai paesi nordici. Esso è stato l’autentico
crogiolo del movimento anarchico sviluppatosi in queste regioni.
È nel corso di questi primi anni di esistenza che la
Federazione regionale spagnola, in particolare, fa progredire
la discussione su anarcocomunismo e anarcocollettivismo, e
che Ricardo Mella e Fernando Tárrida del Marmol propongono
il concetto di anarchismo senza aggettivi, che sarà
felicemente ripreso negli Stati Uniti da Voltairine de Cleyre.
La storia del movimento anarchico comincia con la fine di
quest’organizzazione generale di tutto il movimento
operaio che era l’AIT ai suoi inizi. Le idee anarchiche,
loro, hanno preso vita letteralmente con Proudhon. Ma hanno
avuto precursori, e di valore.
William Godwin è il primo filosofo illuminista a elaborare,
nel 1792, una concezione che oppone la “giustizia politica”
all’esistenza di una sfera politica separata, dunque
a proporre l’abolizione dei governi e degli stati a
vantaggio del bene comune. La sua compagna Mary Wollstonecraft
afferma ad alta voce i diritti delle donne, eguaglianza e
autonomia. Molto tempo prima, Etienne de La Boétie
aveva creato il concetto di “servitù volontaria”,
rivelando un altro aspetto del dominio. Altri autori critici
o utopisti hanno ispirato il pensiero e le pratiche degli
anarchici.
Negli Stati Uniti si sviluppa, durante il XIX secolo una corrente
libertaria ostile a tutte le ingerenze dello Stato e in difesa
dell’autonomia individuale. Autori come Josiah Warren,
Stephen Pearl Andrews, Lysander Spooner, e soprattutto Henry
David Thoreau (La disobbedienza civile, scritto nel
1849) sono a modo loro dei precursori dell’anarchismo.
 La “propaganda con i fatti”
La “propaganda con i fatti”
Si tu veux être heureux, nom de dieu, pends ton
propriétaire… (2)
La storia dell’anarchismo non inizia né finisce
con i personaggi vestiti di nero e bomba sottobraccio. Certo,
la dinamite è stata una delle forme prescelte per farla
finita con il vecchio mondo.
Nel 1892, le bombe di Ravachol hanno distrutto le case di
due giudici che avevano condannato a pene pesanti alcuni compagni
operai per aver guidato una presunta rivolta il primo maggio
dell’anno precedente.
Il coltello di Caserio ha ucciso un presidente della Repubblica
francese nel 1894, l’arma di Czolgosz, qualche anno
dopo, un presidente degli Stati Uniti. Qualche personaggio
di alto livello morto o ferito, a fronte di quanti militanti
assassinati a freddo o spediti in carcere a vita? E la modernizzazione
della polizia internazionale, con la creazione dell’organismo
predecessore dell’Interpol nel 1898, per sorvegliare
e reprimere i sovversivi.
L’anarchismo propone un’idea semplice e chiara:
senza tiranno, sapremo vivere liberi e solidali. Che si tratti
dello zar Alessandro II nella Russia del 1880, del presidente
Carnot nella Francia delle “leggi scellerate”
della fine del XIX secolo, o, più recentemente, del
generale Franco che ha schiacciato la rivoluzione anarchica
in Spagna o di Salazar il satrapo del Portogallo, i sovrani
non sono al sicuro da attentati anarchici.
E tuttavia, quelli che ne sono morti sono rari, poiché
i mezzi utilizzati sono spesso irrisori in rapporto ai servizi
segreti e alle forze di sicurezza dei dittatori. E anche altri,
oltre agli anarchici, hanno tentato di liquidare papi e despoti,
per buone o cattive ragioni.
La “propaganda con i fatti” non si riduce al pugnale
o alla dinamite. Quando quest’espressione è stata
creata, segnalava semplicemente il passaggio all’azione
diretta (affermazione, resistenza o contestazione) a complemento
della propaganda attraverso con la parola e gli scritti, strumenti
tradizionali di un anarchismo illuminato.
 Buenaventura
Durruti, 1896-1936
Buenaventura
Durruti, 1896-1936
Gli anarchici più leggendari, Ravachol o Bonnot,
sono eroi di paccottiglia; ma si leggano gli atti relativi
alla difesa davanti ai tribunali francesi di un Clément
Duval nel 1887, di un Emile Henry nel 1894 o di un Marius
Jacob nel 1905, che rivendicano l’espropriazione di
chi espropria e il diritto all’autodifesa: difendono
gli stessi valori di una Emma Goldman che rivendica e pratica
il diritto all’aborto e all’amore libero, di un
Buenaventura Durruti che pratica la “riappropriazione
individuale” per finanziare progetti editoriali e il
sostegno ai compagni incarcerati.
Quando nel 1897 Michele Angiolillo spara al primo ministro
spagnolo, quando Gaetano Bresci uccide il re d’Italia
Umberto I nel 1900, quando nel 1909 Simon Radowitzky abbatte
il capo della polizia argentina, responsabile di un massacro
di operai in occasione della manifestazione del primo maggio
organizzata dalla FORA, quando Kurt Wilckens liquida il tenente
colonnello Varela nel 1923, colmo d’indignazione per
l’assassinio, sotto la responsabilità di questi,
di 1.550 operai agricoli in sciopero in Patagonia, non sono
solo gli anarchici ad acclamare il loro gesto e a festeggiare
la scomparsa dei tiranni. Organizzazioni operaie, giornalisti,
avvocati e perfino l’opinione pubblica si mobilitano
per sostenerli o per onorarne la memoria.
(…).
Ma gli anarchici sono tra le prime vittime della repressione.
Da otto a dieci anni di carcere per aver gridato “viva
l’anarchia” dai tavolini all’aperto di un
caffè, per aver affisso un manifesto antimilitarista,
per aver rubato qualche coniglio, questo era il prezzo se
si era un anarchico noto alla polizia nella Francia degli
anni ‘90 dell’Ottocento. Ventidue anni di prigione
per Alexander Berkman per il tentato omicidio del direttore
di un’azienda che aveva violentemente represso uno sciopero
a Chicago.
La sedia elettrica per Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,
arrestati nel 1920 negli Stati Uniti e giustiziati sette anni
dopo per una rapina a mano armata che non avevano commesso;
il loro amico Andrea Salsedo era stato trovato morto sotto
la finestra di un commissariato di polizia newyorchese, proprio
come lo sarà Giuseppe Pinelli a Milano nel 1969. Gli
anarchici americani di origine russa sono stati deportati
a San Pietroburgo già all’indomani della rivoluzione
del 1917; i militanti antifascisti tedeschi e italiani sono
stati costretti all’esilio o inviati in campo di concentramento.
E la storia, ahimé, non si ferma qui.
Non sorprende che la bandiera degli anarchici sia nera, il
colore del lutto e della rivolta.

I
cinque anarchici impiccati a Chicago nel 1887, e dal cui ricordo
ha preso avvio la giornata del “Primo Maggio”:
August Spies, Albert Parsons, Louis Lingg, George Engel e
Adolph Fisher
 La giornata del Primo Maggio
La giornata del Primo Maggio
Don’t mourn, organize… (3)
La storia dell’anarchismo attraversa il movimento operaio
organizzato.
È dapprima negli Stati Uniti, dopo la fine della Prima
Internazionale, che i lavoratori alzano la testa e passano
all’azione diretta.
Negli anni ’80 dell’Ottocento, ci si unisce per
la giornata lavorativa di otto ore, centinaia di migliaia
di operai scioperano per rivendicarla. Il 3 maggio 1886 a
Chicago, un raduno convocato per opporsi ai crumiri viene
brutalmente disperso dalla polizia, con morti e feriti. La
manifestazione di protesta organizzata su due piedi finisce
in un gran frastuono: una bomba ha ucciso e ferito poliziotti
e manifestanti.
La condanna a morte di cinque anarchici ingiustamente accusati
di essere gli ispiratori dell’attentato suscita un’ondata
di solidarietà senza precedenti e un movimento planetario
che non accenna ad arrestarsi: la giornata del Primo Maggio,
giornata del ricordo e della lotta per la dignità operaia,
diventa il riferimento di tutta la corrente sindacale, dai
più rivoluzionari ai più compromessi.
Ma la memoria dominante elimina ben presto il ruolo che vi
hanno avuto gli anarchici, mentre i socialisti allontaneranno
gli anarchici dalle loro riunioni. Della Prima Internazionale,
infatti, non è rimasto loro in mente che il primato
del partito politico sull’organizzazione autonoma dei
proletari.
Gli anarchici rispondono sviluppando la propria presenza sul
terreno delle lotte operaie, praticando l’azione diretta,
aprendo luoghi come le Camere del lavoro. All’inizio
del XX secolo, la CGT francese intende organizzare l’insieme
degli operai fuori da ogni linea politica; secondo la Carta
di Amiens, il suo testo fondatore, il sindacalismo basta a
se stesso.
La FORA argentina e la CNT spagnola, che nascono nello stesso
periodo, sono invece organizzazioni rivoluzionarie di tipo
sindacale che, caldeggiando l’abolizione del salariato
e il rifiuto della politica da politicanti, guardano al comunismo
libertario come al fine ultimo. Con una differenza, tuttavia:
la CNT è strettamente legata all’“organizzazione
specifica”, la FAI anarchica, mentre la FORA intende
educare i suoi membri al proprio interno, per portarli ad
adottare il comunismo anarchico.
In quella stessa epoca, negli Stati Uniti gli Industrial Workers
of the World sviluppano tecniche originali di organizzazione,
di azione diretta, di sabotaggio e di propaganda: è
in questo contesto, per esempio, che appare il gatto nero
degli anarcosindacalisti e che Joe Hill mette parole rivoluzionarie
sulle melodie di canti conosciuti da tutti: “Non portate
il lutto, organizzatevi!”.
Il modello degli IWW, con il loro radicale rifiuto dei negoziati
collettivi, si diffonderà in Cile, in Sudafrica, in
Australia, dove militanti di quest’organizzazione saranno,
in particolare, alla testa del movimento antimilitarista nel
1914. Quanto alla SAC svedese, lotta contro il monopolio della
centrale sindacale LO, sviluppa il sistema della “tariffa
sindacale” come alternativa ai negoziati collettivi.
CGT e IWW, dal canto loro, hanno istituito il marchio: si
vede ancora, a volte, e soprattutto sugli stampati, l’indicazione
“questo lavoro è stato effettuato da operai sindacalizzati”.
Avviata al congresso anarchico di Amsterdam nel 1907 da Pierre
Monatte ed Errico Malatesta, continua ancor oggi la discussione
in merito al fatto se l’organizzazione sindacale sia
sufficiente come organizzazione rivoluzionaria, se il sindacato
sia la cellula di base della società futura, o se esso
sia intrinsecamente riformista, o, ancora, se debba essere
affiancato da un’organizzazione anarchica “specifica”.
Quando il Partito comunista dell’Unione Sovietica tenta
di prendere l’egemonia sul movimento sindacale internazionale,
gli anarcosindacalisti ridanno vita all’AIT nel 1922,
con tredici organizzazioni che rappresentano un milione e
mezzo di lavoratori.
Essa federa lotte sviluppate nel corso degli anni precedenti,
con le loro armi specifiche, sciopero generale, solidarietà,
boicottaggio, sabotaggio, e sviluppa le armi culturali con
una serie di riviste di qualità come “Die Internationale”
in Germania o il “Suplemento de la Protesta” in
Argentina.
La crisi economica degli anni trenta e poi il fascismo sferrano
un duro colpo alle organizzazioni radicali. I sindacati socialisti
e comunisti si ripiegano su posizioni difensive o nazionali,
i compagni sono costretti all’esilio, le sezioni dell’AIT
si svuotano dei loro membri in diversi paesi.
La rivoluzione spagnola e la guerra civile saranno l’occasione
per un forte movimento di solidarietà, ma provocheranno
anche divisioni e conflitti inaspettati.
Dopo anni di latenza, si vedono riapparire oggi solidi movimenti
anarcosindacalisti e sindacalisti rivoluzionari in molti paesi,
sotto diverse etichette.
 Joe
Hill (Joseph Hillstrom), 1879-1915
Joe
Hill (Joseph Hillstrom), 1879-1915
 L’insurrezione contadina
L’insurrezione contadina
Nostra patria è il mondo intero… (4)
La storia dell’anarchismo attraversa le rivoluzioni
del XX secolo e le frontiere. La Comune di Parigi del 1871
aveva attratto l’attiva solidarietà dei militanti
dell’AIT d’Italia, Polonia e Svizzera, che avevano
partecipato agli scontri; e i comunardi che erano dovuti andare
in esilio in Svizzera, Belgio, Inghilterra o Spagna vi erano
stati accolti come fratelli.
Emiliano Zapata in Messico è ispirato dall’anarchico
Ricardo Flores Magón. Durante gli anni rivoluzionari,
dal 1910 alla morte nel 1919, guida le sue truppe sotto la
bandiera di Tierra y Libertad, uno slogan di cui è
giunta l’eco fino ai giorni nostri: venuto dalla Russia
del XIX secolo, è passato dalla Spagna per ritornare
in Chiapas.
Nella Russia rivoluzionaria, dal 1917 al 1921, gli anarchici
(molti sono arrivati spontaneamente o per forza dai paesi
dove erano ospiti, Francia, Stati Uniti) difendono l’idea
dei consigli operai, i soviet, dal potere del Partito e dei
suoi burocrati, prima che questi ultimi li costringano all’esilio.
In Ucraina, Nestor Makhno guida l’insurrezione contadina
contro i Bianchi controrivoluzionari, poi contro i Rossi che
vogliono farla finita con gli anarchici; sull’isola
di Kronstadt, marinai e soldati instaurano una Comune libera
che resisterà fin quando non sarà schiacciata
dall’Armata Rossa agli ordini di Trotsky. In esilio
a Berlino, poi a Parigi e a Detroit, gli anarchici russi continuano
le loro pubblicazioni, discutono della loro esperienza, partecipano
alla costruzione delle organizzazioni, come dimostrano, in
particolare, la Piattaforma elaborata da Piotr Archinov e
la “sintesi” sviluppata da Voline sulla base di
quella di Sébastien Faure.
In Cina, alcuni giovani che hanno studiato in Francia diffondono
le idee anarchiche per lottare prima contro i “signori
della guerra”, poi contro l’egemonia del Partito
comunista. Sono inseriti soprattutto nel movimento operaio
del sud del paese, e attivi nei grandi scioperi del 1927 a
Canton e a Hong Kong.
Lo scrittore Ba Jin o Pa Kin (Li Pei Kan) traduce i classici
anarchici e in seguito pubblica una serie di opuscoli in sostegno
della rivoluzione spagnola. In Bulgaria, gli anarchici hanno
partecipato al movimento nazionale rivoluzionario del XIX
secolo, cercando di conferirgli carattere insurrezionale.
Durante la dittatura fascista e la Seconda guerra mondiale,
sopravvivono in clandestinità per tornare ad organizzarsi
subito dopo la fine della guerra: nel 1945, la tiratura del
loro settimanale arriva a 30.000 copie.
A Cuba gli anarchici pubblicano il loro primo giornale nel
1886 e sono rapidamente attivi all’interno del movimento
operaio sindacale e culturale. In questi tre paesi, gli anarchici
sono stati tra i più lucidi critici delle dittature,
i più radicali dei rivoluzionari, prima che i partiti
comunisti stalinisti al potere se ne sbarazzino con la violenza.
Nei movimenti consiliaristi in Germania, in Italia e in Ungheria,
nel 1918-20, gli anarchici investono tutte le loro energie
e subiscono le più pesanti repressioni.
Gustav Landauer, commissario all’educazione della Comune
di Monaco, è assassinato nel 1919, poco dopo Rosa Luxemburg
e Karl Liebknecht, i leader socialisti rivoluzionari; il poeta
Erich Mühsam, dopo anni di prigione, muore assassinato
in un campo di concentramento nel 1934. La Comune di Budapest
è sconfitta nel sangue; le occupazioni di fabbriche
del 1920 in Italia, che testimoniano della crescita del sindacalismo
rivoluzionario, sono sabotate dai socialisti che aprono la
strada alla “controrivoluzione preventiva” organizzata
dalle squadracce fasciste e dallo Stato.
L’emigrazione e l’esilio sono spesso il solo modo
di evitare la morte violenta o anni di prigione. Elisée
Reclus vive in Svizzera dopo la Comune di Parigi, Piotr Kropotkin
ne viene espulso e trova rifugio precario in Francia, poi
in Inghilterra. Agli italiani Errico Malatesta e Camillo Berneri
si dà la caccia da un paese all’altro. Gli anarchici
ebrei polacchi, ucraini e tedeschi sciamano a Londra (dove
un altro emigrato, Rudolf Rocker, diviene il loro “rabbino
goi”, negli Stati Uniti e a Buenos Aires, dove per molto
tempo pubblicano giornali e libri in yiddish.
I successivi esili di Emma Goldman e di Alexandre Berkman
hanno dato il titolo a un bell’epistolario, Nowhere
at home (Da nessuna parte a casa propria). Oppure a casa
propria dovunque, quando dovunque si trovano compagni, si
ricreano gruppi, si scambiano pubblicazioni e corrispondenza?
“Nostra patria è il mondo intero, nostra legge
la libertà”, cantano gli anarchici italiani.
Deportati in Nuova Caledonia dopo la Comune di Parigi, Louise
Michel e Charles Malato vi incontrano i Canachi e la loro
aspirazione all’autonomia; funzionario in Indonesia,
Multatuli si dimette per denunciare il colonialismo olandese
nel suo romanzo Max Havelaar; studenti a Londra,
Jomo Kenyatta e Julius Nyerere seguono le discussioni del
gruppo Freedom; più di recente, renitenti e disertori
francesi e americani denunciano le guerre imperialiste in
Algeria e nel Vietnam.
Appoggiare le lotte di liberazione “nazionale”
senza sostenere i nascenti Stati resta ancor oggi una sfida.
La recente comparsa di gruppi anarchici in Indonesia, nelle
Filippine, in Nigeria, stimolati evidentemente da giovani
formatisi nelle università del Primo Mondo e nutriti
di Internet, cambierà la situazione?
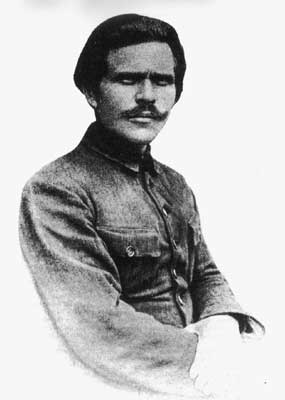 Nestor
Makhno, 1889-1934
Nestor
Makhno, 1889-1934
 Lavoro manuale e lavoro intellettuale
Lavoro manuale e lavoro intellettuale
Quand nous en serons au temps d’anarchie…
(5)
Nel 1901, Francisco Ferrer fonda a Barcellona la Scuola moderna,
che si ispira al razionalismo scientifico e grande fiducia
ha nel progresso. Essa mira alla liberazione dell’individuo
e alla formazione di uomini e donne capaci di trasformare
la società. Sostiene l’istruzione mista tra i
sessi e le classi sociali, al fine di attaccare alle radici
i pregiudizi e di preparare generazioni future dalle menti
lucide. Più o meno nella stessa epoca, Paul Robin e
Sébastien Faure dirigono in Francia scuole libere in
cui la pedagogia è basata sulla libertà, la
fiducia, la promiscuità, la combinazione di lavoro
manuale e lavoro intellettuale.
Ma sarà l’esperienza di Ferrer ad avere l’eco
maggiore: dopo il suo assassinio nel 1909, e sull’onda
della simpatia e della solidarietà, Scuole moderne,
Scuole Ferrer sono fondate in Brasile, in Svizzera, negli
Stati Uniti, in Italia… La pedagogia attiva e le scuole
alternative attuali si ispirano tutte, direttamente o meno,
a questi predecessori.
In Inghilterra (con la scuola di Summerhill tra le altre)
e negli Stati Uniti, le scuole libertarie sono anche più
numerose malgrado le difficoltà opposte loro dal sistema
ufficiale. Più recentemente, ne sono nate in Spagna
(Paideia), in Australia (School without walls), in Francia
(Bonaventure).
Non si tratta soltanto di educare i bambini: “Il compito
rivoluzionario consiste innanzitutto nel ficcare idee nella
testa degli individui” (Jean Grave). La prima attività
di un’organizzazione o di un gruppo anarchico è
spesso la pubblicazione di un giornale, di opuscoli, di volantini.
I testi di Kropotkin, Grave o Malatesta, pubblicati all’inizio
del secolo da “Temps Nouveaux”, si vendevano a
decine di migliaia di copie.
René Bianco ha catalogato oltre 2.000 periodici anarchici
in lingua francese tra il 1880 e il 1980, e le altre lingue
non sono da meno. Dalla stampa manuale alla quadricromia e
alle fotocopiatrici dalle elevate prestazioni, la “propaganda
con gli scritti” è un’arma prediletta dagli
anarchici; anche noi, qui, stiamo a testimoniarlo.
“Diventiamo più reali”, diceva Bakunin
agli operai di Saint-Imier nel 1871: che l’organizzazione
rivoluzionaria sia accompagnata da una “vera solidarietà
fraterna, non soltanto a parole, ma con le azioni, non soltanto
nei giorni di festa, di discorsi e bevute, ma ne[lla] vita
quotidiana”.
Comunità e cooperative ne sono un esempio: in passato,
singoli individui e gruppi hanno dato vita a “colonie
libertarie”, dal Belgio (Colonia L’Essai) al Brasile
(La Cecilia), dalla Francia (Aiglemont, Romainville, ecc.)
al Paraguay (Mosé Bertoni); in Uruguay, la Comunidad
del Sur fondata cinquant’anni fa, si è ricostituita
dopo un lungo esilio in Svezia; dopo il maggio ’68,
si è andati a fare formaggio di capra e a mangiare
castagne nei paesini abbandonati della Francia del Sud, e
ben pochi sono stati quelli e quelle che hanno resistito alla
durezza delle condizioni di vita.
Nei loro atenei libertari e nelle loro biblioteche popolari,
gli anarchici spagnoli o argentini da un secolo a questa parte
diffondono cultura, conoscenze scientifiche e preparazione
rivoluzionaria. Gli individualisti, soprattutto, hanno sostenuto
e praticato le lingue internazionali, ido o esperanto, come
modo di abbassare confini e barriere.
L’obiezione alle tasse, ai vaccini, alle istituzioni
del matrimonio, del voto e dell’esercito appartiene
allo stesso percorso. Oggi, in tutto il mondo fioriscono gli
spazi autogestiti, occupazioni o infoshop dove si cerca di
vivere senza denaro né padrone, o dove si inventano
nuove forme di scambio e di manifestazione pubblica.
Se gli anarchici hanno sete di una cultura senza dominio,
alcuni artisti hanno offerto loro di che arricchirla. Gli
impressionisti Pissarro, Luce e Signac, i pittori e gli incisori
Steinlen, William Morris, Frans Mareseel, Karel Kupka, Man
Ray, più di recente Flavio Costantini, Enrico Baj,
Cliff Harper, Soulas e altri, hanno offerto illustrazioni
alla stampa anarchica e opere originali alle casse di solidarietà.
Joe Hill, Erich Mühsam, Eugène Bizeau, Stig Dagerman
hanno scritto poesie e canzoni, Joan Baez, Georges Brassens,
Leo Ferré, Paco Ibañez, Fabrizio De André
hanno cantato nei raduni prima delle Poison Girls, dei Black
Bird di Hong Kong o dei Binamé di Buxelles.
I film di Jean Vigo, di Armand Guerra, di Jean-Louis Comolli,
le rappresentazioni del Living Theatre o di Armand Gatti sono
altrettanti omaggi all’anarchismo.
 Erich
Mühsam,
1866-1934
Erich
Mühsam,
1866-1934
 L’estate dell’anarchia
L’estate dell’anarchia
A las barricadas, por el triunfo de la Confederación…
(6)
Il più bel capitolo della storia dell’anarchismo
è evidentemente la rivoluzione spagnola del 1936, malgrado
il suo seguito tragico. Per diversi mesi, operai e contadini
hanno vissuto il comunismo libertario nelle fabbriche e nei
villaggi, nelle milizie, nelle famiglie, nei servizi pubblici;
decine di migliaia di donne hanno partecipato all’organizzazione
delle Mujeres Libres. Ma dovevano anche fare la guerra per
difendere la nuova società che stavano creando.
La confederazione anarcosindacalista CNT, fondata nel 1910,
aveva messo tutte le proprie forze nell’educazione del
popolo, nella pratica dell’organizzazione e nella preparazione
dell’insurrezione. Con la Federazione anarchica FAI,
tentativi rivoluzionari sono avviati in diverse regioni del
paese tra il 1932 e il 1934: costituzione nei villaggi di
collettività comuniste libertarie, assalto alle caserme
e ai municipi, che rafforzano il radicamento popolare dell’anarchismo,
suscitando però una smisurata repressione e la polarizzazione
rispetto alla sinistra politica.
Nel luglio 1936, tuttavia, gli anarchici sono pronti a replicare
al colpo di stato del generale Franco e salgono “alle
barricate, per il trionfo della Confederazione”, la
CNT: il movimento delle collettivizzazioni si avvia fin da
subito, contemporaneamente alla costituzione di milizie.
La solidarietà dei compagni stranieri è immediata:
centinaia di anarchici francesi, italiani, tedeschi, argentini,
svizzeri lasciano il loro lavoro già nel mese di agosto
1936 per andare a combattere in Spagna contro il fascismo
e per la rivoluzione sociale.
Venticinque anarchici cinesi arriveranno fino a Marsiglia
prima di dover fare dietro front. Camion di viveri e di abiti,
sotto i quali sono nascoste le armi, attraversano sobbalzando
i Pirenei e passano il confine sotto le acclamazioni di “evviva”.
Ben diverso è l’atteggiamento delle democrazie
europee e della sinistra socialista e comunista, che temono
la generalizzazione della guerra e la vittoria della rivoluzione,
e adottano una politica di non intervento.
Aprono così la porta al massiccio sostegno offerto
da Mussolini e da Hitler ai fascisti spagnoli: inviano loro
truppe, aerei e armamenti pesanti. Soltanto in ottobre l’URSS
cambia tattica, incoraggiando la costituzione delle Brigate
internazionali, rigidamente inquadrate, una delle cui missioni
sarà spezzare lo slancio rivoluzionario popolare a
vantaggio della guerra.
I fronti, così come le vittime, si sono moltiplicati,
alle milizie anarchiche mancano armi e munizioni, le fabbriche
collettivizzate improvvisano veicoli blindati e obici. Poco
a poco, l’intera industria diviene industria bellica
o di retroguardia, e “la guerra divora la rivoluzione”,
come scrive allora il libertario francese Pierre Ganivet.
Nel suo isolamento, ritenendo prioritaria la difesa del fronte
antifascista, la CNT prende la discutibile decisione di entrare
in settembre nel governo di Largo Caballero, poi di accettare
controvoglia la militarizzazione delle milizie.
Si fa così spazio agli stalinisti, che si attribuiscono
il comando della guerra. Nel maggio 1937, attaccano frontalmente
gli anarchici e il POUM a Barcellona, assassinando Camillo
Berneri che era stato uno dei più fieri critici della
partecipazione della CNT al governo.
Quest’ultima, presa tra due fuochi, non sa fare altro
che invitare alla calma.
Ben presto verrà ripreso il controllo delle collettività
della Catalogna e dell’Aragona, quelle del Levante resisteranno
ancora diversi mesi. Nel febbraio 1939, Barcellona è
presa dalle truppe franchiste, in marzo tocca a Madrid. Migliaia
di anarchici e di repubblicani sono massacrati o imprigionati,
centinaia di migliaia prendono la via dell’esilio e
si ritrovano confinati in accampamenti predisposti in fretta
e furia sulle spiagge francesi del Mediterraneo.
Il movimento libertario si è ricostituito in esilio,
con la CNT, la FAI e le organizzazioni di giovani e delle
donne, con le inevitabili divisioni che questo genere di situazione
provoca. All’interno della Spagna, la CNT si è
anche ricostituita senza tregua nella clandestinità,
al prezzo di numerosi morti e interminabili anni di galera.
La stessa sorte toccherà, più tardi, ai guerriglieri
che cercano di rimettere in piedi un movimento di resistenza
e a tanti militanti che hanno tentato di farla finita con
Franco, fino a quando questi non finisce da solo nel 1975.
 Venezia 1984, Barcellona 1993
Venezia 1984, Barcellona 1993
Rue Gay-Lussac, les rebelles n’ont q’les
voitures à brûler… (7)
Il Maggio ’68 non ha avuto inizio nel maggio 1968.
Gli studenti avevano ben dimenticato che l’anarchismo
era tornato ad alzare la testa in Francia e in Italia, subito
dopo la fine della guerra nel 1945; si era ben dimenticato,
negli anni dell’abbondanza, il coraggio di coloro che
pubblicavano giornali, riformavano le organizzazioni, riannodavano
i contatti.
Dai luoghi del loro esilio, gli anarchici spagnoli hanno contribuito
a mantenere accesa la fiamma del movimento, pur essendosi
posti, talvolta, come modelli insuperabili; l’antifranchismo
militante è stato senza dubbio, così come il
movimento contro la guerra del Vietnam, uno dei propulsori
del Maggio ’68.
Dopo la presa del potere da parte dei partiti stalinisti nelle
“democrazie popolari” dell’Europa dell’Est
e in Cina, solo qualche debole voce vi rimaneva a testimoniare
di un fiero passato anarchico. Nei paesi occidentali e nelle
Americhe, i partiti comunisti si arrogavano il ruolo di unica
opposizione al capitalismo e alle democrazie liberali capace
di farsi sentire. Si può ben dire che il mondo si sia
stupito nel vedere la gramigna anarchica rimettere radici.
Negli Stati Uniti, i vecchi compagni di origine russa, italiana,
spagnola, hanno faticato, essi stessi, a riconoscersi negli
hippy e negli studenti arrabbiati; in Germania, non c’era
che un pugno di veterani, Augustin Souchy, Willy Huppertz,
Otto Reimers, che pubblicavano modesti bollettini.
Nel giro di qualche anno, le librerie si sono improvvisamente
riempite di tascabili sull’anarchismo (e su tutte le
correnti di sinistra), riedizioni, antologie, saggi; i professori
hanno cominciato ad accettare ricerche sulla rivoluzione spagnola,
su Makhno e Kronstadt, studi sulla stampa, e poi lavori femministi
e di storia orale. Nel giro di qualche anno si è venuta
a costituire una cultura anarchica di base, accessibile e
accettata.
Anche nell’Europa meridionale, nonostante l’anarchismo
non fosse stato completamente occultato, la diffusione delle
idee e delle pratiche si è accelerata, così
come quella della A cerchiata sui muri. Quando il Brasile
ha conosciuto un breve periodo democratico, alcune opere erano
inviate clandestinamente in Portogallo dove la ferula di Salazar
proibiva lo studio della storia del XX secolo.
Nella Spagna, schiacciata sotto il gioco di Franco, la giovane
generazione cercava le proprie radici, interrogava i suoi
padri, pubblicava di nascosto. Alla morte del dittatore, centinaia
di gruppi hanno adottato il bel nome di CNT.
Nel 1984, anno simbolico come pochi, alcune migliaia di anarchici
si sono dirette a Venezia per ascoltarvi conferenze, partecipare
a dibattiti, assistere a concerti, visitare mostre, raccontarsi
le proprie pratiche.
Nel 1993, erano quasi altrettanto numerosi a Barcellona per
l’Esposizione universale. Questi grandi forum sono luoghi
privilegiati per far incontrare non soltanto compagni di lingue
e culture diverse, ma di diverse generazioni, sostenitori
dell’anarchismo classico e giovani occupanti di case,
universitari canuti e variopinte ragazzine punk. Tra questi
due raduni, la geografia dell’anarchismo aveva preso
nuove dimensioni: nei paesi dell’America Latina e dell’Europa
dell’Est si costituivano o ricostituivano gruppi, pubblicazioni,
memorie. Questo sviluppo multicolore e multiforme non si è
più fermato da allora: gli anarchici hanno un futuro
per davvero.
 Marianne Enckell
Marianne Enckell
traduzione dal francese di Anna Spadolini

