Camminando, camminando
(Gelém Gelém)
abbiamo percorso cammini
sulla lunga strada
abbiamo incontrato Rom felici
Oh! Zingari
da dove venite
con i figli affamati?
Oh, Rom
Oh, figli.
Tutta la mia grande famiglia
la legione nera lha sterminata
Tutti hanno massacrato, uomini
e donne, fra loro anche
bambini inocenti.
(Inno transnazionale dei Rom)
|
Se riguardo lolocausto degli Ebrei ad opera dei nazisti durante
il periodo della seconda guerra mondiale si è ormai ampliamente
a conoscenza grazie a ricerche, studi e soprattutto testimonianze
dirette e indirette di sopravvissuti al massacro, la stessa
sorte toccata ai Rom e ai Sinti penso non si possa definire
nel senso di olocausto dimenticato - ci si può infatti dimenticare
di qualcosa di cui si é a conoscenza - ma semplicemente di olocausto
sconosciuto.
Sconosciuto, non perché non si sapesse, non perché gli storici,
quelli che scrivono i libri, non fossero a conoscenza ma molto
più semplicemente perché gli Zingari non fanno Storia, non contavano
niente allora come non contano niente oggi quando si parla di
loro solo per qualche fatto di cronaca nera (il furto di un
motorino) criminalizzandoli a livello generale, o ipocritamente
compiangendoli quando muoiono dei bambini nellincendio della
roulotte o della baracca dove vivono miseramente.
Da qualche tempo qualcosa è cambiato e alcuni studi e ricerche
hanno portato alle luce lolocausto zingaro e una cifra che
per difetto è stata stabilita in mezzo milione di morti nei
campi di sterminio nazisti e nei luoghi dove venivano rastrellati.
Uno dei primi lavori in questo senso Il destino degli Zingari
di Kenrik D. e Puxon G. è uscito in Italia per la Rizzoli
nel 1975 e mai più ristampato.
Poche le testimonianze dirette, una di queste ci viene offerta
dal sinto tedesco Otto Rosenberg nel libro, a cura di Ulrich
Enzenberg, dal titolo La lente focale, Gli zingari nellolocausto,
uscito da poco in Italia per la Marsilio Editori.
Otto Rosenberg ha oggi 73 anni e vive a Berlino, è membro del
consiglio direttivo della Comunità di sinti e rom della Germania
ed è presidente dellAssociazione sinti e rom tedeschi del Berlino-Brandeburgo.
Otto ha mantenuto il silenzio per oltre cinquantanni, poi ha
voluto che qualcuno trascrivesse la sua storia e ne è nato questo
libro dove ripecorre lonore da lui vissuto quando da bambino
é stato portato con la sua famiglia nel campo di concentramento
di Marzahn assieme ad altre migliaia di Zingari. Finirà, anni
dopo, nello Zigeuner-Lager di Auschwitz-Birkenau, poi a Buchenwald
e infinite a Bergen-Belsen dove sarà liberato. Unico sopravvissuto
di tutta la sua famiglia.
Si legge nella prima nota che correda il libro: Rosenberg
o von Rosenberg figura tra i nomi più antichi delle famiglie
Sinti, la cui presenza in Germania è attestata a partire dal
XV secolo. E Otto si sentiva tedesco a tutti gli effetti. Ma
evidentemente non bastava per essere considerati tedeschi ma
solo zingari la cui piaga doveva essere cancellata dalla faccia
dellEuropa.
Per Otto e tutti gli zingari sopravvissuti allolocausto dei
campi nazisti non ci sono stati risarcimenti di sorta né per
loro né per i famigliari uccisi. Dei risarcimenti non dati ai
Rom e Sinti scampati ai Lager si sta parlando solo oggi a distanza
di 55 anni quando ormai i superstiti sono rimasti ben pochi.
 Franco Pasello
Franco Pasello
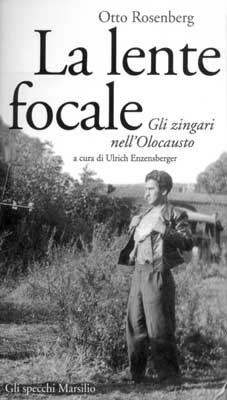
Gli scienziati
dell'immigrazione
Indispensabile, ai fini dello sfruttamento di
coloro che migrano alla ricerca di condizioni migliori rispetto
a quelle dei Paesi da cui essi partono, è la loro classificazione
come pericolosi nemici dei valori altrui. Georg Simmel, che
da studioso ebreo cui nella Germania guglielmina era preclusa
la carriera accademica qualcosa del razzismo ne sapeva, scrisse
che, mentre luguaglianza rassicura le differenze sono di
stimolo (Georg Simmel, Sociologia, Torino, 1998, edizione
originale del 1908). Uno stimolo, tuttavia, non determina quasi
mai univocamente una risposta, e per qualcuno serve solo a scatenare
la voglia di trasmettere quella che Canetti definiva la spina
del comando.
Lo vediamo tutti i giorni. Chi cerca di approdare ai lidi italici,
prima ancora di arrivarci, per la stampa è un clandestino:
parola con cui si usava designare qualcuno che simbarcasse
senza biglietto, usata metaforicamente per suggerire che sulla
barca Italia (o Europa, o mondo ricco), qualcuno cerca di
salire di nascosto, per nascondersi nella cambusa rubacchiando
cibo e scroccando un passaggio a noi che faticosamente stiamo
sudandoci il nostro meraviglioso viaggio verso i lidi del Progresso,
o magari per provocare un ammutinamento.
Nelle retoriche dellimmigrazione, il posto donore spetta allallarmismo
dei confronti delle ipotetiche basse intenzioni, che, mettendoci
tutti in pericolo, legittimerebbero i provvedimenti che sono
stati presi configurando un regime giuridico di serie B che
ricorda quello degli ebrei nel Medioevo.
Al suddetto allarmismo contribuiscono gli scienziati, che del
resto fanno per il regime di turno quello che gli ecclesiastici
facevano nel Medioevo (e che oggi continuano a fare anche se
con meno costanza di successi).
Alessandro Dal Lago ne ha segnalate alcune in un suo recente
libro molto esauriente nellindividuare ed argomentare il punto
cruciale della questione; e, cioè, che contrariamente allopinione
pubblica prevalente, le vere vittime dellimpatto fra i migranti
e la società italiana sono i migranti (A. Dal Lago, Non
persone. Lesclusione dei migranti in una società globale,
Feltrinelli, Milano, 1999).
Si tratta di scemenze grossomodo ben note, del tipo i veri
discriminati siamo noi italiani, gli immigrati fanno tanti
figli che sottometteranno i nostri che sono pochi, o se vogliono
venire qui devono obbedire alle nostre regole digiene e cortesia.
Scemenze che, tuttavia, riempiono gli editoriali che noti e
riveriti scienziati scrivono per i maggiori quotidiani, influenzando
con il loro prestigio lopinione pubblica.
Per esempio, facendo impressione con calcoli demografici, che,
come nota Dal Lago, partono sempre dal presupposto che gli
altri, a differenza di noi persone intelligenti, non dispongano
della possibilità di compiere una libera scelta in merito
ai propri comportamenti futuri, riproduttivi o migratori o daltro
tipo che siano.
Per fare un altro esempio, occupandosi dei reati commessi dagli
immigrati e non di quelli da loro subiti; al fine, poi, di legittimare
come scientifica la misurazione di una loro presunta propensione
a delinquere - che, ovviamente, nessuno si sognerebbe di misurare
negli italiani, nei pescatori islandesi, nei calciatori cinesi,
o nei professori universitari.
Ovviamente, è del tutto arbitrario isolare una categoria di
persone in base ad un criterio X (o due, X, Y), contare il numero
di reati che queste persone hanno commesso, e considerare il
criterio selettivo (non so, pescatore belga, o immigrato in
Italia) come la causa dei reati commessi. Sarebbe come sostenere
che i baristi sono più rispettosi delle leggi, rispetto ai giornalai,
che, invece, avrebbero una maggior propensione a delinquere,
basandosi sul fatto che, in un anno, 100.000 baristi hanno commesso
800 reati e altrettanti giornalai, invece, 1.700 (o viceversa,
naturalmente). Per cui dovremmo stare attenti quando ci rechiamo
al bar piuttosto che a comprare il giornale. Può sembrare strano,
ma, invece, proprio così ragionano, o dicono di ragionare, gli
scienziati, i sociologi in questo caso, anche se non proprio
tutti. In questo modo, con trucchi che di scientifico nulla
possono avere, ratificano e rinfocolano il razzismo dominante.
Quello stesso razzismo che i giornalisti non menzionano, o negano,
quando ci raccontano di un poliziotto o di un concittadino che
usa violenza nei confronti di qualcuno di quelli là, o di
un imprenditore italiano che sfrutta vergognosamente delle operaie
albanesi, in Albania, protetto dalla nostra benemerita forza
di pace.
Fra queste retoriche, funzionali allapplicazione freddamente
alternata del bastone (tu devi tornare a casa tua) e della carota
(ci servono operai), è particolarmente subdola quella che considera
limmigrazione come un problema etnico.
Si parla di una società multietnica come della soluzione democratica
al problema, ma in questo modo si introduce lidea di culture
chiuse le une alle altre e determinanti i comportamenti individuali,
e, ipostatizzando le differenze (a livello collettivo, sulla
base di nozioni generiche e vaghe), si scava un solco fra un
noi ed un loro. Dal Lago fa notare giustamente come tutto
ciò sia il risultato di un processo di costruzione e di etichettamento
operato dalle agenzie sociali dei Paesi ospitanti nella misura
in cui vogliono identificare, stratificare, e controllare i
migranti. Non tenendo conto che ogni persona ha una sua storia,
e che se decide di lasciare il suo Paese opera una scissione
con il patrimonio di reti di relazioni, usi e costumi da cui
proviene, per stabilire nuovi legami ed iniziare un nuovo percorso
di acculturazione nel Paese dove va a stabilirsi.
Nessun italiano si sente a suo agio nello stereotipo dellitaliano
che trova in altri Paesi, e non si vede perché le cose dovrebbero
stare diversamente nel caso di coloro che da tanti altri posti
vengono in Italia. In questa retorica permane unasimmetria,
implicita ma non per questo meno rigida, fra noi e loro,
secondo cui, al limite, la loro cucina è etnica e la nostra,
invece, no. Come ha fatto notare da tempo Silvio Ceccato (S.
Ceccato, Il linguaggio con la Tabella di Ceccatieff,
Parigi, 1951), uguaglianze e differenze sono rilevabili da parte
di un osservatore solo in merito ad operazioni mentali che egli
svolge, fissando un termine di confronto, riferendo ad esso
qualcosa daltro, e utilizzando, altresì, un criterio di confronto:
due oggetti, per esempio, possono essere considerati, secondo
le loro forme, uguali, mentre, prendendo in esame il colore,
il materiale di cui sono fatti, la grandezza, etc., possono
essere ritenuti diversi, o viceversa. E la diversità può essere
attribuita alluno nei confronti dellaltro, o viceversa. Che
tutto ciò avvenga senza che, di norma, se ne abbia alcuna consapevolezza
è evidente, ma non è un buon motivo in per evitare di occuparsene
(come si è spesso fatto in passato, e si continua a fare), equivocando
su parole come informazione e bollando esplicitamente o implicitamente
la nozione di operazione mentale come non scientifica. Rendersi
consapevoli delle attività mentali, al contrario, è il presupposto
della propria responsabilità.
 Francesco Ranci
Francesco Ranci
Il tritacarne
ovvero Sistemi repressivi in azione
Il Tritacarne è il titolo di un libro,
presentato a Terni alcune settimane fa grazie allimpegno degli
attivisti del Comitato Gli altri siamo noi. Karl Louis Guillien,
lautore, è ospite del carcere di Florence, in Arizona. Rischia
di essere condannato a morte. I fondi raccolti con la vendita
del libro dovrebbero servire a pagargli un avvocato decente.
Non si tratta, tuttavia, di un libro sulla pena di morte - anche
se la sua diffusione è parte di una campagna contro la pena
capitale - non è una denuncia contro una mostruosità lontana.
Karl Louis Guillen descrive una sistema penale e carcerario
ormai governato da meccanismi propri, interni, privi di rispondenza
con una qualche esigenza sociale o politica che non sia la sopravvivenza
del sistema repressivo stesso. Un universo kafkiano separato
che appare nella vita reale - sotto la specie di loschi figuri,
poliziotti e procuratori - solo per procacciarsi vittime. La
realtà, nel libro, appare invertita: non la forza della repressione
al servizio della legge e dellordine, ma la legge stessa ridotta
a strumento per ampliare larbitrio dei pubblici ufficiali del
sistema repressivo e giustificarne lesistenza, law and (dis)order.
Con unosservazione acuta Karl ricollega lampliarsi della sfera
di condotte penalmente rilevanti - fenomeno cui va aggiunto
linasprimento delle sanzioni penali - con lesigenza del sistema
repressivo di trovare nuove giustificazioni per investimenti
crescenti nelle forze di polizia, in prigioni, in programmi
correzionali: insomma per depredare i cittadini con una tassazione
crescente volta a mantenere unamministrazione parassitaria,
sostenuta da una propaganda di massa che diffonde il terrore
verso il crimine, visto come minaccia disgregatrice e pervasiva.
Ed ecco le varie guerre al crimine: alla cocaina, al crack,
alla cannabis, al terrorismo, alla violenza in famiglia, alla
pedofilia... Non vi ricorda niente?
Il libro ci parla di un meccanismo che si riproduce quotidianamente
sotto i nostri occhi, segno di un progressivo imbarbarimento
delle coscienze anche in Italia, imbarbarimento che coincide
con la perdita di amore per la libertà. Paure - accuratamente
eccitate dalla stampa - di fantomatici ed incontrollabili pericoli
sociali (il drogato, lemigrato, il mafioso, lo scippatore,
il pervertito sessuale) trovano un sedativo nella scoperta del
capro espiatorio rituale, una vittima sacrificale che purga
la collettività restituendole una tranquillità impossibile;
il nostro sistema penale pare stia riscoprendo questa sua funzione
primitiva.
A fronte della inutilità - oggidì manifesta - della repressione
quale strumento di controllo sociale, il magistrato si carica
di una funzione sacerdotale: colpendo ora questo ora quello
dà lillusione che tutti i mali possano essere riportati sotto
controllo, purché si affidi al buon giudice la spada adatta
da porre accanto alla bilancia. In un paese, quale lItalia,
in cui il dogma dellobbligatorietà dellazione penale ha cancellato
ogni traccia di politica criminale, la repressione del crimine
si è trasformata da laico problema politico in sacra questione,
sottratta alle discussioni dei profani, dimorante nei sacerdotali
palagi dei Giudici. Anche qui un universo parallelo, un meccanismo
autoreferenziale, un sistema di giustizia repressiva nutrita
di leggi eccezionali che, con lalibi di dover combattere draghi
feroci - pedofili, mafiosi, trafficanti - è sempre più vorace,
erode progressivamente gli spazi di libertà del cittadino, per
alimentare il clima demergenza che solo può giustificarlo.
Il Tritacarne di Guillen non è tanto lontano da noi,
se solo sappiamo guardare anche solo oltre la punta del nostro
naso.
 S. V.
S. V.
Intrisi di
ideologia
La parola è una potente signora, che con corpo
piccolissimo ed invisibilissimo, divinissime opere può compiere,
affermava nel quinto secolo avanti Cristo il grande pensatore
greco Gorgia da Lentini, sofista, scettico, retore e fine conoscitore
del linguaggio e delle sue potenzialità.
Queste argute parole, non smentite dallo scorrere dei secoli
(non passa giorno in cui non si debba constatare lormai titanica
influenza dei mass-media e della pubblicità), potrebbero bene
illustrare il punto di partenza delle riflessioni di Felice
Accame, curatore su A della rubrica A nous la libertè e acuto
linguista, i cui ultimi pensieri sono stati da poco raccolti
dalla casa editrice Odradek nellantologia Dire e Condire -
scampoli di ideologia nel linguaggio e nella comunicazione(p.
199, lire 20.000). Questi consistono in brevi racconti, aneddoti,
stralci di vita quotidiana, attraverso i quali Accame ci mostra
come la nostra esistenza sia intrisa di ideologia, che spesso
non riusciamo a controllare perchè non ne percepiamo nemmeno
lesistenza. Cento piccoli cammei - rielaborazioni di puntate
della fortunata trasmissione Caccia allideologico quotidiano
condotta con Carlo Oliva su Radio Popolare di Milano - che disvelano
il potere profondo delle parole, dei gesti e degli oggetti,
apparentemente neutri ma in realtà efficaci veicoli che condizionano
le nostre idee, i nostri comportamenti, la nostra stessa percezione
della realtà.
Il pregio maggiore di questo agile volume è il riuscire a combinare
brillantemente quotidianità ed cultura alta (semiologia, prossemica,
critica della scienza e del linguaggio, etologia umana), passando
sotto il proprio vaglio una gamma di luoghi della comunicazione
che vanno dalle vetrine dei negozi allascensore, dallo scompartimento
ferroviario al lettino dello psicoanalista, dal sesso alla storia
della filosofia e riuscendo a rendere manifesta con leggera
ed agrodolce ironia la fitta trama mistificatoria che noi stessi
tessiamo e che altri ci tessono costantemente attorno.
Accame non vuole qui scrivere un trattato compiuto di critica
dellideologia; vuole soltanto spingerci a riflettere, aiutarci
attraverso esempi concreti ad osservare sotto unangolatura
diversa parti di mondo che siamo abituati ad accettare passivamente
e a dare per scontate. Abbozza cioè una sorta di manuale pratico
di autodifesa mentale. In un mondo dove le idee sono veicolate
dalle merci e sono esse stesse prodotti da vendere ed acquistare,
il difficile esercizio del pensiero critico può permetterci
di salvaguardare i brandelli residui della nostra libertà, evitandoci
una subalternità ancora peggiore di quella economica e sociale:
lasservimento della mente.
 Paolo Chiocchetti
Paolo Chiocchetti
|

