
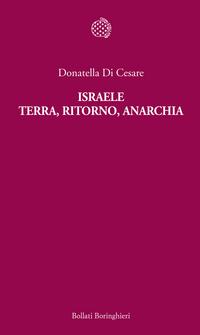 Utopie,
comunità
e vita vera Israele: storia di una contraddizione
Cosa possono avere in comune Israele e il sionismo, da una parte,
l'anarchia con la sua “esagerata idea di libertà”,
dall'altra, e una radicale richiesta di pace in un mondo sempre
più in guerra? Il recente saggio di Donatella Di Cesare
(Israele. Terra, ritorno, anarchia, Bollati Boringhieri,
Torino 2014) riannoda in modo originale i fili a cui questi
temi rimandano. Se sfogliamo l'indice notiamo che il libro,
a sua volta, si articola in tre momenti: il primo ripercorre
le dinamiche interne al movimento sionista, lungo le tappe significative
della sua storia; nel secondo vediamo emergere i motivi di una
originale sensibilità libertaria all'interno del pensiero
ebraico moderno; l'ultimo propone una riflessione, quanto mai
partecipata, sull'attualità della nozione di pace/shalom.
Vediamoli più da vicino.
Che cosa si debba intendere per sionismo è oggi un buon
esercizio didattico, anche presso il popolo di sinistra che
spesso si dichiara, apertis verbis, antisionista senza
sapere bene cosa significa tale espressione. Potremmo dire che
il sionismo sta ad Israele, grosso modo, come il risorgimento
sta all'Italia. Ma il paragone appare insufficiente. Nelle sue
linee generali questa corrente è nata con l'obiettivo
di edificare uno stato-nazione per il disperso e perseguitato
popolo ebraico. Il testo mostra bene come si sia verificato
uno slittamento, in primo luogo semantico, che partendo da Sion
– nome che indica una collina di Gerusalemme e, per estensione,
Gerusalemme stessa – giunge alla nozione, tutta politica,
di ricondurre il popolo ebraico all'idea di nazione e infine
– poiché, in omaggio alla modernità, non
si dà nazione senza stato – alla prospettiva di
un ordinamento statuale, con tanto di ordinamento giuridico,
confini territoriali su cui esercitare il monopolio della violenza
e così via. Tali slittamenti progressivi – pur
partendo da antecedenti storici molto antichi, risalibili al
profondo legame che unisce il popolo mosaico alla terra promessa
– giungono all'idea di uno stato-nazione, rischiando di
perdere lungo il cammino l'afflato originario, suscitando alla
fine perplessità all'interno dello stesso ebraismo. Tutto
ciò nel libro lo vediamo condensato nel “grande
interrogativo”, esplicitato da Joseph Roth, se gli ebrei
non fossero “qualcosa di più che una ‘nazione'”
descrivibile secondo parametri giuridico-politici.
Il sionismo, quindi, è stato un movimento tutt'altro
che granitico; al suo interno, ad esempio, operava la corrente
del sionismo culturale a cui aderiva anche Martin Buber, il
quale reputava riduttivo riportare il concetto di Sion all'idea
di stato-nazione. Buber, lo sappiamo, si farà portavoce
della costruzione non di uno stato israeliano, ma di una “comunità
di comunità” che alla fine avrebbe vanificato ogni
nozione di potere statuale (ricordiamo che Di Cesare ha anche
curato la più recente edizione italiana di Sentieri
in utopia di Buber: cfr. “A” 351, marzo 2010).
Proprio oggi, mentre stiamo assistendo, per opera del capitale
globale, al declino inesorabile degli stati-nazione (di cui
si può ben affermare ciò che fino a ieri si diceva
dei monarchi costituzionali: regnano ma non governano), la prospettiva
buberiana appare meno fantasiosa di quanto i critici un tempo
le imputavano. Assai meno fantasiosa di chi propugnava “l'evoluzione
del socialismo dall'utopia alla scienza”, del “socialismo
in un solo paese”, o di chi si ostinava – e si ostina
tuttora – a parlare di un'“autonomia del politico”,
di una classe sfruttata che decide di farsi stato (mentre, ahimè,
la stessa forma-stato si va disfacendo di fronte ai poteri sovranazionali
e il politico diviene una categoria ancillare rispetto al capitale
finanziario).
Teocrazia anarchica
Soprattutto a Buber, e al suo amico e mentore Gustav Landauer,
è infatti dedicato il capitolo centrale, su “comunità
anarchica e potere planetario”. Con Buber la comunità
prende definitivamente congedo dallo stato. Comunità
dialogica, fondata sulla relazione io-tu, senza potere, dunque
costitutivamente an-archica. E anarchica anche perché
profondamente religiosa, “perché non esiste
sfera politica all'infuori di quella teopolitica”.
Ma qui, sia chiaro, siamo agli antipodi di Schmitt e della sua
teologia politica, quando questi dichiara di aver trasferito
il modello teologico cristiano al campo del diritto: il sovrano
altro non sarebbe che una secolarizzazione del Dio biblico.
Così come Dio crea il mondo ex nihilo, il sovrano
crea dal nulla l'ordine giuridico (il “Dio onnipotente
che è divenuto l'onnipotente legislatore”). Israele,
dirà invece Buber, dovrà essere una teocrazia
anarchica. Teo-crazia diretta, per nulla metaforica: il potere,
la terra e tutto il resto sono di Dio e non degli uomini. Nessuno
si può dichiarare re, sovrano o capo di qualcosa. Teo-crazia
contro iero-crazia, vale a dire contro il potere divenuto monopolio
di una casta sacerdotale che pretende di rappresentare la volontà
divina.
 L'ultima
parte del volume è invece una riflessione, per nulla
scontata, sul desiderio di pace in un mondo in guerra. È
possibile, si chiede l'autrice, una pace non fondata sulla guerra
e sugli eserciti, una pace fondata su sé stessa e non
sul terrore e sulla minaccia? Partendo dal riconoscimento della
letale relazione sempre esistita fra filosofia e guerra –
da Eraclito (“la guerra è padre di tutte le cose”)
fino ai moderni – Di Cesare giunge ad affermare, con Lévinas,
che “della pace si può avere solo un'escatologia”,
poiché la vera pace si situa non dopo, bensì prima,
oltre e al di là di ogni logica di guerra. È la
pace anarchica, non deducibile dalla guerra, non il risultato
di calcoli o di compromessi; al contrario, è l'istante
di una trasformazione completa, senza mediazioni, la cifra dell'avvento
improvviso di un mondo assolutamente altro. L'ultima
parte del volume è invece una riflessione, per nulla
scontata, sul desiderio di pace in un mondo in guerra. È
possibile, si chiede l'autrice, una pace non fondata sulla guerra
e sugli eserciti, una pace fondata su sé stessa e non
sul terrore e sulla minaccia? Partendo dal riconoscimento della
letale relazione sempre esistita fra filosofia e guerra –
da Eraclito (“la guerra è padre di tutte le cose”)
fino ai moderni – Di Cesare giunge ad affermare, con Lévinas,
che “della pace si può avere solo un'escatologia”,
poiché la vera pace si situa non dopo, bensì prima,
oltre e al di là di ogni logica di guerra. È la
pace anarchica, non deducibile dalla guerra, non il risultato
di calcoli o di compromessi; al contrario, è l'istante
di una trasformazione completa, senza mediazioni, la cifra dell'avvento
improvviso di un mondo assolutamente altro.
Vita vera e vita falsa
Alcuni dei temi trattati da Donatella Di Cesare possono rinviare
a un piccolo libro di Judith Butler apparso la primavera scorsa
(A chi spetta una buona vita?, Nottetempo, Roma 2013).
Quali vite sono degne d'essere vissute e a chi spetta una buona
vita, si domanda Butler? E, ribaltando la questione: quali morti
meritano d'essere pianti e compianti, meritevoli di lutto? E
ancora: “come condurre una vita buona in una vita cattiva?”.
L'autrice si è posta questi interrogativi, fornendo alcune
sollecitazioni, in occasione del conferimento del Premio Adorno
(le sue domande provengono proprio da una frase dei Minima
Moralia: “Non si dà vera vita nella falsa”),
ricevuto nel 2012 a Francoforte e preceduto da accese polemiche
per l'impegno della filosofa americana contro l'occupazione
israeliana della Palestina.
L'autrice esemplifica il suo discorso citando le condizioni
di chi vive in stato di guerra o in situazione di occupazione;
di chi è recluso, in attesa di processo; dei precari,
dei migranti, dei clandestini e dei profughi delle società
postindustriali, vittime di un sistema che consolida, amplifica
e amministra la disuguaglianza e la violenza, “forme diverse
di morte sociale”. Implicito è il richiamo alla
questione palestinese. La domanda sollevata da Adorno viene
da Butler rovesciata e articolata sul piano biopolitico (luogo
reale del conflitto contemporaneo), su quell'insieme di procedure,
tecniche e logiche di governo della vita umana: “Se la
resistenza equivale a mettere in atto i principi di democrazia
per cui combatte, allora dev'essere plurale e incarnata
nei corpi”.
Di Cesare nel suo saggio menziona Butler, pur non condividendo
sempre le sue opinioni, come una filosofa che contribuisce a
sviluppare una discussione, “né apologetica, né
scontata”, su Israele. E, infatti, il secondo testo presente
nel libriccino di Butler è dedicato proprio alla questione
palestinese, in cui motiva le ragioni per cui un'ebrea (americana)
come lei, regolarmente iscritta alla sinagoga, può dichiararsi,
senza rinnegare la propria origine, contraria alla violenza
dello stato israeliano e schierarsi in difesa del popolo palestinese.
Federico Battistutta
 Gli
oppositori?
In manicomio“Per tenere a mente Carol Lobravico e Francesco Mastrogiovanni
persone libere”. A queste due vittime delle violenze della
psichiatria Marco Rossi dedica il suo ultimo libro Capaci
di intendere e volere. La detenzione in manicomio degli
oppositori al fascismo (edizioni Zero in Condotta, Milano
2013, pp. 96, Ä 10,00).
Del tema “psichiatria e fascismo” si sono occupati,
negli anni, autorevoli scrittori, ricercatori, giornalisti che
hanno analizzato sopratutto le relazioni intercorse fra le politiche
razziste, eugenetiche e biopolitiche, messe in atto dal regime.
In gran parte delle opere pubblicate fino a oggi si riscontra
una minimizzazione del ruolo e della funzione nefasta che il
manicomio e altre strutture sanitarie, ritenute civili, hanno
svolto nella repressione del dissenso politico e sociale in
Italia.
Marco Rossi, al contrario, ci fornisce, in questo rigoroso quanto
meticoloso lavoro sugli archivi, i dati documentali e gli elementi
necessari per una nuova riflessione sulla reale portata, non
solo in termini statistici, della segregazione manicomiale degli
oppositori politici nel ventennio fascista. L'autore ha analizzato
i fascicoli del Casellario politico centrale di circa un centinaio
di antifascisti, di alcuni “senza partito” e di
“donne degeneri” e ha raccolto le tracce di vita
di alcuni internati raggruppandole in “categorie”
politiche: anarchici, comunisti, socialisti, repubblicani ecc.
Nella prefazione al libro, Luigi Balsamini sottolinea la necessità,
da parte di tutti i poteri, di utilizzare la psichiatria là
dove la detenzione comune non riesce a raggiungere il risultato
sperato. La nota espressione di Lombroso: “I martiri sono
venerati, dei matti si ride: ed un uomo ridicolo non è
mai pericoloso”, ripresa da Balsamini, racchiude in sé
il folle progetto che, purtroppo, è stato applicato a
ovest come a est, di screditare le opposizioni politiche esibendole
come devianti, irrazionali e quindi folli.
La conferma che la psichiatrizzazione di individui scomodi viene
ancora oggi utilizzata associando ad essa comportamenti ritenuti
violenti, la ritroviamo, a distanza di quasi settanta anni dalla
Liberazione, nelle testimonianze degli operatori sanitari e
di coloro che intervennero sulla spiaggia del villaggio turistico,
dove Franco Mastrogiovanni trascorreva le ferie, per la nota
mega-operazione di cattura in stile hollywoodiano.
Libri come questo servono, come si legge nella dedica, per “tenere
a mente”, per non dimenticare. E allora è il caso
di ricordare che, dopo l'ultima ascesa del governo Berlusconi,
in poco meno di un anno, sono stati presentati ben cinque disegni
di legge per la modifica della legge 180 del 13 maggio 1978,
meglio conosciuta come legge Basaglia. Il più preoccupante
è quello che porta la firma dello psichiatra e parlamentare
Carlo Ciccioli (Pdl), ex-dirigente del Msi-Dn, che parla del
contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle
cure che ben si configura con la denominazione di “contratto
di Ulisse”. Come vediamo c'è ancora chi sogna,
nel terzo millennio, l'internamento a vita per motivi psichiatrici
e la trasformazione di strutture sanitarie in carceri a gestione
privatistica.
La speciale qualità di questo lavoro sta proprio nella
sua capacità di stimolare il lettore alla riflessione
sul passato, sul presente e a prepararci a non avere paura per
il futuro, ma a essere consapevoli e a vigilare affinché
tutto ciò non accada. Consiglio vivamente la lettura
di questo libro con la speranza che in tanti lettori induca,
come è avvenuto in me, una partecipazione emotiva straordinaria
e un rinnovato impegno politico.
Angelo Pagliaro
angelopagliaro@hotmail.com
Un rendez vous catalano
tra amore e anarchia
Joan Isaac è senza dubbio una delle voci più
intense della canzone d'autore catalana. In Italia lo si è
conosciuto piuttosto recentemente, verso la fine degli anni
novanta, per le sue partecipazioni al Premio Tenco e per l'amicizia
che lo lega a Sergio Secondiano Sacchi. Ma il primo singolo
di Joan Isaac, Rèquiem, è del 1973. E quasi
fosse per festeggiare i quarant'anni di carriera di Joan Isaac
è stata pubblicata questa ben documentata biografia (Joan
Isaac. Bandera negra al cor, prologo di Joan Manuel Serrat,
Editorial Milenio, Lleida 2013, pp. 256, € 21,00), opera
del poeta e scrittore gaditano Luis García Gil, che già
si era dedicato a raccontare le vite di altri referenti della
canzone d'autore spagnola e internazionale come Joan Manuel
Serrat, Javier Ruibal, Atahualpa Yupanqui e Jacques Brel.
 |
| Barcellona, febbraio 2013. Festival Cose di Amilcare.
Joan Isaac durante il concerto di Eugenio Finardi |
Grazie a una ricerca appassionata ed appassionante, García
Gil ricostruisce la vita e la traiettoria artistica di Joan
Vilaplana i Comín, in arte Joan Isaac, dagli anni dell'infanzia
a Esplugues, poco fuori Barcellona, fino al suo ultimo disco,
Piano, piano, uscito nel 2012. E nel mezzo, oltre ad
un'utilissima appendice con la discografia completa e con fotografie
provenienti dall'archivio privato di Joan Isaac, c'è
tutta la poesia, le emozioni, le lotte, i sogni, le delusioni,
l'impegno di un cantautore controcorrente che García
Gil definisce come un epigono della Nova Canço catalana.
Secondo lo scrittore gaditano, per capire Joan Isaac è
imprescindibile difatti conoscere quella straordinaria esperienza
che rivoluzionò la canzone e la cultura catalana e i
suoi compagni di viaggio. Artisti come Maria del Mar Bonet,
Quico Pi de la Serra e Lluis Llach, tra gli altri. E anche una
figura imprescindibile per quanto molto criticata dai puristi
negli anni Settanta: Joan Manuel Serrat.
Ma, come spiega García Gil, per contestualizzare la raffinata
poesia di Joan Isaac e la sua scelta di scrivere e cantare in
catalano bisogna ritornare agli ultimi anni della dittatura
franchista e alla lenta transizione alla democrazia. È
in tutto questo che nasce una canzone che rimane ancora oggi
un simbolo, A Margalida, dedicata alla compagna di Salvador
Puig Antich, l'ultima persona ad essere giustiziata dal regime
franchista con la barbara tecnica della garrota nel marzo del
1974. E proprio questo 2 di marzo, per ricordare Puig Antich
ai quarant'anni esatti dal suo assassinio, Joan Isaac dedica
uno spettacolo, organizzato insieme agli amici di Cose di Amilcare
e del BarnaSants, intitolato non a caso Cançons d'amor
i d'anarquia. Uno spettacolo che approderà anche
a Sanremo il prossimo 3 maggio.
È questa capacità di unire amore e anarchia, ci
spiega García Gil, la chiave per capire la poesia che
si fa canzone di Joan Isaac, sia nel primo intenso decennio,
segnato da dischi pregevoli come És tard (1975),
Viure (1977) e Barcelona, ciutat gris (1980),
sia negli ultimi quindici anni – dopo una lunga pausa
tra il 1985 e il 1998 in cui il cantautore di Esplugues si è
ritirato dalle scene e si è dedicato alla professione
di farmacista – con dischi superbi come Joies robades
(2002), Duets (2007) e Auteclàssic. Joan Isaac
& Luis Eduardo Aute (2009). Dischi dove un Joan Isaac
maturo intervalla con garbo ed esperienza nuove canzoni con
versioni in catalano di classici in altre lingue, tra cui è
doveroso ricordare lo spagnolo Aute e i nostri Roberto Vecchioni
e Paolo Conte.
Un rendez vous, quello tra amore e anarchia ed un legame,
quello con la cultura e la canzone italiana, che continuerà
anche nei prossimi anni come il nuovo disco che uscirà
a breve, Vuit joies italianes i altres maravelles, con
versioni in catalano di Capossela, Dalla, Battiato, Giorgio
Conte e De Gregori, tra gli altri, fa presagire.
Un bel libro, insomma, questo di García Gil, la cui lettura
è consigliata a chi si vuole avvicinare alla canzone
d'autore catalana e, più concretamente, alla poesia/canzone
di Joan Isaac.
Steven Forti
Documentari/
(r)esistenze cilene
“C'è la terra, ma non c'è
l'acqua. Cosa può fare una persona in quel posto, senza
acqua? Serve l'acqua per lavorare (...) Come si fa a non sentirsi
male per tutto questo?
Voi non vi sentite male?”
Berta, donna mapuche.
Già da diversi anni capita di sentire la sentenza: “Le
guerre del futuro verranno combattute per l'acqua”. Se
fino a tempi relativamente recenti una guerra per l'acqua sarebbe
sembrata tanto assurda quanto una guerra per l'aria (in stile
Spaceballs), oggi a ben vedere ci si può accorgere
che quelle assurde guerre sono già iniziate.
Il caso della Patagonia cilena non è l'unico, ma forse
il più eclatante. A combattere questa guerra non ci sono
due eserciti contrapposti ma multinazionali da una parte, e
villaggi, comitati, semplici cittadini dall'altra. Lo Stato
cileno, nelle vesti di politici corrotti e carabineros,
fa da arbitro cercando di rendere ancora più impari il
conflitto, difendendo con la legge l'arroganza delle multinazionali
e reprimendo con la violenza la triste rabbia del popolo.
Con il documentario Lucciole per lanterne (Italia 2013,
42 minuti), Stefano e Mario Martone raccontano con poetica lucidità
questa “guerra” che si sta combattendo in Cile,
in cui anche l'Italia (purtroppo) gioca un suo ruolo. Infatti
è la “nostra” Enel (società al 33%
di partecipazione pubblica) a controllare il gruppo Endesa Chile,
responsabile del progetto HydroAysén. Un folle progetto
che prevede la costruzione di ben cinque mega-dighe nella Patagonia
cilena, per produrre energia elettrica, portarla nelle zone
industriali di Santiago, e venderla. Tutto ciò per il
solo scopo di ricavarne profitto.
A far da sfondo al documentario vi è anche il “nostro”
Pier Paolo Pasolini, non solo per la citazione iniziale (“Io,
ancorché multinazionale, darei l'intera Montedison per
una lucciola”), ma soprattutto per la fondamentale distinzione
tra sviluppo e progresso fatta da Pasolini. Perché, come
suggerisce il finale del documentario, la soluzione per sconfiggere
un assurdo modello di sviluppo non arriverà dai meeting
sullo sviluppo sostenibile che si tengono tra i grattacieli
delle megalopoli contemporanee, ma potrà arrivare soltanto
dalle persone che combattono ogni giorno per “proteggere
le foreste, le montagne, i fiumi; perché sanno che le
foreste, le montagne e i fiumi proteggono loro”.
Giustamente uno spazio importante del documentario viene riservato
ai volti dei mapuche, il popolo originario della Patagonia,
“custodi del nostro passato” ma anche “guide
per il nostro futuro”, perché non ci sarà
mai né acqua né energia a sufficienza finché
il mondo non si guadagnerà un nuovo “spazio filosofico”
che contenga idee di progresso, e non di sviluppo.
Un documentario girato dall'altra parte del mondo ma che ci
tocca personalmente, non solo per il coinvolgimento di Enel,
non solo perché di privatizzazioni se ne parla molto
anche da noi, ma soprattutto perché se queste “guerre”
non ci toccano gli scontri saranno sempre più impari.
Il senso di tristezza che trasmette il documentario è
lo stesso senso di tristezza che sente il nostro pianeta difronte
a questi dolorosi e inumani mega-progetti; ma questo senso di
tristezza è anche un buon punto di ritrovo da cui possiamo
muoverci tutti insieme per costruire non più delle dighe
ma uno “spazio filosofico” che contenga una nuova
“idea di felicità e di appagamento”. Questo
non sarà possibile senza riconoscere l'importanza delle
moltitudini di piccoli “spazi fisici” che vengono
costruiti ogni giorno dalle persone che sanno di non potere
(e non volere) vivere senza l'acqua limpida dei loro fiumi.
Michele Salsi
 Dalle
Ande
agli AppenniniPasaporte n° 00031, Milan 2 de mayo de 1978. Firma del
titular: Vicente Taquias V. È questo il passaporto
cileno, con la “elle” della malasorte stampata sopra,
di Vicente Taquias Vargas, Urbano per i compagni. Un passaporto
marchiato, per sovversivi indesiderati. Segno distintivo della
strategia dell'Operazione Condor per l'individuazione, cattura,
eliminazione degli oppositori di Pinochet all'estero. Nella
lettera “L” tracciata con il pennarello rosso, il
destino già segnato di molti desaparecidos.
L'autore Alessandro Alessandria, nel suo contributo (Dal
Cile all'Italia. Cinquant'anni di militanza internazionalista,
Sensibili alle foglie, 2013, pp. 304, euro 18,00), ricostruisce
la vicenda personale, intensa, umana e politica di Urbano, ma
anche quella collettiva e sofferta del popolo cileno. Attraverso
documenti e fonti orali offre l'opportunità di accostarsi
alla storia non solo del Cile. Una storia che ci riguarda, divulgata
da un'appassionata prospettiva non ufficiale.
Urbano, cileno di Santiago, classe 1945. Uno tra le migliaia
di esuli ancora oggi sparsi per il mondo, arriva in Italia dopo
il golpe dell'11 settembre 1973. Il padre calzolaio e anarchico.
Fondatore e dirigente di un'organizzazione sindacale dei lavoratori
del legno, durante la dittatura di Videla verrà iscritto
nell'elenco nero e perderà il lavoro in fabbrica. “Mio
padre si portava dietro, con sé, due scatoloni enormi,
due bauli che erano pieni di libri. Pieni di libri! Libri sociali,
No?” La morte del padre, avvenuta nel '79, segnerà
per Urbano la perdita di un importante punto di riferimento,
ideale e affettivo.
La madre un'attivista contro la “falange” fascista,
militante, rivoluzionaria. Agli inizi degli anni Cinquanta,
andranno a vivere in un'immensa baraccopoli di “mattoni
fatti da noi con la paglia”, la Legua Nueva, un
affollato quartiere operaio, di famiglie numerose e di confinati.
Tutti si portavano dietro storie di militanza. Prenderà
presto forma un vivace laboratorio di politica dal basso, vitale
per la sua formazione che influenzerà l'agire nelle battaglie
future, anche quelle lontano dal Cile. Lì c'erano i suoi
veri maestri, i saggi del quartiere, “quelli che riuscivano
a spiegarti le cose”.
In casa aiuta il padre a lavorare su commissione, insieme agli
altri fratelli, nove vivi. Dopo la scuola, tutti intorno a un
banco a fare le scarpe, ascoltare l'unica vecchia radio che
informava sui fatti del Cile, e le riunioni clandestine dei
dirigenti e militanti sindacali. Così fin “da piccoli
abbiamo dovuto cercare di capire e spiare agli angoli delle
strade che non arrivasse la polizia”. Ma senza mezzi non
era possibile studiare. Urbano si ferma alla quarta elementare.
Solo anni dopo, in Italia conseguirà la maturità
artistica.
A dodici anni in fabbrica, presto diventa un dirigente del sindacato
di base dei lavoratori del cuoio fondato dal padre. Conoscerà
il valore della solidarietà nel sostegno alle lotte dei
baraccati: “A volte perdevi lo sciopero perché
ti prendevano per fame”. Suscita tenerezza la determinazione
di quel ragazzetto smilzo di forse quindici anni già
impegnato nella lotta per l'occupazione della terra: “L'avevamo
disegnato nella nostra mente, sui fogli e quando si riusciva
a rimanere, e di solito ci riuscivamo a rimanere, si tracciava
il terreno dove si sarebbero fatte le scuole, l'ospedale, il
campo sportivo (...) sono nati così i quartieri a Santiago”.
Seguiranno altre lotte per l'elettricità, l'occupazione
delle corriere per aumentare il numero delle fermate, allungare
il percorso di due o tre chilometri, e poter andare a lavorare.
In seguito al golpe, Urbano racconta l'arresto a causa della
sua militanza politica e l'internamento nello stadio nazionale
insieme a migliaia di persone. Quindici giorni di bastonate,
torture con scosse trasmesse da fili elettrici. Rilasciato,
se ne guarderà bene dal passare a mettere la sua firma
presso una caserma di polizia. Scampa così alla deportazione
in campi di concentramento. I carabineros invece spareranno
al fratello, freddandolo mentre aspettava l'autobus.
Vicende temerarie lo catapultano dall'altra parte del mondo.
Approdato in Italia con due figlie e la moglie ancora in attesa,
la meta dell'esilio sarà Massa Carrara. La mitica Carrara
dei racconti del padre e dei compagni più anziani. La
Carrara anarchica, antifascista e poi partigiana. Per tutti
sarà Urbano, fedele al nome di battaglia in Cile. Espressione
di intima volontà di militanza futura, anche in terra
straniera. Ai piedi delle Apuane, che forse sentiva un po' come
un prolungamento della sua terra, trova un terreno fertile per
continuare la sua vocazione. Per i cani sciolti come Urbano,
esuli dissidenti e sospettati non sarà facile ottenere
l'asilo politico e il diritto a un libretto di lavoro.
Prima occupazione: addetto alle pulizie in un campeggio. Il
proprietario è un ex comandante partigiano della Garibaldi.
Inizia ad appassionarsi alla Resistenza italiana e alla situazione
politica. Poi un lavoro nel cantiere navale “Apuania”.
Diventa un saldatore specializzato. Dopo il fallimento degli
scioperi di Mirafiori, quando decide di licenziarsi dirà:
“Potevo andare dove volevo.(...) non dovevo chiedere un
posto di lavoro né a partiti, né a sindacati o
al collocamento. Il mestiere me lo ero creato così come
avevo fatto in Cile, osservando e praticando”.
Nel '76 darà vita al Comitato dei lavoratori cileni
in esilio. L'attività di sostegno alla peculiare
resistenza popolare cilena viene ribadita insieme ai principi
internazionalisti di autonomia politica, per un'autentica democrazia
popolare. Autogestione, azione diretta, controllo dal basso,
auto-conquista delle condizioni minime di esistenza. Solo così
“si può dare al termine libertario tutta la ricchezza
dei suoi significati; con la resistenza popolare in Cile cresce
anche un modo nuovo di essere libertari”. Sarà
il contributo che Urbano trasferirà pure nell'esilio.
Non si riesce a pensare Urbano disgiunto dalla passione per
la lotta politica e l'azione. Il libertario audace, l'interventista
energico, quando nel 1988 una nube tossica fuoriesce dallo stabilimento
della Montedison, accorre impavido e insieme ai suoi compagni
dà l'avvio alla mobilitazione di cavatori, operai dei
cantieri navali e tanti giovani: “C'era troppa gente per
una città così piccola come Massa”. Per
quarantacinque giorni, Comune, ferrovie e il palazzo dell'Associazione
degli industriali verranno occupati. Appoggerà altresì
la popolazione della Valle Bormida contro l'inquinamento chimico
dell'Acna di Cengio.
Mai sopito, il legame viscerale con la sua terra e la sua gente
si intensifica intorno alla metà degli anni Ottanta,
quando il Comitato ristabilisce i contatti con i barrios,
i quartieri popolari di Santiago: “Non era ammissibile
che mentre in Cile si stava massacrando il popolo, noi non facessimo
nulla”. Chi ha conosciuto Urbano lo ricorda girare per
la Toscana a denunciare la violenza e la repressione del regime
di Pinochet e raccogliere aiuti a favore del popolo cileno.
Non mancheranno fondi per comprare macchine da cucire per le
donne. È noto l'appoggio al Comitato da parte
delle cooperative dei lavoratori portuali di Carrara, in nome
della solidarietà al popolo cileno che faticava a racimolare
cibo o altri prodotti da scambiare. Sequestrate nel porto, per
due mesi, tre navi con bandiera cilena cariche di derrate alimentari.
Le lotte di Urbano per il popolo cileno si intersecano, solidarizzano
e puntano i riflettori su un'Italia che non conosce ancora la
cultura dell'accoglienza. Alla fine degli anni Ottanta, l'internazionalista
combattivo affianca gli immigrati nelle loro battaglie. Sarà
il primo a portarli in piazza, ad Alessandria, in una manifestazione
per soli stranieri. Il saggio maestro cileno entra in conflitto
con l'ambiente sindacale: “Noi non è che facessimo
assistenza agli immigrati. Noi gli insegnavamo come dovevano
fare per acquisire i propri diritti senza andare dal funzionario
dell'assistenza del sindacato o del volontariato, ma imparare
da soli. Come avevamo insegnato agli operai in Cile, no? Usavamo
la stessa pratica, la stessa politica”.
Lucida l'analisi sull'impossibilità per il volontariato
di risolvere i problemi, ne rallenterebbe addirittura la presa
di coscienza: “Se hai fame, ti va bene che qualcuno ti
dia un piatto di minestra, ma la soluzione di tutti i problemi
non sta né nella coperta né nella minestra, perché
domani avrai ancora freddo e ancora fame (...) perché
la propria liberazione non può essere delegata a nessuno
e nessuno che non sia protagonista della propria liberazione
riuscirà a diventare effettivamente libero”. Sostegno
e solidarietà anche ai profughi della ex Jugoslavia e
alle minoranze etniche e sociali oggetto di atteggiamenti razzistici
e discriminatori, come la comunità rom accampata lungo
il Lavello vicino a una discarica abusiva inquinata dagli scarichi
della Montedison.
Urbano è il primo cileno a presentare presso un tribunale
italiano una denuncia contro l'ex generale Pinochet Augusto
Ugarte, per i reati di omicidio, tortura, lesioni gravissime,
sequestro di persona. La risposta: minacce di morte. Sarà
un brindisi amaro, quando alla morte dell'ex dittatore, Urbano
stapperà la bottiglia regalatagli dal fratello e rimasta
più di vent'anni nel sottoscala. Un'euforia spezzata
perché Pinochet non essendo mai stato processato morirà
da innocente. Urbano porterà avanti anche una battaglia
personale per far valere il suo legale diritto alla cittadinanza.
Pur avendone i requisiti, gli viene negata per motivi ostativi
fondati su calunnie, insinuazioni in un clima di caccia all'anarchico
pericoloso, sospettato di aver avuto contatti con “individui
seguaci della lotta armata”. Perquisito nella sua abitazione
durante la sua assenza per cercare documentazione ritenuta sospetta.
Intimidazioni per aver appoggiato le battaglie ambientaliste.
Accusato da certa stampa di fomentare riunioni di anarchici
insurrezionalisti in occasione del primo anniversario del G8
a Genova. Invece l'incontro incriminato serviva per raccogliere
fondi per il giornale anarchico “Umanità Nova”.
Diventa un caso politico e giuridico nazionale. La rivista “A”,
che anche in passato aveva dedicato spazio alle vicende di Urbano,
ne parlerà a più riprese. Se ne occuperà
pure la stampa moderata con articoli polemici contro le istituzioni.
Essere anarchico può precludere il diritto alla cittadinanza.
L'anarchico cileno la otterrà solo nel 2007.
Urbano ha maturato una disposizione naturale all'immedesimazione
umana di chi condivide la sorte di essere uno straniero del
sud del mondo. Oggi, il militante internazionalista insieme
alla sorella Ana, esiliata da anni a Londra, sostiene il progetto
Ecomemoria, un albero per ogni desaparecido o assassinato
dalla dittatura di Pinochet. Memoria storica ed ecologica anche
in appoggio solidale alla resistenza dei mapuche, nativi americani
che difendono la loro terra sacra dall'ecocidio e dagli espropri
delle multinazionali. Confesserà in un'intervista: “Il
Cile è il luogo della mia giovinezza, della lotta della
prima parte della mia vita. Oggi, dopo 28 anni di vita da esiliato,
il mio terreno di lotta, da anarchico e internazionalista è
qui dove vivo, dove la 'democrazia reale' non si mostra meno
dura verso chi le si oppone, cercando di costruire una società
libera e solidale”.
Claudia Piccinelli |

