|
 Un'idea
chiamata America Un'idea
chiamata America
Bene: si parla dAmerica anche in questo spazio.
Non dellAmerica morta ammazzata al World Trade Centre che
adesso censura dallo spazio radio Imagine, Bob Dylan,
i REM e i Rage Against The Machine e cento altri musicisti
e canzoni colpevoli di essere improvvisamente inadatte allumor
nero dei radioascoltatori in lutto.
Non dellAmerika con la k macchina da guerra dei Poliziotti
del Mondo, non dellAmeriKKKa razzista in fuga da Durban né
degli U$A scritti così, col simbolo del dollaro ad
esplicitare la connessione fondamentale e maligna della politica
col denaro.
America è unidea che ci siamo fatti e che così
abbiamo chiamato; mi spiego meglio: di unimmagine di certa
America che ci siamo fatti noi (e intendo col plurale e col
noi la fetta sociale dei nati nei tardi anni Cinquanta a
cui appartengo, temendo di non essere poi così distante
da altre generazioni e da altri luoghi colonizzati) vedendola
in tv e sognandola al cinema, ascoltandola dentro ai dischi,
leggendola attraverso romanzi, lettere, giornali e poesie.
Insomma immaginandola da qui, a distanza di sicurezza,
dalla provincia inconsapevole e distante dalle torri di controllo
del commercio mondiale, lontano dalla stanza dei bottoni e
dalla prima linea.
Se per gli albanesi lAmerica è (era, meglio) una skyline
che ricalca la curva delle tette delle vallette di Canale
5, io nel mio piccolo ho chiamato America uno stato della
mente, una specie di fiaba per bambini cresciuti, o un sogno
ad occhi aperti: una cosa che abbiamo fatto in molti, illusi
superficiali ipnotizzati dalla pubblicità subliminale
peace and love (a cui soltanto dopo i Crass nelle scritte
sulle magliette e sui giubbotti abbiamo aggiunto anarchy,
parola che in cuor nostro era già scritta col pennarello
nero grosso così e indelebile) a stelle-e-strisce cacciata
dentro a mille e mille dischi, libri e film.
Il discorso viene da lontano, una strada lunga più
di trentanni almeno per quanto mi riguarda.
Forse è nato tutto da un seme piantato in testa quando
alle superiori qualcuno - uno dei tanti supplenti di italiano
del primo anno - mi ha cacciato in mano un ciclostilato di
Howl di Allen Ginsberg e guardandomi fisso negli
occhi mi ha detto di leggerlo con attenzione, ci avrei trovato
dentro delle meraviglie, diceva, e aveva ragione. Oppure è
stato quando ho ascoltato con gli occhi fuori della testa
a boccaperta per la prima volta su un vero impianto stereo
Frank Zappa e le sue Mothers of Invention a casa di
un compagno di scuola di famiglia benestante ma ripetente
e contestatore (lalbum era Burnt weeny sandwich, lui credo
sia diventato il direttore di una catena di supermercati),
o mi guardavo Easy rider o Woodstock al cineforum... e
io sto benedetto seme lo innaffiavo di sospiri e lo concimavo
con tonnellate di semplice genuino triste povero desiderio.
Sarei riuscito a coronare il mio sogno a stelle e strisce
soltanto anni dopo: ho incontrato Allen Ginsberg al Festival
Internazionale dei Poeti a Roma – e anche William Burroughs,
John Giorno, Anne Waldmann, Michael McClure e Gregory Corso...
- senza riuscire a smettere di tremare né a districare
il groppo che mi serrava inesorabilmente la gola, nel 1983
ho attraversato lAtlantico per trascorrere tre settimane
anfetaminiche a NYC senza scrollarmi di dosso il jet lag,
mentre per riuscire a comprare una vera moto avrei dovuto
aspettare i trentanni.
E non è finita: sono un arrivato, gente. Una Fender
lho presa coi risparmi solo due anni fa – non è
tardi, non sono ancora morto – ma più che suonarla,
non ho mai un po di tempo per me, quando sono solo in casa
mi consolo a spolverarla.
Tanti tra noi sfigati teenagers di provincia, cresciuti –
me compreso – a pane comune e marmellata dura e formaggini
in offerta speciale negli ultimi ritagli di campagna veneta
ancora da devastare col cemento e lasfalto, avremmo dato
chissà cosa per poter scambiare – anche solo per
un giro, solo per poco, il tempo di una canzone – il
chopper dentro lo schermo con la vecchia bicicletta ereditata
dal fratello/cugino maggiore, una vera Fender Stratocaster
con la nostra timida Eko corde strausate e con lammaccatura
coperta alla belle meglio con un adesivo del CND staccato
chissà da dove.
Ecco un punto da ponderare: volevamo il chopper ma non avremmo
saputo guidarlo sulle nostre strade (troppo corte, e con troppi
fossi, troppi platani e troppe curve). Volevamo la Fender
e non saremmo assolutamente stati capaci di urlare linno
di Mameli dietro a Jimi Hendrix: lavremmo usata per massacrare
Signore, io sono Irish o Vorrei comprare una strada o
Risposta cioè la versione italiana di Blowin in
the wind (canzoni sovversive imparate in parrocchia).
Per chi ci si è ritrovato in mezzo per questioni anagrafiche,
gli anni ’70 hanno significato qualcosa di molto diverso
dai pantaloni a zampa delefante, dalla discoteca del sabato
sera e dalle perline colorate commercializzate adesso ai ragazzini
che sono arrivati dopo.
Siamo stati terra di mezzo, troppo piccoli per capire
realmente il Sessantotto (però ricordo vivamente lagitazione
di mio padre, che tremava e aveva gli occhi bagnati quando
parlava a casa degli scioperi a Marghera, per mantenere quel
lavoro che avrebbe portato neanche trentanni dopo alla fossa
lui e qualche centinaio daltri suoi compagni attraverso un
calvario di chemioterapie e morfina), e disgraziatamente fuori
tempo massimo per il punk e per il 1977 indianometropolitano.
Sia chiaro, non è stata una questione di scelte obbligate
esplicite: chi non sè adattato alla fabbrica e allutilitaria
non è poi per forza finito in banca, oppure sui marciapiedi
a darsi via o a mendicare spiccioli per Bhagwan o per leroina.
La provincia offre ombra e riparo, grande sottana a fiori
protettrice e discreta: una vita a velocità ridotta,
sopravvivenza forse più che vita, pochi scossoni e
curve morbide. Qualcuno chiama tutto questo mediocrità,
ma per noi bravi ragazzi cresciuti con poca o niente televisione
abituati a condividere discorsi libri dischi film oltre che
la merenda, i chilometri a piedi o in autobus per tornare
a casa – ai casermoni, ai quartieri dormitorio –
erano cosa normale come il puzzo che veniva dagli stabilimenti
e la nebbia della laguna.
Noi allora non lo si sapeva, ma questo spaesamento non era
cosa che succedeva solo in provincia: come confessarono Lalli
e Stefano Giaccone (che stavano a Torino tutte due)
nelle note di copertina di un loro vecchio disco, anche loro
– proprio come qui – sentivano più vicina
al cuore una canzone di Bob Dylan o di Joni Mitchell o un
pezzo di Archie Shepp o della Liberation Music Orchestra piuttosto
che una canzone popolare napoletana o qualsiasi altra canzone
melodica tradizionale tricolore.
Ce lo raccontò anche Eugenio Finardi in più
duna sua canzone, ce lo urlò in faccia rimproverandoci
di sognare la California incapaci di comprendere le parole
dentro ai manifesti e scritte sopra ai muri, ed Eugenio
abitava a Milano.
Musicalmente parlando (la musica è il sogno più
a portata di mano) siamo cresciuti globalizzati, con le radici
nel posto sbagliato, piantate da qualche altra parte: in un
posto che abbiamo chiamato America assecondando la corrente,
mettendo le nostre canzoni in rima con la propaganda degli
invasori.
La nostra America – il sogno di cui vi parlavo allinizio
– assomigliava più che allAmerica a qualsiasi
cosa che fosse diverso da casa-scuola-oratorio, diverso
dalla passeggiata pomeridiana obbligatoria in piazza tasche
vuote a guardare le vetrine senza potersi mai comprare un
cazzo, diverso dal negozio di dischi-libri-giornaliporno
di seconda mano (!), diverso dallautobus giallo che
ferma a ogni pisciata di cane e dalle messe beat (o dai popconcerti-raduno,
che sotto certi punti di vista erano un po lo stesso). America
era qualcosa di distante dai sogni rimasti per forza tali,
dalla felicità immaginata e mai realmente provata.
Ho comprato per caso Frisco Mabel Joy revisited e quando
lho ascoltato sin dal primo istante ho avuto un brivido indescrivibile
che mi ha fatto ricordare violentemente tutte queste frustrazioni
- sepolte chiuse a chiave in un baule da qualche parte in
testa, rimasto al buio e in silenzio per tutti questi anni
- che chiamavo chopper/Fender Strat/California a seconda della
temperatura a cui friggevano la mia inquietudine e la mia
voglia di andare via.
In un rimescolamento malato di date, mi sono venute in mente
tutte le copie riacquistate nel corso degli anni (per usura
e/o per furto) di 4-Way street e del Live at the Old Quarter,
mè venuta in mente la festa per i miei 18 anni organizzata
in garage, ho ricordato la prima canna e la bottiglia di Jack
Daniels che unamica speciale mi aveva regalato come incoraggiamento.
In una parola, Frisco Mabel Joy revisited è per me
un disco magico. In due parole, magico e bellissimo.
Potrei andare avanti per delle pagine con i superlativi, e
senza sentirmi in colpa nei vostri confronti.
E unopera notevole, da non confondersi - per retroterra
culturale, mezzi e prospettive economiche - con la recente
processione di cloni discografici (dopo il tribute collettivo
a Nebraska di Bruce Springsteen di qualche tempo fa, sono
usciti da poco un rifacimento di Rumours dei Fleetwood Mac
e addirittura uno di Songs from a room di Leonard Cohen).
Questo progetto parte da una miscela esplosiva di sentimenti.
Dallamore per certe vecchie canzoni tristi e per certi vecchi
cantanti che accompagnano un pezzo della tua vita e poi piano
piano scompaiono: Frisco Mabel Joy venne pubblicato nei
primissimi anni ’70 da Mickey Newbury, un frequentatore
dei piani alti delle classifiche americane negli anni ’60
(una stella di Nashville, le sue canzoni sono state interpretate
da Kenny Rogers, Ray Charles, Tom Jones, Waylon Jennings,
Elvis Presley e Roy Orbison tanto per dire una manciata di
nomi tutti maiuscoli anche da questa parte delloceano) ma
commercialmente in declino nella decade successiva, scomparso
dalla circolazione in quella ancora successiva e dimenticato
da tutti negli anni ’90.
Ricordo una copia strausata di Frisco Mabel Joy nellarchivio
di una delle primissime radio che ho frequentato: ogni tanto
mettevo in onda qualcosa, magari in compagnia di un blues
di David Bromberg o di una qualsiasi cosa di Townes Van Zandt
(dei quali mi piaceva immensamente la condivisione musicale
dintimità e segreti, sorridente e solare il primo,
fumoso e desertico il secondo), o dei miei Joni Mitchell,
John Fahey, Bruce Cockburn, Neil Young, Eric Andersen, che
ascoltavo devotamente prima di venire fulminato da Patti Smith
e da Stations of the Crass.
Mi piaceva di quel disco di Mickey Newbury soprattutto How
many times così struggente e carica di addii sconfinatamente
tristi e definitivi, tramonti, cose già viste, frasi
pensate e mai dette (per raccontarne lo spleen potrei descrivere
Newbury come una specie di Chet Baker in versione cantautore
country, se non vi fa troppo schifo laccostamento tra i due
generi espressivi distantissimi).
Ritornando alloggi, questa versione revisited è
caratterizzata dallenorme rispetto per loriginale: un rispetto
sincero che non ha impedito il libero volo degli arrangiamenti
e delle interpretazioni.
E curioso ed emozionante ogni singolo contributo: dalliniziale
American trilogy registrata in diretta su un dat in Slovenia
dai norvegesi Midnight Choir alla successiva How many
times rifatta dai Walkabouts (un gruppo indipendente
attivo da ventanni, molti bellissimi album allattivo), via
via fino al bonus track conclusivo San Francisco Mabel Joy
(che però non ricordo fosse presente nelledizione
originale) registrata in casa sua alle Hawaii da Kris Kristofferson,
beato lui che se ne sta lì in spiaggia lontano dallAfghanistan,
da Washington e da Manhattan.
Le varie canzoni sono suggestivamente unite una allaltra
da brevi momenti strumentali interpretati da un Bill Frisell
in puro stato di grazia. La confezione comprende, oltre al
cd, un libretto con molte note informative, purtroppo non
ci sono i testi delle canzoni (immagino per insormontabili
problemi di copyright) ma penso non sia impresa impossibile
scovarli sul web da qualche parte.
Il cd Frisco Mabel Joy revisited è edito dallindipendente
Glitterhouse (la cui base europea è in Germania,
Gruner Weg 25, D-37688 Beverungen, tel. +49 5273
36360, fax +49 5273 21329, http://www.glitterhouse.com,
e-mail: info@glitterhouse.com)
che offre un catalogo molto ricco in quantità e qualità.
Se accettate un consiglio, prendete qualsiasi cosa dei Walkabouts,
oppure Rainer, 16 Horsepower, Dakota Suite. Parte del ricavato
dalle vendite di questo cd andrà a sostenere lo Sweet
Relief Musicians Fund, unassociazione di Los Angeles
che fornisce ai suoi iscritti sostegno economico per le spese
mediche.
La Mountain Retreat ha pubblicato nel 1999 il box set
The Mickey Newbury Collection: questo ed altri suoi
cd si possono richiedere tramite il website http://www.mickeynewbury.com.
Per concludere (quasi), ecco lindirizzo della Mickey Newbury
Society: p.o. box 121984, Nashville TN 37212, USA.
Questa gestisce anche un sito web allindirizzo http://www.congray.com
(attenzione: in questo periodo non sono in grado di collegarmi
ad internet, questi indirizzi ve li passo al buio senza
averli testati personalmente).
E, se volete provare ad ascoltare come suona lAmerica immaginata
di cui parlavo allinizio di questa pagina, correte ad ascoltare
i tre bellissimi album degli Howth Castle. Loro sono
di Torino, ma il cuore, la testa e tutto quel che cè
dentro stanno di certo da qualche parte tra Seattle (...non
lho scritto a caso) e la California.
 Marco Pandin
Marco Pandin
|
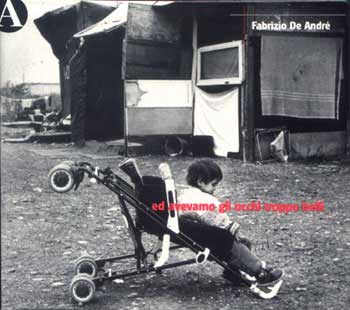
“ed
avevamo gli occhi troppo belli”
Quanto
costa
Una
copia costa 14 euro (lire 27.108).
A
partire da 3 copie, costa 13 euro (lire 25.172)
- sconto 7% circa
A
partire da 5 copie, costa 12 euro (lire 23.235)
- sconto 14% circa
A
partire da 10 copie, costa 11 euro (lire 21.299)
- sconto 21% circa
A
partire da 20 copie, costa 10 euro (lire 19.363)
- sconto 28% circa
Non
chiedeteci ulteriori sconti.
Non si effettua alcuna forma di conto/deposito.
La conversione euro/lira, fissata per legge, fa sì
che i prezzi in lire (peraltro utilizzabile solo fino
al 28.02.2002) siano definiti alla lira. Per la comodità
degli acquirenti, il prezzo finale (cioè
quello dell'intero ordinativo) può essere arrotondato
alle mille lire inferiori (es. 27.108 diventa 27.000,
54.216 diventa 54.000 ecc.).
Per
acquistarlo
Chi
paga anticipatamente
non paga le spese di spedizione postale
I
pagamenti anticipati si possono effettuare:
- con versamento sul nostro conto corrente postale 12
55 22 04 intestato a Editrice A, cas. post. 17120, 20170
Milano;
- con bonifico bancario sul nostro conto corrente bancario
n. 6.81 intestato a “Editrice A - Milano”,
presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale n. 11 di
Milano (Abi 1030, Cab 1612).
- con assegno non/trasferibile intestato a “Editrice
A” spedito in una busta.
Per
acquistare contrassegno è sufficiente comunicarci
(per posta, fax o e-mail) i propri dati ed il numero
di copie richieste – e prepararsi a pagare al postino
il pacchetto che arriverà. Per le spedizioni
in contrassegno (qualsiasi sia l’importo) applichiamo
un sovrapprezzo di 4 euro (lire 7.745).
|
|

