
Anarchici a Roma (e dintorni)
fino al 1946
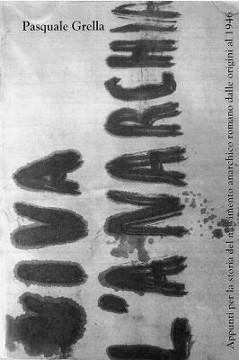 Pasquale
Grella ha recentemente dedicato un libro alla storia del movimento
anarchico romano dalle origini all'inizio del secondo dopoguerra
(Appunti per la storia del movimento anarchico romano dalle
origini al 1946, Roma, 2012, pp. 332, € 18,00) tracciando
una puntuale geografia storica dell'anarchismo, articolata per
quartiere. Pasquale
Grella ha recentemente dedicato un libro alla storia del movimento
anarchico romano dalle origini all'inizio del secondo dopoguerra
(Appunti per la storia del movimento anarchico romano dalle
origini al 1946, Roma, 2012, pp. 332, € 18,00) tracciando
una puntuale geografia storica dell'anarchismo, articolata per
quartiere.
La ricerca riporta alla luce vicende biografiche di decine di
militanti con le loro peripezie, coinvolti/e nelle mille traversie
che tuttavia non spezzarono la loro natura indomita. Da questa
narrazione risulta che tutta la città di Roma era punteggiata
da gruppi relazionati tra di loro attraverso un disegno organizzativo,
non solo pensato, ma anche spesso e per periodi relativamente
consistenti, realizzato. Si tratta di una ricerca a tutto campo,
minuziosa e dettagliata, svolta sulle carte dell'Archivio di
Stato e della Questura di Roma, nonché sulla stampa anarchica
dell'epoca e sul giornale ll Messaggero, favorevole, in alcuni
periodi, agli anarchici ed alle rivendicazioni popolari. Le
poche altre pubblicazioni esistenti, sopravvissute a periodi
di censura e distruzioni, quali ha attraversato il nostro Paese
durante il ventennio, integrano la ricerca.
L'analisi documentale dà un senso umano e storiografico
a vicende delle quali si sa poco, come la presenza degli anarchici
a Civitavecchia di cui si è perso il ricordo, come le
vite piene di impegno e di persecuzioni di Pietro Calcagno e
di Aristide Ceccarelli, solo per citare alcuni dei militanti
più attivi. È inoltre ricordata la rilevante presenza
degli anarchici ai Castelli Romani. Sono anche ricordate le
lotte per la salute e le alleanze con intellettuali illuminati
per l'istruzione popolare. Opera enciclopedica narra come la
Prima Internazionale abbia le sue radici nel Risorgimento e
come dal primo nucleo di ex-garibaldini di Ponte Milvio, che
hanno abbracciato le idee di Michele Bakunin, l'anarchismo si
sia diffuso in tutta la città. Ad Ostia, sul gruppo di
antiautoritari locali si innesta il forte contributo delle colonie
dei braccianti romagnoli. Militanti romani sono presenti al
Congresso di Capolago, il primo tentativo organizzativo su larga
scala degli anarchici italiani.
A Roma si producono i fatti successivi del Primo maggio 1891,
contestualizzati nel tentativo rivoluzionario deciso sul piano
nazionale nel predetto Congresso. Fin dall'inizio della storia
del movimento numerosi militanti subiscono le prove della repressione
governativa. In gran numero sono inviati al domicilio coatto,
colpiti perciò ferocemente negli affetti famigliari.
Nonostante ciò i militanti si distinguono nelle lotte
del lavoro, contro il caporalato nell'edilizia e per la conquista
di migliori condizioni di vita. A Roma si radica la svolta libertaria
e nel suo ambito viene studiato l'importante ruolo svoltovi
da Luigi Fabbri. Il libro ci parla anche della loro partecipazione
alle Camere del lavoro, dove spesso, in ruoli dirigenti, ne
determinano l'indirizzo. È descritto inoltre l'antimilitarismo
contro la Prima Guerra Mondiale, la lunga lotta antifascista,
che nasce prima dell'affermarsi del fascismo e che si snoda
durante i bui anni del ventennio, l'esilio in Europa, in Nord
e Sud America e la Resistenza, ricordando l'eccidio delle Fosse
Ardeatine e la traduzione nei campi di concentramento in Germania
di alcuni anarchici. Insieme agli altri libri che sono usciti
recentemente sulla storia del movimento anarchico romano ed
al Dizionario degli anarchici italiani, con riferimento a quelli
romani, il libro di Pasquale Grella, impostato sulla ricerca
archivistica spiccatamente analitica, contribuisce a delineare
l'immagine di un periodo di grande diffusione degli ideali libertari
tra le masse popolari.
Il libro può essere acquistato per corrispondenza on-line
presso la libreria Gullà, sita in via Bufalini 15 Roma-Ostia
Antica, il suo costo è 18 euro e le spese di trasporto
sono indicate dalla libreria. Si può acquistare inoltre
nelle sedi del movimento romano.
Enrico Calandri
Riedito
il “Cafiero” di Pier Carlo Masini,
ben più che una biografia
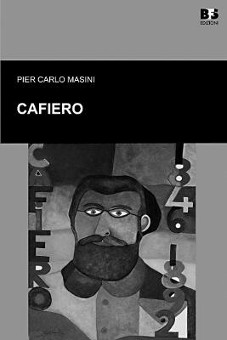 La
nuova edizione del libro di Pier Carlo Masini dedicata a Cafiero
(Cafiero, BFS edizioni, Pisa, 2014, pp. 280, € 20,00),
rivista e ampliata dall'autore prima della sua scomparsa, rappresenta
un accurato lavoro filologico, archivistico e di approfondita
documentazione, continuato negli anni successivi all'edizione
del '74. La postfazione di Franco Bertolucci mette in luce che
non si tratta solo di un libro sull'internazionalista pugliese,
ma fa emergere anche l'originale contributo di ricerca di Masini
nel suo mestiere di storico. La
nuova edizione del libro di Pier Carlo Masini dedicata a Cafiero
(Cafiero, BFS edizioni, Pisa, 2014, pp. 280, € 20,00),
rivista e ampliata dall'autore prima della sua scomparsa, rappresenta
un accurato lavoro filologico, archivistico e di approfondita
documentazione, continuato negli anni successivi all'edizione
del '74. La postfazione di Franco Bertolucci mette in luce che
non si tratta solo di un libro sull'internazionalista pugliese,
ma fa emergere anche l'originale contributo di ricerca di Masini
nel suo mestiere di storico.
Saranno circostanze virtuose a mettere il giovane studente sulle
orme di Cafiero prima ancora di conoscere l'internazionalista
attraverso i suoi scritti e le sue imprese. Luogo preferito
il monte Cèceri vicino Fiesole. E proprio sulle pendici
del monte, lungo le cave e le caverne di Maiano, verrà
ritrovato Cafiero pazzo. Anni dopo, per la sua scelta antifascista
Pier Carlo viene arrestato e mandato al confino a Guardia Sanframondi,
in provincia di Benevento, a soli tre chilometri da San Lupo,
la base di partenza della banda internazionalista del Matese
capeggiata da Cafiero, Malatesta, Ceccarelli. Ai primi di settembre
del 1947 Masini ripercorrerà altresì, insieme
ad Alfonso Failla e ad altri compagni, il cammino degli internazionalisti.
Già nell'estate del '45 sceglie di schierarsi in campo
libertario e matura l'idea di riscrivere la storia dell'Italia
attraverso lo studio del movimento operaio, per conferire dignità
e legittimazione al movimento stesso.
Masini si schiera nel solco del pensiero di Errico Malatesta,
Luigi Fabbri, Francesco Saverio Merlino e Camillo Berneri, dalla
parte di quelli che sanno tradurre “l'utopia della vetta
in proposte, programmi, progetti per cambiare il piano; che
sono continuamente irrequieti, autoironici, insoddisfatti, autocritici
del loro stesso anarchismo, che lo adoprano non come un metro
per misurare e magari condannare gli altri, ma come una lente
per leggere meglio in se stessi e nella società”.
Il contributo sulla pazzia di Cafiero dell'amico e storico mantovano
Gianni Bosio gli suggerisce invece la chiave di lettura della
vicenda umana del rivoluzionario pugliese.
Cafiero, “la settima anima”, il figlio del sole,
un figlio del Mezzogiorno. Napoli sarà la sua patria
adottiva, anche se l'anagrafe lo vuole pugliese, di Barletta
dove nasce nel 1846 da Ferdinando e Luisa Azzariti, una famiglia
benestante, ben accetta a Dio, al re, alle banche e all'elettorato.
Due fratelli e tre sorelle, fin da subito sarà la pecora
nera, l'innominabile sperperatore, vagabondo e sovversivo, vissuto
in galera e morto in manicomio, cattivo esempio per i bambini.
Ramo sbagliato della casata. Per il programma e la lotta internazionale
dissiperà tutto il patrimonio ereditato. Cafiero -per
estensione il cognome si assimilerà al nome- condensa
una personalità che sarà confusa con la leggenda,
anche se il pensiero rimarrà a lungo sconosciuto.
I suoi primi studi in un seminario vescovile del meridione,
dove riti sacri, pratiche ascetiche, venerazione di santi saranno
sconvolti dalle sferzate garibaldine che s'infilavano anche
nei conventi e seminari. A diciotto anni la crisi, la rivolta,
ma di questo passato ne rimarrà in certa misura prigioniero.
La laurea in legge a Napoli, poi i contatti con Firenze, centro
di vita e cultura democratica e agli inizi del 1870 con Parigi,
negli ultimi anni del Secondo Impero. E proprio alle prime avvisaglie
della guerra franco-prussiana, parte per Londra. A venticinque
anni, la seconda conversione votata alla rivoluzione. Lusinghe
della carriera, vita mondana, raffinatezze cedono alle umane
miserie degli operai della metropoli, che paragona a quelle
delle plebi meridionali. Quartieri dove regnano alcolismo, tuguri
fetidi, ladri, cenciosi e prostitute.
A Londra i contatti con Marx e Engels e l'adesione all'Internazionale.
Cafiero sarà altresì il primo divulgatore in Italia
del “Compendio del Capitale” di Marx, redatto nelle
celle del carcere.
Poi le lettere di congedo da Engels, la rottura con il Consiglio
generale e l'avvicinamento a Bakunin - arrivato in Italia nel
1864 e dedito all'attività politica fino al 1874 - il
russo reduce dalla Siberia, l'incubo del Consiglio Generale
per la sua azione “anarchica” all'interno dell'
Internazionale di cui è membro. Fedele al suo maestro,
con cura e dedizione filiale acquisterà una casa con
un po' di terra a Locarno, “La Baronata”, per farvi
risiedere il russo con la sua famiglia e altri rivoluzionari
fuggiaschi. Ma si dimostrerà irato e amareggiato quando
il maestro abuserà della sua fiducia e generosità,
costringendolo a vendere carrozza e bardatura, argenteria di
famiglia e gioielli della madre per pagare i debiti. Cafiero
dirà d'ora in poi: “Né un centesimo, né
un pensiero, né un guizzo di energia, poiché tutto
dovrà appartenere alla rivoluzione”. Sarà
la fine di un'amicizia e di un sodalizio fatto di motivi economici,
politici, ma anche di sentimenti, durato due anni.
Cafiero occupa un posto centrale nella storia del movimento
operaio italiano. Dotato di intraprendenza, forza morale, ma
anche materiale, sarà tra i principali ispiratori e organizzatori,
a Rimini nel 1872, della branca italiana dell'Internazionale,
e poi del contro-congresso di Saint-Imier, le cui risoluzioni
adottate costituiranno le basi dell'anarchismo moderno.
Tra il 1878 e il 1880 concepisce un ampio saggio dal titolo
“Rivoluzione”, il primo consistente e organico elaborato
teorico dell'anarchismo italiano, influenzato dalle idee e dall'azione
di Pisacane, per Cafiero il primo maestro di socialismo e di
anarchismo. La seconda parte poggia come è noto sulla
formula “Da ciascuno secondo le sue facoltà, a
ciascuno secondo i suoi bisogni” e la terza è un
aggiornamento della teoria della “propaganda del fatto”.
Quando alla fine del 1879 l'Internazionale lascia il posto all'affermazione
e sviluppo del movimento socialista da un lato e del movimento
anarchico dall'altro, di quest'ultimo Cafiero ne sarà
il profeta.
Masini indaga in modo particolare gli aspetti più introversi
e contraddittori della sua personalità di indomito rivoluzionario,
impetuoso, mistico sognatore, allucinato. Lo storico toscano
ravvisa segnali di malattia e tendenze che si aggraveranno negli
anni successivi. L'attacco all'amico Andrea Costa -idee di origini
libertarie e nel 1882 primo deputato socialista nel Parlamento
italiano - avrà un forte costo psichico, segno dei primi
sconvolgimenti prodotti nella sua mente. Anche nell'atteggiamento
verso il congresso di Londra, riscontrato nella lettera di Cafiero
a Malatesta e a Kropotkin, si mescolano elementi sensati a uno
stato di anormalità. Così, tralasciando le componenti
paranoiche, la sua sfiducia nella tattica rivoluzionaria e l'indicazione
di una nuova teoria precorreranno le successive tendenze dell'anarchismo
individualista, in contrasto con la linea “organizzatrice”
di Malatesta.
Al VII congresso generale di Bruxelles nel settembre 1874, solo
gli italiani assenti, giungerà un documento scritto e
spedito da Cafiero, dove tra l'altro si annuncia: “L'epoca
dei Congressi è per noi decisamente finita”. Per
Masini, il messaggio andrebbe ricondotto ad un momento di crisi
personale, la rottura con Bakunin, e politica, il fallimento
dei moti insurrezionali in Italia, e letto in chiave psicologica.
Vi ravvisa una tendenza a razionalizzare gli insuccessi fino
a trasformarli in future vittorie. La stessa paura delle spie
e dei mestatori altro non sarebbe che un primo indizio della
sua mania di persecuzione. Ancora significativi: “la ricerca
dell'anonimato, il bisogno di eclissi, l'attrazione delle tenebre
per cui l'organizzazione settaria e segreta diventa per Cafiero
l'ideale rifugio della sua tormentata personalità”.
Necessità interiori pretesto di opportunità politiche
giustificate a se stesso e agli altri. E anche la dichiarazione
di una sua conversione al metodo elettorale e parlamentare sarebbe
quella di un uomo psichicamente in declino.
Incarcerato più volte, tenterà in circostanze
diverse il suicidio. Nel 1883, l'internamento nel Regio Manicomio
di Bonifazio, la richiesta di interdizione da parte dei familiari
e l'interessamento della moglie Olimpia per averlo con sé
in affido. Nel 1886, Cafiero lascia Firenze per il manicomio
imolese di S. Maria della Scaletta, in campagna. Cartelle cliniche
riportano le sue stravaganze, la riluttanza verso gli abiti
sentiti come una camicia di forza, soliloqui, manie di persecuzione.
Poi la tutela alla moglie. Per un anno e mezzo dimoreranno tra
Bologna e Imola, ma senza miglioramento delle condizioni. Sempre
vicino al camino, testa bassa, mangia solo polenta e cipolle.
Taciturno esce da casa mezzo scamiciato in pieno inverno. Oppure
rimane disteso nudo, al sole di primavera. Il più distinto
dei rivoluzionari italiani, garbato nelle maniere, dalla parlata
musicale, elegante, barba signorile, figura maestosa e imponente
esprime così la mancata accettazione delle convenzioni
sociali. La mente devastata dall'attesa “del sol dell'avvenir”
rivelerà l'ultimo sprazzo di lucidità quando alla
vista delle bandiere per l'anniversario della Comune, risponderà:
“Il principio è affermato”. Dopo un periodo
al paese natio, di nuovo il ricovero, questa volta nel manicomio
Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore. La tubercolosi, e
infine la morte liberatrice all'una pomeridiana di domenica
17 luglio 1892.
Se l'edizione del libro su Cafiero pubblicato nel '74 nella
collana “Gli italiani” è segnalata, recensita
dalla stampa italiana e apprezzata, la critica marxista considera
l'indagine del dato psicologico un limite. Invece, come sottolinea
Franco Bertolucci, il merito di Masini sta proprio nell'aver
saputo ben integrare il dato strutturale, caro alla critica
marxista, con quello psicologico. E restituendo dalle masse
indistinte l'individuo come entità, lo storico toscano
introduce un fondamentale contributo innovativo anche sul piano
del racconto biografico.
Al termine della sua ricerca potrà così affermare:
“Cafiero porta con sé, nel suo acuto destino, un
frammento dell'umana odissea [...] tappe della ricerca di un'altra
cosa, di una diversa dimensione, al di là del reale
e dell'umano”.
Claudia Piccinelli
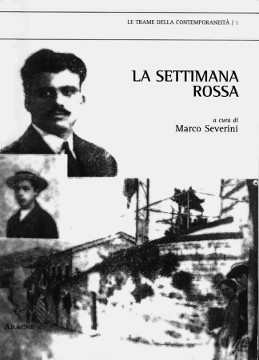 Contro
l'inattualità del progetto,
analisi della Settimana rossaNel 1914, tramontati gli equilibri dell'età giolittiana
e a un passo dalla tragedia della Grande guerra, una rivolta
che passerà alla storia come la “Settimana rossa”
accende le speranze dei rivoluzionari.
Tutto nasce da un comizio antimilitarista previsto per la prima
domenica di giugno, giorno della festa dello Statuto: vietato
dalle autorità in forma pubblica, il comizio si svolge
nei locali della sede repubblicana detta Villa Rossa. All'uscita,
i partecipanti trovano la strada sbarrata da guardie e carabinieri,
poco più tardi il selciato si macchia del sangue di tre
ragazzi colpiti a morte dalle forze dell'ordine. La reazione
popolare non si fa attendere. Anarchici, socialisti, repubblicani,
sindacalisti rivoluzionari conquistano le piazze della città
dorica, mentre la CGdL si accoda alla protesta proclamando quarantotto
ore di sciopero generale. Si verificano tafferugli nelle principali
città del Regno e la rivolta si espande a macchia d'olio
coinvolgendo principalmente le Marche centro-settentrionali
e la Romagna.
Complice il blocco delle comunicazioni e la diffusione di voci
incontrollate circa la fuga del Re, la caduta del governo e
l'imminente proclamazione della repubblica, le dimostrazioni
assumono caratteristiche di un vero e proprio moto insurrezionale.
Non quindi una lotta prettamente economica, per reclamare il
pane, ma il peso di un'antica soggezione che d'un tratto si
spezza e sembra lasciar intravedere, stavolta a portata di mano,
l'agognata possibilità di fare la Repubblica.
Manca lo scontro aperto con esercito e forza pubblica, ma a
fare le spese di quello che Malatesta definirà “uno
scoppio spontaneo d'indignazione popolare” sono più
che altro luoghi e simboli del potere, con in primo piano diverse
chiese fatte bersaglio dagli insorti, a testimoniare l'anticlericalismo
viscerale così diffuso in quelle contrade.
In occasione del centenario sono uscite diverse pubblicazioni
tra cui il volume La Settimana rossa (Aracne, Roma, 2014,
pp. 429, € 25,00) che fin dal titolo si pone come un punto
fermo per la storiografia relativa a quegli avvenimenti, promosso
dall'Associazione di Storia Contemporanea (www.ascontemporanea.it)
e curato da Marco Severini, docente presso l'Università
di Macerata. La ricostruzione procede affrontando ad ampio spettro
molti aspetti connessi al tema principale, grazie ai contributi
di numerosi studiosi, articolati in quattro sezioni: “La
storia”, “Il contesto”, “La geografia”
e “Dalle biografie alla storiografia”.
L'indagine si muove in effetti a tutto campo, a partire dall'approfondimento
storico dei fatti, dal loro riflesso sui quotidiani d'informazione
e nelle carte processuali, passando per l'analisi delle forze
politiche e sindacali e del dibattito parlamentare, con uno
sguardo al contesto internazionale delle lotte operaie e capitoli
specifici dedicati alla massoneria, al Sindacato ferrovieri
e a chi la Settimana rossa la subì, come i cattolici.
Sulla scorta anche di inedite fonti archivistiche viene analizzata
la diffusione territoriale dei tumulti, dedicando particolare
attenzione alla Romagna e l'Emilia, Parma, Roma e Firenze, Torino,
Genova e il Nord-ovest, Milano e il nord-est, Palermo e Napoli.
Seguono alcuni percorsi biografici, dal direttore dell'«Avanti!»,
l'ancora per poco socialista Benito Mussolini, ai profili dei
ragazzi vittime ad Ancona e Fabriano e di altri coprotagonisti
della rivolta, al contributo combattivo e determinante di molte
donne del popolo.
Infine, prima di un bilancio storiografico tracciato dal curatore
Severini, Massimo Papini ritorna sul tema del “mito”
della Settimana rossa e sulla gestione polemica della sua memoria
storica nel secondo dopoguerra. Nella disputa tra anarchici
e partito comunista, Papini conclude che solo quest'ultimo in
quanto unico degno rappresentante del proletariato potesse fare
propria la lezione di quelle giornate, di fronte ad un movimento
anarchico espulso dal corso della storia. La solita tesi, insomma,
che si sgretola al cospetto del mondo contemporaneo e dei fermenti
libertari che attraversano le lotte odierne, smentendo nei fatti
la condanna dell'anarchismo all'“inattualità”.
Questo centenario ha dato modo a diversi soggetti di esprimersi
sulla Settimana rossa e il libro curato da Severini è
uno strumento utile e ben strutturato per comprendere cosa si
mosse in quel frangente. Meno lodevole è l'elaborazione
fatta da altri soggetti di un racconto storiografico neutralizzato
da ogni conflittualità, al cui centro vi è il
passato di Ancona “città sovversiva” che,
appunto perché tale immagine è relegata al passato,
può essere recuperata per rievocazioni istituzionali
e guardata con la curiosità con cui si guarda dentro
la teca di un museo. Così la Mole Vanvitelliana è
stata teatro estivo per una kermesse di presentazioni, mostre
e spettacoli inaugurata dalla sindaca di Ancona, inflessibile
tutore dell'ordine contro migranti ed esclusi di oggi, e dove
si è consumato il tentativo di condividere la memoria
storica di un moto insurrezionale persino con un colonnello
dell'esercito italiano, invitato senza pudore al tavolo dei
relatori.
Non che la vulgata anarchica vada difesa ad ogni costo, specie
quando, come in questo caso, vede ovunque rivoluzioni mancate
per sola colpa dei dirigenti di partiti e sindacati, riformisti
per loro natura e sempre pronti ad accomodarsi con il potere.
Al contrario, ritengo sia più sensato calare la Settimana
rossa nel suo contesto senza negarne gli evidenti limiti e l'inconsistenza
di effettivi sbocchi rivoluzionari, ma valorizzandone semmai
la sempre attuale portata sovversiva al fine di riattivare la
memoria storica come strumento di trasformazione sociale. E,
già che ci siamo, interrogarsi su come in cento anni
sia radicalmente mutato il concetto stesso di “rivoluzione”.
Luigi Balsamini
 Punk,
tossicodipendenti, rockettari, anarchici,
femministe, figli dei fiori, ecc.“Nel '78 io avevo otto anni [...] Se in Inghilterra ci
stava da un pezzo la new wave che seguiva al post-punk, qui,
come a Bari, i primi vagiti del movimento si avvertirono solo
nell'82, fino all'esplosione vera e propria che va dall'83 all'85...[...]
Tempo quei due tre anni e tutto sarebbe cambiato, molta gente
sarebbe andata via, chi in America, chi in Olanda, altri ancora
finiti male, molto male, ne so di storie. [...] Me ne andavo
spesso in villa, il posto migliore, se non l'unico, per fare
conoscenze. Per la popolazione locale quello era un posto frequentato
solo da drogati, il polo di attrazione di ex-sessantottini,
anarchici, comunisti, femministe, figli dei fiori. [...] C'era
ad esempio Donato che aveva un furgone Ford Transit con cui
andava a vendere le uova: era il più eccentrico di tutti,
vestiva da anarchico russo, casacca e colbacco, metteva baschi,
cappelli con bon bon da bohémien [...] I CCCP erano divenuti
un po' l'emblema del punk, secondo me a torto. Rispetto al movimento
giunsero con un bel po' di ritardo, siamo già nell'87
quando si comincia a parlare di loro... C'erano a mio avviso
testi più calzanti, che grondavano furore anarcoide,
di formazioni meno conosciute, tipo gli Underage di Napoli o
i milanesi Wretched [...] Ma ti stavo raccontando del mio giro
di conoscenze. Altro punto di riferimento era Sante Cannito,
secondo me dovrebbero come minimo dedicargli una statua. Lui
sì che m'ha influenzato. Una casa editrice locale aveva
pubblicato tutti i suoi scritti, era un uomo che aveva attraversato
un secolo di storia, di guerre, di lavori duri in campagna,
era stato nei cantieri edili di mezza America, sempre sfruttato.
Più che le fanzine, a noi punk locali ci ha formati lui
con i racconti delle sue avventure, la sua visione delle cose.”
Torna con otto racconti (Francesco Dezio, Qualcuno è
uscito vivo dagli anni Ottanta. Storie di provincia e di altri
mali, Stilo editrice, Bari, 2014, pp. 125, € 12,00),
dopo dieci anni, l'autore di Nicola Rubino è entrato
in fabbrica (Feltrinelli), che a suo tempo ebbe un fortunato
successo di pubblico e di critica, primo esempio di narrativa
postindustriale degli anni 2000.
Dezio resta sempre fedele all'impostazione non-fiction, ma la
questione dello sfruttamento del lavoro resta questa volta sullo
sfondo: protagonisti sono punk, rockettari, tossicodipendenti,
anarchici formatisi intorno alla figura quasi leggendaria di
Sante Cannito, musicisti alternativi o appassionati di controculture.
Quest'umanità varia e vera, organizzando concerti, fondando
associazioni, trovando appena un po' di sollievo nei centri
sociali di Bari o Milano (“la Giungla”, il “Virus”),
emigrando ad Amsterdam o a Londra, cerca di far penetrare idee
di lotta o di aggregazione, novità, tendenze e gusti
musicali degli anni Ottanta in un mondo arcaico, padronale e
atemporale, che è quello della provincia pugliese, Altamura,
città natale dell'autore, ma anche Molfetta, Melpignano,
Sansevero.
Ma questi piccoli eroi picareschi si trovano schiacciati, ai
quattro punti cardinali: 1) come sempre, dalla precarietà
lavorativa, dallo sfruttamento di (im)prenditori rampanti del
mobile imbottito, che arraffano risorse umane e capitali del
territorio e poi delocalizzano nel Sud-Est asiatico; 2) dalla
cultura ufficiale, quella borghese e piccolo-borghese, che è
espressione del potere; 3) dalle mode pop imposte dal consumismo
e dalla musica commerciale; 4) dal male peggiore di tutti: l'indifferenza
della provincia a qualsiasi espressione culturale (anche borghese
o consumistica), la totale necrosi cerebrale, l'ottusità
che riduce la vita ad un insieme di funzioni puramente biologiche.
Led Zeppelin, AC/DC, Clash, Pink Floyd, Underage, Wretched,
Ramones, Orda, Ultravox, Not Moving, Chain Reaction, Kranio,
Negative Disarcore, Rich Fish in Hand, Boohoos, CCCP, Gods of
Metal, Delgados, Arab Strap. Sono più di 70 i gruppi
musicali citati (già il titolo è un omaggio ad
una canzone degli Afterhours), su cui i protagonisti si confrontano
e si scontrano, esprimendo giudizi veementi ma raffinati sul
rock, il post-rock, il punk, il post-punk
e la new wave, senza che sia indebolita la forza narrativa
del testo (i nomi dei gruppi sono in carattere rilevato, e la
playlist è scaricabile tramite apposito codice nell'ultima
pagina del libro, che ha una bella veste tipografica e vignette
dell'autore).
Ma il sentimento che pervade tutto il libro non è la
nostalgia di quel decennio, né l'intento è quello
di ricostruire l'epoca. La suggestione è un'altra: in
un'antropo-geologia 'carlo-levianamente' refrattaria a qualsiasi
cambiamento, l'effetto atmosferico, la restituzione del clima
degli anni '80 è affidata soprattutto alla musica. Eppure
essa è deposito residuale, pulviscolare: questa musica
arriva da altri mondi, ha una forza prorompente se viene dalle
grandi città, se ha attraversato interi continenti, ma
qui non ha potere se non sui nostri eroi, apolidi anche in casa
propria: è destinata ad essere spazzata via da una terra
che apparirà ancora più nuda e desolata ai sopravvissuti,
a quelli che non hanno voluto piegarsi.
La scrittura autobiografica di Nicola Rubino è entrato
in fabbrica era stata apprezzata per le sue forti implicazioni
autocaricaturali: il sindacalese del sindacalista, l'aziendalese
del manager, la patina dialettale degli operai, fino alle due
pagine di avanguardia, con la sintassi abolita, che esprimevano
l'effetto della catena di montaggio, frantumatore della psiche
(http://www.treccani.it/magazine/lingua italiana/percorsi/Silverio
Novelli).
L'autore, che non ha voluto piegarsi alle logiche onnivore del
mercato editoriale, che impongono un continuo presenzialismo
in libreria, torna dopo un decennio di silenzio con una prosa
altrettanto matura e sperimentale: gli otto racconti sono dei
monologhi di personaggi diversi, con un felice effetto stratigrafico,
di filigrana tra la voce narrante adottata di volta in volta
(con le inflessioni del parlato) e quella autoriale (con il
suo sigillo di stile), quasi a creare l'intonazione di un resoconto
impersonale di memorie orali e collettive, appartenenti ad un'intera
comunità provinciale, affidate ad un cantastorie.
Claudia Mazzilli
Canto
di odore
e di musica
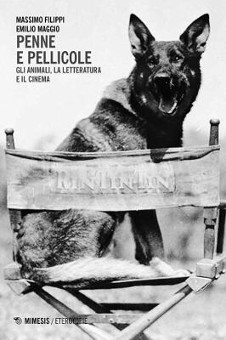 «They
haven't got no noses/ they haven't got no noses/ and Goodness
only knowses/ the noseleness of Man!», cantilenava al
colmo del divertimento (e della pietà) il cane Quoodle
ne L'osteria volante di G. K. Chesterton (nella traduzione
di Primo Levi: «Non hanno proprio naso/ non hanno proprio
naso/ e Dio solo sa quanto/ sia disnasato l'Uomo»). «They
haven't got no noses/ they haven't got no noses/ and Goodness
only knowses/ the noseleness of Man!», cantilenava al
colmo del divertimento (e della pietà) il cane Quoodle
ne L'osteria volante di G. K. Chesterton (nella traduzione
di Primo Levi: «Non hanno proprio naso/ non hanno proprio
naso/ e Dio solo sa quanto/ sia disnasato l'Uomo»).
La vista umana, suggeriscono Massimo Filippi ed Emilio Maggio
nella densa raccolta di saggi Penne e Pellicole (Mimesis,
Milano, 2014, pp. 220, € 18,00), ha qualcosa di imperioso:
risponde all'urgenza di oggettivare l'altro e conservare la
(presunta) identità del sé, trasformandosi così
nello «sguardo onnipotente, continuo e instancabile di
una rappresentazione ingabbiante». E soffocando il senso
dell'odorato. Nell'odorare ci si perde, per questo l'Umano ne
ha così paura. Tanto da averne fatto, scrivevano Adorno
e Horkheimer nella Dialettica dell'illuminismo, «un'onta,
uno stigma di classi sociali subalterne, di razze inferiori
e animali ignobili». Eppure tutti noi emettiamo involontari
segnali olfattivi, testimonianza inaggirabile del fatto che
non ci apparteniamo mai del tutto, che non esiste un nostro
proprio, che il limite tra interiore ed esteriore non può
negare porosità e aperture per sostenersi. Che siamo
animali tra gli animali.
Abbandonando l'occhio fagocitante del voyeur che caratterizza
tutte quelle prospettive fintamente animaliste che insistono
nel tracciare improbabili confini tra “noi” e “loro”
(forse per ricavare nuove umanissime emozioni da quelle penne
e da quei manti), i due autori danno puntualmente ragione del
perché, esattamente come nel caso di Joy, il cavallo
protagonista del colossal spielberghiano War Horse a
cui è dedicato un capitolo del libro, l'Animale «è
sempre e comunque fuori campo, anche se continuamente
inquadrato dall'obiettivo della macchina da presa».
L'Animale è fuori campo ogni volta che lo si osservi
con sguardo disponente, o si pretenda di imbrigliarlo –
magari animati dalle migliori intenzioni – entro le coordinate
di un pensiero fondazionalista, ennesima variante della volontà
di dominio rivestita dei panni linguistici cari alla filosofia
analitica.
Gli animali che percorrono queste pagine non conoscono pretesa
né furia.
Di qui il loro vivo interesse per la letteratura e per il cinema,
e più in generale per il linguaggio inteso nella sua
funzione espressiva più che rigidamente denotativa, se
il linguaggio può diventare la chiave per una concezione
non più assimilante del pensiero. Cominciano finalmente
ad abbozzarsi i tratti di quella «lingua minore»
che sola possa restituirci agli animali che dunque siamo, «una
lingua altra, una voce dell'altro mondo, al contempo universale
e corporea, una lingua che tutti conoscono, parlano e comprendono,
ma che prende forma e consistenza solo nella vicinanza, nel
contatto e nella carezza. Lingua dell'incontro e del commiato,
lingua tattile».
Serena Contardi
 Léo
Ferré/
Un libro, un festival, una rapinaMi è sempre difficile scrivere di quello che mi sta
a cuore. O meglio, di quello che ho dentro il cuore. Qui sono
alle prese nientemeno che con Léo Ferré, la canzone
francese e le parole di tanti amici. Amici nell'accezione comune
della parola, amici per affinità intellettuale, amici
ascoltati e letti e mai conosciuti.
È quindi con emozione che provo a raccontarvi questo
Ferré e gli altri. La grande canzone francese e i
suoi interpreti (Rimini, 2014, pp. 301 € 16,00) a cura
di Enrico de Angelis, recentemente uscito per i caratteri dell'Editrice
NdA.
Il libro nasce da materiale che potrebbe sembrare marginale,
o semplicemente solo informativo: le brochure di un festival
musicale. Ma se il festival in questione è il Festival
Ferré – che dal 1995 si tiene a San Benedetto del
Tronto, con ben pochi mezzi ma con molto amore e grande intelligenza
– e le brochure contengono piccole gemme di Giuseppe Gennari,
Enrico de Angelis, Guido Armellini, Mauro Macario (e molti altri),
ogni dubbio scompare. Quel che rimane è la consapevolezza
di quanto sia stato prezioso questo lavoro di strutturazione,
recupero, volontà di ricostruire una storia: la storia
(non banalmente didascalica) del Festival Ferré e al
contempo di buona parte della canzone francese.
L'opera è divisa in cinque parti, che contemplano, nell'ordine:
le presentazioni annuali del festival dal 1995 al 2013, tutti
gli scritti su Léo Ferré, i pezzi sugli altri
artisti ed autori stranieri presenti al festival e a seguire
quelli sugli italiani, per concludere con una succulenta antologia
di canzoni, traduzioni in lingua italiana di canzoni di Ferré
e di altri autori.
Léo è, in questo libro e per il Festival Ferré,
inizio e conclusione di ogni discorso, ma soprattutto è
il fulcro catalizzatore di un ostinato e contrario tentativo
(riuscito) di ricerca artistica, di futuro, di divulgazione
della migliore canzone italiana e francese. Complicato riassumere
in poche righe quello che emerge da questo ventennale lavoro
collettivo di una banda di sognatori un po' folli (di quella
splendida follia che crea il bello, nonostante tutto e tutti)
capitanati da Giuseppe Gennari e dalla famiglia Ferré
(soprattutto nella persona della moglie di Léo, Maria
Cristina), che di anno in anno coinvolge compagni di viaggio
generosi e straordinari, come ad esempio Ugo Nespolo, che al
Festival ha regalato ben cinque manifesti (da uno dei quali
è stata tratta la copertina del libro).
Il Festival ha consegnato annuali premi alla carriera, anche
postumi (per esempio Fabrizio De André, Luigi Tenco,
Piero Ciampi, Georges Brassens, Barbara, Jacques Brel, Serge
Gainsbourg), ad artisti di indiscutibile grandezza. Ha accostato
personaggi celebri e meno conosciuti in concerti, recital, presentazioni
di libri, dibattiti, sempre in virtù della qualità
e mai del successo commerciale. Scoverete sorprese anche tra
i grandi nomi italiani dove, accanto ad un brassensiano per
eccellenza come Nanni Svampa, troverete il francofilo che non
ti aspetti, ovvero un Francesco Guccini vincitore nel 2004 ed
insospettabile ma convinto traduttore di Brel già dagli
anni Settanta, come raccontato in modo impeccabile da Enrico
de Angelis nel suo scritto per l'edizione in questione.
Tra gli stranieri incontrerete icone assolute come Juliette
Gréco, Jane Birkin, Dee Dee Bridgewater, Georges Moustaki
(“star” nel 1998 e oggi uno degli assenti che hanno
velato gli occhi all'edizione 2014, anno che ha strappato al
festival pure amici come Francesco Di Giacomo e Roberto Freak
Antoni). A me è piaciuto soprattutto sbirciare tra i
nomi meno noti, a volte (in Italia) sconosciuti ai più,
come la “rockettara” Mama Béa Tekielski o
la “fatina” (così la definisce Gennari) Isabelle
Aubret. È soprattutto per trovare o ritrovare questi
artisti che consiglio di leggere il libro, assolutamente generoso
nell'offrirci incontri inaspettati e sorprendenti.
Interessante, infine, la parte dedicata ai testi, soprattutto
la piccola antologia di traduzioni/adattamenti, dove ancora
una volta vediamo affiancati nomi noti e meno noti di validissimi
traduttori, da quelli storici come Gennari e Renato Dibì
ai più giovani Alessio Lega e Raffaella Benetti, passando
addirittura per “collettivi” di traduzione, classi
di liceo che proprio grazie a Gennari hanno avuto la fortuna
di imparare almeno in parte il francese su Ferré (certi
insegnanti non li hai mai avuti né conosciuti... ma li
rimpiangi!).
È divertente giocare a confrontare alcune traduzioni,
cito ad esempio (e con femminile orgoglio) Quella ferita
(Cette blessure) sulla quale si sono cimentati Gennari
e Andrea Satta (il cantante dei Têtes de Bois, “specialisti”
in Ferré e assidui frequentatori del Festival): più
diretto, concreto, asciutto il primo; più astratto, poetico,
impercettibilmente naïf il secondo.
Concludendo, il Festival Ferré, finalmente raccontato
in questo libro, è un piccolo miracolo (assolutamente
laico!), che ogni anno si compie. Un mondo a parte, che qui
potrete conoscere, un mondo molto diverso da questa nostra bistrattata
quotidianità di cultura in declino e civiltà impazzita.
Un mondo in cui rifugiarci, ma con il quale dobbiamo tentare
di contagiare l'altra realtà, quella un po' grigia di
tutti i giorni.
Se davvero, come dice Léo, “la felicità
è una rapina permanente”, continuiamo ad andare
di terra in terra, di sogno in sogno, di accordo in accordo,
a compiere questo dolcissimo, umano sovversivo illecito.
Margherita Zorzi
Un libro per ricordare Federico Tavan/
Diceva cose, l'hanno colpito
“ ...tutti i lama del Tibet riuniti
possono scuotere sotto le loro sottane l'apocalisse che han
preparato ...”
(A. Artaud)
 Federico
Tavan, se voleva, sapeva farsi ascoltare. Federico
Tavan, se voleva, sapeva farsi ascoltare.
Sarà che diceva cose che nessuno si sarebbe sognato di
ignorare.
Sarà che sapeva come dirle e come scriverle, le cose
che voleva dire.
E sapeva in quale lingua scriverle, nella sua, che dopo tanti
anni è anche un poco la nostra ... o no?
Federico Tavan è stata una intelligenza singolare che
ha indicato luoghi non comuni e aperto inedite visioni sulla
vita ma, direi, soprattutto sulle ipocrisie della nostra società,
e, in particolare di certi ambiti e sistemi.
Il mio incontro con lui mi ha radicalmente cambiato la vita
e mi ha dato prospettive divergenti sulle quali ragionare.
Qui non parlo di un dato estetico, non solo almeno, quanto di
un dato profondamente politico.
E non solo e non tanto perchè Tavan era un proletario
orgoglioso di esserlo e dichiaratamente anarchico ma perchè
tutta la sua vita e il racconto che ne fece fra poesie, lettere
ed altri scritti come le sue memorabili performance ed
il suo ultimo silenzio, lo sono.
La sua poesia non aveva nè ha bisogno di esegeti, critici
letterari: le sue parole sono chiare, dirette, si spiegano da
sole.
Parole autonome nel discorso.
Autonome nel linguaggio, e nella lingua.
È stato triste vedere quest'uomo, nonostante le sue reiterate
denunce anche pubblicate da chi evidentemente non ne comprendeva
il significato, è stato triste vedere questo nostro maestro
e complice, questo compagno di giochi infuocati, affondare nel
vuoto di contesti sociali e culturali a lui estranei, tanto
da scegliere, infine, il silenzio.
Un uomo che scriveva di amare talmente le parole che se le sarebbe
mangiate, arrivò a scrivere “[...] è arrivata
la nausea delle parole [...] Le ultime poesie lette in pubblico
le leggevo con conati di vomito.”
Era il più grande fra di noi e nessuno ha avuto il coraggio
di proteggerlo, forse per rispetto, per pudore, ma la vacua
dabbenaggine delle conventicole provinciali l'ha portato a soffocare
nel silenzio.
Si, è stato triste vedere questo intelligentissimo ermeneuta
della nostra pochezza culturale su ogni prospettiva pedagogica
altra, libertaria, autonoma, venir depotenziato del significato
delle sue stesse parole.
Depotenziato del suo pensiero creatore di significati liberati
e connessioni straordinarie.
Depotenziato da coloro che forse, volendo salvarlo da se stesso,
hanno innescato nel suo straordinario fisico sovversivo la depressione.
Le sue parole, comunque sono ancora lì, per tutti.
Raffaele Lazzara
 Immagine
e realtà
delle donne alle origini del movimento socialistaElena Bignami, nel suo Le schiave degli schiavi. La “questione
femminile” dal socialismo utopistico all'anarchismo italiano
(1825-1917) (Clueb, Bologna, 2011, pp. 295, € 24,00)
dichiara subito quali sono i principali obiettivi del suo lavoro:
quello di «rileggere la storia del socialismo ricollocando
la “questione femminile” nella sua effettiva dimensione
di nodo centrale del dibattito culturale e politico del movimento
operaio» e quello di «indagare più a fondo
il rapporto tra movimento operaio e storia delle donne in Italia»,
in maniera particolare con l'anarchismo. L'autrice snoda la
sua riflessione in quattro densi capitoli, i primi due dedicati
a Socialismo utopistico e “questione femminile”,
gli altri alle Anarchiche in età liberale.
A partire da Claude-Henri de Saint-Simon, per proseguire con
Charles Fourier e il dibattito internazionalista, per citare
alcuni tra i passaggi più significativi, la prima parte
del volume evidenzia «un lunghissimo, accidentato e mai
concluso percorso di inclusione della “questione femminile”»
nell'anarchismo italiano (p. 16). La seconda parte, invece,
dove si ricostruisce la militanza anarchica femminile in età
liberale, è quella in cui si concentra maggiormente l'utilizzo
di fonti inedite ed è condotta privilegiando un taglio
biografico, che vuole far luce sui soggetti e sullo stile politico,
snodandosi principalmente attraverso gli spazi pubblici e privati
di due città: Firenze e Milano.
Tra le numerose questioni affrontate da Bignami, il rapporto
tra spazio, militanza e genere è tra i più significativi:
«Si usciva allo scoperto, ci si affacciava allo spazio
pubblico, o almeno, a quella fetta di spazio concessa e accessibile,
come poteva essere la dimensione collettiva del movimento. Si
diventava conferenziere, organizzatrici, pubbliciste, in una
parola militanti» (p. 170).
Tra i luoghi dove l'impegno politico viene espresso c'è
il caffè, che a fine Ottocento ha perso la sua connotazione
prettamente borghese, ma Bignami deve sottolineare come la presenza
delle militanti «macchiasse indelebilmente la loro integrità
morale e rispettabilità femminile» (p. 176), soprattutto
agli occhi di chi procedeva alla schedatura presso il Casellario
politico centrale. La casa è l'altro luogo dove Bignami
conduce con consapevolezza la riflessione, poiché «si
prestava particolarmente alle caratteristiche della militanza
dell'internazionalista, clandestina e piena di pericoli. Ma
la casa è anche il luogo femminile per eccellenza, lo
spazio fisico nel quale la donna incontra una collocazione precisa
e una riconosciuta legittimazione» (p. 176). Il Vaticano,
in particolare “le stanze della sora Cesira”, cioè
la casa fiorentina di Francesco Pezzi (Forni) e di Maria Luisa
Minguzzi, è uno dei luoghi «di politica, ritrovo
e ristoro» su cui l'autrice si sofferma, restituendo il
profondo e vitale intreccio tra dimensione politica e amicale:
«La casa estende i propri confini, diventa uno spazio
comune collettivo e partecipato, dove si (con)vive, si condivide
e si mescolano inscindibilmente vita e militanza. [...] È
un luogo, dunque, che rassicura, incoraggia e stimola, zona
di mezzo e propedeutica alla partecipazione pubblica femminile
e quindi anche agli spazi politici, un primo palcoscenico verso
la militanza attiva, nel quale le qualità “maschili”
(l'intellettualità) e “femminili” (la competenza
casalinga) possono più agevolmente convivere e compenetrarsi»
(p. 179).
L'intreccio tra pubblico e privato induce l'autrice ad assegnare
una peculiare rilevanza alla dimensione della coppia: «gli
anarchici da sempre hanno condiviso ogni singolo aspetto del
vivere quotidiano, insieme agli ideali la stessa casa, gli stessi
spazi, luoghi ed eventi, nel bene e assolutamente nel male.
Anche gli affetti si consumavano nel circolo ristretto degli
affiliati e non sarebbe potuto essere diversamente, non sarebbe
stato concepibile e materialmente possibile. La rete amicale
diventava, così, la nuova famiglia, solo “di poco”
allargata» (p. 198).
Tornando alla dimensione pubblica della militanza, Bignami sottolinea
le scarse notizie sull'aspetto esteriore delle anarchiche rispetto
ai loro compagni di fede. Tale lacuna, scrive l'autrice, «è
compensata e spiegata dalla spasmodica attenzione che le autorità,
in particolare ma non solo, dedicavano alla condotta morale
femminile in relazione a una presunta condizione “biologica”
delle stesse, riassumibile nella dicotomia tra una missione
naturale di genitrice, e una missione sociale, di custode della
famiglia» (p. 171). Significativa in questo senso è
la rispondenza tra le descrizioni delle militanti e il modello
dell'isterica che si va “scientificamente” definendo
dalla fine dell'Ottocento.
Tra i profili tracciati, tra cui quelli di Leda Rafanelli e
di Nella Giacomelli, si segnala quello di Maria Rygier, che
come guida dell'antimilitarismo consente di riflettere sull'entità
intrinsecamente problematica della leadership politica femminile,
che fa percepire il corpo nella scena pubblica come patologico
o maschile: Maria Rygier «ha tutte le caratteristiche
della sfrontata modalità maschile di fare militanza,
virtù comprese, che addosso a lei, donna, provocano reazioni
contrastanti» (p. 237).
Barbara Montesi
 Anarchia.1/
Al cinema? Solo violenza e ammazzamentiL'anno scorso era The Purge (La notte del giudizio)
poi è arrivato da qualche settimana sugli schermi dei
cinema italiani il sequel Anarchia. La notte del giudizio.
Per i produttori è un ricco business: l'anno scorso hanno
speso per realizzare il primo film 3 milioni di dollari e ne
hanno incassati 90 in tutto il mondo. Adesso sperano di eguagliare
se non superare quella cifra. E non a caso ci hanno piazzato
la parola anarchia. Se c'è sangue, se ci sono tanti morti
e tanta violenza come non pensare che si tratti di anarchia?
E in questa logica Anarchia. La notte del giudizio è
un film che non ha nulla a che vedere con la corrente politico-sociale
conosciuta con il termine anarchia e come la si può intendere
leggendo questa rivista o i tanti libri in circolazione, le
azioni che fanno gli anarchici e le idee che propugnano. No,
in questo film anarchia vuol dire licenza di uccidere. L'azione
si colloca nel 2022 e per una notte le autorità danno
il via libera alla violenza e la gente può uccidere e
farsi uccidere senza nessuna sanzione da parte del potere politico-poliziesco-giudiziario.
In pratica il film è un susseguirsi di scontri a fuoco
fra cattivi e cattivissimi. Di «buoni» neanche parlarne.
Insomma nessuno si sottrae agli scontri e agli ammazzamenti.
Fatta eccezione per un gruppetto, ovviamente armato fino ai
denti, che incontra un uomo superarmato, ma con una personale
missione arrivare a una casa dove sta l'assassino di suo figlio.
E durante questo viaggio ne capitano di tutti i colori (da leggersi
«di ammazzamenti a getto continuo»).
Ma c'è anche un momento di pseudofiction politica quando
il gruppetto viene catturato da una banda agli ordini di ricconi
che non vanno in strada a sparare, ma preferiscono godersi lo
spettacolo della lotta fra i loro mercenari e il gruppetto guidato
dall'uomo superarmato. Altri morti e rivolta del gruppetto con
supereroe che si ribella ai ricconi dopo aver sterminato i loro
mercenari.
Insomma, un film da non vedere e che, come troppe volte succede,
usa il termine anarchia per descrivere situazioni di orrenda
violenza.
Luciano Lanza
Anarchia.2/
Cogliamo gli spunti di riflessione
“Prima che tale organamento incominciasse ad essere considerato
come possibile e desiderabile da tutta una categoria di pensatori,
[...] la parola anarchia era presa universalmente nel senso
di disordine, confusione; ed è ancor oggi adoperata in
tal senso dalle masse ignare e dagli avversari interessati a
svisare la verità”. (Errico Malatesta, L'Anarchia,
Nova Delphi Libri, Roma, 2013, p. 21)
È proprio questo ciò che è successo con
il film Anarchia. La notte del giudizio (2014, James
DeMonaco), i cui autori hanno deciso di rinominare impropriamente
una situazione di totale violenza e prevaricazione con il nome
di una filosofia che niente ha a che vedere con quanto si svolge
sulla scena.
Il film è un racconto distopico ambientato in una Los
Angeles di un futuro molto prossimo (è il 2022). A seguito
di un cambio di regime in chiave autoritaria, gli Stati Uniti
d'America si trovano votati a nuovi Padri Fondatori i quali
sembrano aver portato il paese entro una situazione di benessere
economico e sociale non indifferente, con un tasso di disoccupazione
al 5% e una stabilità sociale apparentemente invidiabile.
Tale obiettivo sarebbe stato raggiunto grazie alla decisione
delle autorità di permettere alla popolazione di dare
sfogo, una volta all'anno, alle pulsioni più cupe senza
cadere vittima della legge. Per 12 ore, infatti, il ricorso
alla violenza è concesso e totalmente impunito.
Lo spettatore è indotto fin da subito a capire come la
decisione del governo di permettere alla violenza sociale di
esplodere ricada interamente sulle fasce più povere della
popolazione; ecco spiegati i dati socio-economici favorevoli:
l'uso della violenza è chiamato a risolvere arbitrariamente
e brutalmente il problema della redistribuzione e della disuguaglianza.
Negli Stati Uniti del 2022, la povertà è combattuta
eliminando fisicamente gli appartenenti alle classi meno abbienti.
L'esito di questa nuova ritualità introdotta dal governo
è quello di una classe ricca che continua ad aumentare
le proprie ricchezze grazie alla progressiva eliminazione del
problema della redistribuzione dei profitti, della diseguaglianza
e del malcontento sociale.
Nonostante il film sia pensato per la fruizione da parte di
un grande pubblico e non contenga al proprio interno una critica
socio-economica ben ponderata, dà modo allo spettatore
di interrogarsi sul tema del conflitto sociale, della lotta
di classe e della prevaricazione dei ceti privilegiati nei confronti
di chi è posto alla base della piramide.
All'inizio del film, l'errore più grave commesso da James
DeMonaco, sceneggiatore e regista, sembra la decisione di denominare
una situazione di caos e violenza gratuita con il termine Anarchia,
come a dire che quelli mostrati siano gli esiti di una libertà
che gli esseri umani non sono in grado di gestire: lascia liberi
gli uomini e avrai delitti, abusi e prevaricazioni! La scelta
del titolo pare quindi far capo a quell'errore, dettato dalla
non conoscenza, che fa credere ai più che anarchia
sia sinonimo di caos.
Col passare dei minuti però, il regista ci svela che
la popolazione americana non è affatto libera come crede.
Le violenze infatti sono permesse da un governo autoritario
che concede ai propri cittadini di 'sfogarsi' secondo
delle precise direttive; inoltre, interi eserciti governativi
sono riversati nelle strade per commettere in prima persona
violenze contro le classi più povere, prendendo letteralmente
di mira e assaltando i quartieri popolari, al fine di mantenere
un equilibrio sociale in favore dei privilegiati.
Ecco forse lo sbaglio più grande: la scelta dagli autori
è stata probabilmente quella di definire come anarchica
una situazione di abuso di libertà; in verità
quella raccontata nella pellicola è una realtà
in cui regna un completo assoggettamento del popolo americano
al nuovo regime. In questa storia distopica non è presente
alcun esercizio di libertà, ma solo un assoluto asservimento
di individui in balia di poteri esercitati nei loro confronti.
Tanto per la deriva del conflitto sociale quanto per i dubbi
sollevati dalla scelta del titolo, La notte del giudizio
può intendersi come buona palestra per lo sviluppo di
riflessioni, non solo su questioni politiche e socio-economiche,
ma anche sulle erronee definizioni mainstream di libertà
e anarchismo.
Carlotta Pedrazzini
Costruzioni
sul nulla
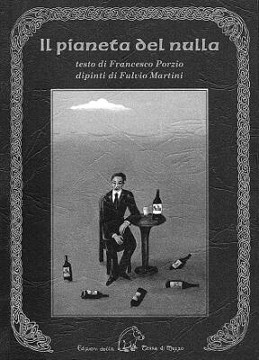 Nel
leggere Il pianeta del nulla di Francesco Porzio e Fulvio
Martini (Edizioni della Terra di Mezzo, Milano, 2010, pp. 244,
€ 25,00) ci troviamo di fronte a un breve racconto che
attraverso l'idea – peraltro già collaudata da
autori sia lontani nel tempo, come Swift e Abbott, che più
vicini a noi, come Orwell e Huxley – di una storia di
pura fantasia, se non di fantascienza, descrive la nostra vita
sulla Terra al giorno d'oggi. Nel
leggere Il pianeta del nulla di Francesco Porzio e Fulvio
Martini (Edizioni della Terra di Mezzo, Milano, 2010, pp. 244,
€ 25,00) ci troviamo di fronte a un breve racconto che
attraverso l'idea – peraltro già collaudata da
autori sia lontani nel tempo, come Swift e Abbott, che più
vicini a noi, come Orwell e Huxley – di una storia di
pura fantasia, se non di fantascienza, descrive la nostra vita
sulla Terra al giorno d'oggi.
Siamo a bordo di un'astronave dove un essere proveniente da
un altro pianeta, mandato in ricognizione esplorativa sul nostro,
al fine di verificare la pericolosità dei suoi abitanti,
sta preparando un rapporto descrittivo delle condizioni di vita,
abitudini, aspetto fisico, religioni, credenze e altro riguardante
gli stessi, da inviare ai suoi superiori.
Sei capitoli/notizie più una breve conclusione. Un lungo
racconto che, col tono leggero di chi osserva dall'alto l'altrui
stupida follia, descrive la vita di questa scimmia glabra di
scarsa intelligenza, divenuta predominante su un pianeta che
ha distrutto quasi completamente. Siamo noi gli yugwgnum,
non vi è alcun dubbio, il riconoscimento è voluto
e immediato. Leggiamo velocemente la nostra storia sciagurata
e, una dopo l'altra, passiamo in rassegna le immagini che, in
abbondanza, la illustrano con efficace ironia, fino ad arrivare
all'ultima pagina, alle conclusioni nelle quali viene suggerita
l'eliminazione definitiva del pianeta per non correre il rischio
che i suoi abitanti se ne vadano in giro a infestare il resto
dell'universo con la loro violenza, la loro stupidità
e il loro odore insopportabile.
Un'esagerazione dunque, utile ai fini della scrittura? Niente
affatto purtroppo. Di veramente inventato c'è solo l'extraterrestre
e la sua risoluzione finale. Tutto il resto è l'oggi,
al massimo tra qualche decennio. Cito qua e là dalle
Informazioni generali sul pianeta degli yugwgnum:
“Dapprima la sua furia si è rivolta contro gli
”animali“ (così essi chiamano le altre creature,
di gran lunga meno feroci) e contro gli individui della stessa
specie, poi contro il pianeta stesso. Nessun altro essere vivente,
che io sappia, ha praticato l'omicidio con la stessa continuità
e determinazione. L'ultimo rapporto riferiva di un conflitto
planetario che avrebbe causato (si direbbe fantascienza!) più
di settanta milioni di morti. Ma a ben guardare tutta la loro
storia non è altro che una serie ininterrotta di soprusi,
assassini, devastazioni e stermini di massa. [...]”
Ci si è chiesto come fosse possibile un fenomeno di tali
proporzioni. Sono state formulate diverse teorie a riguardo.
Una delle più accreditate punta sulla natura sociale
di questa scimmia gregaria, che nel corso della sua abnorme
proliferazione avrebbe mantenuto le caratteristiche essenziali
della vita di branco. Ciò avrebbe determinato la persistenza
di un gran numero di individui dotati di modeste capacità
intellettive e facilmente manipolabili dai capi branco di turno.
Questa teoria ha una parte di verità ma non basta a spiegare
come milioni di scimmie “sapienti” (così
si autodefiniscono!) vengano convinte con estrema facilità
a commettere o a legittimare le più bestiali atrocità
e ingiustizie.
“Anche la teoria “culturale” non è
del tutto soddisfacente. È vero che questi bizzarri individui
hanno elaborato dei codici (le cosiddette “verità”
religiose o ideologie) che poi hanno attribuito a una divinità
superiore [...] per trarre vantaggio dalla credulità
dei loro simili. È vero che alcuni di loro, essendo riusciti
a spacciarsi per gli intermediari di tale “divinità”,
hanno spinto questi esseri dalla mente debole a sottomettersi
e a riprodursi senza controllo. La fede cieca in tali fantasmi
li avrebbe privati di ogni dubbio e responsabilità, convincendoli
a commettere le azioni più crudeli nel nome di concetti
astratti e insensati. Per quanto possa sembrare assurda, pare
che l'analisi poggi su riscontri obbiettivi. [...] Ti ricordi
le risate quando l'istruttore ci raccontava che una volta dei
gruppi di yugwgnum si sono trovati a fronteggiarsi e ognuno
pretendeva di essere quello “eletto da Dio”? [...]
La specie dominante si è differenziata ancora di più
dalle altre [...] per il suo bizzarro stile di vita che in tempi
recenti [...] l'ha portata ad alterare completamente il rapporto
con la natura e con gli altri esseri viventi”.
E così prosegue, nei restanti cinque capitoli, descrivendo
“bizzarri” stili vita, abitudini e abitudine ai
falsi sentimenti che hanno costruito una società intessuta
di azioni e parole vuote, una civiltà fondata sul nulla
che sta prendendo il sopravvento su tutto il pianeta riducendolo
a un pianeta del nulla.
Un'esagerazione dunque, utile ai fini della scrittura?
Abbiamo tra le mani un magnifico racconto o un'opera letteraria
imperdibile e finemente illustrata? Secondo me no e secondo
me questo lo sanno bene anche autore e illustratore. È
un libro però che nasce da un'urgenza, dalla consapevolezza
improcrastinabile che la nostra situazione si è fatta
veramente troppo seria per lasciar correre, così seria
e paradossale da apparire ridicola se guardata con molta, molta
distanza.
Forse gli yugwgnum migliori di quelli descritti sono qualcuno
in più di quelli riconosciuti nel racconto? Forse qualche
angolo salvabile c'è ancora? Certamente, può darsi,
ma che differenza fa?
Di sicuro c'è grande necessità di libri come questo,
come di tutte quelle azioni, parole, immagini che contribuiscono
in vario modo a smontare il castello di ipocrisia e falsità
sul quale si regge la nostra “civiltà”, la
sua finta cultura e la sua arte per allocchi, lasciando cadere
i frantumi nel vuoto.
Infatti uno degli autori del testo lo ritroviamo impegnato in
un'operazione affine, anche se di stampo completamente diverso,
quando scrive Sfratto/manifesto per un'arte futura -
apparso sull'ultimo numero della rivista di cultura libertaria
“ApArte” e precedentemente pubblicato dalla “casa
editrice” Libera e senza impegni - dove denuncia,
con esasperata passione, il desiderio di successo travestito
da gesto creativo che la fa da padrone nei territori dell'arte
visiva e non solo.
Gli autori quindi - cito dal risvolto di copertina - sono un
critico d'arte che ne ha abbastanza della falsità dell'arte
e un artista che ne ha abbastanza della falsità della
critica. Così invece di fare un catalogo di dipinti con
commenti appropriati, cioè qualcosa di “attuale”
e “calato nel nostro tempo”, ironizzano loro, hanno
pensato al suddetto racconto. Per il testo sto parlando dello
storico dell'arte Francesco Porzio - di cui “A”,
nel numero estivo (“A” 391) riporta una
lettera (in risposta a Federico Zenoni), nel capitolo dedicato
alla psicoeditoria creativa e autoprodotta – e per le
immagini di Fulvio Martini, pittore, scrittore ed erborista.
Silvia Papi
L'anarchismo,
uno stile di vita
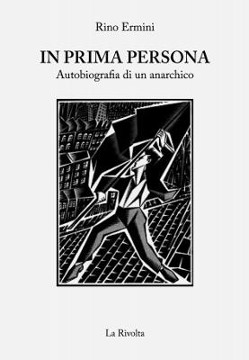 Se
assumiamo la classica definizione di generazione come un assieme
di individui che hanno vissuto le medesime esperienze significative,
che ne sono stati segnati e che hanno agito misurandosi con
le stesso ordine di questioni, si coglie subito il fatto che
il testo di Rino Ermini (In prima persona. Autobiografia
di un anarchico, La Fiaccola, Ragusa, 2014, pp. 88, €
6,00) tanto più è una narrazione di vicende individuali
quanto più è testimonianza di un'avventura collettiva. Se
assumiamo la classica definizione di generazione come un assieme
di individui che hanno vissuto le medesime esperienze significative,
che ne sono stati segnati e che hanno agito misurandosi con
le stesso ordine di questioni, si coglie subito il fatto che
il testo di Rino Ermini (In prima persona. Autobiografia
di un anarchico, La Fiaccola, Ragusa, 2014, pp. 88, €
6,00) tanto più è una narrazione di vicende individuali
quanto più è testimonianza di un'avventura collettiva.
Attraverso la narrazione della sua avventura esistenziale Rino
Ermini descrive uno spicchio significativo del formarsi di una
generazione militante anarchica, e non solo, nell'Italia fra
la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, del suo agire,
in un contesto straordinario quale è stato il maggio
rampante italiano sulla base della visione del mondo alla quale
è pervenuta e delle sue sconfitte.
Naturalmente vi è nel percorso di Rino un riferirsi a
vicende, ambienti, accadimenti specifici e, sebbene non vengano
mai esplicitamente dichiarati, un punto di vista ed un modo
di porsi originali non, ovviamente, nel senso della narcisistica
ricerca di un'originalità intesa come solipsistica autoaffermazione
ma in quello proprio di percorso fortemente radicato in un vissuto
ed in un ambiente specifici.
L'anarchismo di Rino Ermini nel suo formarsi è assolutamente
“classico” rispetto ai tempi ed al contesto, affonda
le sue radici nella tradizione del movimento operaio toscano,
nella memoria della resistenza, nelle lotte giovanili e studentesche
del tempo.
In questo senso un amante della tassonomia lo potrebbe definire
“movimentista”, sebbene infatti Rino sia stato nel
corso degli anni '70 membro di gruppi anarchici fra Scandicci
e Firenze, è evidente che il centro del suo essere anarchico
è il partecipare alle lotte sul territorio, il vivere
l'anarchismo come stile di vita, sistema di valori, prassi trasformativa.
Da ciò il suo non apprezzare lo polemiche che divisero
allora (solo allora?) il movimento anarchico, polemiche che
trascesero sin troppo spesso in ostilità reciproche fra
compagni che pure erano divisi da dettagli, e il porre l'accento
sull'iniziativa dal basso in quartiere, nei luoghi di lavoro
che ha frequentato, nei movimenti.
Come rilevavo, Rino narra, soprattutto per quel che riguarda
gli anni '70 ed i primi anni '80 di una serie di vicende che
caratterizzarono il movimento a Firenze, di incontri, di scoperte,
di esperienze.
Ammetto che leggendo le sue memorie più di una volta
ho sorriso ripensando a compagni e vicende del tempo che conoscevo
in qualche misura e ai quali Rino fa cenno.
Ad esempio, Rino ricorda “Gianni Carrozza [...] valente
compagno anarchico, che lavorava a una tesi su Camillo Berneri
e che voleva farla talmente bene che non so se l'abbia mai conclusa”.
Io che di Gianni Carrozza sono stato, e sono, sodale, posso
tranquillizzare Rino, con la sua tipica velocità da bradipo,
Gianni ha concluso la sua tesi che effettivamente gli ha preso
moltissimo tempo e il suo lavoro su Berneri è tuttora
importante, basta pensare alle recente edizione degli “Scritti
scelti” di Camillo Berneri a cura di Zero in Condotta
alla quale Gianni ha collaborato.
Nondimeno leggendo quanto ne scrive Rino, mi torna alla mente
la casa in Via Puccinotti a Firenze dove Gianni abitava con
altri compagni, che io stesso ho frequentato a lungo e dove
intere nottate venivano dedicate a discussioni indiavolate sui
massimi sistemi ed al consumo di golosi salumi calabresi.
Rino di quell'ambiente ricorda in particolare un compagno, noto
come “il cittadino”, così si faceva chiamare
giacché sosteneva che il temine “compagno”
è troppo impegnativo, e che anch'io conoscevo bene come
un tipo ameno.
Possono questi ed altri sembrare dettagli di poco conto ma li
cito perché si colga l'intento dell'autore di rendere
conto del vissuto quotidiano di un milieu che allora
si costituì e che tentò di mettere in discussione
l'esistente (perché rimuoverlo?) sia nel senso di fare
effettivamente una rivoluzione che in quello di cambiare nell'immediato
la vita quotidiana sulla base dei valori di eguaglianza e libertà,
rompendo radicalmente con il conformismo imperante e costruendo
un proprio spazio, una sorta di inframondo che solo la sconfitta
che venne alla fine del maggio rampante spazzò via.
Le memorie di Rino ovviamente non si fermano al maggio rampante,
in particolare importante è la narrazione del passaggio,
attraverso una serie di lavori, alla condizione di insegnante.
Come credo sia abbastanza noto, Rino Ermini, e lo rivendica,
ha vissuto l'insegnamento come un'occasione importante per mettere
in pratica i propri convincimenti per quanto riguarda la pedagogia,
tema al quale ha dedicato alcuni opuscoli e molti articoli.
In questo senso lo si può considerare una persona meritatamente
fortunata visto che ha svolto a lungo un lavoro che ama e nella
cui pratica ha potuto tradurre nei fatti le sue idee.
Ancora una volta si può parlare di un anarchismo attivo,
vissuto, saldamente impiantato nelle relazioni sociali che hanno
caratterizzato la sua vita. Se nella natia Toscana Rino si collegava
a robuste radici contadine e proletarie, nel lavoro di insegnante
ha potuto e saputo costruire nuove relazioni e nuove esperienze
sulle quali, proprio perché note, non mi dilungo.
Infine, se dovessi segnalare un pregio, forse il pregio,
di questo lavoro, credo consista proprio nella relazione stratta
fra ciò che un tempo i compagni chiamavano con orgoglio
l'Idea e la pratica quotidiana, nel non volersi impancare a
maestro di una qualche verità valida per tutti ma nel
dare un contributo, un contributo utile, ad un'avventura collettiva
tutta in divenire.
Cosimo Scarinzi
Una
fiaba
fuori mercato...
 Quanti
anni aveva George Sand quando pubblicò La storia del
vero Gribouille? Quanti
anni aveva George Sand quando pubblicò La storia del
vero Gribouille?
La dedica dell'opera alla signorina Valentine Fleury porta la
data del 26 luglio 1850. Dunque George Sand aveva quarantasei
anni: l'età della piena maturità. Perlomeno dal
punto di vista anagrafico.
Ma sentite come descrive alla signorina Fleury l'epilogo dello
scontro tra l'esercito del signor Calabrone, composto da miliardi
di calabroni, bombi e vespe, e quello delle api:
«Alla fine i bombi rimasero padroni del campo di battaglia,
e allora iniziò un'orgia immonda. I vincitori, rimpinzandosi
di miele in mezzo alle vittime e camminando sui cadaveri delle
madri e dei bambini, si ubriacarono in modo talmente indecente
che molti creparono d'indigestione, rotolando alla rinfusa tra
i morti e i moribondi.»
Questo passaggio, come numerosi altri della narrazione, testimonia
non soltanto della piena maturità anagrafica e professionale
di George Sand, al secolo Madame Amandine-Lucie-Aurore Dupin,
ma anche di una sua conoscenza dei fatti del mondo e della natura
umana che non si nasconde dietro nessuna ipocrisia.
Se sostituissimo alla parola “bombi” qualsiasi altro
nome di persona, esercito o masnada, potremmo sentir vibrare
nel racconto tutto l'orrore e la brutalità delle attuali
cronache di guerra.
George Sand però, per sua stessa ammissione alla signorina
Fleury, sta scrivendo una “fiaba”.
Il suo eroe è Gribouille, uno “scarabocchio”:
un ragazzino di dodici anni ritenuto sciocco da tutti, genitori
compresi. E questo perché?
Perché in un mondo dove «I padri rimproveravano
ai figli di non crescere abbastanza in fretta per guadagnare
denaro; i figli rimproveravano ai padri di non morire abbastanza
presto per lasciargliene», Gribuille si ostina a rifiutarsi
di imparare a «uccidere e saccheggiare».
Che tenacia, questa Madame Dupin! Due anni dopo essere scesa
dalle barricate del '48 scrive una fiaba il cui eroe è
niente po' po' di meno che un idealista. Proprio lei che, delusa
dagli esiti delle giornate di giugno, scelse di ritirarsi per
il resto della vita – circa trent'anni – a Nohant,
in campagna.
Di che cosa parla questa fiaba?
Parla di ricchi e di poveri. Di genitori e di figli. Di soldi.
Parla d'amore e di giustizia. In sostanza, dice del senso della
vita.
Con uno stile asciutto, la prolifica scrittrice francese ci
guida attraverso la sua personale visione del mondo. Decisamente
cruda! Di chi ha partecipato appassionatamente alle vicende
politiche del suo tempo, si è tirato in disparte, e ha
scelto di osservare con occhi, orecchie e cuore bene aperti.
Dei poveri fa dire alla regina dei prati che «fanno
come i ricchi, si uccidono tra loro e depredano a più
non posso; è una guerra continua».
Dei geni fa dire al signor Calabrone che «si tratta
di veri cretini» perché fanno voto «di
servire, proteggere e amare tutto quello che respira».
«La cosa migliore, secondo me, è invece lasciar
lavorare gli altri, e prendere; prendere, prendere!»
afferma Calabrone. «Con la forza o l'astuzia, ragazzo
mio, ma è l'unico mezzo per essere sempre felici.»
Alla signorina Valentine Fleury l'anticonformista George Sand
non risparmia davvero nulla.
Allora perché leggere questa durissima metafora della
vita?
Perché è scritta con onestà. Con intelligenza.
Perché, come la vita, è piena di poesia e di sorprese.
E vale la pena leggerla soprattutto da grandi, per ammirare
la risolutezza del piccolo Gribouille senza vergognarsi di parteggiare
per lui, anzi! Per voler prendere esempio da quel babbeo!
Sulla montagna di cenere dell'epilogo spunta infine «un
bel fiore che chiamano “non ti scordar di me”».
È la speranza, alla quale l'Autrice della fiaba comunque
non vuole rinunciare.
La speranza di un mondo nuovo.
«La qual cosa danneggiò i procuratori e gli
avvocati che avevano pullulato ai tempi del re Calabrone. Ma
si misero a fare altri mestieri, perché venne anche il
momento in cui non ci furono più processi e in cui tutti
erano d'accordo su tutto.»
E il lieto fine si rivelerà alla fine ancora più
lieto... Ma solo in questa favola.
(George Sand, La storia del vero Gribouille, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano, 1988)
Emanuela Scuccato
|

