|
dibattito
Il suicidio del capitalismo?
di Enrico Maltini
con uno scritto di David Graeber
Con il suo libro Il capitale nel XXI secolo, l'economista francese Thomas Piketty ha messo in crisi gli adepti dell'attuale struttura capitalistica.
Questo sistema sarebbe irrimediabilmente minato dall'aumento insostenibile delle diseguaglianze. Per questo la questione della distribuzione della ricchezza andrebbe oggi posta al centro.
“la libertà politica senza
eguaglianza economica è un inganno, una frode, una bugia”
Michail Bakunin
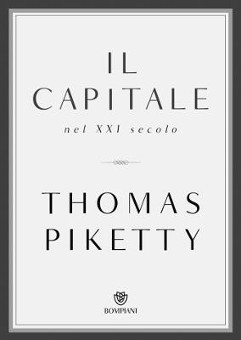 “Credo
nel capitalismo, nei mercati aperti e nella proprietà
privata...” sono parole di Thomas Piketty che si possono
leggere nell'inserto culturale del Corriere della Sera
del 9 ottobre scorso. E proprio questo è il bello: perché
uno che nel capitalismo ci crede, sta provocando da qualche
tempo una crisi di sconforto negli adepti dell'attuale struttura
del capitale, dei mercati aperti e della proprietà privata.
Contraddizioni in seno al capitalismo? Vediamo. “Credo
nel capitalismo, nei mercati aperti e nella proprietà
privata...” sono parole di Thomas Piketty che si possono
leggere nell'inserto culturale del Corriere della Sera
del 9 ottobre scorso. E proprio questo è il bello: perché
uno che nel capitalismo ci crede, sta provocando da qualche
tempo una crisi di sconforto negli adepti dell'attuale struttura
del capitale, dei mercati aperti e della proprietà privata.
Contraddizioni in seno al capitalismo? Vediamo.
Il capitale nel XXI secolo. Con questo titolo temerario,
l'economista francese Thomas Piketty ha pubblicato nel 2013
un volume di oltre 900 pagine (nella traduzione italiana di
Bompiani, 2014, 22 euro), che chi scrive non esita a definire
sorprendente. Sorprendente in primo luogo perché
comprensibile ai non addetti e di facile e perfino piacevole
lettura, cosa di per sé straordinaria per un testo di
economia, poi perché già nella premessa espone
i risultati più significativi, così che chi vuole
si accontenta e chi non si accontenta può approfondire
i diversi aspetti leggendo i capitoli relativi, ciascuno dei
quali ha un senso compiuto. Sorprendente infine perché
ha suscitato dibattiti accesi tra gli economisti, gettando nella
costernazione gli adepti dell'accademia, egemonizzata dal pensiero
neoliberale. Il dramma di quest'ultima è che il soggetto
non può essere tacciato di essere marxista né
anarchico né comunque un rivoluzionario antisistema.
E perché lo sconforto? È che costui ha dimostrato
con una serie di numeri, dati e diagrammi di “precisione
atroce e difficilmente confutabile”, che in un regime
capitalista, se non intervengono fattori esterni di disturbo,
i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre
più poveri, ma alla fine inevitabilmente tutto il sistema
va a rotoli.
Un trattato su uguaglianza e disuguaglianza
Il libro tratta del “Capitale” considerandone l'aspetto
più essenziale e meno dibattuto: la sua distribuzione
tra gli abitanti in tempi e luoghi diversi ed è di fatto
un grande trattato sull'uguaglianza e la disuguaglianza. L'autore
parte da una constatazione semplice ma fondamentale, quasi tautologica:
in ogni dato momento il mondo, o una parte di esso, ha una ricchezza
data, nè più nè meno, dunque la questione
fondamentale dell'economia, la sola che davvero conta, è
come quella ricchezza si distribuisce fra gli abitanti. Un argomento
che gli economisti hanno sempre trattato poco, lasciandolo semmai
ai politici e ai sociologi. Ma politici e sociologi non hanno
il rigore del ricercatore e hanno in compenso una ideologia
di riferimento che falsa inevitabilmente l'analisi. Inoltre
l'autore del libro non ha alcuna pretesa di costituire una teoria
economica, ma solo di osservare l'andamento delle disuguaglianze
nell'ambito del sistema reale e individuarne, più che
le ragioni primarie, che sono materia di più alta speculazione
socio-politica e filosofica, le cause contingenti e le loro
correlazioni. L'interesse e l'urgenza, dell'argomento
viene rimarcata da Piketty perché a suo giudizio tali
disuguaglianze possono diventare, e stanno diventando, insostenibili
tanto da pregiudicare lo stesso sistema capitalistico. “L'economia
deve rimettere la questione della distribuzione del reddito
al centro dell'analisi economica” scrive, e per far questo
la questione deve essere considerata, nella misura del
possibile - l'economia non è una scienza esatta - con
un approccio scientifico, politicamente laico, e fondato
su numeri, fatti e dati.
Come in ogni lavoro di ricerca che si rispetti, la “parte
sperimentale” è preceduta da una trattazione -
quella che nelle pubblicazioni scientifiche prende il nome di
“materiali e metodi” - ove l'autore descrive le
fonti dei dati e la metodologia di elaborazione. Seguono l'analisi
critica dei dati raccolti, la discussione dei risultati e le
conclusioni. In verità, in questo caso proprio la ricerca
e la raccolta dei dati, attinti da fonti storiche largamente
inesplorate e su lunghi periodi di tempo è forse la parte
più sostanziosa del lavoro, tanto che la loro sempilce
esposizione è di per sè estremamente eloquente.
In nome della trasparenza, e a suo dire per favorire critiche
e contributi, l'autore ha messo tutti i dati originali e i dettagli
delle metodologie di elaborazione in un sito internet consultabile1.
Rispetto al quadro storico e geografico, la trattazione parte
dai pochi dati disponibili sulla situazione nel XVIII secolo,
fino ai dati e alle statistiche sempre più attendibili
dei tempi nostri (al 2010-2012 per l'esattezza), con un riferimento
in particolare a Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e
Regno Unito, ma che si estende ad altre parti del mondo. Una
mole di dati davvero impressionante, che giustifica l'entità,
anche ponderale del volume.
Piketty richiama brevemente le classiche teorie economiche:
da Robert Malthus (Saggio sul principio di popolazione,
1798) per il quale l'aumento vertiginoso della popolazione dei
contadini poveri a cavallo del 19° secolo si prospettava
come il vero problema che terrorizzava la ricca nobiltà,
a David Ricardo (Principi dell'economia politica e dell'imposta,
1817) per il quale la crescita continua della popolazione, a
fronte di una quantità finita di terre coltivabili, avrebbe
alla lunga creato pochi ricchissimi proprietari e uno stuolo
di contadini miserabili, con inevitabili rivolte e sconquassi
sociali. Per inciso Ricardo (già allora più avanti
di Matteo Renzi?), proponeva come efficace rimedio una forte
imposta fondiaria: l'aborrita patrimoniale, come diremmo
oggi.
Cinquant'anni dopo Karl Marx pubblicava il primo libro del Capitale,
ove non più di una società agricola si trattava,
ma di una dinamica industriale in pieno sviluppo e in mano a
pochi non più latifondisti, ma veri “capitalisti”,
cui faceva fronte lo sfruttamento di schiere non più
di contadini ma di un proletariato industriale, altrettanto
miserabile. Con la crescita della popolazione, l'esodo dalle
campagne e il capitale industriale che - a differenza di quello
fondiario - non è limitato e consente un'accumulazione
infinita, arriverà quello “spettro che si aggira
per l'Europa, lo spettro del comunismo”, che condurrà
all'inevitabile vittoria finale del proletariato. Non è
andata esattamente così... ma quella è un'altra
storia.
Meriti e demeriti di quelle e di altre teorie meno note vengono
discussi e una prima osservazione che ne deriva è che
in economia ogni determinismo, anche relativo alle origini delle
disuguaglianze, è fallace: non esistono meccanismi puramente
economici perché sempre i cambiamenti politici e sociali,
l'incidenza di guerre e rivoluzioni, tanto sociali che tecnologiche,
e/o di altri eventi straordinari, catastrofici nel senso
proprio di “capovolgimenti”, ne modificano l'evoluzione.
Una seconda “lezione”, che è tra i nodi centrali
del libro, è che “la dinamica della distribuzione
delle ricchezze si muove su fenomeni di grande portata”
e non esiste alcun naturale meccanismo intrinseco che determina
nel tempo una riduzione delle differenze (come è invece
tesi di tutte le ideologie liberali, a partire dalla mitica
mano invisibile del mercato, di Adam Smith2).
Di fronte alla serie storica dei livelli di uguaglianza-disuguagliaza
nei diversi paesi l'assioma liberista secondo cui il “libero
mercato” senza vincoli e regole e fondato sul solo meccanismo
domanda-offerta, determinerebbe il migliore dei mondi possibili3
e il più democratico, frana fragorosamente. Non a caso
uno dei (pochi) tentativi nostrani di confutare le teorie di
Piketty è firmato da Oscar Gianninio, in un blog che
ha come motto “Perchè il mercato ha ragione anche
quando ha torto”. Tutto dire, quanto a fanatismo ideologico!
Viceversa, il libro è stato giudicato fondamentale da
ben altri economisti “eretici” quali il premio Nobel
Peter Krugmann e Joseph Stigliz.
Quanto sono grandi le disuguaglianze?
Un buon indicatore del livello di disuguaglianza in un paese
è la quota di reddito che il 10% (il decile) più
ricco della popolazione ha in rapporto al reddito globale4.
Tale quota risulta, ad esempio negli Stati Uniti tra il 1910
e il 1920 del 40% circa (ossia il 10% più ricco si spartiva
il 40% del reddito globale, lasciando il restante 60% per il
90% della popolazione), la quota cresceva fino ad oltre il 45%
nel 1940, scendeva improvvisamente al 35% tra il 1940 e il 1980,
per poi risalire costantemente, raggiungendo il 50% circa nel
dato del 2010. Un andamento ad U che si ripete nei paesi occidentali,
con ordini di grandezza simili.
Ma dobbiamo anche sapere che dentro quel 50-60% del reddito
che va al 90% dei meno ricchi, si nasconde un'altra enorme sperequazione:
al 50% dei più poveri, ovvero il 30% della popolazione,
tocca una quota che va dal 2 al 5% del totale (il 4% in Francia,
il 2% negli USA).
Dati analoghi sono spesso riportati dai media, con una qualche
indignazione per la palese ingiustizia che descrivono, ma con
molto meno impegno nell'indagare sulla loro origine e ancor
meno sui possibili rimedi. Tanto ci pensa, come sappiamo, la
mano invisibile...
II dati sopra riportati sono un esempio ma nel libro che, ripetiamo,
è tutto impostato sulla misura delle disuguaglianze,
troviamo un'infinità di altri dati, rapporti e correlazioni
sulle divergenze di reddito e di capitale nei diversi paesi,
dagli Stati Uniti alla Scandinavia, dal Giappone all'Africa
sub-sahariana e nelle diverse epoche. Una mole di dati troppo
difficile da sintetizzare.
Diciamo solo che il reddito medio nei paesi ricchi è
oggi di 2500-3000 euro mensili, nei più poveri di 150-200
euro mensili e la media mondiale di 600-800 euro mensili, è
su questi valori medi che si innestano mostruose disuguaglianze.
Qual è il primo motore delle divergenze?
Il tema dell'origine e dell'evoluzione delle differenze è
il nucleo centrale del libro: secondo l'autore in un regime
capitalistico puro, in assenza di turbamenti extra-ordinari,
il fattore principale da cui derivano uguaglianza e disuguaglianza
è il rapporto tra reddito del capitale e reddito del
lavoro. Questa la spiegazione:
in un dato tempo e in un dato luogo, in un piccolo villaggio
come nel mondo intero, l'economia risponde ad una equazione
semplice:
la ricchezza R, intesa come reddito nazionale
globale, è data dalla somma dei redditi da capitale r
e dei redditi da lavoro g.
R = r + g
Piketty individua un fattore fondamentale di divergenza quando
r > g, ovvero quando, per un periodo relativamente
lungo, i redditi da capitale sono maggiori dei redditi da
lavoro.
Il rapporto fra i due si può valutare in modo conveniente
esprimendo il valore complessivo dei patrimoni privati
(immobiliari, finanziari e di investimento, al netto dei debiti)
in annualità del reddito nazionale (cioè
del reddito, la ricchezza, prodotta in un anno nel paese5).
Ad esempio in Francia risulta che il rapporto capitale/reddito
nazionale equivale per tutto il XVIII e XIX secolo, fino al
1914, a circa sei-sette annualità di reddito (cioè
i patrimoni dei soggetti privati avevano un valore complessivo
sei-sette volte superiore al reddito nazionale annuale). Il
rapporto crolla bruscamente in conseguenza della prima guerra
mondiale, delle crisi tra le due guerre e della seconda guerra
mondiale, arrivando negli anni tra il '20 e il '50 del secolo
scorso a due-tre annnualità. Dopodichè il rapporto
riprende a salire e da allora ad oggi non ha più smesso
di crescere. Un andamento del tutto simile si osserva nel Regno
Unito. Scopriamo così che siamo oggi tornati ad un rapporto
patrimonio/reddito della nazione, simile a quello della “Belle
Epoque”, alla vigilia della grande guerra!
Oggi, in Europa e Stati Uniti, il reddito nazionale pro capite
è stimato intorno a 30.000-35.000 euro, mentre il capitale
privato si aggira intorno ai 150-200.000 euro pro capite (dunque
un rapporto tra 5 e 6). Pro capite significa che sarebbero
questi i numeri per ciascuno di noi, se non ci fossero le micidiali
disuguaglianze di cui sopra.
Per chi - come chi scrive - non mastica più che tanto
di economia, è bene ricordare che il reddito è
un flusso di ricchezza, che ogni anno si produce in un
paese, mentre il capitale è uno stock, un serbatoio delle
ricchezze accumulate nel tempo dagli abitanti. Di fatto, il
reddito nazionale è molto vicino al fatidico pil (prodotto
interno lordo), quello che ogni sera ci assilla nei telegiornali.
Ma quale è la causa prevalente di un andamento economico
in cui il reddito da capitale rimane a lungo maggiore del reddito
da lavoro? La risposta appare fin banale: è un regime
di crescita relativamente lenta, o addirittura nulla ed è
esattamente la condizione in cui si trova l'Europa oggi, con
un Italia che più che crescere lentamente, non cresce
affatto.
Il meccanismo che correla una crescita debole a un incremento
della disuguaglianza viene così spiegato da Piketty:
“Avviene che nelle società a crescita debole i
patrimoni ereditati dal passato assumono naturalmente un rilievo
sproporzionato rispetto al debole flusso del tasso di crescita.
In queste condizioni il rendimento del capitale investito (in
azioni, obligazioni, terreni, immobili o altro) supera il reddito
del prodotto che si ricava dal lavoro (il cosiddetto tasso di
crescita del paese). Persistendo negli anni questa situazione,
avremo una divergenza crescente tra chi vive della rendita dei
capitali e chi vive con i redditi da lavoro: un'esaltazione
continua della disuguaglianza. Diversamente accadrebbe se un
tasso di crescita elevato e un conseguente alto reddito del
lavoro, rendesse più conveniente per il possessore di
capitali l'investimento produttivo anziché la rendita”.
La condizione in cui il tasso di rendimento del capitale supera
in misura significativa il tasso di crescita è stata
la più “frequente nel corso della storia, quantomeno
fino al XIX secolo ed è destinata con ogni probabilità
ad essere la norma nel XXI. In questa condizione per chi eredita
patrimoni dal passato basta risparmiare una quota anche limitata
di reddito del proprio capitale perché quest'ultimo si
accresca più in fretta rispetto alla crescita economica
nel suo complesso. In tali condizioni, è pressoché
inevitabile che i patrimoni ricevuti in eredità prevalgano
largamente sui patrimoni accumulati nel corso di una vita di
lavoro, e che la concentrazione del capitale raggiunga livelli
assai elevati, potenzialmente incompatibili con i valori meritocratici
e i principi di giustizia sociale che costituiscono il fondamento
delle nostre moderne società democratiche”.
Nelle ultime due righe si avverte un forte sapore di eufemismo,
per non dire “incontrollabili rivolte sociali”.
Come sappiamo e come ci viene ogni giorno ripetuto, l'Europa
non cresce o cresce poco, dunque la prospettiva è che
chi dispone di capitali diventerà sempre più ricco
a spese di chi vive solo di lavoro, destinato a restare sempre
più povero. E così potrebbe essere ancora per
anni, mettendo a rischio “l'essenza stessa della democrazia”
dice ancora Piketty. Tutto questo senza tenere conto della disoccupazione,
solo pochi anni fa ben lontana dai livelli attuali.
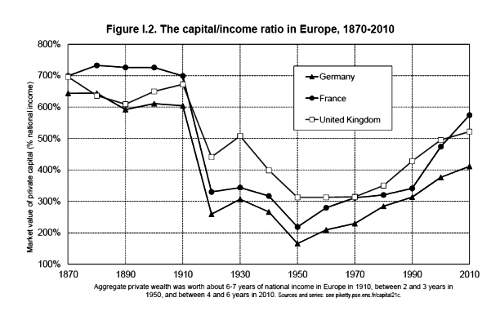 |
| Il grafico mostra il valore del capitale privato in %
del reddito nazionale tra il 1870 e il 2010 |
Per contro, continuando il ragionamento su chi determina
cosa, ci si deve chiedere quando e perché una crescita
anziché lenta può essere rapida e quali altre
situazioni sono favorevoli ad una riduzione della disuguaglianza.
Le dinamiche di sviluppo degli ultimi tre secoli indicano che
tassi di crescita elevati, associati a minori differenze, si
verificano solo in conseguenza di eventi eccezionali e non come
norma: nel lasso di tempo considerato i più importanti
di tali eventi, nel mondo occidentale, sono stati: la rivoluzione
francese nel 1789, la rivoluzione tecnologica a cavallo del
'900, la prima e la seconda guerra mondiale e, nei paesi emergenti,
il forte sviluppo da condizioni di sottosviluppo.
La storia dimostra anche che a favore della convergenza, ossia
di una riduzione delle differenze, vi sono essenzialmente i
processi di diffusione della conoscenza e le politiche di investimento
in materia di formazione ed educazione, processi che consentono
al tempo stesso la crescita generale della produttività
e la riduzione delle disuguaglianze, sia a livello di ciascun
paese, sia a livello mondiale. In effetti un incremento dei
livelli generali di conoscenza si accompagna sempre ai periodi
di forte sviluppo produttivo e il recente sviluppo delle economie
emergenti ne è una dimostrazione palese.
Anche se può sembrare ridicolo parlare di riduzione delle
disuguaglianze, ad esempio nella Cina di oggi, si deve tener
conto degli abissali livelli di povertà preesistenti.
Piketty non vi insiste troppo, forse per non essere liquidato
come comunista, ma è evidente che tra le cause
di turbamento, con effetto determinante di riduzione delle disuguaglianze,
si collocano le lotte operaie e i conflitti sociali, anche questi
tipici dei momenti di forte sviluppo. Per le ragioni che vedremo,
gioca a favore anche l'incremento demografico, minimo da noi
ma ancora elevato in paesi in via di sviluppo, oltre al ruolo
evidente delle politiche fiscali.
Un effetto contrario ha invece il debito pubblico, questione
oggi scottante, che ha l'effetto di far pagare a tutti gli interessi
versati ai prestatori di denaro allo stato.
Dunque non vi sono mani invisibili, ma solo meccanismi a favore
o contro l'uguaglianza e questo stride in maniera evidente con
le teorie liberiste secondo le quali in un mercato “perfetto”
il meccanismo domanda-offerta assicura di per sé la promozione
di crescita e benessere. Anzi, è esattamente il contrario:
è proprio in un mercato perfetto, non turbato da eventi
eccezionali, che le dinamiche di incremento delle disuguaglianze
si instaurano e si auto-alimentano.
Ben vengano allora i turbamenti (lo abbiamo sempre detto, no?)
ed in effetti hanno avuto un effetto positivo, su scala mondiale,
le lotte per l'indipendenza, la decolonizzazione, la caduta
del muro di Berlino, ecc. Certamente una crescita rapida dei
redditi da lavoro ha seguito sempre la fine di una guerra e
la fase di ricostruzione, ma non è proprio un dato confortante.
Per un'idea dei numeri in gioco: una crescita del pil dell'1%
sul lungo periodo è considerata buona, mentre un tasso
del 3-5% annuo si verifica solo in condizioni eccezionali e
non di lungo periodo. Al contrario, un tasso dell'0,1 o 0,2%
annuo è appena sufficiente a mantenere lo statu quo.
Sembrano numeri piccoli, ma il loro effetto cumulato negli anni
è molto maggiore di quel che si immagina.
C'è rimedio?
Nelle centinaia di pagine del Capitale nel XXI secolo
trovano posto moltissime altre osservazioni, dati e correlazioni
tra i fattori che influiscono su uguaglianza e disuguaglianza.
Vengono trattate a fondo la questione del debito, dell'accesso
alla conoscenza, i livelli salariali, le sperequazioni retributive
e l'“estremismo meritocratico”, le politiche fiscali,
i problemi in materia di successione ereditaria, il ruolo dell'Unione
Europea e molto altro. È negli ultimi capitoli che viene
affrontata nei dettagli la questione dei possibili rimedi.
Anche per l'altra faccia della medaglia, quella dei rimedi,
il discorso è lungo, complesso e articolato ma alla fine
rimane un nucleo centrale che anche qui sfiora la banalità:
occorre un'imposta progressiva sul capitale6,
altrimenti non se ne esce. Piketty evita astutamente il termite
patrimoniale, ma il senso è quello.
Facile a dirsi ma meno a farsi, dal momento che richiederebbe
una vera trasparenza sulla reale sostanza dei capitali e soprattutto
dovrebbe essere mondiale - o almeno europea per cominciare -
e non compromessa dai paradisi fiscali che lo stesso capitale
si è costruito. Oltre al fatto, possiamo esserne certi,
che questa soluzione non è gradita a coloro che vi dovrebbero
provvedere. Va detto che queste difficoltà sono chiaramente
esposte e che la proposta è analizzata nei particolari,
pro e contro. A parte l'effettiva realizzabilità, un
particolare illuminante si ricava dai dati: di quale entità
dovrebbe essere il prelievo?
Gli ordini di grandezza calcolati sarebbero questi: un tasso
di imposta dello 0% sui capitali (beni immobili compresa l'abitazione,
investimenti finanziari ecc.) fino a 1 milione di euro; un'imposta
dell'1% sui capitali da 1 a 5 milioni di euro e del 2% oltre
i due milioni. Oppure una maggiore progressività tipo
il 5-10% oltre 1 miliardo di euro, o anche, al contrario, lo
0,1 sotto i 200.000 euro e lo 0,5 fino a 1 milione di euro.
Abbiamo sempre saputo che “se tutti pagassero le tasse,
eccetera”, ma personalmente non avrei mai immaginato che
prelievi praticamente inavvertibili per un contribuente
sano di mente, come quelli calcolati da Piketty, fossero sufficienti
per rendere se non altro meno indecente la distribuzione della
ricchezza. In realtà l'efficacia di prelievi tanto modesti
deriva dall'effetto di accumulazione nel tempo, analogamente
a quanto prima ricordato a proposito del saggi di crescita.
La feroce opposizione liberista a prelievi di simile entità
- difficile anche definirli una patrimoniale - è
palesemente pura ideologia, o forse pura stupidità. Il
fatto che anche prelievi di quest'ordine di grandezza siano
considerati utopici, perché scatenerebbero protezionismi
e trucchi fiscali tra le nazioni, ci insegna quali livelli di
egoismi estremi siano ai vertici di quella che pudicamente chiamiamo
“convivenza”.
Quali critiche, da destra e da sinistra?
Diciamo subito che le critiche da destra, essenzialmente derivate
da un articolo di Chris Giles, caporedattore economico del Financial
Times, basate su alcuni errori rilevati nei dati, sono state
giudicate assai deboli. Tutti gli osservatori convengono che
in una simile massa di dati qualche errore è inevitabile,
e la loro correzione non inficia peraltro i risultati. Di “stroncatura
fallita” da parte di “negazionisti della disuguaglianza”
ha scritto perfino Il Sole 24 ore (6 giugno 2014) a firma
di Paul Krugman. Tra l'altro, ci vien da suggerire che quella
de Il capitale nel XXI secolo, è una critica al
sistema capitalistico che non nasce da considerazioni etiche,
o politiche o da opposte teorie economiche, ma che individua
un meccanismo interno di autodistruzione del sistema e ne propone
un rimedio. Dunque, alla faccia del Financial Times,
possiamo dire che lo scopo ultimo di Piketty è la salvezza
del capitalismo... ma di che si lamenta allora la destra?
Più sottili le critiche, non molte in verità,
da sinistra, ma anche più ideologiche: ad es. il Manifesto
definisce il libro “una inconfutabile fotografia del
capitalismo contemporaneo” e ne conferma l'importanza,
ma critica essenzialmente il fatto che nella teoria esposta
non viene spiegata la natura primaria, costitutiva dell'accumulazione
capitalista originaria e l'origine della proprietà privata.
In un articolo tratto da Le Monde Diplomatique Piketty
viene criticato in quanto riformista, a differenza di
Marx che del capitalismo propone l'abbattimento (ma l'Economist
lo definisce “il Karl Marx del XXI secolo”).
Altre critiche lamentano la mancanza di parole quali “merce
lavoro”, “sfruttamento”, “lotta di classe”.
Sono tutte osservazioni lecite, ma a mio parere fuori luogo:
l'autore è un riformista e lo dice chiaramente,
riferisce esplicitamente le sue tesi a periodi non turbati
da avvenimenti particolari, riferisce le sue previsioni a questo
sistema politico-economico in questo periodo e solo nel caso
che nessun evento eccezionale ne modifichi la dinamica interna.
Anche i rimedi che propone, per quanto ritenuti abbastanza utopici,
sono quelli virtualmente possibili all'interno di questo
sistema e di questo andamento economico. Peraltro, proprio l'aver
circoscritto a condizioni definite le sue osservazioni, fa del
lavoro di Piketty un classico lavoro di ricerca, i cui risultati
ognuno può discutere, e non una speculazione teorica
cui contrapporre altre speculazioni. Teorie e speculazioni sono
confutabili, i dati non lo sono.
In definitiva un testo che non propone la rivoluzione ma dà
delle informazioni utili sul funzionamento del sistema in cui
viviamo, con una concretezza che ha messo in crisi d'identità
l'accademia ufficiale, quella iperliberista per la quale gli
unici rimedi ammessi sono austerità, rinuncia, scrificio,
tagli, risparmio, sobrietà, moderazione, parsimonia e
chi più ne ha più ne metta, purchè sempre
ed invariabilmente degli altri.
Infine, perchè tanta attenzione per le tesi di Piketty?
Sarà forse perché le dinamiche economiche perverse
da lui descritte sono esattamente quelle che stiamo oggi vivendo?
Sarà forse perchè qualcuno comincia a preoccuparsi?
“Perseverare diabolicum...” titola un sito recensendo
il libro.
Enrico Maltini
post scriptum
A proposito di “contraddizioni in seno al capitale”:
a Londra, l'11 novembre 2014, il “Financial Times Mc Kinsey
Book of the Year Award” è stato assegnato a Il
capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty. Ma siamo matti?
Note
- http://piketty.pse.ens.fr/capital/21c
- Lo scozzese Adam Smith, 1723-1796, viene considerato il primo
degli economisti classici. Il suo La ricchezza delle nazioni
nel 1776 diventa il testo di riferimento per tutti gli economisti
del XVIII e XIX secolo. La metafora della mano invisibile,
che regolerebbe automaticamente gli equilibri in un libero mercato,
è tuttora il cardine delle dottrine liberali della deregulation
e del laissez-faire.
- Più precisamente, il sistema creerebbe per tutti sempre
maggiore ricchezza e benessere, e un possibile incremento delle
disuguaglianze sarebbe un positivo stimolo alla crescita.
- È lo stesso concetto alla base del movimento “Occupy
Wall Street”, che definisce se stesso “il 99%”
e prende di mira l'1% (il centile) più ricco.
- Il reddito nazionale è la somma dei redditi da capitale
e dei redditi da lavoro, in un anno.
- Attualmente è soggetto ad imposte - più o meno
alte nei diversi paesi - il reddito del capitale, non
il capitale stesso.
Il
capitalismo selvaggio è tornato
(e non si addomesticherà da solo)
di
David Graeber
I
capitalisti diffondono la ricchezza solo quando minacciati
da rivalità globali,
movimenti radicali e dal rischio
di sollevazioni nei loro paesi.
Negli anni '90, ero solito discutere con amici russi sul
capitalismo. Era un periodo in cui molti giovani intellettuali
dell'Est Europa stavano accogliendo con fervore tutto
ciò che era associato a quel particolare sistema
economico, anche se le masse proletarie dei loro paesi
rimanevano profondamente sospettose. Ogni volta che facevo
notare qualche nuovo abuso criminale da parte dei nuovi
oligarchi e dei politici corrotti, che stavano privatizzando
i loro paesi riempiendo le loro tasche, alzavano le spalle.
“Se osservi l'America, era pieno di imbrogli come
questo nel 19° secolo, con le ferrovie e tutto il
resto” ricordo che mi spiegò un gioioso e
occhialuto giovane russo. “Siamo ancora nello stato
selvaggio. Ci vuole sempre una generazione o due prima
che il capitalismo civilizzi se stesso”.
“E pensi davvero che il capitalismo farà
tutto da solo?”
“Guarda la storia! In America ci sono stati i baroni-rapinatori,
poi, cinquant'anni dopo, il New Deal. In Europa c'è
stato lo stato sociale...”
“Ma Serghei” protestai (ho dimenticato il
suo vero nome) “non è successo perché
i capitalisti hanno deciso di essere buoni. È successo
perché avevano paura di voi''.
Sembrò commosso dalla mia ingenuità.
In quel periodo c'erano una serie di postulati che chiunque
doveva accettare se voleva che gli venisse permesso anche
solo di prendere parte a seri dibattiti pubblici. Erano
presentati come una serie di equazioni auto-evidenti.
“Il mercato” era equivalente al capitalismo.
Capitalismo significava esorbitante ricchezza per i vertici,
ma anche rapido progresso tecnologico e crescita economica.
Crescita significava aumento della prosperità e
ascesa di una classe media. A sua volta l'ascesa di un'agiata
classe media stava sempre a significare governance
democratica e stabile.
Una generazione più tardi abbiamo imparato che
nessuno di questi presupposti può essere più
assunto come corretto.
La vera rilevanza del volume di successo di Thomas Piketty
“Il capitale nel XXI secolo” è dovuta
al fatto che esso dimostra, in modo meticolosamente dettagliato,
che nel caso di almeno una delle equazioni essenziali,
i numeri semplicemente non quadrano. Il capitalismo non
ha al suo interno una innata tendenza a civilizzare se
stesso. Lasciato ai suoi dispositivi, ci si può
di norma attendere che crei tassi di rendimento sugli
investimenti molto più alti del tasso complessivo
di crescita economica, cosicché l'unico possibile
risultato sarà di concentrare sempre più
ricchezza nelle mani di élite ereditarie di investitori.
In altre parole, quello che è successo nell'Europa
Occidentale e nel Nord America approssimativamente tra
il 1917 e il 1975, quando in effetti il capitalismo creò
crescita elevata e minore ineguaglianza, fu un'anomalia
storica. C'è una crescente presa di coscienza tra
gli storici dell'economia sul fatto che le cose andarono
così. Ci sono molte teorie sul perché. Adair
Turner suggerisce che fu la particolare natura della tecnologia
industriale della metà del secolo scorso a consentire
alti tassi di crescita e un movimento sindacale di massa.
Lo stesso Piketty sottolinea la distruzione di capitale
durante le guerre mondiali e le alte tasse e regolamentazioni
che furono permesse dalle mobilitazioni di guerra. Altri
danno differenti spiegazioni.
L'Età dell'oro
del capitalismo
Senza dubbio furono coinvolti molti fattori, ma quasi
tutti sembrano ignorare il più ovvio. Il periodo
in cui il capitalismo sembrò in grado di procurare
una ricchezza ampia e diffusa fu precisamente anche il
periodo in cui i capitalisti sentirono di non essere gli
unici sulla piazza: quando affrontarono un rivale globale
in Unione Sovietica, movimenti anticapitalisti rivoluzionari
dalla Cina al Mozambico e la possibilità di una
sollevazione di lavoratori in casa propria. In altre parole,
invece di alti tassi di crescita che diedero ai capitalisti
maggior ricchezza da distribuire, il fatto che questi
avvertirono il bisogno di corrompere almeno una qualche
porzione di classe lavoratrice fece confluire più
soldi nelle mani delle persone comuni, creando un aumento
di domanda per i beni di consumo che fu largamente responsabile
dei significativi tassi di crescita economica che caratterizzarono
l'Età dell'oro del capitalismo. A partire
dagli anni '70, quando ogni significativa minaccia politica
iniziò a svanire, le cose sono tornate alla normalità,
con un avaro 1% che presidia un ordine sociale caratterizzato
da crescente stagnazione sociale, economica e addirittura
tecnologica.
Per essere precisi, fu il fatto che le persone, come il
mio amico russo, credevano che il capitalismo avrebbe
inevitabilmente civilizzato se stesso a garantirgli di
non doverlo più fare.
Al contrario, Piketty inizia il suo libro denunciando
“la pigra retorica dell'anti-capitalismo”.
Non ha niente contro il capitalismo in quanto tale –
e nemmeno contro l'ineguaglianza. Desidera solo che venga
controllata la tendenza del capitalismo a creare una inutile
classe di parassiti che percepiscono rendite e interessi.
Afferma di conseguenza che la sinistra dovrebbe focalizzare
la propria attenzione su governi eletti, dedicati a dare
vita a meccanismi internazionali che tassino e regolino
le ricchezze polarizzate. Alcune delle sue proposte –
una tassa sul reddito del 80%!? – possono sembrare
radicali, ma abbiamo a che fare con un uomo che, avendo
dimostrato che il capitalismo è un gigantesco aspirapolvere
che risucchia la ricchezza e la porta nelle mani di una
minuscola élite, insiste nel dire che non dobbiamo
semplicemente staccare la spina alla macchina, ma provare
a costruire un aspirapolvere leggermente più piccolo
che risucchi nella direzione opposta. Per giunta non sembra
capire che non importa quanti libri venda o a quanti summit,
con luminari della finanza o membri delle élite
politiche, partecipi – il mero fatto che nel 2014,
un intellettuale francese di sinistra possa dichiarare,
senza correre rischi, di non voler rovesciare il sistema
capitalistico ma solo di volerlo salvare da se stesso,
è il motivo per cui tali riforme non avverranno
mai. L'1% non esproprierà se stesso, nemmeno se
glielo si chiede gentilmente. E ha speso gli ultimi trent'anni
a impedire l'accesso ai media e alla politica, per assicurarsi
che nessuno provi a farlo utilizzando gli strumenti elettorali.
Dacché nessuno sano di mente si augurerebbe un
ritorno di qualcosa di simile all'Unione Sovietica, non
vedremo neanche niente che assomigli alla socialdemocrazia
della metà del secolo scorso, che fu creata per
contrastarlo. Se vogliamo un'alternativa alla stagnazione
e all'impoverimento, dobbiamo solo trovare il modo di
staccare la spina della macchina e ricominciare da capo.
David Graeber
traduzione di Carlotta Pedrazzini
originariamente apparso su The Guardian il 30 maggio
2014 |
|

