
L'arte
del vivere
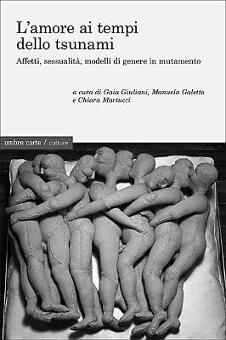 Sarà
banale incominciare parlando di precarietà, visto che
non si fa altro che ripeterlo, ma il fatto che siamo in un'epoca
così, di precarietà economica e lavorativa che
condiziona lo scorrere delle nostre giornate e influenza il
nostro umore, crea una precarietà esistenziale con la
quale si cerca di convivere e sulla quale si provano ad inventare
nuove forme di resistenza. Sarà
banale incominciare parlando di precarietà, visto che
non si fa altro che ripeterlo, ma il fatto che siamo in un'epoca
così, di precarietà economica e lavorativa che
condiziona lo scorrere delle nostre giornate e influenza il
nostro umore, crea una precarietà esistenziale con la
quale si cerca di convivere e sulla quale si provano ad inventare
nuove forme di resistenza.
L'ordine delle cose è buttato all'aria e ciò che
ha tenuto per molto tempo mostra crepe da tutte le parti: famiglia,
modelli tradizionali di coppia, ruoli di genere, sessualità;
dal pubblico al privato grande è il disordine sotto il
cielo.
È questo lo tsunami di cui si parla nel libro L'amore
ai tempi dello tsunami. Affetti, sessualità, modelli
di genere in mutamento (Ombre corte, Verona, 2014, pp. 238,
€ 22,00). Un maremoto che le curatrici cercano di attraversare
mostrando una serie di esperienze e riflessioni che, raccolte
in volume, vanno a formare l'insieme, un po' eterogeneo ma armonico,
del testo. Come a dire, in estrema sintesi, che ogni grave crisi
mostra sempre un'opportunità di trasformazione e cambiamento
creativo se si hanno gli strumenti e la capacità per
starci dentro.
Racconti di vita vissuta e riflessione filosofica costituiscono
capitoli di diverso impegno che a mio avviso cercano, sostenendosi
a vicenda, di dare testimonianza concreta di esperienze molto
interessanti.
Il volume è nato per iniziativa di un'associazione culturale
bolognese - il cui nome, PrecArt - già la dice
lunga. Obiettivo di questa associazione è quello di valorizzare
la ricerca (accademica ma non solo) sulle tematiche di genere,
compiuta da studiose/i che vivono in condizione di precarietà.
Chiara Giuliani, Manuela Galetto, Chiara Martucci (le curatrici)
e la maggior parte dei soci/e «vivono una condizione di
precarietà che le contraddistingue dal punto di vista
sia del lavoro “immateriale” che svolgono, sia degli
stili di vita, dislocati a livello territoriale, complicati
dall'assenza di una continuità di reddito e caratterizzati
da relazioni affettive e d'amore anch'esse instabili, precarie
o eccedenti l'idea tradizionale di coppia, amicizia e famiglia».
La domanda che emerge tra le pagine è questa: come si
vive avendo un lavoro che non garantisce uno stipendio fisso
tutti i mesi su cui poter contare, con la disponibilità/necessità
a spostarsi, per tempi più o meno lunghi, in luoghi diversi
del territorio nazionale e/o all'estero, con relazioni affettive,
di vario genere, instabili e sentendo la necessità, oltretutto,
di viverle in una maniera che non rientra più nei ruoli
di genere stabiliti nella “normalmente intesa” coppia
e famiglia? Quale significato vanno ad assumere queste parole
– coppia, famiglia - se le si privano di tutti quegli
stereotipi su cui è costruito il nostro immaginario?
Ovviamente chi racconta e scrive non ha risposte, ma testimonia
e riflette criticamente sulle molteplici forme di ribellione
a quell'insieme di strutture materiali e discorsi che possono
essere unificati col termine etero-sessismo. Abbandonata quindi,
più o meno felicemente, l'idea di amore/affettività
solo all'interno della coppia eterosessuale, monogama –
per quanto inserita in una versione moderna di coppia-matrimonio-figli
e famiglia – inizia il disancoramento da tutta una serie
di cornici sentite come autoritarie per entrare in una fase
di sperimentazione queer. Termine col quale non si va
a definire un atteggiamento sessuale non etero-normato ma –
e in maniera estremamente più sfaccettata e complessa
– tutto ciò che ha a che fare con l'identità
di genere. Qualcosa che appartiene a categorie sia simboliche
che materiali, dove la classe sociale, la razza di appartenenza
e il capitale culturale hanno ruoli fondamentali.
In breve possiamo dire che questo è il territorio in
cui si muove la riflessione di questo interessante libro che
ha il pregio di rimane sempre molto interlocutorio/aperto e
di non voler mai mettere la parola fine alle questioni che tocca.
Tre cose fondamentali ci vengono regalate come aiuto per i tempi
difficili in cui transitiamo: la prima, come già anticipato,
è l'evidente possibilità di fare della crisi un'opportunità
e, senza banalizzare, significa dire che visto che la terra
trema tanto vale imparare a ballare, cioè non restare
rigidamente ancorati a ciò che sta franando, cercando
tutti i modi possibili e immaginabili per perpetuare il conosciuto,
ma affrontare lo sconosciuto, con tutte le difficoltà
e la paura che questo comporta e che il libro mette ben in evidenza.
«[...] il lungo lavoro di indagine e riflessione che abbiamo
fatto per dare visibilità e riconoscimento alla pluralità
di traiettorie di vita/lavoro, nostre e altrui, mi ha insegnato
ad andare oltre gli approcci vittimisti e a vedere come per
alcune donne e uomini la precarietà e la crisi abbiano
costituito anche occasioni materiali per mettere in discussione
le regole del gioco e sfuggire ai ruoli che normalmente avrebbero
l'obbligo di adempiere: nelle scelte di lavoro e abitative,
nelle abitudini amorose, nelle pratiche affettive, nei ruoli
sociali, nelle tipologie di consumo. [...] Agire soggettivamente
la precarietà significa assumersi il rischio e la libertà
di prendere parte ad un sistema di innovazione capace di sfruttare
incertezza, moltitudini acentriche e complessità per
estrarne nuove forme di valore. [...] Cercando nel frattempo
di creare e consolidare pratiche collettive: per costruire reti
di protezione e mutuo aiuto da un lato, ma anche per re-imparare
ad immaginare e sperimentare possibilità di cambiamento
nel/del presente».
La seconda riguarda proprio l'idea di lavoro, di cui si parla
sempre di questi tempi in cui il lavoro manca, mentre ci spingono
verso un'accettazione passiva della svendita del proprio tempo
e delle proprie capacità. Mai come in questo periodo
è importante non vivere sensi di colpa e avere un'idea
chiara del cosa significhi lavoro, per riappropriarsi o mantenere
salda quella forza interiore che permette i sacrifici necessari
a rivendicare i propri diritti. Ad esempio si dice:
«Mentre tutto cambia, si continua a considerare il valore
del lavoro come un dogma indiscutibile e si moltiplicano tabù
e non detti sulla sua mancanza, la sua organizzazione, sui criteri
che orientano ciò che si produce e come lo si produce,
e sul modo in cui si attribuisce valore agli esseri umani. Si
tratta di una coltre di ipocrisia che continuiamo a tessere
tutte e tutti (nostro malgrado?). Una coltre fatta di silenzi,
di finzioni, di omissioni, e di connivenze che bisogna avere
il coraggio di vedere e smascherare, se si vuole andare oltre
la naturalizzazione dello status quo».
Terza cosa che il libro ci regala è l'idea di quanto
sia importante la ricerca di una dimensione autentica in cui
vivere affettività e amore, compreso quello genitoriale,
che sono sì bisogni primari, ma con molteplici modi d'espressione.
Siamo in un'epoca ricca di grande fermento – e il testo
ne porta testimonianza - ma estremamente dura e pericolosa.
Saremo noi, con le nostre scelte a stabilire che individui stiamo
diventando. Quali tipi di rapporto stiamo ingaggiando con i
desideri, l'amore e il bisogno di riconoscimento mentre lasciamo,
ad esempio, che le piattaforme “social” regolino
il flusso del nostro “capitale affettivo” , togliendolo
sempre più dalla sfera privata? Saremo in grado di costruire
forme di vita che sfuggano a questi meccanismi pervasivi? Quali
impegni ci assumiamo per rendere buona la vita?
Abbiamo tra le mani un libro molto stimolante, che tocca trasversalmente
un'infinità di temi fondamentali e lo fa in maniera assolutamente
non banale. Scardina e si interroga, propone alternative e ne
mostra la difficoltà, pagine estremamente vive, che rimestano
in quel che si sta pensando adesso, in spazi piccoli, di nicchia
certo, forse tra i migliori. Invece sui media imperversa
la banalità.
Silvia Papi
Decrescita,
anarchia,
amore, eutéleia
 Ho
letto con vero piacere Dall'economia all'eutéleia
(sottotitolo: “Scintille di decrescita e di anarchia”.
Edizioni per la decrescita felice, Editori Riuniti University
Press, Roma, 2014, pp. 312, € 21,50), riflessione filosofica
di Alessandro Pertosa. Ho
letto con vero piacere Dall'economia all'eutéleia
(sottotitolo: “Scintille di decrescita e di anarchia”.
Edizioni per la decrescita felice, Editori Riuniti University
Press, Roma, 2014, pp. 312, € 21,50), riflessione filosofica
di Alessandro Pertosa.
Con coraggiosa autonomia di pensiero conduce a una visione che,
oltre a dichiararsi tale, rientra nell'universo delle proiezioni
concettuali e prospettiche dell'anarchia. Particolarmente interessante
soprattutto se si pensa che è la risultante di un percorso
personale di riflessione e di studi non movimentista, tanto
meno militante. Proprio per questo è anche indizio della
grandezza insita nei modi di pensare tendenti al libertarismo
anarchico.
Il libro parte da un'analisi acuta e profonda, una critica irriducibile
dell'economia, dei suoi fondamenti e della sua impostazione,
presentata come non riformabile, soprattutto non “usabile”
per un cambiamento radicale che riesca ad essere liberatorio,
liberante e realizzatore di una libertà sociale diffusa,
conviviale e condivisa. L'oikonomia, come viene costantemente
nominata per ricordarne l'origine etimologica, si definì
fin da subito sui capisaldi dispotici tipici della cultura e
della visione greca. Il kyrios (il pater familias
signore indiscusso) esercitava” [...] la sua autorità
sulla moglie, sui figli e in misura ancor maggiore sullo schiavo,
instaurando con i suoi sottoposti tre diverse tipologie di relazione:
la prima, di coniugalità, con la moglie; la seconda,
di paternità, con i figli; la terza, di padronanza, col
servo” (pag. 32). Così l'oikos, la famiglia,
era il luogo del potere tirannico, che attraverso il nomos
era consacrato anche giuridicamente.
Quando il nomos, cioè le leggi che regolano le
relazioni, si estese dalla famiglia alla polis, poi allo
stato, fino al mondo intero com'è oggi, si mantennero
le stesse dinamiche relazionali e culturali profondamente diseguali
e violente che erano in uso all'interno dell'oikos originario.
L'oikonomia dunque sarebbe irriducibile alla libertà
perché, come è asserito in modo chiaro fin dal
titolo del primo capitolo “L'economia è dominio”.
Parla di economia in quanto tale, non soltanto quella capitalista,
compreso il baratto o qualsiasi altro surrogato dello scambio
economico. Chiarissimo quando afferma “ogni tentativo
di riformare o ingabbiare l'economia all'interno di impianti
ideologici fondati su concetti di giustizia ed uguaglianza risulta
vano, perché non si può giustificare o rendere
perequata una trama di relazioni basate essenzialmente sulla
violenza e sul dominio” (pag. 42).
Un'innegabile radicalità il cui sbocco inevitabile è
il ripudio tout court delle logiche e delle pratiche
economiche come mezzi di scambio e relazione tra esseri umani.
Liberata la strada si sono così aperti i varchi per l'eutéleia,
che più o meno significa far bene seguendo fini condivisi,
conviviali, comunitari e fraterni. Una proposta “rivoluzionaria,
anarchica e decrescente non ancora concretizzata”, come
è definita a pag. 238.
Pertosa, che insieme a Maurizio Pallante cura il sito-rivista
www.artedecrescita.it,
è un convinto sostenitore della decrescita, non intesa
come fatto economico legato al pil (data la sua critica radicale
all'economia in quanto tale), ma come progetto rivoluzionario
che presuppone l'uscita dalla razionalità economica e
dalle sue logiche perché al contrario sono fondate sulla
crescita illimitata dei consumi e dell'uso delle risorse. La
decrescita è il naturale sbocco di uscita dalla gabbia
della voracità economica imperante.
Eutéleia e decrescita con un'impronta dichiarata decisamente
anarchica, che si realizzano soltanto se c'è un rifiuto
diffuso e condiviso degli individui di esercitare qualsiasi
potere dispotico nei confronti degli altri. Una visione non
dogmatica che mira “a elaborare forme appassionate di
comunità [...], per superare il proudhoniano [...] principio
d'autorità (politica, religiosa, militare, morale e sociale)
che governa da sempre l'orizzonte dell'oikonomia”
(pag. 291). Un anarchismo visto innanzitutto quasi come un suggerimento
etico che impregna di sé le scelte, gli atti e la qualità
delle relazioni all'interno delle pratiche e dell'orizzonte
eutéleico, possibile solo attraverso il ripudio della
cappa soffocante di ogni impostazione economica.
La coerenza teorica di questa visione è completata dall'amore
come elemento fondante della qualità delle relazioni,
sia sociali sia interpersonali, che dovrebbe sostituire gli
scambi economici. “La chiave per cogliere questa rivoluzione
ontologica e antropologica che propongo è l'amore universale;
è quell'amore che supera la scissione nella relazione,
è quell'amore che trasforma in un'esperienza concreta
l'utopia della fraternità” (pag. 251). Il dono
senza ricambio o contropartita quindi senza munus (dono
che pretende restituzione), ma donum, dono che regala
senza aspettarsi od esigere restituzione o ricompensa, quale
superamento dello scambio economico che si dà per indebitare,
quindi schiavizzare e sottomettere.
Nonostante la sua bellezza indiscutibilmente apprezzabile perché
tenta di elevarsi dal piano meramente pratico ad un piano valoriale,
una tale proposta mi sembra fragile. Una condivisione sociale
estesa, seppur anarchica, sebbene debba tendere all'amore per
gli altri come ben sottolineava Malatesta, per potersi realizzare
non può fondarsi esclusivamente su di esso come strumento
di relazione. La complessità umana non è fatta
solo d'amore, qui connotato fra l'altro da tinte talmente elevate
che rimanda alle esaltazioni cristiane delle origini. L'insieme
dei sentimenti, delle pulsioni, delle reazioni psicologiche
è ampio e vasto, conflittuale e contraddittorio. Se si
fonda un assetto su un solo aspetto dell'umana condizione, in
questo caso l'amore, quando se ne presenteranno altri facilmente
crollerà.
Interessante alla fine dell'ultimo capitolo la critica che Pertosa
fa ai pensatori e teorizzatori della decrescita. A Serge Latouche
in particolare perché non capisce l'importanza della
pratica anarchica per la sua realizzazione, vedendola soprattutto
come ideologia anticapitalista invece che più semplicemente
come una pratica di liberazione. Ma anche a Maurizio Pallante
che, pur identificandola come “una strada e non la meta”,
non riesce ancora ad aver presente l'eutéleia anarchica
come prospettiva di riferimento.
Per usare le sue stesse parole, “l'eutéleia –
nella mia visione – non è sinonimo di anarchia.
L'anarchia è la modalità con cui si costruisce
il nuovo mondo. Quindi l'anarchia è il mezzo che mi consente
di operare verso l'utopia: questa utopia è l'eutéleia,
che d'anarchia e di decrescita è fatta”, scritte
in una mail di scambi d'opinione. Il suo panorama utopico, l'eutéleia,
si realizza perciò attraverso modalità anarchiche
di relazione sociale fondate sul rigetto dell'economia.
Un libro interessante e stimolante dunque, perché è
innanzitutto un excursus teorico e filosofico che non
pone, né propone, un percorso politico. Da una parte
analizza a fondo i fondamenti del senso e della qualità
delle relazioni umane e sociali, denunciando sopra ogni cosa
il dispotismo insito nell'economia, la stessa che non a caso
oggi determina e impoverisce la qualità dei vincoli e
degli scambi in seno alle società. Dall'altra parte prospetta
come dovrebbe essere al posto di ciò che è, cercando
di definirne senso, fondamenti e significati fondanti.
Andrea Papi
Montelupo,
nuovo disco di canti anarchici
 Loro
li ho “conosciuti” per caso... mentre navigando
in rete ascoltavo i miei amati canti anarchici. Si chiamano
Montelupo e vengono da Roma, precisamente dalla zona di Guidonia
e Tivoli. Loro
li ho “conosciuti” per caso... mentre navigando
in rete ascoltavo i miei amati canti anarchici. Si chiamano
Montelupo e vengono da Roma, precisamente dalla zona di Guidonia
e Tivoli.
Il progetto Montelupo nasce nel 2012 e mira al recupero dei
canti anarchici italiani. L'attuale formazione della band vede
Daniele Coccia alla voce, Eric Caldironi alle chitarre e Alessandro
Marinelli alla fisarmonica, ai quali si aggiunge presto Nicolò
Pagani al contrabbasso. Agli inizi di novembre è uscito
il loro primo lavoro in studio con l'etichetta “Goodfellas”:
Il canzoniere anarchico (2014, € 12,95).
Appena ho saputo la notizia non ho potuto fare a meno di comprare
il loro disco, un po' per curiosità, un po' per la passione
per il canto popolare e più di un po' per l'amore per
quei personaggi ormai dimenticati raccontati dai testi di queste
canzoni.
Come ogni buona collezionista di musica metto su il cd e leggo
il libretto che lo accompagna. Non si può non leggere
l'introduzione di Alessio Lega che scrive: “Ma cazzo!
Questo è il mio disco! Era da un po' di anni che ce l'avevo
in testa”.
La potenza di questo lavoro sta proprio nel fatto che le canzoni
non tradiscono la loro naturale vocazione alla ribellione e
alla propaganda, ma si presentano in una veste “svecchiata”
(se mi è concesso usare questo brutto termine!) grazie
ai nuovi arrangiamenti. Il lavoro mescola ritmi folk ad arrangiamenti
più jazz, a cui si intrecciano divertenti marcette, fino
all'appassionante “tango di Caserio”.
Quello compiuto dai Montelupo è un vero e proprio viaggio
nella tradizione anarchica intrapreso attraverso le 17 tracce
che compongono il cd. Sul libretto ogni pezzo è introdotto
da una breve presentazione di Franco Schirone che spiega l'origine
del testo, della musica o racconta la storia dei protagonisti.
Solo per citarne alcune anche se tutte meriterebbero uguale
considerazione non solo per la loro bellezza, ma perchè
ognuna meriterebbe di essere rievocata alla memoria.
Il disco si apre con “La ballata del Pinelli” che
narra le ultime ore in questura del ferroviere anarchico Giuseppe
Pinelli, una vicenda relativamente giovane che racconta la storia
di un uomo che molti compagni, milanesi e non, hanno avuto il
privilegio di conoscere.
Per tornare un po' più lontano nel tempo non si può
non nominare “Il feroce monarchico Bava”. Nel 1898
in tutto il paese si erano scatenate numerose proteste in seguito
al rincaro di alcuni generi alimentari di prima necessità.
A Milano il re Umberto I, quello che i “nostri”
libri di storia ricordano come “il re buono”, ordinava
al generale Bava Beccaris di sparare sulla folla che chiedeva
il pane.
Bellissima la versione contenuta nel canzoniere del Lazio di
“Bevi bevi compagno”, nata dall'unione dei testi
di “Se nasce l'anarchia” e da quello della canzone
d'osteria “La canzone che ammazza li preti”, unificate
da Sandro Portelli.
Immancabili i testi del celebre Pietro Gori: “Addio Lugano
bella” scritta dopo l'arresto nel 1895 mentre fuggiva
dalla polizia italiana e una versione dei suoi “Stornelli
d'esilio” sulla quale non riuscirete a stare fermi. Vi
commuoverete sentendo l'arrangiamento di “Dimmi bel giovane”,
poesia internazionalista che riprende le parole pronunciate
da un giovane per l'ammissione alla Comune di Parigi. Il disco
si chiude con il tradizionale “Canto dei malfattori”,
scritto da Attilio Panizza e che tende a rivoltare la continua
accusa di “malfattori” con cui lo stato bollava
gli anarchici.
Numerose le collaborazioni all'interno di questo primo lavoro
dei Montelupo. Bianca Giovannini, cantante del complesso romano
“BandaJorona”, presta la sua voce in alcuni pezzi
insieme a tanti altri, come Giancarlo Barbati Bonanni, voce
in “Bruceremo le chiese” o Andrea Ruggiero, violinista.
Che dire... un disco da ascoltare non solo perché piacevole,
ma perché vivo.
Sarà forse la potenza della musica che ci salverà
dall'oblio? Questo non posso assicurarlo, ma posso assicurare
che i Montelupo sono riusciti a sottrarre alla dimenticanza
tutte le storie, vicine lontane, collettive e individuali, raccolte
in questo lavoro.
Camilla Galbiati
Piazza della Loggia,
un'opera lirica, il depistaggio
I quarant'anni della strage di piazza della Loggia a Brescia
(28 maggio 1974) hanno avuto in dono un'opera lirica, Il
sogno di un cosa, ideata da Mauro Montalbetti (compositore),
Marco Baliani (autore, drammaturgo e regista teatrale) e Alina
Marazzi (regista cinematografica). Può sembrare una contraddizione,
ma non lo è: i tre artisti arricchiscono la memoria dell'attentato
terroristico, che segue di cinque anni la bomba di piazza Fontana
a Milano, e lo fanno seguendo una via nuova: siamo distanti
dall'incedere satireggiante di Morte accidentale di un anarchico
(Dario Fo, 1970) e, allo stesso tempo, dal teatro civile canonico,
con il quale lo spettacolo condivide solo la tematica.
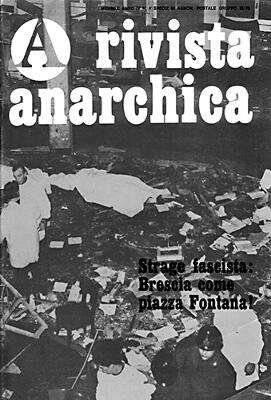 |
| La copertina del numero “A” 030 (giugno
1974-luglio 1974) dedicata alla strage
di Piazza della Loggia |
Il sogno di una cosa, invece, si caratterizza per una
molteplicità di stili: musica, la cui partitura è
eseguita dall'Ensemble Sentieri selvaggi diretto dal Maestro
Carlo Boccadoro, teatro e installazioni video; diretta emanazione
dei tre autori del progetto. Ne deriva una commistione di generi
che ben si adatta a uno spettacolo senza una trama lineare,
che procede per quadri: se il filo rosso rimane la strage di
Brescia, non mancano riferimenti agli altri episodi che segnarono
la strategia della tensione: piazza Fontana, la stazione di
Bologna, l'Italicus, Ustica solo per citarne alcuni.
Un grande merito di questo spettacolo sta nell'aver portato
sul palco, in tutta la sua vigliaccheria, l'antagonista con
cui le indagini sulla strage di piazza della Loggia, ma non
solo, si sono dovute scontrare: il depistaggio. Ulteriore monito
e ulteriore conferma della direzione che dovrebbero prendere
le decisioni in materia di stragi da parte degli organi preposti,
intraprendendo così un percorso che possa portare a rivelazioni
e verità che riguardano tutta la popolazione di questo
Paese. Pur tra polemiche e difficoltà, il 24 settembre
2014, la Camera dei deputati ha approvato la legge per introdurre
nel codice penale i reati di depistaggio e di inquinamento processuale;
in attesa del parere del Senato, un piccolo, ma significativo,
traguardo.
Il sogno di una cosa, espressione di marxiana e pasoliniana
memoria, declinata a Brescia e nel resto d'Italia nell'auspicio
e nella partecipazione per costruire una società migliore
in cui vivere e da lasciare a chi verrà, ci fa intuire,
fin dal titolo, il carattere collettivo di questa rappresentazione;
un carattere collettivo che non si deve fermare al palco, ma
raggiungere la platea e proseguire per via, così da non
rimanere solo una bella serata a teatro.
Matteo Pedrazzini
Taranto,
città invisibile
 Venditori
di fumo. Quello che gli italiani devono sapere sull'Ilva e su
Taranto di Giuliano Pavone (Barney edizioni, Milano 2014,
pp. 251, € 16,90) esordisce con due citazioni tratte dall'ordinanza
di sequestro dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto, disposta
dal Giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco, nel
luglio del 2012: “Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato
nell'attività inquinante con coscienza e volontà
per la logica del profitto, calpestando le più elementari
regole di sicurezza”. “La gestione del siderurgico
di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale
noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione
e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone”. Venditori
di fumo. Quello che gli italiani devono sapere sull'Ilva e su
Taranto di Giuliano Pavone (Barney edizioni, Milano 2014,
pp. 251, € 16,90) esordisce con due citazioni tratte dall'ordinanza
di sequestro dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto, disposta
dal Giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco, nel
luglio del 2012: “Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato
nell'attività inquinante con coscienza e volontà
per la logica del profitto, calpestando le più elementari
regole di sicurezza”. “La gestione del siderurgico
di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale
noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione
e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone”.
L'autore dedica il libro non solo alla memoria del piccolo Lorenzo
Zaratta, una delle innumerevoli vittime dell'inquinamento industriale,
ma anche “a chi ama Taranto e lo dimostra coi fatti”,
riferendosi agli esperti attivisti che operano nell'associazionismo
ambientalista tarantino e che si spendono e si sacrificano quotidianamente
per portare alla luce la verità, in quanto l'omertà,
la menzogna e la connivenza a Taranto fanno ancora più
rabbia della noncuranza con cui l'industria ha devastato ambiente
e distrutto vite umane, per la logica spietata del massimo profitto
dei padroni. Parafrasando Italo Calvino, Taranto sembra una
“città invisibile”, in senso letterale, in
quanto dimenticata e sconosciuta ai più. La politica
nazionale è sempre rimasta sorda alle richieste di aiuto
giunte più volte dal capoluogo jonico e, anzi, ha adeguato
l'impianto normativo alle esigenze dell'Ilva, della grande industria,
piuttosto che pretendere il rispetto delle regole da parte del
colosso siderurgico. La politica locale, inoltre, dopo anni
di stasi sostanziale, sembrava, anche grazie alle spinte dell'associazionismo
ambientalista e ecopacifista tarantino, aver preso a cuore il
problema, invece, ha palesemente tradito le aspettative, mostrando
un asservimento perdurante alle bieche logiche del profitto
e della grande industria. “Città invisibile”
Taranto lo è in senso letterale, perché sconosciuta,
dimenticata, poco considerata e compresa, abbandonata.
Con “Le città invisibili” di Italo Calvino
ha in comune la natura fantastica, estrema, fortemente allegorica:
doppia come due sono i suoi mari, piena di contrasti, liquida
e sfuggente. Taranto, in questa congiuntura, sembra visibile,
ma non è niente. Anche se potrebbe essere tutto. Una
città dove regna la convinzione che nulla mai possa cambiare,
in una sorta di anno zero, dopo anni di sostanziale immobilismo:
il blocco, da parte della magistratura, dell'azienda matrigna,
il siderurgico più grande d'Europa, un colosso esteso
che apre disparati orizzonti davanti alla città, dalla
crisi occupazionale e irreversibile a tensioni sociali fuori
controllo, nell'implosione più totale.
L'alternativa? Messa a norma degli impianti, riconversione,
bonifiche e sostanziale ripensamento dell'economia cittadina,
come esempio di nuovo modello di sviluppo ecocompatibile e ecosostenibile,
per un futuro salubre e prospero. E se il terremoto politico-giudiziario
si rivelasse l'ennesimo fallimento e tutto, ancora una volta,
fosse destinato a tornare come prima del sequestro degli impianti
siderurgici?
“A Taranto dominava un'accozzaglia di superficialità,
scarsa preparazione, finta conoscenza dei problemi, mischiata
a rozza e insensata sicurezza. In tanti credevano che l'inquinamento
li avrebbe corazzati e che, respirando un po' alla volta i veleni,
si sarebbero immunizzati. Una folle e insensata convinzione
che albergava anche nella mente di gente laureata” . Così
ha scritto Alessandro Marescotti, Presidente dell'associazione
ecopacifista PeaceLink, nell'introduzione del fumetto “L'eroe
dei due mari. Taranto, il calcio, l'Ilva e un sogno di riscatto”
(Altrainformazione, 2012). In quanto attivista e redattrice
di PeaceLink - Telematica per la Pace, mi sento di denunciare
che il caso Ilva, attualmente, viene semplicemente rappresentato
come una vertenza occupazionale o una mera questione di politica
industriale. Ma i drammatici dati di malattia e di morte, che
ancora qualcuno si ostina a mettere in dubbio e a confutare,
vengono “derubricati a fattore scatenante di un problema
esclusivamente economico”, anziché essere considerati
essi stessi il vero problema. Taranto, nella sua tragedia lenta,
silenziosa, inesorabile, è schiacciata sotto il peso
del ricatto occupazionale e di relazioni pericolose e bieche
connivenze che l'Ilva ha intrattenuto con coloro che erano preposti
a controllare e denunciare le emissioni inquinanti: i sindacati,
le forze dell'ordine, gli organi di giustizia, la stampa e la
politica fino ai più alti vertici istituzionali ...e
persino la Chiesa.
Il caso Ilva rappresenta, attualmente, il terreno su cui si
misurano la credibilità e le autentiche priorità
del nostro Paese, in una storia profondamente italiana, fondata
su componenti umane e disumane di ignavia e di eroismo, di cinismo
e solidarietà, di scelte avventate e corruzione, di malaffare,
di grandi opere e omissioni. Dunque, Taranto è ormai
la “città visibile” in assoluto, al centro
di un interesse legittimo, in quanto costituisce, nella propria
esplicita e implicita complessità, un caso che offre
strumenti per analizzare problematiche dibattute e per interpretare
a fondo i rapporti che intercorrono tra giustizia e informazione
e tra politica e potere economico.
Laura Tussi
Cinema, riflessioni in disordine/
Dalla cantina
Austria + cantina = Fritzl e Priklopil. Mh. Ci si aspetterebbe,
infatti, che Im Keller (“Nella cantina”)
ultimo documentario del cineasta Urlich Seidl, sia la continuazione,
o almeno, la ricerca della matrice di quelle realtà disturbate
e sotterranee che han fatto rabbrividire il mondo intero. Di
cine-precedenti già ne abbiamo: Michael (2011)
di Markus Schleinzes è un esempio lampante.
E invece no. Seidl come al solito lascia a casa i compiti e
ci mostra implicitamente il suo vero obiettivo: non l'investigazione
del singolo, ma la curiosità di svelare l'anima umana,
polverosa e arrugginita, partendo dai suoi “caratteristici”
connazionali. A quanto pare, quest'anima si trova in cantina.
La cantina, infatti, è il vero soggiorno per il bourgeois
transalpino e transfrancese: l'austriaco tipo si trova a suo
agio dove l'italiano tipo di solito accatasta valigie rotte
e vestiti di venti estati fa.
Seidl ci accompagna in un grottesco tour del seminterrato: siamo
quindi ospiti di una coppia estrema sadomaso, di un cantante
lirico che ha trasformato la sua cantina in un circolo di tiro,
di un simpatico beone che suona il trombone ed è ossessionato
da Hitler e chi più ne ha più ne metta.
 |
| Un fotogramma del film Im Keller |
Ancora una volta, con Seidl, non ci si ferma mai al primo piano,
bisogna mettere a fuoco tutto. Ben lontano dal mostrarci il
classico caso di fiera degli orrori tipica delle televisioni
che somministrano al solitomino Silveriano un po'di autostima,
ci troviamo a digerire malamente immagini di persone e vite
che, per quanto possano essere antitetiche con le nostre, ci
dicono tanto di chi siamo. Così, nella coppia sadomaso
troviamo la voglia d'amore, nel signorotto dal do di petto e
dal grilletto facile la confusione politica del mondo moderno,
e nel trombonista pseudo-filo-nazista ci troviamo a ridere,
non di lui, ma delle sue battute.
Seidl non ha mai nascosto il suo interesse per le sfumature
più torbide dell'animo umano, presenti in tutta la sua
filmografia, dai primi documentari come The Last Men,
fino alla trilogia Paradise. Ma dove i detrattori vedono
nel suo cinema un odio manifesto verso il prossimo, io vedo
un acuto e costruttivo interesse nell'umanità. Acuto:
perché Seidl è un mostro della mise-en-scène
reale. Quest'ossimoro filmico si materializza nei suoi protagonisti,
che si aprono totalmente di fronte alla camera, nudi e inermi
e sinceri, come in trance, ci svelano i loro più
intimi segreti e passioni. Da buon demiurgo, Seidl li manipola
per l'inquadratura perfetta, ma il succo c'è, si sente,
è amaro, ma va giù.
Costruttivo: perché per chi ha fede nell'uomo, per chi
ha voglia di conoscere, per chi è pronto a confrontarsi
con le diversità, lo sguardo di Seidl ci porta a una
riflessione continua con e su noi stessi. Un meccanismo automatico
che ci guida all'autocritica e alla di(co)struzione di molti
luoghi comuni che sono inesorabili e onnipresenti, ma si fa
presto a dimenticare, avvolti dalle paccottiglie poco riciclabili
targate “famiglia”, “patria”, “società”.
Abbiate pazienza, rabbrividite alla violenza grafica di alcune
cantine e cantinieri, ma lasciate che il vostro cervello si
specchi in queste immagini, lontano dal narcisismo, e vicino
all'anarchismo.
Nicolò Comotti
P.S: voi mi chiedete dove e quando vederlo? Eeh... boh?!
La rete non mi suggerisce nessuna prossima uscita italiana.
Vi posso solo dire di tenere gli occhi aperti, un consiglio
“legale” può essere MUBI, ottima piattaforma
online per il cinema d'autore. Per quello para-legale... la
rete è la rete, ce la caviamo così.
Anarchia e cristianesimo/
Convergenze parallele?
 “Cattolici
e anarchici” sarebbe una strana congiunzione – a
mio avviso falsa, perlomeno, a causa dell'incompatibilità
dei due congiunti. “Cristiani e anarchici”, al contrario,
è un'assimilazione che richiama analogie profonde e strutturali.
Omonimo libro, quello di Lucilio Santoni (Cristiani e Anarchici:
viaggio millenario nella Storia tradita verso un futuro possibile,
Infinito Edizioni, Modena, 2014, pp.144, € 12,00), si caratterizza
come un'articolata riflessione tra il cristianesimo (originario,
precedente alle confessioni che ne hanno tradito molti degli
assunti) e le condizioni di possibilità dell'anarchismo.
Se anarchia significa ribellione alle gerarchie, ordine senza
Stato, società senza dominio e vita senza biopolitica,
cristianesimo significa parafrasi, seppur rivelata dai cieli,
di molte di queste istanze. Cristo, si creda o no che sia figlio
di Dio, e certo non ci credo io che non ho mai abusato di stupefacenti
particolari, è stato un anarchico con pochissimi precedenti:
ribelle all'impero romano, contro le gerarchie del suo tempo,
creatore di micro-comunità (pensiamo agli apostoli) alternative,
e teorico di una fondamentale distinzione tra giusto e giustificato. “Cattolici
e anarchici” sarebbe una strana congiunzione – a
mio avviso falsa, perlomeno, a causa dell'incompatibilità
dei due congiunti. “Cristiani e anarchici”, al contrario,
è un'assimilazione che richiama analogie profonde e strutturali.
Omonimo libro, quello di Lucilio Santoni (Cristiani e Anarchici:
viaggio millenario nella Storia tradita verso un futuro possibile,
Infinito Edizioni, Modena, 2014, pp.144, € 12,00), si caratterizza
come un'articolata riflessione tra il cristianesimo (originario,
precedente alle confessioni che ne hanno tradito molti degli
assunti) e le condizioni di possibilità dell'anarchismo.
Se anarchia significa ribellione alle gerarchie, ordine senza
Stato, società senza dominio e vita senza biopolitica,
cristianesimo significa parafrasi, seppur rivelata dai cieli,
di molte di queste istanze. Cristo, si creda o no che sia figlio
di Dio, e certo non ci credo io che non ho mai abusato di stupefacenti
particolari, è stato un anarchico con pochissimi precedenti:
ribelle all'impero romano, contro le gerarchie del suo tempo,
creatore di micro-comunità (pensiamo agli apostoli) alternative,
e teorico di una fondamentale distinzione tra giusto e giustificato.
Anarchici e cristiani, dunque, non una dicotomia ma secondo
Santoni un'omonimia. Abile nell'unire, l'autore, comprende che
astraendo da tutto, forse da un po' troppo di questo “tutto”,
cristianesimo e anarchia sono due filosofie volte a sfumare
le distinzioni tra i pronomi della distanza: “io”
e “noi”. L'alterità, che sia per Cristo o
per Thoreau, è ciò che rende umani: agire per,
ovvero fare con uno scopo che tenda a un altrove abitato, è
l'unica forma di azione possibile. Penso dunque siamo,
al contrario del solipsismo cartesiano, pare essere la firma
di questo manifesto di Santoni colmo di azzardi, e dunque di
enunciati interessanti, dato che senza azzardo non si fa nient'altro
che ripetere già detti senza differenze.
Certo: io non so se davvero, come dice Vito Mancuso nella sua
prefazione al testo di Santoni, l'anarchico sia l'unico vero
cristiano, ma certo è che l'anarchico è l'unico
che oggi prende sul serio l'idea che questo sia un mondo che
vada vissuto senza piegarlo alla logica, aberrante e capitalista,
del self-interest. Va da sé: il cristianesimo
è contro i padroni in terra, ma rimane ancorato ai padroni
del cielo: e se il potere bieco viene rifiutato, un altro strano
potere rimane solido - quello di un qualcuno, sia pure divino,
che può controllare ogni tuo fare, e punire ogni tuo
dire. Nessuna critica, sia ben chiaro, al libello del Santoni:
perché anche io credo che essere anarchici, un po' come
cristiani, sia categoria dello spirito. E lo spirito, giustamente,
può non avere a che fare con Dio, ma esporsi semplicemente
al suo intendere l'esistere come ricerca della frugalità.
L'anarchia e il cristianesimo, onestamente, mi pare continueranno
a viaggiare su binari assai lontani ma chissà che, a
furia di correre verso un al di là che non sia solo aldilà,
non si ritrovino in questo strano e futuro mondo possibile in
cui la vita umana, come quella animale, prenda forma sociale
in assenza di geometria statale.
Leonardo Caffo
Ma il sogno non è
il contrario della realtà
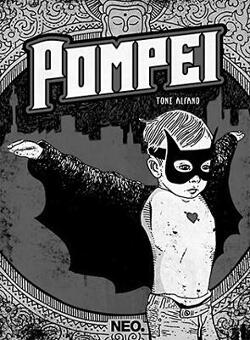 Non
sono una grande esperta di graphic novel lo ammetto. Dimentico
troppo spesso quanto sia meraviglioso il poter leggere dando
anche nutrimento ad un senso estetico visivo oltre che mentale
a noi stessi, che l'atto della lettura si compie. Non
sono una grande esperta di graphic novel lo ammetto. Dimentico
troppo spesso quanto sia meraviglioso il poter leggere dando
anche nutrimento ad un senso estetico visivo oltre che mentale
a noi stessi, che l'atto della lettura si compie.
Peccato perché nelle occasioni in cui invece mi sono
cimentata in questo doppio viaggio, potenziato in più
direzioni simultanee dell'apprendimento, in un universo di grafemi
molto più ampio che il mero alfabeto, ne sono uscita
assolutamente soddisfatta e con un immaginario più completo;
una guida visiva esteticamente stimolante che accompagnava una
storia avvincente. Si era trattato per lo più di pubblicazioni
legate all'ambito libertario, che narravano vite di figure conosciute
o meno del movimento anarchico, in cui la storia narrata veniva
descritta graficamente da immagini e schizzi di inchiostro con,
devo dire, sempre un bel tratto grafico a supporto dell'immaginazione
creativa.
Questa volta invece mi è capitata tra le mani Pompei
(NeoEdizioni, L'Aquila, 2014, pp.136, € 17,00), una
graphic novel di cui subito la copertina ha rapito il mio sguardo.
Mi si propone di leggerlo e dare un parere, in realtà
mi si fa un vero e proprio regalo. Pubblicato nel settembre
2014 da Neo Edizioni, Pompei, scritto e disegnato da Toni Alfano,
Pompei è un bellissimo romanzo grafico suddiviso in cinque
capitoli – ciascuno introdotto da una citazione –
e realizzato con l'uso di tre colori (bianco, nero e rosso),
mediante inchiostro e matita. Arrivato forse nel momento giusto,
di esso subito mi hanno colpita le tavole illustrate. Ancor
prima di capire di cosa parlasse, e mi aspettavo al solito una
storia con un inizio e una fine, mi sono sfogliata avanti e
indietro quei piccoli capolavori che ogni pagina offriva, fronte
e retro. Mi sono persa nel suo linguaggio visivo di così
eclettico impatto, capace di sintonizzare molteplici stili grafici
diversi, dal realistico al decorativo/stilizzato (non so se
siano gli aggettivi giusti tecnicamente per definire le illustrazioni
di Tony!) passando per schizzi da viaggio e appunti di ogni
forma, accompagnate da didascaliche perifrasi o preponderanti
calligrafie parlanti, come sibilline chimere e assolutamente
parte integrante del disegno. Un dialogo continuo tra segno
e senso, talvolta sinergico, talvolta dissonante e talvolta
silente, criptico e misterioso, profondo, quasi oscuro... un
sogno! Qualcuno l'ha definito, in breve, un diario onirico che
racconta la ricerca di sé e degli altri. Una sorta di
saggio filosofico che stuzzica l'intelletto su più fronti,
che fa fare un passo in avanti alla graphic novel e la spinge
dove non era forse mai arrivata. Non una storia da raccontare,
da illustrare ma un'esplorazione nei ricordi, nei sogni, negli
immaginari e nei tempi dell'umanità.
Un'analisi interiore e insieme una rassegna di stati d'animo
comuni a tutti gli esseri viventi eppure così intimi
e privati da non essere sempre di facile espressione collettiva.
Un appassionante disorientamento coglie il lettore-osservatore
alle prese con quest'opera è legato all'essere immersi
in un immaginario potente e frastornante, chiaro e caotico,
imprendibile e pieno di verità, vario, fatto di parti
irrelate eppure inspiegabilmente tenute insieme. Pompei è
viaggio visivo folgorante, il racconto di una scoperta, è
un tentativo di ricondurre all'unità ciò che nella
vita si sgretola o si blocca. Ad esso fa da sfondo una città
riconsegnata alla modernità nell'istante della propria
distruzione e diventa metafora per questo romanzo grafico poetico
e potente. Pare essere un sogno (vividissimo), infatti, la dimensione
entro la quale si muovono gli eventi, prendono l'avvio le riflessioni
e i ricordi della voce che leggiamo. Così scrive Toni
Alfano nell'introduzione dal titolo Pompei: “[...] le
nostre vite, le nostre relazioni, i nostri ruoli, sono solo
frutto di identificazioni, illusioni, destinate ad essere riassorbite
nella forza che le ha generate: un sogno”.
Ma il sogno non è il contrario della realtà, è
piuttosto ciò che esiste fuori dall'interpretazione,
dall'utilizzo, dal rinvenimento incessante dei significati;
è il vivere senza appigli, conferme, posizionamenti.
Leggere questo libro è stata un'esperienza intensa; rileggerlo
per scriverne un'avventura rivelatrice. Grazie anche a una recensione
in particolare, trovata su un blog di letture, [http://squadernauti.wordpress.com/2014/11/25/pompei/]
mi si sono rivelate probabilmente solo alcune delle migliaia
di sottili connessioni, allusioni e rimandi che fanno l'occhiolino
allo spettatore in uno scenario di lettere e simboli, allegorie
poetiche visivamente penetranti. A quel punto l'ho riletto nuovamente
e penso che inizierò ad usarlo come il libro delle risposte,
avete presente? Quello che apri a caso una pagina e ci trovi
tu la connessione. L'ho già sperimentato in qualche occasione
con Pompei e ne sono stata deliziata! Certo, leggerlo tutto
dall'inizio alla fine rivela intuizioni e riflessioni profonde
sullo stato d'essere dell'umano, su realtà e sogno, sulle
più recondite angosce del vivere, le paure e gli irrisolti,
sulla visione del tempo e dello spazio, sull'ambiente che ci
circonda e molto altro ancora, in maniera apparentemente confusa
ma in realtà ben articolata con sapiente riflessione.
E il volo conduce il lettore al quarto capitolo, ai tre colori
e all'inchiostro di Zeppelin (aperto da una frase di Ovidio),
alla grafica e al carattere della prima e della terza parte;
durante un viaggio in dirigibile, nella voce del narratore compare
ancora il motivo della paura, del disordine da esso generato,
di una vita che sfugge, del passato incarnato dall'infanzia.
Si assiste alla pratica di decontestualizzazione di frasi proprie
di certi ambiti (ad esempio, la bambina impegnata nell'esercizio
ginnico che tra la folla annuncia: “a tutti i passeggeri”,
p. 112); si ripresenta l'immagine del mattone rosso (già
citato a p. 27) che si può portare con sé senza
esitazioni solo nell'infanzia, allorché l'agire è
un gioco libero da scopi e condizionamenti (“un gioco
senza regole, senza ruoli, improvvisato e compiuto nella sacralità
della trasformazione”, p. 112). Con una citazione di Tolstoj,
si apre Molok. La sorgente, il capitolo quinto, che conclude
questo multiforme sogno. Qui anche la paura avrà fine,
qui l'umano affluirà (p. 130) in se stesso, libero, e
accetterà la compresenza di realtà e sogno, dell'abbandono
e del restare, della insopprimibile contraddizione dell'essere
al mondo: “C'è un luogo dove la parte manifesta
e quella non manifesta si uniscono. Dove i sogni possono descrivere
la realtà e viceversa. Questo luogo è sempre accessibile.
Le porte sono sempre aperte e i segreti che vi sono nascosti,
rivelati. Pochi sono però quelli che decidono di addentrarvisi,
perché la consuetudine umana, pur cogliendone il senso,
non tollera il paradosso. Non sopporta che questo sia
al contempo quello (p. 119).
Pompei è allora la rappresentazione di un sogno, di un'immagine
che si trasforma nel tempo; l'io attraversa la pluralità
e la molteplicità (di figure, di culture, di specie viventi,
di esseri semplici e composti, di invenzioni disegnate) e si
riunifica, pur rimanendo sostanzialmente dischiuso, e si disperde
nel sentire, restando corpo. Lo smarrimento dentro il quale
ci tiene Toni Alfano con quest'opera, che è di certo
un invito al lettore a mantenere viva una coscienza individuale
è il perdersi del fare esperienza, dell'“abbandono
del noto verso l'ignoto”, un osservare per guardarsi dentro.
Gaia Raimondi
Cent'anni
di non-solitudine
 È
uscito il quaderno curato dall'Associzione Culturale Centro
Studi Storici della Val di Pesa, “Storie di badanti e
di badati” con saggi e introduzioni di Gabriella
Fregoso e Stefania Mori, e illustrazioni del laboratorio d'arte
Acquerellando, insieme alla Scuola d'Italiano del Circolo
ARCI di S.Casciano. Il titolo esatto è BADA(n)TE
BADarci – Storie (offerta libera, pp. 32). È
uscito il quaderno curato dall'Associzione Culturale Centro
Studi Storici della Val di Pesa, “Storie di badanti e
di badati” con saggi e introduzioni di Gabriella
Fregoso e Stefania Mori, e illustrazioni del laboratorio d'arte
Acquerellando, insieme alla Scuola d'Italiano del Circolo
ARCI di S.Casciano. Il titolo esatto è BADA(n)TE
BADarci – Storie (offerta libera, pp. 32).
La scuola d'italiano per stranieri della quale mi occupo da
circa dieci anni ha, fra gli altri, lo scopo di dar voce dignità
e cittadinanza a chi spesso non ce l'ha. Questo secondo lavoro
dopo Il mondo è il tuorlo di un uovo sodo, rientra
nelle attività della Scuola. In questo caso la parola
è data ai numerosi assistenti domiciliari privati, detti
badanti, che ci frequentano. Si tratta di giovani uomini,
ma soprattutto giovani donne che vengono dalla Romania, dallo
Sri Lanka, dall'America Latina. È stata una signora dominicana
che alla nostra richiesta di raccontare per iscritto un episodio
significativo della sua vita e una ricetta ad esso collegata
- storia che avrebbe arricchito il lavoro pubblicato lo scorso
anno -, ha risposto: “perché invece di occuparvi
di storie legate al cibo non raccogliete le storie di quelle
come noi che vengono da lontano per occuparsi dei vostri parenti,
che li curano negli ultimi anni della loro vita e li accompagnano
verso la morte?”. Abbiamo ascoltato, letto e trascritto
i loro racconti e ci siamo imbattuti in una serie di elementi
che, interagendo, complicano di molto le cose.
Chi ha bisogno di cura offre un'opportunità a chi ha
bisogno di lavorare, ma a decidere chi, come e quando, sono
altri: i parenti di chi deve essere assistito. Questi comuni
cittadini, spesso lavoratori dipendenti sempre più deprivati
dei loro diritti, diventano datori di lavoro, devono vedersela
con leggi di mercato e con diritti altrui. La logica è
tendere al miglior sevizio possibile con i costi più
bassi. Non si ricercano particolari professionalità,
piuttosto la disponibilità a non considerare “lavoro”
il tempo impiegato. Le istituzioni, in ritardo rispetto al fenomeno
dell'invecchiamento della popolazione, tendono a risparmiare
sui costi dello stato sociale e invece di incrementare servizi
adeguati cercano di cavarsela finanziando solo in parte l'iniziativa
privata. Le sanatorie per colf e badanti sono una testimonianza
di quest'atteggiamento, si capisce dal confronto con le leggi
sull'immigrazione più rigide, selettive, aggressive.
L'opinione pubblica, come le istituzioni, tendono a minimizzare,
a far finta di nulla come se il lavoro di cura fosse un normale
lavoro domestico e che l'ultima parte della vita non fosse più
vita. Sullo sfondo, la storia sociale della donna che - serva,
colf o badante -, come sempre nei momenti difficili, deve interrompere
il suo percorso di emancipazione, lasciare la sua casa e mettersi
al servizio degli altri. Un badante scrive: “La domenica
mattina io guardavo il computer, mi collegavo con la mia famiglia
nel mio paese e lui diceva: “Dino lo vuoi il caffè?”
rispondevo: “Aspetta vengo io”. Ma non facevo in
tempo, dopo un minuto me lo portava lui. Anche con Novello sono
stato molto bene. Era un amico. Me lo diceva sempre: “Deni
siamo amici, vero?” Per Novello ero Deni, per Giorgio
ero Dino.” Le storie raccolte sono sufficienti a comprendere
che solo i rapporti umani di solidarietà e di amicizia
possono rendere più accettabile la vita di chi è
costretto a vivere queste esperienze.
Questo nuovo quaderno è collettivo, nel senso che hanno
partecipato diverse associazioni che lavorano nel sociale. Ci
sembra un buon viatico per orientare la discussione su un problema
che, pur riguardando un numero molto alto di persone, stenta
a uscire dalle mura domestiche.
Stefania Mori
stefaniamor@tiscali.it
- www.cssvp.com
Una bella figura di anarchica,
maestra, naturista, femminista
 “La
paura della libertà possono averla solo i tiranni; la
libertà degli altri non può in nessun caso nuocere
alla nostra, a meno che non si voglia imporre con la forza;
questo è il pericolo di tutti quelli che vogliono far
valere la loro ragione su quella degli altri; dover ricorrere
alla forza per imporla, cosa che deve generare la protesta e
ribellione dell'oppresso e produce disarmonia nelle relazioni
sociali, disarmonia che dev'essere sostenuta da leggi coercitive,
eserciti, tribunali ecc. ovvero da tutto ciò che tanto
critichiamo noi che propaghiamo la libertà integra dell'individuo
come base della perfetta organizzazione sociale”1. “La
paura della libertà possono averla solo i tiranni; la
libertà degli altri non può in nessun caso nuocere
alla nostra, a meno che non si voglia imporre con la forza;
questo è il pericolo di tutti quelli che vogliono far
valere la loro ragione su quella degli altri; dover ricorrere
alla forza per imporla, cosa che deve generare la protesta e
ribellione dell'oppresso e produce disarmonia nelle relazioni
sociali, disarmonia che dev'essere sostenuta da leggi coercitive,
eserciti, tribunali ecc. ovvero da tutto ciò che tanto
critichiamo noi che propaghiamo la libertà integra dell'individuo
come base della perfetta organizzazione sociale”1.
È uscito la scorsa estate un libro che narra la biografia
di Antonia Maymón (Carmen Agulló Díaz e
Pilar Molina Beneyto, Antonia Maymón. Anarquista,
maestra, naturista. Edizioni Virus, Barcelona, 2014, pp.
278, € 20,00), un libro che mi ha aperto gli occhi sulla
necessità della ricerca storica e del recupero della
memoria. Dopo averlo letto mi sembra impossibile che finora
potessimo sapere poco o niente della vita di questa donna, esempio
di coerenza, ma anche protagonista in prima persona delle lotte
e dei dibattiti dell'anarchismo spagnolo. Si tende a dire che
in Spagna ci sia stata abbondanza di anarchici nella pratica
ma che pochi si siano occupati della teoria: la vita e la grande
quantità di scritti di Antonia Maymón ci lasciano
testimonianza degli importanti dibattiti di inizo secolo in
cui si delinea il movimento che con tanta forza arriverà
al '36; e di come pedagogia e naturismo non siano meri interessi
degli anarchici bensì caratteristiche intrinseche al
movimento.
La vita privata e professionale di Antonia (1881-1959) è
stata completamente dedicata all'ideale anarchico. Maestra già
nel 1899, si orienta presto verso la pedagogia razionalista
e vive gli anni dei grandi scioperi nella Saragozza di inizio
secolo, città che accolse gli espulsi da Barcellona dopo
i fatti della Setmana Tràgica e la fucilazione
di Ferrer i Guàrdia. Tra questi, ricorda in particolare
Teresa Claramunt come sua iniziatrice agli ideali anarchici
“che apre gli occhi a una ragazza piena di pregiudizi”
e con la quale fonda il Comitato contro la guerra in Marocco
(causa della Setmana Tràgica). Dopo il suo intervento
in comizi e manifestazioni subisce la repressione dello sciopero
del 1911, e scappa a Bordeaux con il suo compagno, dove le segnalazioni
della polizia ci dicono che continua la sua militanza tra i
compagni esiliati e gli interventi come oratrice. Nel 1917,
dopo la morte del suo compagno, la troviamo di nuovo in Spagna
dove porta avanti un'instancabile attività; la sua vocazione
pedagogica si plasma non solo nell'insegnamento ma anche nella
scrittura di articoli e romanzi, e nella pronuncia di conferenze.
Collabora con riviste pedagogiche, naturiste, anarcosindacaliste
e femministe, e per gli argomenti che porta avanti nei maggiori
dibattiti dell'epoca si può considerare una delle donne
che più hanno riflettuto sull'anarchismo in Spagna.
La Maymón considera che la rigenerazione della società
sia possibile solo attraverso una nuova pedagogia che reintegri
l'uomo alla natura in tutti gli aspetti della vita. L'anarchismo
offre una soluzione agli errori sociali e il naturismo è
il mezzo per raggiungere un equilibrio con il resto delle forme
viventi. Per questo porta avanti il nesso indissolubile tra
anarchismo e naturismo, criticando fortemente il vegetarianesimo
naturista che fa riferimento solo a questioni alimentari, poiché
non si tratta solo della cura del corpo ma anche dello spirito.
Lo sviluppo integrale fisico è permesso solo a pochi
mentre la grande maggioranza muore facendo lavori estenuanti
e disumani; da qui il nesso con l'anarchismo perché tutti
abbiano diritto a una vita sana. Significativo è il concetto
approvato dal Congresso Naturista di Malaga del 1927, di cui
le era stata assegnata la presidenza: “Il naturismo non
può essere solo questione di stomaco, bensì di
naturalizzazione di tutti gli atti umani, il che è impossibile
senza una trasformazione sociale che permetta lo sviluppo integrale
dell'individuo”.
La critica alla scuola statale come strumento per perpetuare
l'ordine stabilito è il motore che la muove: “Come
un uccellino, che dopo tanti anni in gabbia non sa più
volare o si mette a volare disperatamente scontrandosi contro
il primo ostacolo che trova, così l'umanità all'uscire
dalla prigione infantile, si trova disorientata, diventando
alcuni pupazzi dei tiranni, ed altri tiranni dei propri simili,
e tutti boia di se stessi.”2
Abbiamo notizia della sua presenza in molte e diverse scuole
razionaliste della Catalogna ma anche di tutto il territorio
spagnolo dove porta avanti il modello di Ferrer arricchito da
un forte legame con la natura e la società. Vari ex-alunni
intervistati ricordano come la sua pedagogia li “iniziava
alla vita”. I continui spostamenti sembrano rispondere
alle chiamate dei compagni dove c'era bisogno di una persona
competente in materia di educazione ma anche alle forti reticenze
esercitate dai circoli conservatori dei diversi paesini dove
fu maestra. Oltre ad essere contrari ad un insegnamento anti
dogmatico e alla coeducazione di bimbi e bimbe, sembra che le
sue abitudini naturiste e la sua difesa dell'amore libero dalle
istituzioni creassero scandalo. A questo proposito interviene
nel famoso dibattito sul cameratismo amoroso tra Emile Armand
e Maria Lacerda da Sousa: la Maymón difende relazioni
sessuali libere basate sull'amore, inteso come comunione di
caratteri, crede quindi nella monogamia ma nella libertà
di entrambe le parti di terminare una relazione. Insiste sul
problema della libertà di scelta femminile che è
sottomessa all'indipendenza economica: nella società
capitalista sono impossibili relazioni libere quindi le donne
vendono il loro corpo in modo occasionale (prostituzione) o
definitivo e legale (matrimonio).
Una delle sue rivendicazioni più ripetute è la
maternità libera, cosciente e desiderata. Qui, come fanno
notare le autrici, il discorso femminista sembra sottomesso
a un'esagerata importanza della maternità, che considera
di ogni donna, e all'importanza di preparare le bambine ad essere
madri già dalla scuola con una materia chiamata maternología.
Fa riferimento anche all'eugenetica (nella corrente del neomalthusianesimo)
per evitare di produrre carne da cannone. Considera la madre
come persona che è capace di dare la vita non solo fisicamente
ma soprattutto a livello emotivo e intellettuale, figura che
rivendicherà in alcuni romanzi difendendo il ruolo della
madre adottiva e la possibilità di avere figli con chi
si vuole e quando si vuole. Scrive anche racconti infantili
contro i personaggi di fantasia e la superstizione.
Nel 1931 con la proclamazione della Repubblica troviamo i suoi
articoli più rivoluzionari che criticano le riforme palliative
repubblicane. Scrive contro la libertà “regalata”
per legge dal governo dopo una dittatura militare: “ay!
Questa merce non si vende né si procura gratis, si ottiene
a forza di carne macellata e ribelli schiacciati; in quanto
dono individuale, non si può trasferire ad altri e per
questo quando gli incauti vollero allungare la mano per prenderla,
se la videro sfuggire tra le dita. [...] Porque la libertad
o se vive o no es tal.”3
Negli anni '30 quindi quando aveva già cinquant'anni,
si ha notizia di due figli adottivi di circa 20 anni di cui
si prende cura e che danno una mano nelle scuole che gestisce,
ma che poi nella sua vecchiaia non la riconosceranno come madre.
Con la rivoluzione del luglio 1936 la troviamo tra Castellón,
Murcia e Valencia, non vuole incarichi politici per potersi
dedicare completamente alla pedagogia, continua comunque a partecipare
a comizi, si ricorda un intervento in ottobre '36 a fianco di
Federica Montseny in cui afferma chiaramente che la lotta antifascista
non era solo spagnola bensì mondiale e che la guerra
doveva essere vista in un processo più ampio di rivoluzione
sociale. Concetti fondamentali della guerra civile spagnola,
vista a posteriori, ma che sorprende sapere che fossero così
chiari in quel momento.
Collabora anche con Mujeres Libres tra il '37 e il '39,
troviamo un suo articolo nel primo numero della rivista omonima
dove critica l'educazione che si da alle bambine e loda il metodo
Pestalozzi.
Nel 1939 con la vittoria franchista finisce in carcere ma esce
nel 1940 per intercessione del prete del paesino murciano dove
insegnava e a cui lei aveva salvato la vita nel 1936 col risultato
che dovranno cambiare parrocchia al prete per le critiche dei
conservatori...
Negli ultimi anni entra ed esce dal carcere e vive precariamente
appoggiandosi a persone che la apprezzavano ma che come lei
non possedevano quasi niente. Contro la sua volontà termina
i suoi giorni in un ospedale di suore nel 1959.
Valeria Giacomoni
Note
1. Antonia Maymón: La Verdad, año I, nº9,
21 agosto 1932 citato a pag.88
2. Antonia Maymón: Helios, año VII, nº77,
ottobre 1922, pág 201-202
3. Antonia Maymón: Estudios, gennaio 1932, pág
62-63
Anarchia, rom,
amore, Italia
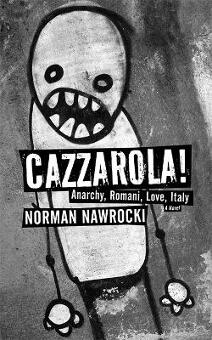 Ho
trovato il volume di Norman Nawrocki su una bancarella a Londra,
letteralmente sommerso da una montagna di libri. In mezzo a
tanti testi in inglese, è stato il titolo Cazzarola!,
scritto in capital, ad attirare la mia attenzione; il sottotitolo
poi, Anarchy, Romani, Love, Italy ha fatto sì
che lo comprassi senza pensarci troppo. Ho
trovato il volume di Norman Nawrocki su una bancarella a Londra,
letteralmente sommerso da una montagna di libri. In mezzo a
tanti testi in inglese, è stato il titolo Cazzarola!,
scritto in capital, ad attirare la mia attenzione; il sottotitolo
poi, Anarchy, Romani, Love, Italy ha fatto sì
che lo comprassi senza pensarci troppo.
Il libro di Nawrocki (PM Press, Oakland, 2013, pp. 320, €
14,20) mi risulta di difficile definizione; viste le sue caratteristiche,
lo definirei impropriamente un romanzo storico, ma anche - forse
sempre impropriamente - un romanzo realista. Divisibile in due
parti, il racconto copre 130 anni di storia italiana e narra
le vicende della famiglia Discordia, partendo dal bisnonno nato
nel 1880 tra le montagne dell'Abruzzo, arrivando ad Antonio,
musicista e studente di filosofia, la cui vita si svolge nel
quartiere San Lorenzo a Roma. Sono cinque le generazioni che
si raccontano all'interno dello stesso libro; storie ordinarie,
di persone comuni, ma straordinarie per il loro contenuto. La
famiglia Discordia è caratterizzata da un antagonismo
che accomuna tutti i suoi membri; attraverso i loro occhi l'autore
ricostruisce avvenimenti storici significativi, a cui hanno
partecipato individui affamati di libertà e giustizia
sociale come il biennio rosso, la resistenza al regime fascista,
la settimana rossa.
Quello di Nawrocki è un tentativo di raccontare la storia
italiana dando voce ai suoi protagonisti, a chi ha avuto parte
attiva in quegli accadimenti e ha creduto e lottato per un cambiamento.
È, a mio avviso, un tentativo riuscito di descrizione
storica, di cui ho apprezzato la mancanza di linearità
e l'accento sulla correlazione degli eventi. I personaggi sono
uniti da un legame di parentela, così gli eventi descritti
sono accomunati dall'opposizione ad ogni forma di autoritarismo,
dalla resistenza alle imposizioni, dalla ricerca di libertà
e uguaglianza.
Nella prima metà del libro troviamo le vicende di tre
fratelli Discordia, Ricardo, Rafaele e Massimo, nati nel 1900,
decisi a lasciare il villaggio natio in Abruzzo perché
stanchi di una vita da braccianti nei possedimenti di un grande
proprietario terriero. Sullo sfondo, l'Italia di inizio Novecento
che non ha dimenticato i moti popolari del 1898, Bava Beccaris
e i colpi di cannone sparati sulla folla affamata.
Presto le strade dei tre fratelli si dividono, con Ricardo che,
ancora quindicenne, decide di mentire sulla propria età
e partire per il fronte, ammaliato dalla propaganda sulla giustezza
della prima guerra mondiale. Attraverso gli occhi di Ricardo,
osserviamo la vita in trincea, vediamo tutti i proclami patriottici
dissolversi di fronte all'insensatezza dell'uccisione di giovani
che si differenziano solo per il colore della divisa; poi la
decisione di disubbidire e l'avvicinamento ai movimenti radicali.
Nel libro, il personaggio racconta la sua storia proprio ad
un giovane collaboratore di A-Rivista Anarchica, intento a raccogliere
testimonianze sui disertori.
Terminato il resoconto di Ricardo, il lettore si trova catapultato
a Torino, tra le mura della fabbrica Fiat in cui Massimo Discordia
lavora come operaio; si sta pianificando l'occupazione dell'intero
stabilimento: è il 1920. Siamo in pieno biennio rosso
e di nuovo l'autore ci mostra la storia attraverso gli occhi
di chi vi ha preso parte.
Percepiamo così la tensione dei lavoratori nel pianificare
l'occupazione, la rabbia che li ha spinti ad agire, la speranza
nella rivoluzione sociale, la paura che li pervade al pensiero
che possa sopraggiungere l'esercito e che al fallimento dell'operazione
segua il licenziamento. Il lettore viene trascinato in mezzo
a loro, tra gli operai che denunciano il mancato aumento dei
salari nonostante il generale aumento dei prezzi; sembra di
sentire il rumore assordante dei macchinari, il suono stridente
del ferro sul ferro, le grida dei feriti, numerosissimi in quegli
anni a causa dell'assenza di misure di sicurezza negli stabilimenti.
Poi la decisione del partito socialista di non appoggiare né
sostenere una rivoluzione e gli industriali che rientrano, non
senza timore, nelle fabbriche.
L'escalation fascista segue alla paura di un possibile
sovvertimento dell'ordine politico ed economico costituito,
sono in molti a credere nei proclami mussoliniani; le camicie
nere diventano sempre più numerose e armate. Poi la marcia
su Roma, la dittatura, la nascita degli Arditi del Popolo e
la resistenza. È qui che incontriamo Enrico Discordia,
un partigiano, e sua moglie Isabella, una staffetta. Sono loro
a descriverci le difficoltà della vita passata sui monti
a contrastare la tirannia. È con loro che conosciamo
le spedizioni punitive, le fughe, il confino. Il racconto è
frammentato, arricchito da notizie tratte da giornali italiani,
continuamente riportato a vicende più contemporanee,
come la strategia della tensione degli anni '70, la difficile
situazione della popolazione rom in Italia e il recente rafforzamento
dei movimenti neofascisti nelle periferie di Roma.
Il continuo interrompersi della narrazione, i salti temporali,
vengono utilizzati dall'autore per mettere in luce la presenza
di un comune denominatore che accomuna tutti gli eventi descritti,
quasi a segnalare un eterno ritorno della storia che ripropone
costantemente le proprie dinamiche: la violenza compiuta da
chi detiene il potere al fine di mantenere invariato l'ordine
costituito e gli aspri contrasti in seno alla popolazione, tra
chi si schiera con l'autorità e chi invece vi si oppone.
La seconda parte del volume ruota quasi unicamente intorno alla
storia di due personaggi a noi contemporanei, Antonio Discordia
e Cinka Dinicu; lui studente di filosofia e musicista, vive
nel quartiere San Lorenzo a Roma, lei giovane rom trasferitasi
in Italia dopo la morte del padre, vive non senza problemi in
un campo nomadi nella periferia romana. A scandire la vita di
questa coppia, razzismo, incomprensioni, pregiudizi e una continua
contrapposizione noi-voi che non permette di vivere liberamente.
Un gadjo e una rom, tanto malvisti per le strade di Roma
quanto all'interno del campo. Cinka ci porta per i vicoli romani,
dove suona il violino, mostrandoci tutte le difficoltà
di una vita dettata dall'incertezza e dalla precarietà.
In questa seconda parte l'autore traccia anche una descrizione
delle periferie romane in cui aleggiano tensioni irrisolte,
pronte ad esplodere da un momento all'altro; una situazione
di cui i fatti di cronaca dell'ultimo periodo sembrano darci
conferma.
Con la storia di Antonio e Cinka, si conclude una narrazione
lunga 130 anni.
Cazzarola! è un tentativo ambizioso di presentare
quasi un secolo e mezzo di storia dell'antagonismo e dei movimenti
radicali in Italia, un progetto che richiederebbe forse volumi
didascalici e lineari; la scommessa di Nawrocki è invece
quella di proporre una soluzione diversa, un resoconto incalzante
di testimonianze articolate sotto forma di romanzo.
Carlotta Pedrazzini
Destini incontrati
e raccontati
 Si
sente “un ladro di anime” Corrado Stajano per la
curiosità mai sopita che lo porta a trafugare destini
compiuti di uomini e donne (Corrado Stajano, Destini,
Archinto, Milano, 2014, pp. 192, € 15,00). Figure tratteggiate
di fino, interpreti della storia del Novecento. Nella raccolta
dei ritratti, nell'arco di circa quarant'anni, la sensibilità
di Stajano scrittore indaga e accoglie non soltanto il bel mondo
popolato da protagonisti indiscussi, distinti, conosciuti. Certo,
compaiono amici, maestri, penne note e volti di elevata caratura
come Alberto Cavallari, “testimone di dignità perduta”,
autentico artigiano della scrittura e grande giornalista, incontrato
in casa di Elio Vittorini a Milano lungo i Navigli. E, riprendendo
i titoletti degli articoli, conosciamo i destini dei conti di
Collegno, di padre David Maria Turoldo, “il frate rosso”,
di Cesare Cases, “il ragazzo di bottega che umiliò
Thomas Mann”. Incontriamo Giulio Einaudi, “l'editore
di un'altra Italia” e Franco Cavallone, “il notaio
che inventò le toffolette”, tenera e morbida parola
per designare gustosi dolcetti americani. Raffaele Mattioli,
un banchiere umanista, illuminato, letterato e mecenate. Si
sente “un ladro di anime” Corrado Stajano per la
curiosità mai sopita che lo porta a trafugare destini
compiuti di uomini e donne (Corrado Stajano, Destini,
Archinto, Milano, 2014, pp. 192, € 15,00). Figure tratteggiate
di fino, interpreti della storia del Novecento. Nella raccolta
dei ritratti, nell'arco di circa quarant'anni, la sensibilità
di Stajano scrittore indaga e accoglie non soltanto il bel mondo
popolato da protagonisti indiscussi, distinti, conosciuti. Certo,
compaiono amici, maestri, penne note e volti di elevata caratura
come Alberto Cavallari, “testimone di dignità perduta”,
autentico artigiano della scrittura e grande giornalista, incontrato
in casa di Elio Vittorini a Milano lungo i Navigli. E, riprendendo
i titoletti degli articoli, conosciamo i destini dei conti di
Collegno, di padre David Maria Turoldo, “il frate rosso”,
di Cesare Cases, “il ragazzo di bottega che umiliò
Thomas Mann”. Incontriamo Giulio Einaudi, “l'editore
di un'altra Italia” e Franco Cavallone, “il notaio
che inventò le toffolette”, tenera e morbida parola
per designare gustosi dolcetti americani. Raffaele Mattioli,
un banchiere umanista, illuminato, letterato e mecenate.
Non manca l'amicizia, nata in Sardegna, con Peppino Fiori, guida
e maestro. Il giovane Stajano, con la trasmissione “AZ.
Un fatto come e perché”, sarà coinvolto
nell'avventura televisiva.
Facendo leva sul coraggio della verità, Fiori riuscirà
a gettar luce sul caso Satgia, pastore innocente di Orgosolo
condannato all'ergastolo, dando un decisivo contributo per la
sua liberazione. A Milano, Stajano incontra l'amico e maestro
sardo impegnato con la troupe di Tv7 per un servizio sui funerali
delle vittime di piazza Fontana, e nel corteo funebre dietro
le bandiere nere degli anarchici, anche Tiziano Terzani, il
bravo cronista e “viaggiatore incantato”, con in
groppa il figlio Folco.
Invece, l'esistenza di Claudio Magris, mai sentito nominare
prima, si paleserà a Corrado Stajano, mentre insieme
a Ermanno Olmi stava conducendo un documentario sulla lettura
in Italia, nei primi anni Settanta. Nella biblioteca aperta
nel cuneese da Giulio Einaudi, l'incontro con un contadino di
Dogliani. Voleva leggere “Il mito asburgico” di
Magris, lui, che aveva fatto la guerra contro gli Asburgo. “Si
deve conoscere il mondo per progredire”, diceva. La saggezza
contadina aveva colto nel segno.
Tuttavia, la prospettiva di Stajano presuppone sempre un'ottica
dal basso.
Riaffiora nei suoi scritti chi è scivolato nelle retrovie
della dimenticanza, oppure chi, sconosciuto, in qualche modo
vive ancora nella mente. Destini ai margini, come quello di
Danilo Montaldi, cremonese, classe 1929, morto “annegato
coi suoi sogni di rivolta” al modo degli emarginati dei
suoi scritti. I maestri? Un padre marinaio, condannato per aver
scritto una lettera a un anarchico, e un piastrellista, il Butta,
che portò in provincia la notizia delle purghe di Stalin.
Accanto, una moglie capace di alleviargli la sofferenza di emarginazione,
la stessa toccata ai suoi personaggi. Giorgio Manzini, mantovano,
“l'umile cronista delle tute blu” degli operai della
Falck di Sesto San Giovanni, e dopo la strage di Piazza Fontana,
delle trame che insanguinarono il Paese, il terrorismo. Non
cede a compromessi, non è un arrampicatore, si sente
un escluso. Ha una testa e un'umiltà da contadino, e
allo stesso tempo dell'operaio-uomo-massa schiacciato nell'ingranaggio
della ripetitività quotidiana. Ma porterà avanti
fino in fondo la sua missione.
Saverio Tutino, l'amico partigiano della Val d'Aosta e del Canavese,
“guerrigliero della memoria”, raccoglitore di destini
di uomini e donne senza nome, scovati nei loro diari. Forse
il più famoso, quello di una contadina mantovana, scritto
su un lenzuolo a due piazze. Poi l'idea di creare un Archivio
nazionale dei diari, a Pieve Santo Stefano, nell'aretino, per
strappare dall'oblio i destini di chi, senza far rumore, ha
gettato le radici della storia tra Otto e Novecento.
Destini compiuti si intersecano con quelli di mogli, compagne,
sorelle, nonne rimaste dietro le quinte. Presenze incisive occhieggiano
sullo sfondo come fari luminosi, insostituibili guide.
Scorrendo questi destini, ci si chiede: avrebbero potuto trovare
compimento senza la loro presenza?
Come è successo a Vincenzo Consolo, “l'amico della
lava nera”, conosciuto a Zafferana Etnea in occasione
del premio letterario “Zafferana-Brancati, nell'autunno
del 1968. Un'amicizia continuata a Milano negli anni di piazza
Fontana, quando Consolo si sentiva ancora un immigrato. Non
riusciva a concludere la sua seconda opera. La spinta decisiva
alla conclusione del libro giungerà proprio dalla moglie
Caterina: lo incoraggia, lo scuote dalla paura di scrivere,
dal pudore. Pubblicherà il suo romanzo storico “Il
sorriso dell'ignoto marinaio”, nel 1976.
E le donne di Ermanno Olmi? Una madre di famiglia contadina:
saprà far campare la famiglia in una povera casa di ringhiera,
dopo il licenziamento del marito ferroviere, per essersi rifiutato
di prendere la tessera del fascio. Ermanno ancora piccolo imparerà
a fare il pane, durante le lunghe estati contadine trascorse
dalla nonna a Treviglio, nel bergamasco, mentre si dava da fare
come garzone di fornaio. Donne che apriranno la sua sensibilità
poetica a quel mondo dalle tonalità minori, ma cariche
di profonda umanità. E poi la moglie Loredana, “presente
anche quando non c'è” , riferimento importante
soprattutto nei momenti in cui è difficile mantenere
accesa la speranza.
Romano Bilenchi, “il ribelle di Colle Val d'Elsa”,
scrittore sempre lucido nella memoria. Intrappolato nella sua
lunga malattia che gli impediva anche di parlare. Troverà
la forza nella presenza insostituibile di una donna, la moglie
Maria, compagna di una vita, in grado di leggere le sue parole
mute e di farsi tramite del suo pensiero di uomo e scrittore,
fermo e pronto nell'anteporre in ogni circostanza le ragioni
della libertà. L'affettuosa amicizia con Paolo Volponi,
avvocato, poeta visionario dai libri dimenticati, “convinto
che i ribelli fossero il lievito della terra” e “la
nevrosi la coscienza critica del mondo”. Direttore dei
servizi sociali e culturali alla Olivetti di Ivrea, in seguito
Volponi soffrirà per esserne escluso. Rilevanti figure
femminili puntellano il suo cammino: Giovina Jannello, intelligente,
colta, prestigiosa assistente personale di Adriano Olivetti,
sarà al fianco di Paolo, fermo sostegno agli scossoni
dell'esistenza. E un'altra donna dal forte temperamento fa capolino:
la sorella minore, Maria Luisa, risoluta madre badessa delle
Clarisse di Urbania.
Sarà un'altra donna ancora, Maria, moglie dello scrittore
Giuseppe Antonio Borgese a fissare la memoria dei destini incontrati
dal 1915 al 1947, a Palazzo Crivelli, a due passi da Brera,
a Milano. Firme di artisti, letterati, politici, molti in seguito
perseguitati, esiliati, o morti nei lager venivano richieste
da Maria in segno di amicizia, e gli invitati le imprimevano
su una tovaglia di lino bianco. Poetessa, scrittrice, amante
del teatro, riservata e accogliente, ricamerà quei nomi
scritti col lapis a punto erba, con il filo rosso, per lasciarne
indelebile traccia. Oggi, la nipote Giovanna conserva la tovaglia
di lino bianco, appesa a una parete. Un'opera senza vetro, senza
cornice, a memoria di quei destini tanto diversi, insoliti,
molti tragici.
Attraverso lo sguardo d'insieme dei ritratti incontrati -e non
sono pochi- si può dire che lo stesso Stajano ripercorra
a ritroso anche il proprio destino. Compagne di strada? Una
passione empatica, una capacità di vedere dentro le pieghe
dell'esistenza. E una scrittura chiara, essenziale, profonda,
capace di esprimere “Il colore della vita”.
Claudia Piccinelli
Anarchia
nel Regno Unito
Ovviamente non è fatto di grande momento ma è
bene premettere a quanto scriverò che non sono un lettore
abituale di Dylan Dog, non mi spiace ma non lo leggo regolarmente
e se la mia attenzione è caduta sul fascicolo del dicembre
2014, che mi è stato segnalato da un mio amico, è
stato per il titolo e la bellezza della copertina. Un titolo
(Anarchia in Inghilterra, Sergio Bonelli Editore, Milano,
2014, n. 339, pp. 100, € 3,20) che rimanda ad una nota
canzone dei Sex Pistols del 1977, Anarchy In The UK,
che propone un' interpretazione dell'anarchismo che nulla ha
a che vedere né con l'anarchismo comunista e classista
né con quello umanista, ma che ha un indubbio fascino
o che quantomeno ne aveva allora per me dal punto di vista estetico.
Ne riporto due brani che, a mio avviso, ne rendono tutto il
carattere giovanilista/nichilista:
Io sono un anticristo
Io sono un anarchico
Non so cosa voglio
Ma so come ottenerlo
Voglio distruggere un passante
Perché io voglio essere l'anarchia
Non uno schiavo
Voglio essere anarchico
(Oh, che nome)
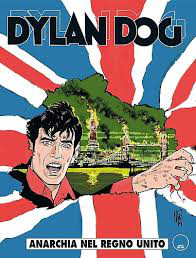 Voglio
essere anarchico Voglio
essere anarchico
(Sono completamente ubriaco)
Torniamo a Dylan Dog, si tratta di un detective che ha a che
fare con il sovrannaturale, con mostri di ogni sorta, con crimini
ai confini della realtà. Come può l'anarchia irrompere
nella sua vita? Avviene che Dylan Dog venga, ingiustamente va
da sé, fermato e portato in una stazione della polizia
dove viene portato anche John Malloy, il leader carismatico
del News Slaves Riot (nuova sommossa degli schiavi), individuo
dall'attitudine non propriamente tenera, una sorta di macchina
della rivolta. I membri del movimento stanno devastando Londra
e assediano la stazione della polizia per liberare il loro leader
e gli scontri raggiungono uno straordinario livello di violenza.
Dylan Dog si rende conto che sta avvenendo qualcosa di straordinario,
rileva che Malloy canta una vecchia canzone, Here lies justice
(Qui giace la giustizia) e si rende conto che è in azione
lo spirito di un agitatore del diciannovesimo secolo, Andrew
Keed, assassinato in modo atroce nel 1854 da uomini dei padroni
dell'azienda contro cui si batteva. Andrew Keed, infatti, portava
una maschera per nascondere deturpazioni causategli da un incidente
sul lavoro e i rivoltosi che devastano Londra a assaltano la
stazione di polizia portano una maschera simile. A questo punto
Dylan Dog evade dalla prigionia e raggiunge il vecchio stabilimento
abbandonato dove Andrew Keed era stato lasciato morire di fame
in una cella segreta e, incendiando il tutto, ne libera lo spirito.
Di colpo i ribelli rinsaviscono, le maschere che ne coprono
il volto scompaiono, la rivolta, che Dylan Dog comprende ma
non condivide, finisce.
Insomma una singolare anarchia, mera distruzione ad opera di
masse invasate da uno spirito angosciato, un uguagliamento dell'anarchia
alla mera distruzione ma, nel contempo, un'efficace denuncia
dell'oppressione sociale sia nel 1854 che nel 2014 e, questa
è la cosa che più mi interessa, la comprensione
del fatto che oggi l'ordine del mondo è a rischio. Una
comprensione che attraverso un giornale a fumetti viene comunicata
a strati della popolazione che la comunicazione nostra raggiungerebbe
a stento. Se poi qualche lettore di Dylan Dog, incuriosito dal
titolo, volesse informarsi sull'anarchismo...
Cosimo Scarinzi
Errata corrige
Sullo scorso numero (“A” 394, dicembre 2014 - gennaio
2015) nell'articolo
di Piero Brunello “Cent'anni dopo” (a p. 124),
per un nostro errore è stato scritto che i processi per
infrazione alla legge marziale furono un milione; in realtà
gli individui, quasi tutti soldati, incorsi in procedimenti
penali, furono circa 400mila. Ce ne scusiamo con l'autore e
con i lettori.
|

