
Per una critica radicale
dell'economia politica
 Dieci
anni prima dello scoppio del crack finanziario, su una rivista
tedesca del 1995, un caustico pubblicista di nome Robert Kurz
raggelava l'euforia dei Nineties, sostenendo che «se l'estate
siberiana del boom fordista nel dopoguerra» era stata
già breve, «l'epoca seguente del “capitalismo
da casinò”» degli anni '80 e '90 sarebbe
stata «ancora più breve» (1).
La crisi finale, anzi, era già in corso dagli anni '70
e presto uno scoppio fragoroso l'avrebbe annunciata al mondo.
«Crisi?... quale crisi?», chiosavano nel frattempo
gli osservatori economici, e la tesi di Kurz restò «voce
di uno che grida nel deserto». Gli «uomini il cui
orizzonte è il mercato – commentò Kurz –,
[...] “credono” alla crisi assoluta solo quando
loro stessi mangiano dalla pattumiera». Dieci
anni prima dello scoppio del crack finanziario, su una rivista
tedesca del 1995, un caustico pubblicista di nome Robert Kurz
raggelava l'euforia dei Nineties, sostenendo che «se l'estate
siberiana del boom fordista nel dopoguerra» era stata
già breve, «l'epoca seguente del “capitalismo
da casinò”» degli anni '80 e '90 sarebbe
stata «ancora più breve» (1).
La crisi finale, anzi, era già in corso dagli anni '70
e presto uno scoppio fragoroso l'avrebbe annunciata al mondo.
«Crisi?... quale crisi?», chiosavano nel frattempo
gli osservatori economici, e la tesi di Kurz restò «voce
di uno che grida nel deserto». Gli «uomini il cui
orizzonte è il mercato – commentò Kurz –,
[...] “credono” alla crisi assoluta solo quando
loro stessi mangiano dalla pattumiera».
Quattro lustri dopo, quando anche il soddisfatto «ceto
medio ha iniziato a frugare nei contenitori» (2)
dell'immondizia, le idee della «critica del valore»
che Kurz ha elaborato con E. Lohoff, N. Trenkle, A. Jappe fra
gli altri, cominciano a suscitare meno indifferenza: sic transit
gloria mundi.
Nello scorso mese di giugno è uscito, per Mimesis, Terremoto
nel mercato mondiale (Mimesis, Milano, 2014, pp. 86, €
5,90), di Trenkle e Lohoff. Il libretto, in poche pagine, rende
gli strumenti del pensiero marxiano adatti a ristabilire il
giusto nesso tra «l'enorme bolla dei mercati finanziari»
e la più generale crisi del capitalismo. Il lettore viene
così scrollato dall'ipnosi, di sapore antisemita, delle
attuali «personificazioni» della crisi che vanno
dalle urla contro la casta degli speculatori, ai deliri del
signoraggio.
Attribuire responsabilità esclusivamente al capitale
finanziario, inoltre secondo gli autori, significa rovesciare
la «connessione di causa-effetto» della logica capitalistica.
La vera causa del tracollo si trova sotto la superficie finanziaria,
nelle profondità contraddittorie del meccanismo capitalista.
Ma di quale contraddizione parla la «critica del valore»?
Per Marx - riferimento teorico insostituibile - il valore di
una merce è dato dal tempo di lavoro speso per la sua
produzione. Il «lavoro» che dà sostanza al
valore però, il lavoro astratto, è un'astrazione
tipica del solo capitalismo, una funzione che riduce tutti i
differenti lavori concreti a «quantità di tempo
indifferenziato speso per produrre una merce» (3).
Una merce rappresenta, sul mercato, una mera quantità
di lavoro astratto in base alla quale può essere scambiata
con altre che esprimano una quota uguale della medesima sostanza.
Nel meccanismo di valorizzazione, anche i lavoratori sono privi
di differenze e ridotti a semplici portatori di capacità
di lavorare: una capacità qualsiasi da riversare nelle
diverse branche della produzione. Un operaio può sempre
essere convertito in centralinista, purché lavori e produca
valore. In questo gioco sociale, la capacità di lavorare
diventa una merce (la forza-lavoro) da vendere agli imprenditori
in cambio di un salario. I capitalisti hanno il ruolo di generare
nuovo valore costringendo i portatori di forza-lavoro a lavorare
più tempo di quanto sia necessario a riprodurre il valore
che costano. Per ottenere questa «estorsione di plusvalore»,
i proprietari di capitale sono costretti ad aumentare ossessivamente
la produttività, rinnovando il potenziale tecnologico.
Ma, ed è questa la contraddizione centrale, la rincorsa
tecnologica ha condotto, negli ultimi trent'anni, ad un livello
di produttività così alto che il lavoro umano
– l'unica merce in grado di generare valore – è
diventata superflua per la produzione. Il capitalismo ha segato
il ramo sul quale era seduto. Negli anni '80, però, il
crollo fu rimandato proprio grazie alla stampella del capitale
fittizio e l'accumulazione sembrò così ripartire.
Ma, nello scambio di prodotti finanziari, anche se il denaro
venduto come merce ritorna accresciuto, si accresce soltanto
di una sostanza fittizia, non basata su «valore effettivo».
Con la creazione di titoli, infatti, si anticipa un valore –
che viene utilizzato da subito come fosse «reale»
–, sperando nella sua futura effettiva realizzazione nel
processo di produzione. Come in un incantesimo, il capitale
si accresce, raddoppia secondo dinamiche che il libro spiega
con originalità; ma la massa di valore, la vera sostanza
della ricchezza capitalista, non aumenta di un grammo.
Tuttavia, se il valore anticipato non viene poi generato nella
produzione di merci tramite impiego di forza-lavoro, il meccanismo
crolla: tutte le bolle finanziarie, in ogni crisi, sono scoppiate.
Che fare?
In un contesto in cui il lavoro – restando la base di
una società in cui senza vendere forza-lavoro non è
possibile accedere alle risorse – si è trasformato
in una comparsa costretta a recitare sul palco tecnologico-informatico
soltanto per qualche minuto; autorevoli esponenti politici propongono
con acume di trasformare i «servizi per il lavoro in un
diritto di cittadinanza» (4). Per
farne cosa?
E i tentativi di risanamento e austerità? Secondo gli
autori: una drammatica fiction degli Stati per conservare credibilità
sui mercati finanziari e rimandare di un poco il crollo della
montagna di promesse di pagamento ormai insolvibili.
La critica radicale piuttosto, ecco la proposta del libro, dovrà
dirottare la produzione verso i bisogni concreti svincolando
la società dalle assurde contraddizioni della logica
del valore. Voler mantenere in vita artificiale il cadavere
del capitalismo, condannando milioni di disoccupati a cercare,
per sopravvivere, di interpretare ancora quel ruolo superfluo
che qualcuno favoleggia di trasformare in un «diritto»
o a morire di fame in mezzo all'abbondanza sarebbe, secondo
gli autori, la più grande «occasione mancata»
della critica dell'economia politica.
Riccardo Frola
Note
1. R. Kurz, «La fine della politica
e l'apoteosi del denaro», Manifestolibri, p.119
2. Sono dichiarazioni di M. Iazzolino, segretario
generale della fio.PSD
3. A. Jappe, in Gruppo Krisis, Manifesto
contro il lavoro, DeriveApprodi, p.126
4. È quanto ha sostenuto G. Cuperlo,
Corriere della sera 23/09/2014
Educazione
alla diversità
Noi popoli indigeni non siamo il problema.
Siamo piuttosto, in larga misura, la soluzione.
(E.L. Hernandez, teologo messicano zapoteco)
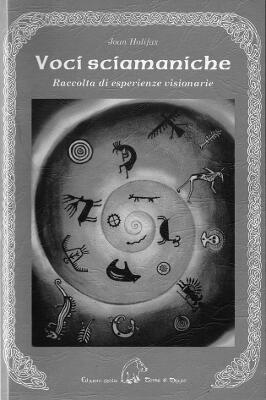 Voci
sciamaniche è una “raccolta di esperienze visionarie”
(Editore della terra di mezzo, Milano, 2013, pp. 272, €
23,00) – come recita il sottotitolo - che vanno a comporre
il libro curato da Joan Halifax, trent'anni fa, negli Stati
Uniti, stampato poco dopo in Italia da Rizzoli e che, nel 2013,
le Edizioni della Terra di Mezzo hanno riproposto. (La curatrice
del volume oggi è monaca buddista. In gioventù
si laureò in filosofia e antropologia, per molti anni
collaborò col grande studioso di miti Joseph Campbell,
fu moglie di Stanislav Grof - psichiatra e ricercatore nel campo
degli stati di coscienza non ordinari - con il quale sperimentò
l'LSD come mezzo per alleviare le sofferenze dei malati terminali.
Passò inoltre lunghi periodi della sua vita tra i Dogon
del Mali e gli Huicholes e i Maya del Messico, studiando la
loro cultura e partecipando ai rituali sciamanici). Voci
sciamaniche è una “raccolta di esperienze visionarie”
(Editore della terra di mezzo, Milano, 2013, pp. 272, €
23,00) – come recita il sottotitolo - che vanno a comporre
il libro curato da Joan Halifax, trent'anni fa, negli Stati
Uniti, stampato poco dopo in Italia da Rizzoli e che, nel 2013,
le Edizioni della Terra di Mezzo hanno riproposto. (La curatrice
del volume oggi è monaca buddista. In gioventù
si laureò in filosofia e antropologia, per molti anni
collaborò col grande studioso di miti Joseph Campbell,
fu moglie di Stanislav Grof - psichiatra e ricercatore nel campo
degli stati di coscienza non ordinari - con il quale sperimentò
l'LSD come mezzo per alleviare le sofferenze dei malati terminali.
Passò inoltre lunghi periodi della sua vita tra i Dogon
del Mali e gli Huicholes e i Maya del Messico, studiando la
loro cultura e partecipando ai rituali sciamanici).
Philippe Godard in un bell'articolo “La vita come un gioco”
pubblicato su questa
rivista nel dicembre 2014, dice: «Il “mondo”
è un concetto che implica un'unica realtà: l'infinito
dell'orizzonte e degli esseri. Se questa infinita diversità
resiste, evolve, se certe culture scompaiono, ma altre vedono
la luce, allora il mondo è mondo. In caso contrario,
non è che una prigione a livello globale. In origine,
ogni cultura inventata dall'uomo è stata soltanto un
gioco: esseri umani inventarono cosmogonie, come i bambini immaginano
una situazione nel mondo; si diedero regole e modi di vivere
come fanno i bambini nei loro giochi del momento. Il fatto che
questi giochi di culture, divenendo complessi, siano diventati
altrettanti ostacoli alla libera realizzazione degli esseri
e dei desideri non impedisce che il gioco resti all'origine
del mondo umano: la vita è un gioco, e il bambino sa
che cos'è il gioco di vivere».
A questo pensiero voglio aggiungere una riflessione ovvia ma,
penso, non inutile. Voglio sottolineare l'evidenza del fatto
che noi siamo immersi nel mondo culturale di una sola e piccola
parte dell'emisfero, mentre contemporaneamente esistono altri
popoli e altre geografie che, anche, stanno facendo –
hanno fatto – la storia. Quindi è chiaro che abbiamo
la possibilità di vivere la nostra storia come punto
di vista interlocutorio in mezzo ad altre storie – alle
quali è stata data meno risonanza, ma che non sono per
questo meno importanti o prive di significato –, oppure
possiamo perpetuare la visione meschina e calcolatrice di chi
pensa che gli altri siano sempre più arretrati, inferiori
o primitivi, in ogni caso da non prendere in considerazione.
In una prospettiva interlocutoria il senso della vita che ognuno
di noi va ricercando emerge dal confronto della molteplicità,
nel secondo caso il senso della vita si esaurisce e viene meno.
Aggiungo che la storia si è sempre costruita su mitologie,
da sempre per tutti i popoli via d'accesso al mondo dello spirito
e matrice dei comportamenti umani più ancestrali e profondi.
Il mito nasce in risposta a bisogni primordiali - ripararsi,
scaldarsi, nutrirsi... – e non ha esaurito la sua funzione;
trovo quindi interessante chiedermi, e chiedere, quale sia il
mito che dà senso alla vita quotidiana di ognuno di noi,
qual è il mito capace, oggi, di spiegare la nostra vita?
Lascio aperta la domanda e con questi pensieri mi avvicino alle
voci sciamaniche che sono raccolte nel libro di cui voglio parlare.
In circa duecentocinquanta pagine si susseguono trentasei narrazioni,
trentasei voci che ci mettono a confronto con mondi lontani
dal nostro abituale orizzonte. Un panorama vasto e variegato
che comprende Siberia, Australia, Africa, Groenlandia, Melanesia
e le Americhe del Nord, Centro e Sud. Luoghi dove lo/a sciamano/a
è una figura centrale - mistica, sacerdotale e politica
allo stesso tempo - con molteplici funzioni. Oltre a essere
uno specialista dell'anima è guaritore, veggente, visionario,
poeta, cantore, è capo spirituale, ma spesso anche giudice
e politico, in quanto depositario della storia e della cultura
sacra e secolare del suo popolo.
La figura sciamanica nasce durante il paleolitico superiore
e oggi sopravvive ovunque esistano ancora popoli di cacciatori/raccoglitori
e laddove questa antica tradizione sacra sia riuscita, in qualche
modo, a mantenersi viva nonostante le trasformazioni - spesso
molto pesanti - dell'ambiente culturale circostante.
I racconti delle “esperienze iniziatiche”, cioè
di che cosa ha portato quegli individui a diventare dei “guaritori”
e come questo è avvenuto, è un viaggio all'interno
di tradizioni differenti ma con chiari punti in comune. Uno
fra tutti, la percezione del mondo come luogo in cui tutto è
vivente e ciò che vive è relazione, senza separazioni
tra specie, nella consapevolezza della sacralità del
legame che unisce ogni cosa. Come dice Leonard Crow Dog, Sioux
del Nord America: – «Mitakuye oyasin, tutti i miei
parenti! Voleva dire tutti quelli con due gambe, tutti quelli
con quattro zampe, anche quelli con otto zampe e quelli senza:
significava quelli con le ali e quelli con pinne, quelli con
radici e con foglie, ogni cosa viva, tutti nostri parenti».
Sappiamo che la separazione e la frammentazione hanno costituito
il punto di forza su cui si è basato lo sviluppo dell'Occidente.
Cose utili e meravigliose sono state scoperte grazie all'osservazione
sempre più ravvicinata del particolare separato dall'insieme
di appartenenza. Ma cosa stava comportando tutto ciò
per l'equilibrio personale di ognuno e del pianeta intero abbiamo
dimenticato di chiedercelo. Oggi le conseguenze sono gravi e
ben visibili. In questo panorama divenuto catastrofico le voci
sciamaniche ci raggiungono come acqua per la sete. Sono storie
di visioni, di esperienze interiori, spesso drammatiche, che
aprono l'accesso a stati di coscienza non ordinari. Narrano
cosmogonie che non sempre risuonano con facilità alle
nostre orecchie. Di sicuro rendono evidente l'esistenza di un'apertura
della mente alla quale normalmente non abbiamo accesso, un passaggio
fra realtà ordinarie e non ordinarie. Un passaggio e
allo stesso tempo una barriera fra mondi che coesistono.
Possiamo smettere di liquidare tutto questo come necessità
tribali, ormai da tempo superate dall'evoluta cultura occidentale,
e provare ad usarle come cassa di risonanza per comprendere
se qualcosa di fondamentale è andato perduto lungo la
strada della nostra evoluzione?
Pensiamo anche al fatto che queste culture/religioni non hanno
mai costruito intorno a sé chiese o altri luoghi di potere:
non è cosa sufficiente a sostenerci nel prestare loro
ascolto con attenzione? Non si tratta di assumere modi d'essere
che non ci appartengono, ma semplicemente di deciderci una buona
volta a imparare gli uni dagli altri affinché questa
infinita diversità possa resistere, evolvere, perché
se certe culture scompaiono, ma altre vedono la luce, allora
il mondo è mondo. In caso contrario, non è che
una prigione a livello globale.
La sopravvivenza dei popoli nativi, in ogni parte del mondo,
continua a subire pesantissimi attacchi. Se ne parla poco o
niente. Leggere dei principi su cui molti di essi basano la
propria esistenza è un fatto educativo: all'ascolto,
al rispetto, al dialogo.
Silvia Papi
Ma
l'anarchia
è differenza
 Questa
non è una rivista come le altre, questo non è
soltanto un annuario che approfondisce La pratica della libertà
e i suoi limiti (Aa. Vv., Libertaria 2015, a cura di Luciano
Lanza, Mimesis, Milano 2015, pp. 261, € 20,00). È
assai di più, è una vera e propria introduzione
al pensiero anarchico, alle sue radici, alla sua complessità,
alla sua attualità e soprattutto alla sua differenza.
Con questa parola intendo non soltanto la differenza rispetto
ad altre teorie e pratiche politiche ma in primo luogo la differenza
interna al movimento anarchico. È anche a questa sua
pluralità che si deve il fatto che «l'anarchismo
è la forma più avanzata di pensiero politico»
(N.Chomsky intervistato da J.Sethness, p. 57). Questa
non è una rivista come le altre, questo non è
soltanto un annuario che approfondisce La pratica della libertà
e i suoi limiti (Aa. Vv., Libertaria 2015, a cura di Luciano
Lanza, Mimesis, Milano 2015, pp. 261, € 20,00). È
assai di più, è una vera e propria introduzione
al pensiero anarchico, alle sue radici, alla sua complessità,
alla sua attualità e soprattutto alla sua differenza.
Con questa parola intendo non soltanto la differenza rispetto
ad altre teorie e pratiche politiche ma in primo luogo la differenza
interna al movimento anarchico. È anche a questa sua
pluralità che si deve il fatto che «l'anarchismo
è la forma più avanzata di pensiero politico»
(N.Chomsky intervistato da J.Sethness, p. 57).
Già nei fondamenti storici, nei “padri fondatori”
vive la differenza. L'anarchia, infatti, «è il
movimento storico radicato, almeno teoricamente, nel lavoro
di William Godwin e Pierre-Joseph Proudhon, articolato più
chiaramente nell'opera di Michail Bakunin, Pëtr Kropotkin,
Emma Goldman e altri. Spesso è associato a una posizione
antistatalista, ma a mio avviso sarebbe meglio definirla come
dedizione nei confronti di due posizioni: critica del dominio
in tutte le sue forme e propensione per forme di organizzazione
e resistenza dal basso. Un simile punto di vista trascura un
altro tipo di pensiero anarchico: l'anarchia individualista
di Benjamin Tucker e Max Stirner, i cui propositi moderni sono
libertari, come quelli di Robert Nozick. In ogni caso, in genere
si associa il termine anarchia con le prime posizioni piuttosto
che con l'ultima» (T. May intervistato da R. Marshall,
p. 67). Rispetto al comunismo, l'anarchismo è libero
da ipoteche totalitarie; si ispira ai propri iniziatori ma non
li venera; «il terzo vantaggio, il più importante,
è che le idee anarchiche sono centrali nella maggior
parte dei movimenti sociali odierni» (G. Kuhn, p. 47).
I principi invalicabili dell'anarchismo sono pochi e si possono
condensare nella «libertà dell'individuo e la non
prevaricazione sugli altri individui» (F. Eva, p. 169),
«nel rifiuto del dominio, nell'irrinunciabilità
all'eguaglianza quale condizione stessa della libertà,
nella fiducia nell'autonomia dell'individuo come strumento di
autorganizzazione dei singoli nella storia» (P. Adamo,
p. 239).
Contrariamente a ciò che spesso si pensa, rivoluzione,
comunismo, antistatalismo, astensionismo non sono dei principi
fondamentali dell'anarchismo ma soltanto alcune delle sue possibili
manifestazioni. E infatti in questo libro c'è chi attacca
senza incertezze lo Stato e c'è chi - come Chomsky -
lo difende rispetto alle multinazionali poiché in queste
ultime «nessuna influenza è possibile. Quelle sono
vere tirannie. Quando la società è dominata in
gran parte da tirannie private, che rappresentano la peggiore
forma di oppressione, le persone hanno bisogno di un qualche
tipo di auto-difesa. E lo Stato la garantisce» (citato
da Kuhn, p. 49). C'è chi vede nel mercato sempre e soltanto
il mercato del capitale e c'è chi ritiene possibile un
mercato dove lo scambio sia volto non al profitto di pochi ma
al vantaggio di molti, se non dell'intero corpo sociale. C'è
chi è per la rivoluzione violenta contro la violenza
del potere e diffida oggi più che mai di una democrazia
rappresentativa al tramonto, «in cui contano le lobbies,
i leader carismatici e i sondaggi di opinione» (Colin
Crouch, ricordato da F. Codello, p. 130) e altri - come Berti
e Adamo - che ritengono la liberaldemocrazia l'espressione oggi
più avanzata dell'esigenza anarchica del massimo di libertà
coniugata al massimo di eguaglianza.
C'è chi vede negli attivisti e nei militanti la reale
incarnazione del progetto e critica i «giochi verbali,
le controversie intellettuali di filosofi radicali, da caffè
o salotto» (L. Pezzica, p. 223) e c'è chi, al contrario,
pensa che «non si deve mitizzare la teoria “bassa”
che nasce dalla partecipazione militante più di quella
“superiore” che sarebbe reperibile in un canone»
(L. A. Williams, p. 179) o giudica le tendenze antintellettualistiche
uno degli ostacoli da superare in quanto l'anarchismo «non
viene riconosciuto come pensiero “nobile”, abbastanza
sofisticato da essere studiato e approfondito, e quindi non
riesce a incidere o orientare, o stimolare correnti di pensiero
al di fuori del ristretto circolo degli aficionados. [...] Quelli
citati dai mass-media sono gli attivisti che intervengono attivamente
nelle dinamiche di movimento (No-TAV e No-MUOS per esempio)
o nei cosiddetti Centri Sociali; con un approccio dei media
solo appena modernizzato, ma sostanzialmente ancora orientato
alla criminalizzazione di fine Ottocento e Novecento. Nei dibattiti
culturali, in televisione, nelle pagine culturali dei quotidiani
più diffusi manca a tal punto la presenza di anarchici
che anche autori che lo sono o che gli anarchici considerano
interni al pensiero libertario (Albert Camus per esempio) vengono
genericamente definiti/attribuiti all'area progressista»
(F. Eva, p. 168). C'è chi vede ancora nel Sessantotto
un modello di rivolta anarchica e chi critica aspramente il
suo essere stato funzionale al dominio spettacolare «poiché
questa società detta dell'abbondanza sembra reprimere
il puritanesimo delle sue origini, si trasforma realmente in
società permissiva senza la quale la festa non potrebbe
darsi in quanto spettacolo. Un profumo di orgia si diffonde
nello spirito del tempo, di cui il maggio '68 costituisce in
qualche modo l'acme e il simbolo» (S. Latouche, p. 15)
e chiede a chi voglia «“salvare” e riprendere
la carica libertaria» del Sessantotto di «farsi
carico di un ripensamento radicalmente critico non solo di quel
che allora pensava, ma anche di quel che pensa ora e di come
lo pensa» (F. Melandri, p. 232).
C'è chi non è disposto ad allontanarsi dai principi
dell'anarchismo ottocentesco e chi vede in questa rigidità
un ostacolo, optando piuttosto «per una specie di pragmatismo
fallibilista, ovvero per una versione “senza aggettivi”
dell'anarchismo, in cui la prospettiva utopica (una società
egualitaria, non egualitaristica, in cui le relazioni tra gli
uomini non siano determinate da meccanismi di dominio) non viene
legata né a rigide prescrizioni istituzionali, politiche
o economiche, né a precise metodologie e linee d'azione,
ma piuttosto a una sperimentazione individuale e collettiva»
(P. Adamo, p. 237). C'è chi fonda la possibilità
stessa dell'anarchismo su un'antropologia positiva, fiduciosa
nella “naturale” tendenza umana alla cooperazione
- dimenticando magari la critica di Bakunin a Rousseau - e chi
come Chomsky si spinge a definire quella umana «una specie
malsana» (p. 56) o concorda con Immanuel Kant e con Isaiah
Berlin sul legno storto dell'umanità, dal quale nulla
si potrà ricavare di perfettamente dritto (F. Codello,
p. 132).
Come si vede, questo volume è davvero pervaso dalla consapevolezza
del limite non soltanto dell'azione politica qui e ora ma del
limite universale delle cose umane, senza però che questo
implichi la rinuncia a fare tutto il possibile per costruire
una società di liberi e di eguali. Nessuna “grande
rivoluzione”; al suo posto l'azione quotidiana, pervasiva,
capillare, tenace. Una libertà che non è l'inizio
o la conclusione di una trasformazione definitiva ma è
piuttosto la «risoluzione di problemi reali, soprattutto
perché gli anarchici hanno riflettuto molto sulla risoluzione
di problemi reali puntando la loro attenzione sul microlivello,
cosa che altre ideologie politiche non sentono in realtà
di dover fare finché non si sono impadronite del potere
statale» (D. Graeber, p. 80). Non la palingenesi ma l'anarchismo
che già c'è nel corpo sociale, nel tessuto delle
relazioni collettive e delle aspirazioni individuali: «Una
nuova figura, quindi, che sia in grado di riunire in sé,
anche se con momenti distinti, il riformismo e il rivoluzionarismo.
Che faccia le cose concrete, banalmente quotidiane ma sapendovi
imprimere il segno del possibile totalmente altro. [...] Riassunta
in uno slogan la proposta è: pensare da anarchici, agire
da libertari. [...] La rivoluzione come momento risignificante
della società» (L. Lanza, p. 255).
Se «anche l'anarchismo si è trasformato un po'
in merce, e non è più percepito come una minaccia»
(G. Kuhn p. 48), le ragioni sono molte. Una è la sua
riduzione al campo dei diritti umani, alla difesa delle donne,
dei migranti, degli omosessuali, dimenticando che la rivendicazione
dei diritti civili - da sola - è perfettamente coerente
con l'esistente ultraliberista e che la libertà della
persona è tale soltanto in un quadro di liberazione collettiva
soprattutto dallo sfruttamento del capitale, dal dominio di
un mercato del lavoro ridotto all'immenso profitto delle multinazionali.
Un'altra ragione può essere anche una sorta di ingenuità
nella lettura troppo ottimistica di alcuni eventi contemporanei,
come quella che Mohammed Bamyeh fa delle «grandiose rivoluzioni
della primavera araba», nelle quali si sarebbe ottenuta
«la rara combinazione di metodo anarchico e intento liberale.
[...] Persino le forze di governo ora accettano praticamente
tutte le richieste dei rivoluzionari (p. 40). Neppure un accenno
alla eterodirezione statunitense di queste presunte “primavere”,
che infatti sono finite nell'inverno di poteri militari antichi
e feroci, come in Egitto.
L'annuario 2015 di Libertaria è dunque un'articolata
introduzione al pensiero anarchico anche perché fa toccare
le ragioni per le quali «è difficile racchiudere
tutti i protagonisti e le proposte riconducibili visibilmente
all'idea anarchica in un solo corpo dottrinario al singolare,
l'anarchismo» e piuttosto si deve sempre parlare di «anarchismo
plurale» (S. Vaccaro, p. 145), da mettere ogni giorno
alla prova - nelle sue possibilità e nei suoi limiti
- all'interno di «un'articolazione sociale che si nutra
della diversità come linfa vitale. L'acquisizione in
toto del concetto di libertà esige il riconoscimento
reciproco della diversità» (L. Lanza, p. 255).
L'anarchismo è differenza.
Alberto Giovanni Biuso
Il
fuorigioco?
Limita la libertà (di movimento)
Quando Gianni Brera da direttore chiamò Luciano Bianciardi
(Grosseto 1922-Milano 1971) a collaborare sulle pagine del prestigioso
Guerin Sportivo, lo scrittore grossetano - diventato notissimo
per quel romanzo, La vita agra, che metteva rabbiosamente
alla gogna il modello social-borghese degli anni del boom economico
- era già fortemente debilitato nel fisico a causa dell'alcool.
Infatti, la sua rubrica settimanale aperta al dialogo coi lettori,
Così è se vi pare, non ebbe una durata lunga,
iniziò alla fine di settembre del 1970 e si protrasse
fino al novembre dell'anno dopo. Tifoso della Fiorentina (ma
dei fiorentini diceva peste e corna), appassionato e pure molto
competente di calcio, Bianciardi al terzo dei suoi figli che
gli pose l'interrogativo “perché una persona seria
come te si occupa di sport?”, di rimando confermò
“perché sono una persona seria”. Difatti.
Come si può leggere nel volume lI fuorigioco mi sta
antipatico (Stampa Alternativa, Viterbo, 2007, pp. 384,
€ 16,50) serissime erano le risposte che consegnava agli
affezionati lettori del Guerin che gli scrivevano. Scanzonato
e schietto emetteva i suoi giudizi su calciatori, allenatori,
atleti di altri sport e, spesso, si sbilanciava in paralleli
con la letteratura, la storia che dalla penna di qualche altro
cronista potevano apparire eccessivi ma non dalla sua. Alla
ricorrenti e fatidiche dieci domande poste, Bianciardi l'anarchico
(“uomo che vorrebbe una società basata sul consenso
e non sull'obbligo”) non perdeva occasione per osannare
il fascinoso Gigi Riva, ma al di sopra dell'idolo dei tifosi
del Cagliari scudettato, poneva solo Silvio Piola, lo svedese
Gunnar Nordahl e il gallese John Charles. Dell'allora allenatore
della nazionale, Ferruccio Valcareggi, diceva che era “un
onesto amministratore della pedata” e dovendolo avvicinare
ad un personaggio del Risorgimento (epoca di cui si poteva considerare
un esperto) chiamava in causa Quintino Sella. Su Vittorio Pozzo
si esprimeva così: “Era un ottimo alpino che faceva
cantare da solisti terzini, da coristi i mediani e da soprani
gli attaccanti. Con questo assieme strepitoso veniva fuori un
ottimo melodramma. E vinceva partite e campionati del mondo”.
Ad un lettore che gli domandava: “Se fosse il presidente
dell'Inter farebbe il cambio alla pari Mazzola-Rivera?”
ribatteva: “Se fossi il presidente Fraizzoli non farei
lo scambio alla pari. Ma siccome sono Bianciardi, lo farei anche
domattina”.
Del fuorigioco sentenziava “mi sta antipatico (da qui
il titolo del libro di Stampa Alternativa), come tutte le regole
che limitano la libertà di movimento e di parcheggio”,
mentre un personaggio come Helenio Herrera Bianciardi proprio
non lo sopportava: “in questa società dove molti,
troppi vendono fumo, Helenio Herrera si trova benissimo, e sa
tenere da par suo l'ufficio stampa di Helenio Herrera. Come
tecnico? Manca di intuizione psicologica, si abbandona all'ambiente
in cui opera, vince i campionati se ha alle spalle un dirigente
come Moratti”.
Mimmo Mastrangelo
Un'enorme
potenzialità
di contagio sociale
Quando tu prendi il potere,
allora il potere si prende te
J. Holloway, p. 80
 Agire
altrimenti. Anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo
è il titolo dell'ultima antologia curata da Salvo Vaccaro
per elèuthera (Milano, 2014, pp. 247, € 15,00). Agire
altrimenti. Anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo
è il titolo dell'ultima antologia curata da Salvo Vaccaro
per elèuthera (Milano, 2014, pp. 247, € 15,00).
L'anarchia è intesa qui come elemento vitale, che appartiene
cioè alla vita, e presente, non rimandabile a un lontano
e ipotetico futuro. Essa è motore di conflitto permanente
contro il governo, sempre più governance post democratica
(iperburocratica) e sempre meno government rappresentativo,
contro l'accanita competizione che tende a uniformare di sé
tutti i campi del vivere sociale, contro la guerra permanente
e la logica repressivo-securitaria degli Stati nazionali, contro
la manipolazione e la falsificazione permanente, contro il saccheggio
della ricchezza sociale e ambientale che è la cifra comune
del neoliberismo. A questo proposito assai significativamente
Graeber (p. 36) scrive non di “neoliberismo” ma
di “neoliberalismo” per intendere come esso sia
più che un movimento economico un movimento politico,
“una reazione a tutte quelle vittorie ottenute dai movimenti
sociali degli anni Sessanta”.
L'anarchia è stata adottata, per lo meno come mezzo,
e in maniera più o meno consapevole, da parte di un gran
numero di movimenti di lotta che negli ultimi venti anni hanno
dato corpo a forme di resistenza all'ordre établi. In
questa antologia si riportano analisi su alcuni di questi movimenti.
Manca, ed è un peccato, una riflessione su quello greco,
tra i più spiccatamente anarchici e maturi, a mio modo
di vedere, sia nella pratica che nelle riflessioni. Ma ci sono
i movimenti americani di Occupy con le riflessioni di David
Graeber, Michael Albert e Noam Chomsky, ci sono le influenze
zapatiste sul postmarxismo di John Holloway, gli indignados
e le relazioni tra costoro e buona parte del movimento anarchico
spagnolo, attivo in quel grande momento di presa di coscienza
collettiva che sono state le acampadas, gli hacker di Anonymous;
fino ad arrivare a un insieme di contributi, alcuni dei quali
ruotano intorno a concetti centrali e fecondi come “l'utopia
persistente” (definizione coniata M. Abensour che per
R. Kinna combacia con il pensiero anarchico, p. 150) e l'insurrezione,
declinata come attacco permanente e rifiuto dell'attesa, altri
a mio parere assai meno centrati, perché sostanzialmente
neo (e non anti) deterministi, quando teorizzano il collasso
– d'emblée – della civiltà industriale,
o il crollo del capitalismo globale (Uri Gordon, pp. 129-144).
A chiudere un ricco saggio riassuntivo che ha il merito di sintetizzare
un rinnovato modo di pensare l'anarchismo in azione: il post-anarchismo
e la politica radicale oggi di Saul Newman, autore di cui elèuthera
ha pubblicato ultimamente un altro, simile, e stimolante, scritto:
Fantasie rivoluzionarie e zone autonome. Post-anarchismo e spazio
politico (2013, pagg. 81, € 8,00). Newman identifica la
politica radicale contemporanea con “forme di organizzazione
transnazionale antiautoritarie” basate sulla “democrazia
diretta o non-rappresentativa”, cioè in buona sostanza
“anarchiche”. Un anarchismo per lo più “inconscio”
perché “modo particolare di intendere e praticare
la politica, un modo che persegue l'autonomia dallo Stato e
che non punta alla conquista del potere, ma alla sua decentralizzazione
e democratizzazione” (S. Newman, pp. 234-235).
Quindi, metodo anarchico dicevo: ovvero orizzontale, antiautoritario,
antigerarchico (Graeber, p. 39) che prende forma nelle assemblee
generali, nei gruppi di lavoro a esse collegati e nell'abitudine
all'azione diretta e spesso illegale in grado di imporre obiettivi
intermedi, nel mutuo appoggio come pratica solidale extra, o
anti, statale.
Un metodo che è immediatamente prassi in quanto rifiuta
la distinzione tra forma e sostanza e che è collettivo
perché elaborato attraverso il confronto transnazionale,
nel comune rifiuto della conquista del potere a qualunque grado
e nell'intento altrettanto comune di disperdere e neutralizzare
quanto più possibile tale potere.
I movimenti contemporanei nella loro eterogeneità, cito
ancora l'ottima introduzione di S. Vaccaro, intendono divenire
“rivoluzione senza farsi istituzione della rivoluzione”:
vero e proprio nodo gordiano della modernità, questo,
che l'anarchismo, solo tra i movimenti rivoluzionari, ha individuato
e affrontato, anche se invero non (ancora?) risolto.
Da qui la salutare attenzione al presente, la tensione continua
a “creare spazi prefigurativi in cui sperimentare nell'immediato
il tipo di struttura esistenziale che esisterebbe in una società
libera dallo Stato e dal capitalismo” (D. Graeber, p.
42). “Il comunismo – scrive D. Graeber (p. 46) –
esiste già nel nostro intimo relazionarci con gli altri
su un milione di livelli differenti. Quindi si tratta di espanderlo
progressivamente fino a distruggere il potere del capitale”.
Questo nella consapevolezza che il capitalismo è un “modo”
non una “cosa” (J. Holloway, p. 80), così
come lo Stato, come già ripetutamente indicato tra gli
altri da M. Bakunin e E. Colombo, non è solo “una
serie di istituzioni e strutture di potere, ma una particolare
relazione autoritaria, un particolare modo di pensare e organizzare
le nostre vite” (S. Newman, p. 226). Mezzi e fini libertari
hanno un'enorme potenzialità di contagiare l'ambito sociale,
più di quanto esse non facciano già, in un'epoca
in cui “la distanza dell'istituzione sociale dalla società”
è “divenuta sempre più chiara a porzioni
sempre maggiori di popolazione” (J. Holloway, p. 74).
Testi come questi sono preziosi strumenti da provare a utilizzare
in una fase in cui hanno raggiunto l'apice le politiche di saccheggio
dei governi e dei loro collegati transnazionali: N. Chomsky
ricorda giustamente, e lo fa spesso, che ad aprire la strada
al New Deal sono stati gli scioperi degli anni Trenta. Allo
stesso modo oggi è necessario occupare e rioccupare le
piazze, fisicamente o simbolicamente, ovvero infiltrare il sociale
che ci circonda, dando vita a esperienze più diffuse
possibile di assemblearismo, conflitto con l'ordine costituito
e autogestione di tutti gli aspetti della nostra vita, costruire
ponti tra sfruttati di diverse latitudini e sponde del Mediterraneo
per generalizzare un'insubordinazione di massa e radicale, che
è il solo mezzo nelle nostre mani per far mutare di segno
le politiche dei governi o, se si vuole, della governance transnazionale.
Ma queste mani ce le dobbiamo sporcare, possibilmente smettendo
di autorappresentarci come originale ma innocuo movimento di
opinione e dandoci da fare penetrando davvero nel sociale, agendo
fianco a fianco – ognuno con i suoi modi ma in maniera
solidale – con chi “sta sul pezzo”, senza
tentennamenti, ortodossie, capziosi distinguo o soverchie paure.
Antonio Senta
La vagina
scomparsa
 Ogni
anno la rivista Time interroga i propri lettori: “quale
parola vorresti venisse bandita il prossimo anno?” e propone
una lista di termini tra i quali scegliere. Si tratta perlopiù
di neologismi abusati o espressioni gergali divenute quasi insopportabili
come OMG (oh mio dio) o LOL (che ridere). Tra i buoni propositi
che si è soliti formulare in vista del nuovo anno, Time
ne propone uno linguistico-lessicale, auspicando la rimozione
dal linguaggio – soprattutto quello dei media –
di parole che avrebbero ormai perso (o non hanno mai avuto)
un significato. Ogni
anno la rivista Time interroga i propri lettori: “quale
parola vorresti venisse bandita il prossimo anno?” e propone
una lista di termini tra i quali scegliere. Si tratta perlopiù
di neologismi abusati o espressioni gergali divenute quasi insopportabili
come OMG (oh mio dio) o LOL (che ridere). Tra i buoni propositi
che si è soliti formulare in vista del nuovo anno, Time
ne propone uno linguistico-lessicale, auspicando la rimozione
dal linguaggio – soprattutto quello dei media –
di parole che avrebbero ormai perso (o non hanno mai avuto)
un significato.
Nella lista di vocaboli da mettere al bando nel 2015, la presenza
di femminista ha sorpreso tutti. In molti hanno criticato con
indignazione questa scelta (per cui Nancy Gibbs, redattrice
di Time, si è pubblicamente scusata). Ma com'è
potuto accadere che un termine con una forte accezione rivoluzionaria
venisse declassato fino ad essere inserito in una lista di parole
di cui ci si augura il pensionamento?
Quanto accaduto è probabilmente sintomo della credenza
diffusa di una inopportunità delle istanze femministe
nel XXI secolo, per alcuni divenute ormai anacronistiche. Non
è il vocabolo in sé ad essere riconosciuto come
obsoleto, ma ciò a cui rimanda e da cui deriva: il femminismo.
Non c'è più alcun bisogno di parlare di emancipazione
femminile e liberazione sessuale in questa nostra nuova era,
poiché tutto è già stato conquistato. Ma
è davvero così?
Il gesto femminista. La rivolta delle donne: nel corpo, nel
lavoro, nell'arte (a cura di Ilaria Bussoni e Raffaela Perna,
Derive Approdi, Roma, 2014, pp. 166, € 20,00) fornisce
uno spunto per una riflessione sull'efficacia e l'importanza
del femminismo oggi. A partire dalle immagini delle manifestazioni
femministe di ieri, avvenute principalmente negli anni Settanta,
ma ancor più dalle immagini del gesto femminista per
eccellenza: pollici e indici che si univano a formare un triangolo
che rimandava al sesso femminile. Il volume, una raccolta collettanea
di sedici saggi accompagnati da diverse foto di donne che esibiscono
il simbolo della vagina, non ha come obiettivo la sola narrazione
storica, ma si interroga su cosa sia rimasto della rivoluzione
(incompiuta) femminista, proponendo un'analisi critica di quanto
avvenuto in quegli anni e di ciò che ne resta.
Il libro prende vita da una domanda delle curatrici: dov'è
finito il gesto femminista? Così presente per più
di un decennio, il simbolo di un'intera lotta sembra essere
scomparso. Viene realizzata una ricerca genealogica, indagando
sulle sue radici. Quando è apparso per la prima volta
e dove? Scopriamo così, dopo aver interrogato diverse
esponenti del movimento femminista nel mondo, che il simbolo
della vagina è comparso per la prima volta in Italia,
dove è poi divenuto il segno distintivo delle battaglie
del femminismo.
La portata rivoluzionaria di quelle mani alzate è data
principalmente dal contesto. Sono gli anni Settanta. Aborto,
riforma del diritto di famiglia, divorzio, maternità
consapevole sono obiettivi delle lotte compiute in nome di un'autodeterminazione
che fino a quel momento non era concessa. Forte è il
rifiuto del ruolo che si pensava fosse ''naturalmente'' assegnato
ad ogni donna proprio in virtù del suo organo riproduttivo.
Era la vagina a conferire significato al genere femminile e
a darle un posto ben preciso all'interno della società.
Eppure, nonostante il sesso ricoprisse un ruolo così
centrale nella vita delle donne, tanto da condizionarne ogni
aspetto dell'esistenza, questo si rivelava un tabù inesplorabile,
non conoscibile né tantomeno narrabile; qualcosa di cui
non poter nemmeno disporre in modo libero e autonomo. È
proprio questa la condizione che trasforma l'esposizione pubblica
del gesto femminista in un atto rivoluzionario. Con pollici
e indici uniti, le donne mettevano in luce ciò che fino
a quel momento era rimasto rinchiuso nello spazio buio dell'indicibile,
si riappropriavano di qualcosa che non gli era mai appartenuto
fino in fondo, affermavano la loro volontà di scegliere
cosa farne e svincolavano una parte anatomica dalla sua funzionalità
organica. Il genere si staccava ufficialmente dal sesso, affermandosi
come costruzione sociale, come un processo che niente aveva
a che vedere con la biologia. Con quel gesto le donne dichiaravano
di essere finalmente libere di decidere del proprio ruolo e
della propria individualità in completa autonomia.
Nascono i collettivi, i gruppi di dibattito e autocoscienza
entro i quali ci si confronta portando la propria esperienza.
Sfidando il patriarcato all'interno della famiglia e rifiutando
il ruolo sociale fino a quel momento imposto, il movimento femminista
attaccava la chiesa cattolica e lo stato e proponeva teorie
e pratiche sociali alternative a quelle esistenti. La sua connotazione
antagonista avvicinava il femminismo di quegli anni alle lotte
di classe e lo allontana dalla sua ala definita “borghese”.
Eguaglianza, giustizia sociale, liberazione dai vincoli morali
e istituzionali sono gli obiettivi che spingono le donne a scendere
in piazza al fianco degli uomini nelle manifestazioni operaie,
e a farlo nuovamente insieme ad altre donne nelle manifestazioni
femministe.
Attraverso le testimonianze di chi ha preso parte alle lotte
di quel periodo, il volume ricostruisce il significato della
battaglia femminista combattuta in nome dell'autonomia e della
liberazione, il percorso intrapreso e i mezzi utilizzati, compreso
quello artistico. Propone anche un'analisi critica degli errori
del passato, del presente e delle debolezze dell'intero movimento.
Resta comunque da capire per quale motivo il gesto femminista
risulti attualmente scomparso, avvistato l'ultima volta in una
manifestazione nei primi anni ottanta e mai più rivisto.
È interessante notare come il segno della vagina sia
forse l'unico gesto riconducibile ad una rivoluzione che non
viene sistematicamente ripreso e riprodotto. A quarant'anni
dalla sua prima apparizione, quel segno resta scabroso, sovversivo
oggi forse più di ieri vista la sua sparizione dalla
scena pubblica. Si tratta di un gesto di forte rottura, con
una valenza politica radicale, che rimanda esplicitamente alla
sessualità e al piacere. La sua dipartita mostra quanta
sia ancora la strada da percorrere per raggiungere una liberazione
sessuale ed un'emancipazione reale ed efficace.
Considerata la scomparsa della “vagina femminista” e visti
gli attacchi degli ultimi anni al diritto all'aborto, al perdurare
del tabù dell'educazione sessuale, all'ostruzionismo
nei confronti di un dibattito sulla fecondazione assistita e
alla mistificazione delle teorie di genere, è forse ancora
presto per pensare ad un pensionamento del termine femminista.
Ne abbiamo ancora bisogno, e questo volume ci aiuta a capirlo.
Carlotta Pedrazzini
Una vita
avventurosa
 Oreste
Ristori è una figura interessante, ancorchè non
molto nota, dell'anarchismo non solo italiano, a cavallo tra
'800 e '900. Oreste
Ristori è una figura interessante, ancorchè non
molto nota, dell'anarchismo non solo italiano, a cavallo tra
'800 e '900.
Nasce a San Miniato (PI) il 12 agosto 1874. La famiglia ben
presto si trasferisce a Empoli dove il giovane Oreste muove
i primi passi politici nel gruppo anarchico locale. Nel 1892
subisce il primo arresto, cui segue un decennio di condanne,
arresti, domicilio coatto ed evasioni. Nell'agosto del 1902,
per sfuggire alle persecuzioni della polizia, raggiunge il Sud
America dove vivrà spostandosi tra Argentina, Uruguay
e Brasile. Spesso in prima linea come agitatore sociale e pubblicista,
nel 1936, dopo essere stato uno dei protagonisti delle insurrezioni
operaie nella città di San Paolo contro i movimenti parafasciti,
è espulso dal paese e rimpatriato. Arrestato nel corso
delle manifestazioni popolari in occasione della caduta del
fascismo dell'estate 1943, muore fucilato per rappresaglia degli
squadristi a Firenze, al poligono di tiro, la mattina del 2
dicembre di quell'anno insieme all'anarchico Gino Manetti e
tre militanti comunisti Armando Gualtieri, Luigi Pugi e Orlando
Storai.
L'Archivio storico del Comune di Empoli gli ha dedicato un sito:
http://www.oresteristori.it.
Carlo Romani ha curato la voce sul Dizionario biografico degli
anarchici italiani e ha pubblicato l'articolo Oreste Ristori
un'avventura anarchica, sul n. 1/1999 della «Rivista
storica dell'anarchismo».
Su Ristori è appena uscito, per BFS edizioni (via I.
Bargagna, 60, 56124 Pisa, info_bfsedizioni@bfs.it,
tel. 050 9711432) il volume di Carlo Romani Oreste Ristori.
Vita avventurosa di un anarchico tra Toscana e Sudamerica
(pp. 288, € 20,00), del quale proponiamo questo stralcio:
Ristori combatteva una visione secondo cui l'anarchismo era
uno scopo inalienabile dell'umanità. Capiva invece che
le trasformazioni sociali, la possibile via rivoluzionaria,
sono frutto di un continuo lavoro nel presente, nelle azioni
quotidiane, dove nessuno meglio del libertario cosciente, già
libero dalle soggezioni imposte dalla disciplina e dal controllo
dello Stato borghese, è l'agente privilegiato da seguire
nei momenti in cui la tensione sociale irrompe in maniera più
repentina e violenta. Hobsbawm direbbe che gli anarchici, eroi
romantici, non avrebbero mai potuto realizzare la rivoluzione
per la loro incapacità di organizzare le forze in lotta
in maniera che si costituissero in effettiva resistenza agli
apparati repressivi esistenti. La rivoluzione di cui parla lo
storico inglese non è la stessa che idealizzavano gli
anarchici. Eroi romantici, utopici o, se vogliamo, ribelli primitivi,
gli anarchici durante il processo autogestionario della Rivoluzione
spagnola, dimostrarono che era possibile, con molta determinazione,
quasi una fede cieca, a partire da un lavoro costante, rivolto
al micro, al locale, organizzare amministrativamente comunità
senza il bisogno di una forza autoritaria centralizzata e repressiva.
Le rivoluzioni nascono in maniera spontanea, senza data prevista,
dipendono dalle condizioni favorevoli che si vanno generando
nel calore della lotta e hanno bisogno di una gran dose di coraggio
personale in tutti gli individui coinvolti. Spetta però
alla frazione più cosciente del proletariato dirigere
questo processo rivoluzionario. A Buenos Aires gli anarchici
non si erano dimostrati degni della fiducia che avevano l'obbligo
di trasmettere all'insieme dei lavoratori e questo non piacque
a Ristori. Dopo un breve periodo di calma, la repressione politica
ricominciò a farsi sentire. La visibilità che
Oreste esibì, nell'ansia di rimettere in moto il movimento,
gli procurò immediatamente dei guai. Arrestato assieme
a Basterra, il 14 gennaio fu condotto a bordo del piroscafo
tedesco “Schleswig” con destinazione Brema.
Purtroppo per il console italiano, il capitano della nave tedesca
si rifiutò di ricevere a bordo due passeggeri costretti
a viaggiare contro la loro volontà, quasi causando un
incidente diplomatico col governo argentino che, per superare
il problema, dopo due giorni di fermo del piroscafo nel porto
di Buenos Aires, cedette, aspettando un'altra occasione per
espellerli. In ringraziamento per la decisione adottata in quel
caso, Ristori e Basterra organizzarono una colletta tra i compagni
portuali per consegnare una medaglia al capitano della nave
tedesca, minacciando nel frattempo il governo argentino di rappresaglia
attraverso il boicottaggio degli stivatori addetti al caricamento
delle navi coinvolte nella deportazione di prigionieri. Il boicottaggio
era il primo strumento di pressione utilizzato dai sindacati
anarchici. In quell'occasione, col movimento sindacale in riflusso,
i lavoratori si rincuoravano quando qualche iniziativa veniva
presa, facendo crescere la loro autostima. E fu quel che fecero
Basterra e Ristori nel corso della loro deportazione. Vediamo
questa piccola beffa.
Il giorno 16, il Ristori – il quale si era fatto passare
per belga – ed il Basterra, venivano condotti per ferrovia
a La Plata, ed imbarcati sul Magdalena, postale inglese in partenza
per il Brasile e Southampton.
Giunto il piroscafo a Montevideo ove faceva il suo primo scalo,
il Ristori e il Basterra che erano stati raggiunti a bordo da
vari anarchici profughi in quella Città chiedevano al
Capitano il permesso di scendere a terra, cosa a cui questi
annuì senz'altro, aggiungendo che tutti i passeggeri
erano liberi di sbarcare ove volessero, non facendo egli il
carceriere. Naturalmente essi non tornarono a bordo. Ma non
contenti di ciò dopo aver fatto provare che avevano perduto
il piroscafo per mera sbadataggine, riuscivano a riscuotere
dal rappresentante la compagnia di Navigazione in Montevideo,
– come si usa del resto per i viaggiatori che per caso
perdono il piroscafo a Montevideo – la restituzione di
metà importo del viaggio pari a $ 20 oro per ciascuno,
e che han servito a tenere allegri per vari giorni, i malnutriti
anarchici dell'Argentina profughi a Montevideo.
Il modo patetico in cui vennero ridicolizzate le autorità,
per quanto irriverente, risollevò il morale degli esuli
a Montevideo che erano riusciti a sfuggire alla deportazione
imminente.
Carlo Romani
Teatro delle Albe/
Aung San Suu Kyi ovvero dell'ironia
Vita agli Arresti di Aung San Suu Kyi, andato in scena
al Teatro Rasi di Ravenna, è la proposta del Teatro delle
Albe per la regia di Marco Martinelli con Ermanna Montanari
(e con Roberto Magnani, Alice Protto, Massimiliano Rassu). La
domanda “è distante la Birmania? Evidentemente
no. Vicina come ogni parte della terra” racconta lo spettacolo.
Ad ognuno i suoi perché. Per me è vicina, perché
nei soprusi della polizia Birmana, ordinati dal regime militare,
vedo Aldrovandi, Cucchi, No Tav, Genova. In generale vedo tutti
quei momenti in cui lo stato si è fatto “mandante”
e il poliziotto “assassino”. Cosa è successo?
Perché come in un lampo è tornato questo pensiero
che raggela il sangue ma che nella quotidianità viene
assopito? Perché non ci si può più rassicurare
e cullarsi nella tranquillità avendo negli occhi quel
riserbo all'immedesimarsi? Perché non avviene come con
le immagini dei telegiornali che rendono lontani disastri anche
spesso vicini?
Perché, se non fossi impacchettato nella mia (quotidiana?)
impotenza o incuranza, se non fossi come incastrato nella sedia,
nei miei modi civili, mi verrebbe da alzarmi e gridare verso
il palco: guardate che qui la situazione è tragica alla
stessa maniera. Guardate che i soprusi sono qui di fianco, qui
nel cuore dell'Europa democratica, dagli esempi che ho fatto
prima alla quotidianità mostruosa dei singoli. L'inferno
di molte, troppe persone.

Da qui parte la mia vicinanza o meglio “l'avvicinamento.”
Lo spettacolo riesce con sottili ma efficaci espedienti a rendere
la Birmania vicina e piano piano a far sorridere. Come? Saw
Maung, per esempio, il dittatore birmano, interpretato da Massimiliano
Russu, ricalca la figura del nostro politico medio, un po' mafiosetto,
uno che cerca di essere furbo ma è uno sciocchino, un
cialtrone, un italiota. Con quella voce rauca di chi te la vuole
contare. È il padrino. È un ossimoro, ma non c'è
da stupirsi se il male è mediocre. D'altronde siamo in
Italia, ops, scusate in Birmania. Il dittatore è buffo,
si intoppa, non crede neanche lui più in quello che fa.
Occupa una poltrona e tira a campare.
Come ammesso dal regista, lo spettacolo nasce quando si accorgono
della somiglianza fisica tra Aung San Suu Kyi ed Ermanna Montanari.
Il fascinoso personaggio dell'eroina birmana esalta i lineamenti
del volto e le movenze orientali dell'attrice protagonista.
E poi quando Ermanna parla al microfono il tempo si ferma, i
vecchi spettri emergono, quelli nuovi si placano. Senti che
le distanze non esistono, né di tempo e né di
spazio. E della sua bravura è già stato scritto
in modo molto autorevole: “sperimentatrice delle possibilità
e del potere della voce umana” recita la motivazione del
Premio Lo Straniero, dedicato alla Memoria di Carmelo Bene che
le è stato conferito nel 2006. Nel momento in cui Ermanna
prende il microfono, secondo me, succede proprio un mistero:
lo spettacolo nello spettacolo. Alcuni momenti meravigliosi
quanto rari ma, quando avvengono, la magia pervade il teatro.
Improvvisamente la Birmania si allontana. E causa ne è
proprio Ermanna Montanari – Aung San Suu Kyi.
Con l'evolvere della vicenda biografica della protagonista mi
sento sempre più piccolo e squallido.
Quindici anni di reclusione e la protagonista dice: “Se
avessi odiato i miei carcerieri, allora sarei stata effettivamente
loro prigioniera”. Certo, ma dove trovare la forza per
sfidare i carcerieri se non usando la forza dell'ironia? Sbeffeggiarli
li rende deboli. Ma io mi chiedo se quella sofferenza che ho
provato all'inizio dello spettacolo è reale, se il mondo
in cui viviamo è sempre più invivibile e se il
malessere collettivo si estende a macchia d'olio. Vorrà
dire che siamo noi i nostri carcerieri? Come essere ironici?
“La serietà come unico umorismo accettabile”
è una frase di Flaiano (e come mai i suoi aforismi sono
sempre attuali?). E se facciamo quello che non ci piace? Se
non prendiamo la materia nella sua interezza? Non siamo forse
noi i prigionieri? E chi sono i nostri carcerieri?
Ritorna in me una beffarda voce che dice: “ciò
che è buono appare, ciò che appare è buono”.
Lo spettro della società dei consumi? Ognuno deve combattere
i propri oppressori e per farlo, lo spettacolo insegna: un'arma
potente è l'ironia.
 |
| Marco
Martinelli con Ermanna Montanari |
L'ironia però sembra lontana. Svilita. In un pezzetto
dello spettacolo i Moustache Brothers, comici birmani che rischiano
la vita per le loro battute sul regime, dicono: “in Italia
esiste un comico che si chiama Crozza che prende in giro i politici
e più li sfotte e più guadagna soldi. A noi aumentano
solo gli anni di reclusione”. La leggendaria ironia della
Birmania è lontana da noi. Qui noi siamo comici. L'ironia
(che ci manca) porta con sé un tipo di risata diversa
dalla nostra? La risata rivoluzionaria, antiautoritaria, liberatrice.
Andrea Manica
 Quarta
edizione per il fabbro anarchico
Umberto TommasiniL'anarchismo, secondo il mio punto di vista, si è basato
soprattutto sull'individuo militante cosciente e responsabile.
Le strutture organizzative hanno evitato, quasi sempre, di appiattire
le singolarità con un modello di disciplina e uniformità.
Anche per questo, l'anarchico (e l'anarchica) ha, di solito,
una vita densa: impegno e utopia, resistenza e sogni.
Questo è il caso di Umberto Tommasini (1896-1980) per
60 anni attivista mai fanatico, aperto alle novità libertarie
e nemico di ogni autoritarismo. Attraverso l'esempio, e mai
dando lezioni, è stato un vero “maestro”
e come tale ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione
di molti anarchici e libertari. A Trieste e non solo. Perciò
ricordarne l'esistenza ricca di ideali e di lotte offre un modo
di conoscere meglio le teorie e le pratiche anarchiche.
Ogni edizione dell'autobiografia ha una sua storia. Tutto inizia
con una nuova tendenza storiografica che vuole dare voce agli
“esclusi”: la scoperta delle fonti orali. Senza
la registrazione, fatta nell'estate del 1972 nella casetta di
Vivaro in Friuli, non avremmo mai avuto un documento di eccezionale
importanza, una finestra su un militante e un movimento quasi
del tutto sconosciuti o mistificati. Il progetto del libro
restò in un cassetto per diversi anni: gli anni Settanta
erano piuttosto densi di cortei, assemblee, scontri con fascisti
e polizia, volantini mattutini, pomeridiani, serali, affissioni
notturne, ecc. Insomma mancava il tempo per dedicarsi ad un
lavoro metodico e di non immediata utilità. Solo Clara
Germani si mise al lavoro seriamente e con regolarità
trascrisse, in più di 600 cartelle, l'intervista di 16
ore. Da ricordare che allora usò una piccola Olivetti
32, regalo per il suo diciottesimo compleanno. Ciò
comportò un impegnativo lavoro di “taglia e cuci”
per riordinare il discorso in ordine cronologico, ma fatto con
le forbici e il nastro adesivo...
Dare una forma scritta coerente alla narrazione orale richiede
notevole impegno. Nel nostro caso, il salto di paradigma espressivo
andava fatto con grande attenzione per salvare la spontaneità
del dialetto triestino e rendere leggibile un testo a chi non
fosse abituato a maneggiare questa lingua, una variante del
veneto. Il risultato fu un volume di più di 500 pagine
con glossarietto annesso. Poi un inserto fotografico e la prefazione
di Paolo Gobetti, il figlio di Piero, è l'animatore della
“videostoria”. Da anni andava raccogliendo interviste
preziose come quelle agli anarchici spagnoli esiliati e pieni
di speranze dopo la caduta di Franco. Lo stesso Umberto rese
un'ora di conversazione nel 1976 proprio a Gobetti all'interno
di una sessione della Biennale di Venezia dedicata alla guerra
di Spagna. È l'unica videoregistrazione in cui egli parla
con il suo linguaggio schietto e antieroico.
Parte integrante del volume del 1984, apparso quattro anni dopo
la sua morte, fu ricavata da un lavoro di scavo nell'Archivio
Centrale dello Stato a Roma, dove si accumulavano le informative
dell'OVRA, la polizia politica di Mussolini. Qui il suo fascicolo
si apre con la dicitura “Attentatore”, peraltro
molto fondata: nel 1926 e nel 1937 quasi si realizzò
il sogno di uccidere il “duce”.
Le duemila copie del libro andarono esaurite in tempi brevi.
Ci “aiutò” un onorevole democristiano di
destra, il padre padrone del principale circolo culturale triestino:
un'ora prima della presentazione ci chiuse la sala regolarmente
affittata. Un'affannosa ricerca di uno spazio ci permise di
deviare le 200 persone che volevano partecipare alla presentazione,
curata da Pier Carlo Masini, Paolo Gobetti e Nico Berti.
La polemica successiva scosse l'opinione pubblica triestina
e molte centinaia di triestini protestarono contro la discriminazione.
Tutto ciò promosse questo libro pericoloso e bisognava
passare a rifornire le librerie due volte la settimana. L'editrice
militante Antistato (oggi scomparsa) non perse i pochi fondi
disponibili e investiti in questa opera voluminosa anche grazie
al sostegno del compagno Attilio Bortolotti, un friulano emigrato
in Canada ed estimatore di Umberto.
Ci furono poi decine di presentazioni, locali e nazionali, che
permisero di far conoscere meglio la ricchezza umana e la determinazione
politica dell'anarchismo italiano, ma anche francese e spagnolo.
La soddisfazione di questa impresa era turbata dalla constatazione
che molti lettori mostravano serie difficoltà nel seguire
le pagine in dialetto. E così si giunse all'edizione
tradotta in italiano. Anche qui Clara Germani ci mise tutta
l'attenzione necessaria. Bisognava ridurre le dimensioni senza
far perdere il valore complessivo. Dopo molti anni, nel 2010,
Odradek, editore romano impegnato nella stampa di lavori sui
movimenti popolari, pubblicò “Il fabbro anarchico”
preferendo questo titolo al precedente “L'anarchico triestino”
troppo locale. Collaborò anche Claudio Magris con un'intervista
nella quale considera “epico” il libro e “straordinario”
il racconto di Umberto.
La versione in italiano è la base di altre due edizioni.
La prima esce a Barcellona nell'autunno del 2011 con un titolo
che cerca di riallacciarsi al grande movimento del 15M (Maggio)
una sorprendente mobilitazione spontanea che occupò le
principali piazze spagnole per circa un mese. Ecco che Tommasini
diventa Un indignat del segle XX. La minuscola casa editrice
catalana Llibres de Matrícula affronta però una
crisi molto grave e licenzia, per motivi economici, l'unica
lavoratrice (e traduttrice) il giorno dopo la presentazione
del libro. E così il volume circola assai poco, in pratica
solo nell'ambiente militante in cui ha un ruolo cruciale La
Rosa de Foc, la libreria della CNT in Calle Joaquim Costa, a
un passo da un noto edificio, il Centre de Cultura Catalana
de Barcelona, Calle Joaquim Costa 34b.
La seconda edizione tradotta è realizzata nel novembre
scorso dalla Fundación Anselmo Lorenzo, editrice della
CNT con sede a Madrid con un catalogo mirato a rafforzare la
cultura anarchica, in particolare di tipo storico. È
scelto il titolo El herrero anarquista. Memorias de un hombre
de acción. La traduzione è di Paca Rimbau
che vi dedica quasi un anno e l'Introduzione storica viene adattata
per un lettore non italiano e quindi presenta un maggior numero
di note esplicative. Questo volume ha un grande pregio: l'inserto
fotografico comprende una quarantina di riproduzioni, più
numerose e meglio stampate degli altri tre inserti. Il Prologo
è di Pere Gabriel, un docente dell'Universitat Autònoma
de Barcelona e uno dei migliori esperti di storia dell'anarchismo
spagnolo.
Nella capitale catalana, a metà novembre 2014, si svolge
una bella presentazione dell'autobiografia orale con la collaborazione
di un interessante gruppo, l'AltraItalia, composto da giovani
“emigrati” anni fa dalle nostre terre quando in
Spagna era facile trovare lavoro. Il loro orientamento è
genericamente di sinistra senza preconcetti verso l'anarchismo
e, dato assai rilevante, hanno varato una serie di iniziative
per far conoscere la memoria e l'attualità di un paese
ribelle. Intendevano, e intendono, dimostrare che l'Italia era
migliore dell'immagine diffusa nel mondo e che non si esauriva
in un furbo e deprimente personaggio da spettacolo televisivo
(Berlusconi) o in una congerie di politici, conservatori di
varie tendenze, di basso profilo. Quindi il libro e il nuovo
docufilm realizzato da due giovani registi triestini, Ivan Borman
e Fabio Toich, si sono inseriti in un programma di diffusione
della nostra storia di lotte e speranze. E le memorie, sempre
vive e gustose, di Umberto hanno apportato un'esperienza preziosa
fatta di scontro, individuale e collettivo, contro ogni potere.
Due presentazioni si sono svolte anche a Madrid, nella sede
della CNT e nella libreria LaMalatesta.
Si sta aspettando la traduzione in francese per aumentare la
conoscenza di questa figura di protagonista generoso, oltre
che modesto, della storia antiautoritaria del Novecento europeo.
Claudio Venza
|

