
La “rivoluzione interiore”
di Tiziano Terzani
Il contributo di Tiziano Terzani alla corrente culturale degli
obiettori della crescita e degli intellettuali, che credono
in una vera società alternativa, proviene da un gruppo
di pensatori che ha vissuto a lungo nel cosiddetto “terzo
mondo”, ponendo in discussione l'idea stessa di progresso
e sviluppo, tra cui Ivan Illich e Serge Latouche.
Terzani ha origini operaie, comuniste e anticlericali: il padre
ha combattuto tra i partigiani della Resistenza. La sua vita
si dipana tra Oriente e Occidente, in qualità di giornalista
professionista, rendendosi presto conto delle ragioni dei popoli
asiatici colonizzati.
Come argomenta Gloria Germani, curatrice del libro Terzani.
Verso la rivoluzione della coscienza (edizioni Jaca Book,
Milano, 2014, pp. 126, € 9,00), dalle umili origini Terzani
eredita un forte bisogno di giustizia, la volontà di
creare il senso della vita, la ricerca di un modo di vivere
collettivamente più giusto e autentico. Studia la storia
delle civiltà asiatiche così distanti e diverse
dal mondo occidentale, prendendo coscienza del fallimento dell'esperimento
comunista in Vietnam, degli orribili esiti della rivoluzione
cambogiana di Pol Pot, del fallimento del comunismo maoista
in Cina, del disastro esistenziale del moderno liberismo in
Giappone e del crollo del comunismo in Russia.
Terzani avvertiva tutta la disperazione per aver appreso come
i tentativi verso la modernità, dal comunismo cinese
al liberismo economico giapponese, portassero ad esiti aberranti
per la vita umana, dalla capacità affettiva e relazionale
al rapporto con la natura e l'ecosistema, intuendo che le rivoluzioni
comuniste, ma anche e soprattutto il capitalismo, hanno un tratto
fondamentale in comune con la mentalità scientifica tipicamente
occidentale. La sua opera è un continuo sdegno di fronte
alla modernità di stampo occidentale, all'industrializzazione,
all'ossessione per il denaro che distrugge interi paesi, con
la colonizzazione dell'immaginario, in quanto l'Occidente ha
distrutto interi popoli, prima con le chiese e i crocifissi
e ora con la televisione, ancora più che con le armi
nucleari, agli albori della globalizzazione, tramite la colonizzazione
della mente.
La visione occidentale e meccanicistica della scienza cartesiano-newtoniana
ha plasmato la vita moderna, generando la specializzazione e
la frammentazione, tipiche del nostro tempo, che ci impediscono
di comprendere gli effetti delle nostre azioni e spesso anche
il senso dell'esistenza. Le civiltà orientali si sono
sempre poste il grande obiettivo di disincentivare e scoraggiare
l'insorgere continuo dell'ego, la presunzione della persona,
la superbia dell'individuo per raggiungere la pace e la vera
felicità, nel distacco dal piccolo Io che illusoriamente
l'Occidente crede autonomo, per fare invece emergere un sè
più grande. Per l'uomo moderno occidentale, l'unica conoscenza
valida è quella dell'utile, al fine di manipolare, possedere,
cambiare, dominare il mondo con il sistema di pensiero su cui
si fonda la modernità, nel segno della grande unificazione
del sapere, al contrario delle scoperte più all'avanguardia
nel campo della conoscenza, dai sistemi complessi alla scienza
della complessità, che le antiche sapienze asiatiche
conoscevano, come il Tao, l'interconnessione, il nodo infinito,
non la dualità cartesiana mente/corpo, ma il tutto
è uno.
Attualmente l'unico obiettivo di tutti i governi è la
crescita economica, il valore essenziale è il denaro
e la religione prioritaria è l'economia, dove si valuta
esclusivamente il profitto nel potente circuito della dittatura
finanziaria, nella finanziarizzazione, per cui oggi la nuova
lotta di classe dovrebbe essere contro l'oligopolio e l'oligarchia
dei mercati dell'alta finanza. Il filosofo del '600 Thomas Hobbes
stabilì che la prima forza che guida l'agire è
l'interesse personale ed egoistico, la competizione sfrenata
tra individui scatenati nell'affermare la propria autodeterminazione.
Così Terzani, il corrispondente estero, ha avuto il coraggio
di denunciare il fatto che il materialismo sfrenato ha marginalizzato
il ruolo dell'etica nella vita quotidiana, a vantaggio di disvalori
come il denaro, il successo, il tornaconto personale, di cui
tutti siamo succubi e vittime. Per questo sosteneva che è
necessaria una “rivoluzione interiore”, in quanto
le cause della guerra tra civiltà sono dentro di noi,
nelle passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia,
la vanità e che la sofferenza risiede proprio nell'avidità,
nell'attaccamento morboso, nel cercare la felicità fuori
di sé. Terzani auspicava una silenziosa “rivoluzione
interiore”, fondata su una percezione diversa dell'ego,
una “rivoluzione della decrescita”, per un futuro
in cui l'idea di socialismo sopravviverà a questo periodo
egoista e capitalista, con l'alto ideale di una società
in cui nessuno sfrutta il lavoro dell'altro e ognuno fa il dovuto
e non accumula l'eccesso, secondo un concetto di frugalità
tipico delle tradizioni di saggezza, ristabilendo così
l'armonia con la morte e la natura, comprendendo in tal modo
che fenomeni apparentemente scollegati, come la gravissima crisi
ecologica, economica, finanziaria, etica, esistenziale e l'incremento
delle guerre sono intimamente connessi al tipo di conoscenza
dualistica, che annienta le diversità e le complessità,
e all'egocentrismo occidentale che si alimenta di idolatria
invece di raggiungere l'essenziale, il tutto, l'uno.
Laura Tussi
Luigi Di Gianni/
Cine-occhio kafkiano e libertario
Poiché il cinema non è solo
un'esperienza linguistica, ma, proprio in quanto ricerca linguistica,
è un'esperienza filosofica.
Pier Paolo Pasolini
È tra i massimi registi e documentaristi italiani e
ha firmato oltre 60 film. L'opportunità di “aprirci”
a Luigi Di Gianni, un maestro del nostro cinema, definito a
buon diritto il filosofo della macchina da presa, ci viene offerta
dalla Cineteca di Bologna con uno speciale DVD, dal titolo Uomini
e spiriti (Andrea Meneghelli, 2013, Cineteca di Bologna
€ 9,90) che, attraverso 16 film realizzati tra il 1958
e il '71, ripercorre la poetica e quell'attitudine intrinseca
con cui vengono indagati gli aspetti più irrazionali
e illogici della nostra cultura, specie quelli radicati nel
Sud più arcaico.
Luigi Di Gianni nasce a Napoli nel 1926. Si laurea in Filosofia
con una tesi su Heidegger e si diploma in Regia presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma dove poi insegnerà,
oltre a insegnare in diverse università italiane. Avvalendosi
della consulenza scientifica di Ernesto de Martino, nel '58
inizia l'attività di documentarista-cineasta con Magia
Lucana e che nello stesso anno vince il premio come miglior
documentario alla XIX edizione del Festival di Venezia. È
un acuto osservatore: il suo sguardo non è mai neutrale
verso l'oggetto preso in esame, sebbene la ricerca antropologica
che lo anima non abbia in sé nulla di estetizzante, vista
la brutalità quasi orrifica che guida la sua mano. Di
Gianni utilizza le armi della “settima arte” per
evidenziare con maggior forza la lotta dell'uomo contro la natura,
il fato, la povertà. Le genti del Meridione, protagoniste
delle vicende narrate nei suoi documentari, “portano”
sul viso una sofferenza eterna tramandata di generazione in
generazione e nel contempo sono dominate dal potere sovrannaturale.
È un cinema di ricerca e di denuncia, come si evince
dalle sue stesse parole: “Ho sempre provato amore per
chi non può niente e si dibatte inutilmente contro un
destino che lo sovrasta: è lo stesso amore che provo
per i contadini della mia terra, dell'Italia meridionale, per
gli oppressi in generale”. I suoi film esplorano in particolare
l'intreccio tra ritualità pagana e cattolicesimo nell'Italia
del Sud, la fatica e la dignità del lavoro, la fragilità
dell'uomo soggiogato dalla forza degli eventi che non può
controllare; ecco perché gli ultimi sono i primi ma restano
vittime sacrificali predestinate. Sintomatiche a tal proposito
le parole che l'antropologa Clara Gallini scrive: “[...]
La Lucania [...] del regista è astorica, fatta di voli
e gesti antichi, fissati nella lenta solennità dei movimenti,
in sguardi immobili che sembrano provenire da distanze immemorabili
e senza tempo. [...] La lettura di Di Gianni ci richiama di
più l'immagine che del contadino del Sud aveva proposto
Carlo Levi in 'Cristo si è fermato a Eboli'”.
Egli imprime alle opere una spiccatissima personalità
d'autore senza dimenticare le lezioni della cultura mitteleuropea,
della scuola sovietica e dell'espressionismo tedesco. Il suo
cinema non è scalfito dal tempo, bensì è
disseminato di essenze e suggestioni kafkiane e dreyerane.
Negli anni Sessanta l'antropologa e fotografa Annabella Rossi
è consulente e autrice dei testi dei documentari di Di
Gianni. Si ricordano: La Madonna di Pierno ('65), Il
male di San Donato ('65), La Possessione ('71). Nel
febbraio 2006 l'Università di Tubinga gli conferisce
la laurea honoris causa in Filosofia per meriti nel campo
del cinema d'ispirazione antropologica.
Costantemente coerente alla propria poetica, Di Gianni dà
vita a un cinema “estremo” basato sull'immagine-tempo
e non sull'immagine-movimento, eccezion fatta per il piano sequenza
capace di evocare un mondo d'immagini prima che di parole. Un
codice visivo dove la langue è in primis immaginazione.
Installazioni di corpi, non per forza attori, pronti a un'accensione/ascensione
cristologica nella tenuità di luci e ombre. È,
ciò nonostante, un cinema annichilito dalla mancanza
di acume di produttori e distributori, nonché da una
stampa sempre più disattenta e omologata.
|
| Una scena del film Tempo di raccolta |
Nella sua ricerca cinematografica estetica/estatica emergono
una perfetta sintonia e un parallelismo culturale con Carl Theodor
Dreyer, Friedrich Wilhelm Murnau, Josef von Sternberg, Dziga
Vertov, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Franz Kafka, Albert
Camus, Jean-Paul Sartre. Di Gianni predilige il bianco e il
nero e, proprio quando è costretto a ricorrere al colore,
utilizza colori saturi, innaturali, di una grigia tonalità
come l'esistenza dell'uomo. La musica dodecafonica di Arnold
Schönberg, Anton Webern, Alban Berg è protagonista
e fa da contrappunto doloroso a tali atmosfere.
Il rapporto con il sovrannaturale, l'estasi, la possessione,
l'onirico sono altri tratti peculiari della poetica di Di Gianni.
In Grazia e numeri ('62), I Fujenti ('66), La
potenza degli spiriti ('68), Nascita di un culto
('68), L'attaccatura ('71), attraversando il Profondo
Sud, egli documenta la presenza ancora molto forte di riti
connessi a forme di ritualità magico-religioso-protettive.
Come scrive Andrea Meneghelli nell'Introduzione del libretto
allegato al DVD, “il suo cinema è la documentazione
di un rimosso sociale”. Negli ultimi tempi ha realizzato:
La Madonna in cielo, la “matre” in terra
(2006), Carlo Gesualdo da Venosa - Appunti per un film
(2009), Un medico di campagna (2011) ispirato all'omonimo
racconto di Franz Kafka. Altri film sono in fase di lavorazione.
Lo scorso anno è stato nominato Presidente della Lucana
Film Commission.
Nel DVD Uomini e spiriti sono presenti tra gli altri:
Magia Lucana ('58), Frana in Lucania ('60), L'Annunziata
('62), Il culto delle pietre ('67), La tana ('67),
Tempo di raccolta ('67), Nascita di un culto ('68),
L'apparizione ('68), Nascita di un culto ('68).
La sua è una promenade alla riscoperta di un Meridione
arcaico, misterico, folle, dimenticato, eppure tanto affascinante
e suggestivo: “Io salvo l'identità lucana, raccomando
sempre di non vergognarsi del proprio passato e di essere stati
poveri. La povertà non è solo tragedia se la si
guarda con gli occhi di chi è riuscito ad uscirne senza
rinnegarla”. Forgia un cinema tutto suo, attraverso il
quale non pretende di catturare la verità pur
ricercandola incessantemente con vigore e integrità etica
straordinarie. Un cinema autorevole che s'impone per la sua
filosofia; dove l'immagine recupera il significato espressivo:
eloquente e risolutiva di per sé che, azzerando tempo
e spazio, è sempre attuale e dev'essere d'ispirazione
e monito per le nuove generazione di autori e registi, affinché
non si sprofondi nel baratro della non-cultura televisiva che
ormai sovrasta indomita plagiando la massa. Proprio come afferma
Pasolini: “La responsabilità della televisione,
in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto 'mezzo
tecnico', ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa.
[...] Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la
televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo
di informazione al mondo”.
Domenico Sabino
Resistenza a Milano 1943-45/
Contro i nazi-fascisti e per la rivoluzione sociale
 Per
le edizioni Zero in Condotta è stato recentemente pubblicato
il volume Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici
nella Resistenza a Milano (1943-45) di Mauro De Agostini
e Franco Schirone (Milano, 2015, pp. 360, € 20,00)
di cui pubblichiamo il comunicato editoriale e la prefazione
di Giorgio Sacchetti. Per
le edizioni Zero in Condotta è stato recentemente pubblicato
il volume Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici
nella Resistenza a Milano (1943-45) di Mauro De Agostini
e Franco Schirone (Milano, 2015, pp. 360, € 20,00)
di cui pubblichiamo il comunicato editoriale e la prefazione
di Giorgio Sacchetti.
Per gli anarchici la battaglia contro il fascismo, che comincia
a svilupparsi fin dalla nascita del movimento mussoliniano,
prosegue durante tutto il ventennio e si dispiega con la Resistenza,
costituisce un momento particolare della lotta rivoluzionaria;
fascismo, democrazia borghese, totalitarismo staliniano vengono
combattuti come forme diverse di oppressione statale in vista
della creazione di una società di liberi ed eguali.
Questo studio ricostruisce, per la prima volta in modo organico
e completo, le vicende del movimento anarchico milanese dagli
anni della dittatura fino ai mesi immediatamente successivi
alla Liberazione. Avvincente e documentata narrazione di un'esperienza
resistenziale popolare ed “altra”, quella degli
anarchici, in una città-chiave come Milano, crocevia
dei destini della Nazione ma anche proscenio della duratura
guerra civile europea.
Negli anni della dittatura la resistenza libertaria prosegue
tenace nonostante l'occhiuta vigilanza della polizia, anche
al confino e in carcere, ma è opera soprattutto di vecchi
militanti che rimangono fedeli alla propria storia. Sono gli
insuccessi della guerra fascista a incrinare il consenso al
regime mentre la caduta del fascismo e l'8 settembre portano
sulla scena politica una nuova generazione di giovanissimi ansiosi
di creare un mondo nuovo. A Milano si realizza la non facile
saldatura tra i militanti “storici” e centinaia
di giovani animati da spirito spontaneamente libertario e rivoluzionario,
portando alla nascita delle formazioni “Malatesta –
Bruzzi”. Ma le aspirazioni rivoluzionarie sono così
radicate e diffuse che lo stesso PCI guarda con preoccupazione
alle “tendenze anarcoidi e di sinistrismo” ampiamente
presenti nelle formazioni partigiane.
Oggi, mentre la tradizionale vulgata nazional-popolare
della Resistenza come”guerra patriottica” interclassista
viene progressivamente soppiantata da un infame revisionismo
storico che pone sullo stesso piano vittime e carnefici, risulta
tanto più necessario riscoprire l'anima rivoluzionaria
della lotta antifascista.
In appendice sono pubblicati diversi documenti in larga parte
inediti, come gli elenchi completi degli appartenenti alle formazioni
“Malatesta – Bruzzi”, le versioni integrali
della relazione di Giuseppe Seregni e del diario scritto da
Pietro Bruzzi dal 13 agosto 1943 al 3 maggio 1944, un mese prima
dell'arresto che lo porterà alla fucilazione.
Zero In Condotta
La presenza complessiva degli anarchici nella Resistenza è
già stata fatta oggetto di numerosi studi, alcuni di
grande pregio, ormai a partire dall'ultimo decennio del secolo
scorso. Tuttavia, trattandosi di un movimento di non facile
approccio per chi non abbia un retroterra di conoscenza approfondito,
si è rilevato spesso necessario, anzi indispensabile,
partire dal locale (o magari dalle storie di vita). Sì,
perché ad un movimento politico-culturale-sociale eterogeneo
e decentrato corrispondono spesso fonti altrettanto decentrate
e magari disperse. Ebbene queste pagine, oltre a rappresentare
un indubbio elemento di conoscenza, costituiscono anche un prototipo
per come si debba procedere nella ricerca storica di base. Senza
questi lavori, pazienti e minuziosi, le grandi opere di “sintesi”
non avrebbero più la materia prima per analisi e ricostruzioni
di largo respiro.
Mauro De Agostini e Franco Schirone, studiosi di vaglia, ci
propongono un'avvincente e documentata narrazione di un'esperienza
resistenziale popolare ed “altra”, quella degli
anarchici, in una città-chiave come Milano, crocevia
dei destini della Nazione ma anche proscenio della duratura
guerra civile europea. Lì dove lo scontro tra fascismo
e antifascismo ha assunto, da sempre, i connotati della guerriglia
sociale aperta il racconto di quelle vicende si fa decisivo.
Le modalità e le costanti di un conflitto apertosi nel
1919-1922 ritornano dunque negli anni 1943-1945 come ricapitolazione,
svolgimento finale e “recupero della memoria” (per
usare le parole di Claudio Pavone) durante la Resistenza, sotto
la cappa dell'occupazione tedesca. E si tratta di uno scontro
epocale, “guerra dei trent'anni” tra opposte visioni
del mondo, tra modelli di civiltà antitetici, il cui
esito produrrà contraddizioni più o meno impreviste:
come l'affermarsi di democrazie dai tratti autoritarie di antifascismi
di marca totalitaria.
La seconda guerra mondiale nelle sue molteplici rappresentazioni
raffigura una sorta di architrave della memoria europea, e pertanto
delle identità, di tutte quelle componenti sociali, politiche,
nazionali e culturali che vi furono coinvolte. Ciò vale
a maggior ragione per un paese come l'Italia alle cui istituzioni
spetta la peculiarità della nefasta primogenitura del
fascismo, e il disonore di una turpe alleanza con il nazionalsocialismo
hitleriano, dalla guerra d'Etiopia almeno fino all'8 settembre
1943. Per la generazione dei militanti libertari, reduci delle
antiche battaglie, l'epilogo di un'esperienza traumatica vissuta
in prima persona – guerra, persecuzioni, prigionia, esilio
e lotta armata – non sarà mai l'ora zero
per un nuovo spensierato inizio. Esso imporrà, piuttosto,
il dovere della memoria oltreché della coerenza antitotalitaria.
Le inaudite devastazioni fisiche e morali patite significarono,
innanzitutto, una grande confutazione delle illusioni e delle
finzioni ideologiche e politiche del Novecento, secolo destinato
a proiettare perennemente le sue ombre lugubri. “Mai come
allora – ha scritto Karl Dietrich Bracher (Zeit der
Ideologien) – l'idea di progresso si era rivelata
in tutta la sua ambivalenza: di fronte alla fede in un miglioramento
morale e culturale inarrestabile e automatico dell'uomo, c'era
l'esperienza di Auschwitz”. Né bastò più
il Comunismo come “quintessenza dell'antifascismo”,
giacché anche dopo il 1945 continuava ancora, nell'URSS,
la disumanità dei campi di concentramento...
La Resistenza, quale fenomeno storico ormai inesorabilmente
lontano nel tempo, fagocitata e depotenziata di tutta la sua
carica sovversiva dalla retorica istituzionale, oppure attaccata
in blocco dalla società dei consumi culturali veloci
e dei talk show, dai nuovi fascismi (più che dal
vecchio “revisionismo” del buon De Felice), ha man
mano esaurito la sua funzione pedagogica e di appeal
tra le giovani generazioni e non solo. Tuttavia anche lavori
come questo propostoci da De Agostini e Schirone – peraltro
estremamente ricchi dal punto di vista delle fonti utilizzate
e ben organizzati sul piano del racconto – ci richiamano
almeno un paio di riflessioni sulla metodologia di indagine
da adottare, sulle necessarie letture storiche da effettuare
sul lungo periodo. Tutte questioni che, allo stato, appaiono
ancora irrisolte nel milieu storiografico. Occorrerebbe,
in sostanza, passare davvero dalla attuale visione strettamente
singolare e univoca della Resistenza (ma quale memoria condivisa!)
ad una visione invece davvero plurale delle molteplici Resistenze.
Occorrerebbe inoltre superare senza remore la cronologia ristretta
del 1943-1945, discorso che ci pare debba valere anche per le
vicende dell'anarchismo.
Dopo la fase di “internazionalizzazione” –
che riguarda l'esperienza militante che matura fra le due guerre,
epoca in cui il movimento si misura con i totalitarismi in ambito
europeo – si delineerebbe così una periodizzazione
inedita. Si tratterebbe (sull'onda di alcune suggestioni dello
storico Giovanni De Luna) di prendere in considerazione tutto
in blocco il decennio della crisi 1938-1948. Ed è proprio
in questi anni, infatti, che precipitano eventi di portata epocale,
tali da marcare tutto il secondo Novecento anche per gli anarchici.
Ne citiamo solo i principali: gli esiti letali della sconfitta
in Spagna, la seconda guerra mondiale come guerra ideologica
antifascista, l'incardinamento dei tre partiti che per il mezzo
secolo successivo domineranno lo scenario politico italiano,
la conferma della statalizzazione dei sindacati, l'avvento della
repubblica e di un sistema liberal-democratico, la guerra fredda
con la giustapposizione della nuova coppia comunismo / anticomunismo
alla vecchia coppia fascismo / antifascismo, l'Unione Sovietica
come “faro” indiscutibile della sinistra...
Da rilevare anche che la partecipazione dei libertari italiani
alla lotta armata antifascista marcherà indubbiamente
la differenza fra i percorsi antropologico culturali successivi
intrapresi dalle varie correnti dell'anarchismo internazionale.
Così, se nell'area anglofona prevarranno i temi della
rivoluzione nonviolenta e dell'anti-bellicismo, in quella sud-europea
saranno invece gli stilemi classici dell'antifascismo di estrema
sinistra ad imporsi, non ultimo il mito della “Resistenza
tradita”.
Giorgio Sacchetti
I ribelli (strani?)
di Marco Sommariva
 È
stato ristampato il volume di Marco Sommariva Ribelli
(pp. 192, € 15,00) con sette capitoli aggiuntivi
e l'introduzione di Giuseppe Cospito, docente di storia della
filosofia all'Università di Pavia, che pubblichiamo. È
stato ristampato il volume di Marco Sommariva Ribelli
(pp. 192, € 15,00) con sette capitoli aggiuntivi
e l'introduzione di Giuseppe Cospito, docente di storia della
filosofia all'Università di Pavia, che pubblichiamo.
Si tratta di un'autoproduzione; per eventuali ordini contattare
l'autore all'indirizzo mail marco.sommariva1@tin.it.
“La storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente
disgregata ed episodica”, perché questi “subiscono
sempre l'iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano
e insorgono” scriveva Gramsci nei suoi Quaderni del
carcere verso la metà degli anni Trenta del Novecento.
E aggiungeva che “ogni traccia di iniziativa autonoma
da parte dei gruppi subalterni dovrebbe perciò essere
di valore inestimabile per lo storico integrale; da ciò
risulta che una tale storia non può essere trattata che
per monografie e che ogni monografia domanda un cumulo molto
grande di materiali spesso difficili da raccogliere”.
Va quindi reso merito a Marco Sommariva innanzitutto di avere
svolto un lungo e minuzioso lavoro di ricerca per compilare
i centouno capitoli di questo libro, ognuno dei quali costituisce
un piccolo saggio di quelle “monografie” che lo
stesso Gramsci avrebbe scritto, se solo fosse uscito vivo dalle
carceri fasciste.
Non tutti i “ribelli” di cui si parla in queste
pagine appartengono per nascita e condizione sociale ai gruppi
subalterni, ma anche coloro che provengono dalle classi agiate,
da San Francesco a Ernesto “Che” Guevara, ne sposano
la causa rinunciando a un'esistenza da privilegiati per dedicare
(e spesso sacrificare) la vita in favore degli umili e dei diseredati,
o comunque alla lotta contro ogni forma di ingiustizia e di
oscurantismo.
Certo, chi si limitasse a scorrere rapidamente l'indice del
libro, rimarrebbe decisamente sorpreso: che cosa hanno in comune
– si potrebbe chiedere il nostro lettore distratto –
l'astronomo e matematico Galileo Galilei e il capo indiano Toro
Seduto, l'umanista Pico della Mirandola e il “ladro gentiluomo”
Arsenio Lupin, il poeta religioso Jacopone da Todi e il pediatra
e pedagogista Marcello Bernardi, il fondatore del socialismo
scientifico Karl Marx e il folksinger Bob Dylan, il letterato
dandy Oscar Wilde e l'attivista nero convertito all'Islam
Malcom X, il profeta della non-violenza Gandhi e il guerrigliero
zapatista Marcos? In che senso possiamo definire “ribelli”
filosofi come Ruggero Bacone o Georg Wilhelm Friedrich Hegel?
In realtà tutti costoro, così come gli altri personaggi
descritti in questo libro – molti dei quali poco noti
ma non per questo meno importanti – sono accomunati dall'opposizione
a ogni autorità costituita, dal rifiuto di piegarsi al
Potere in tutte le sue manifestazioni: politiche, economico-sociali,
religiose, filosofiche, culturali e così via. Sono uomini
di fede che hanno anteposto i valori del cristianesimo originario
ai dogmi e alle pratiche della Chiesa ufficiale, scienziati
che hanno scelto di cercare la verità nel “gran
libro della natura” piuttosto che nei volumi polverosi
dei loro predecessori, filosofi che hanno esercitato la critica
razionale nei confronti di ogni tradizione inveterata, letterati,
poeti, artisti e musicisti che, con le loro opere, hanno sfidato
canoni e regole dei rispettivi generi per affermare il proprio
spirito libero creatore, uomini e donne che hanno scelto di
vivere la propria sessualità senza preoccuparsi di norme
e convenzioni sociali. Ma sono anche, se non soprattutto, persone
comuni, semplici contadini, operai e artigiani che non si sono
voluti piegare a un destino di sfruttamento e di oppressione,
al quale sarebbero stati destinati per il solo fatto di appartenere
a una classe inferiore. In molti casi, i protagonisti non sono
nemmeno individui singoli, ma gruppi sociali, politici, religiosi,
artistici e così via.
Il filo conduttore dei capitoli del libro, scanditi dallo scorrere
dei secoli che tuttavia – almeno in apparenza –
sembra lasciare inalterate gerarchie millenarie, è costituito
dalla lotta contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione
(politica, sociale, economica, religiosa, razziale, sessuale),
per realizzare ovunque libertà e uguaglianza, non solo
giuridiche, ma anche e soprattutto sostanziali. Una lotta quasi
sempre disperata per la sproporzione delle forze in campo e,
quindi, destinata fin dall'inizio alla sconfitta, almeno nell'immediato.
Eppure, nei tempi lunghi della storia, i vinti di ieri sono
spesso i vincitori di oggi o perlomeno di domani: la rivolta
dei Ciompi fiorentini viene repressa e per secoli accadrà
lo stesso a ogni tentativo di organizzare le rivendicazioni
(non solo salariali) dei lavoratori ma, a partire dai primi
successi delle Trade Unions, oggi almeno in una parte del mondo
i diritti sindacali sono universalmente riconosciuti; Sandro
Pertini e Nelson Mandela vengono imprigionati a lungo dai regimi
illiberali contro i quali si battono ma poi, dopo aver contribuito
in maniera decisiva alla loro caduta, diventano presidenti delle
loro nazioni; Martin Luther King viene assassinato, ma quarant'anni
dopo un afroamericano siede alla Casa Bianca.
E tuttavia non è una storia in bianco e nero, quella
che ci racconta Sommariva, una storia in cui, come nei vecchi
film western, i “buoni” sono tutti da una parte
(e alla fine trionfano) e i “cattivi” dall'altra
(e vengono battuti). Non tutti i protagonisti dei brevi ritratti
di cui è composto il libro possono essere proposti come
modelli da imitare: tra di essi ci sono infatti ladri e assassini,
briganti di strada e cacciatori di taglie. Ma le loro vicende,
se esaminate in modo obbiettivo e collocate nelle condizioni
storiche determinate in cui si svolsero, dimostrano che spesso
la differenza tra un eroe e un criminale, un terrorista e un
patriota, dipende da queste piuttosto che da una presunta malvagità
innata in alcuni esseri umani.
A volte, del resto, la violenza degli oppressi appare l'unico
mezzo per opporsi a quella degli oppressori, esercitata con
strumenti tanto più potenti e, spesso, più sofisticati
e meno visibili. È il caso di molti dei personaggi descritti
in queste pagine, nei confronti dei quali l'autore non nasconde
la propria simpatia umana e vicinanza politica (la stessa che
gli fa preferire Gracco Babeuf a Robespierre, Saint Simon, Owen,
Fourier e Proudhon a Engels, Rosa Luxemburg a Lenin, Carlo Rosselli
a Palmiro Togliatti). Personaggi riconducibili alla costellazione
molteplice e variegata del movimento anarchico e libertario:
non solo teorici come Max Stirner e Michail Bakunin, Alexandr
Herzen, Henry David Thoreau e molti altri, ma anche agitatori
come Pietro Gori e Carlo Tresca, che tentarono di metterne in
pratica gli insegnamenti con l'azione politica, “cani
sciolti” come il regicida Gaetano Bresci e vittime innocenti
come Sacco e Vanzetti.
Scorrendo le pagine del libro troviamo numerose figure femminili,
molto diverse tra loro per nascita, condizione sociale e cultura,
ma accomunate dal rifiuto della condizione di sudditanza e subordinazione
alla quale sarebbero state destinate solo in quanto appartenenti
al sesso tradizionalmente considerato “debole”:
sono guaritrici ed erboriste, levatrici e prostitute, per questo
bollate e perseguitate per secoli come streghe, paladine dei
diritti della donna come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft,
scrittrici anticonformiste come Emily Dickinson; o ancora le
suffragette, epiteto spregiativo affibbiato a coloro che si
battevano per il diritto di voto. E, man mano che ci avviciniamo
ai nostri giorni, le donne si fanno portavoce di battaglie universali,
che oltrepassano l'orizzonte dell'emancipazione femminile: è
il caso di Rosa Louise Parks, grazie alla cui fermezza verranno
abolite le discriminazioni razziali sui mezzi pubblici negli
USA, e soprattutto di Malala Yousafzai, la giovanissima pakistana
alla quale nemmeno i proiettili dei talebani sono riusciti a
impedire di coltivare il sogno dell'istruzione per tutti, compresi
i figli e le figlie di coloro che l'avevano ridotta in fin di
vita. Ed è significativo che il libro si chiuda proprio
con il suo ritratto, come a voler ribadire che la lotta contro
ogni forma di schiavitù e oppressione passa prima di
tutto attraverso la conoscenza.
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la
nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno
di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché
avremo bisogno di tutta la nostra forza” scriveva sul
primo numero dell'”Ordine Nuovo”, il giornale dei
Consigli di fabbrica torinesi da lui fondato nel 1919, quel
Gramsci con cui ho aperto questa brevissima introduzione e che
viene nominato diverse volte nel libro, anche se non sono sicuro
che si sarebbe riconosciuto nella definizione di “ribelle”.
Credo tuttavia che queste sue parole possano essere fatte proprie
da tutti coloro che, proseguendo la millenaria lotta dei protagonisti
di queste pagine, credono nella possibilità di lasciare
un mondo migliore rispetto a quello che hanno trovato.
Giuseppe Cospito
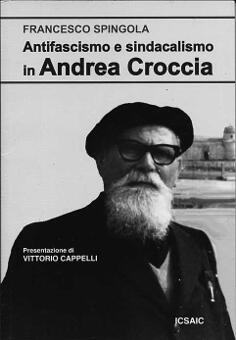 Andrea
Croccia
calabrese, comunista-anarchico, antifascistaEdito dall'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo
e dell'Italia Contemporanea (ICSAIC) di Cosenza è uscito,
da pochi mesi, il libro di Francesco Spingola, dal titolo Antifascismo
e sindacalismo in Andrea Croccia. Documenti e testimonianze
(Cosenza, 2014, pp. 96, senza prezzo). L'autore, attuale
segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Territoriale,
ricercatore e studioso di antropologia, con il suo lavoro ha
voluto rendere omaggio ad Andrea Croccia, prestigiosa figura
di comunista-anarchico, antifascista e sindacalista arbëreshë
che ha contribuito, con la sua incessante attività politica
e sociale, alla costruzione, in Calabria sia del Partito Comunista
Italiano che della CGIL.
Andrea Croccia, figlio di Angelo e di Domenica Durante, di mestiere
contadino, nasce a Civita (Cosenza) il 2/5/1899. La sua è
stata una vita avventurosa. Conosce, a soli sei anni, l'emigrazione
partendo con il padre in Argentina. Nel 1910 il padre lo lascia
solo per rientrare brevemente in Italia con lo scopo di portarsi
in America moglie, figlia e madre ma muore nel bastimento durante
il viaggio. Andrea ha solo 11 anni e sopravvive grazie all'ospitalità
di alcune famiglie italo-albanesi. Cerca di ricongiungersi con
il nonno a Buenos Aires, ma durante le ricerche apprende che
anche questi è morto. Si reca allora da uno zio
materno, ma viene scacciato, racconterà dopo, come non
si farebbe neanche con “un cane randagio”. Finalmente
incontra l'anarchico Carlo Berneri che lo impiega a vendere
il giornale “Arriva” da lui fondato. Dopo varie
vicissitudini, a soli 13 anni, ritorna in Calabria a Frascineto.
A 18 anni viene chiamato alle armi e sul Monte Grappa rischia
di morire per assideramento. Trasportato d'urgenza, all'ospedale
di Palermo, gli vengono amputati parzialmente tutti e due i
piedi. Nel 1921 fonda la sezione Comunista di Frascineto.
Nel 1924 aderisce al “Gruppo Anarchico del Sud”
e viene segnalato per i suoi contatti con Errico Malatesta.
Nel 1927 viene licenziato dalle ferrovie e nel 1933 a Frascineto
(Cosenza), i fascisti gli sparano e vivrà tutta la vita
con una pallottola in corpo. Da quel momento in poi la sua vita
sarà un inferno: viene più volte arrestato, continuamente
vigilato, vessato, confinato. Dopo la Liberazione lavora presso
la Camera del Lavoro di Cosenza. Nel 1948 risulta essere il
primo dei non eletti, ma poi, per l'improvvisa morte di un deputato
calabrese, subentra a Montecitorio. Rimane deputato per 24 ore,
si dimette per far posto, su sollecitazione di Togliatti, alla
compagna milanese Elsa Molè. Consegnato il tesserino
di parlamentare, con tutti i privilegi derivanti da quello status,
con le protesi di legno, le stampelle, il basco nero e il pizzetto
sul mento ritorna tra i contadini e i pastori di Frascineto
da dove era partito a soli sei anni.
Scrisse, nel 1954, dalla lontana Liguria, all'amico Domenico
Licursi: “La bellezza della Vita, la speranza che cerchi,
sono tra la tua gente. Bisogna cancellare quella brutta parola
che il primo prepotente ha scritto: “questo è mio”
e sostituirla con un'altra parola, più bella, più
umana: “questo è nostro”. La Vita, Caro Domenico,
sarà quella che vogliamo.”
Il libro di Francesco Spingola è impreziosito da numerose
foto e documenti inediti.
Per richieste:
francospingola@cgilpollino.it
- istitutocs@virgilio.it.
Angelo Pagliaro
 La
prima guerra mondiale
in Val di PesaIl volume (a cura di Alberto Ciampi e Francesco Fusi, Di
fronte al Fronte. Val di Pesa e Prima guerra mondiale. Frammenti,
Centro Studi Storici della Valdipesa – n. 14, San Casciano
in Val di Pesa (Fi), 2015, pp. 208, € 18,00) è composto
dalla premessa ed una introduzione ad Antimilitarismo
di Gian Pietro Lucini a firma di Alberto Ciampi oltre al punto
di vista di Marco Rossi e Gianluca Cinelli. Segue il capitolo,
Interventismo e antimilitarismo in Val di Pesa con una
pungente analisi sulla Mobilitazione civile e protesta popolare,
di Francesco Fusi. Una ampia appendice iconografica e documentaria
arricchisce la pubblicazione seguita da due storie intime, di
due soldati-contadini, il primo che morirà pochi anni
dopo a causa della guerra, il secondo, sarà disperso.
Queste due storie si sviluppano attraverso l'analisi di una
gran quantità di corrispondenze dal fronte.
Rispetto alla gran messe di scritti su e attorno al conflitto,
questo lavoro è eccentrico, guarda alle contraddizioni,
in alvei border line e nelle pieghe della storia: in
quegli elementi che hanno fatto sì che questa guerra,
per molte ragioni, non fosse uguale alle altre. Il punto di
vista di ambienti che nell'immaginario appaiono estranei a tale
contesto, sono invece, a nostro avviso, luoghi di indagine che
inducono a cogliere, se non meglio, almeno in maniera parecchio
differente il perché di adesioni o avversioni. In questa
indagine emergono persone e fatti contraddittori di migranti
politici i quali, partiti da posizioni rivoluzionarie, si
troveranno in panni reazionari e conservatori, magari continuando
a ritenere di essere veri rivoluzionari. Oppure chi o coloro,
che su differenti posizioni, pro o contro, hanno mantenuto intatto
il proprio atteggiamento nonostante il traumatico passaggio
della guerra, ora convinti di aver aderito coerentemente ai
propri ideali, ora avendo preso atto dell'errore della scelta.
Ma anche di coloro dei quali non possiamo avere un pensiero
successivo, perché un “poi” non l'hanno avuto
lasciando in vario modo la vita sulle trincee.
Per ulteriori informazioni sul volume: www.cssvp.com,
alanark-@tiscali.it.
Alberto Ciampi
Fabrizio De André
tra memoria e presente
 Tutti
gli appassionati di Fabrizio De André conoscono sicuramente
Romano Giuffrida per il suo documentario Faber, del 1999, fatto
insieme a Bruno Bigoni oppure per il suo libro “De André:
gli occhi della memoria (tracce di ricordi con Fabrizio)”
del 2002 o, più probabilmente, per entrambi. Romano torna
sul luogo del misfatto con un altro libro (De André
che bella compagnia, disegni di Massimo Caroldi, edizioni
Piagge, Firenze, 2014, pp. 240, € 11,00) dedicato a De
André, pescando una citazione da Anime salve per
il titolo (“che bello il mio tempo che bella compagnia”). Tutti
gli appassionati di Fabrizio De André conoscono sicuramente
Romano Giuffrida per il suo documentario Faber, del 1999, fatto
insieme a Bruno Bigoni oppure per il suo libro “De André:
gli occhi della memoria (tracce di ricordi con Fabrizio)”
del 2002 o, più probabilmente, per entrambi. Romano torna
sul luogo del misfatto con un altro libro (De André
che bella compagnia, disegni di Massimo Caroldi, edizioni
Piagge, Firenze, 2014, pp. 240, € 11,00) dedicato a De
André, pescando una citazione da Anime salve per
il titolo (“che bello il mio tempo che bella compagnia”).
In realtà si tratta di una prosecuzione logica del libro
del 2002, che viene riproposto integralmente, a cui è
aggiunta una intervista/conversazione con Alessandro Santoro,
prete nel quartiere e nella Comunità di Base delle Piagge
(periferia di Firenze). Non si tratta, badate bene, di un ripescaggio
con aggiunta di... qualcosa. È invece una vera e profonda
evoluzione del pensiero e dell'atteggiamento di Romano, estremamente
stimolante.
Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che “gli occhi della
memoria”, e quindi le prime 150 pagine circa di questo
libro, ripercorrono la produzione di Fabrizio De André
con il vissuto dell'autore, con una contestualizzazione puntuale
degli anni di uscita dei vari album. Romano ripercorre con gli
occhi della memoria la sua situazione di allora, gli avvenimenti,
la lettura che ne dava De André e l'impatto su di lui
con le sue riflessioni, spesso molto stimolanti. Questa parte,
che ho letto con piacere, ripercorre molti dei pensieri che,
sono sicuro, hanno attraversato la mente di chi, come me, ha
visto il suo atteggiamento verso la realtà “ufficiale”,
cambiare, evolversi. Piano piano la guerra, le prostitute, il
potere, la morte, il suicidio, i diversi, i matti, i rom, le
minoranze... sotto le parole sferzanti di De André, prendevano
un significato nuovo, diverso, decisamente in direzione ostinata
e contraria. Questo e molto altro potete (ri)trovare nella prima
parte del libro “De André che bella compagnia”.
Bene, benissimo, direte. Cos'altro c'era da aggiungere? Gli
occhi del presente. O meglio uno sguardo attento alla realtà.
Romano racconta come, “inciampando” nella Comunità
di base delle Piagge si è sentito rimettere profondamente
in discussione. Il rione delle Piagge, “è il classico
esempio di dormitorio urbano nato grazie alle disastrose politiche
urbanistiche e sociali attuate dalle amministrazioni cittadine
che si sono alternate alla guida della città tra gli
anni Settanta e Ottanta. È in questo contesto che nel
1994 Alessandro Santoro, prete allora ventinovenne, decise di
“giocarsi la vita” a fianco dei respinti, degli
ultimi, dei minimi della storia come li chiama lui.” Partendo
da un prefabbricato donato dalla Caritas, il prete ha creato
un centro sociale dove esistono (prendete fiato!) “progetti
di inserimento al lavoro destinati a ragazzi e adulti in situazioni
di difficoltà, di marginalità sociale, di dipendenza;
laboratori ludici, artistici, doposcuola, campi di animazione
esitiva; spazi per il gioco dei bambini, centri di alfabetizzazione
per bambini e ragazzi stranieri che frequentano le scuole elementari
e medie; [...] corsi di lingua italiana per stranieri; il Fondo
Etico e Sociale che svolge attività di microcredito;
attività di commercio equo e solidale; EdizioniPiagge,
la casa editrice alternativa; la promozione di cultura e di
pratiche di consumo critico e di riciclaggio [...] E tutto questo
attraverso la pratica dell'autogestione e quindi nella logica
della responsabilizzazione collettiva.”
Questo incontro/inciampo ha chiaramente scombussolato Giuffrida,
facendogli franare “gli ultimi residui di quella storia
che mi ero raccontato e che mi aveva permesso negli anni del
cosiddetto “riflusso” di dismettere gli abiti del
“rivoluzionario” per indossare quelli, certamente
più comodi, dell'indignato militante pronto alla vibrante
protesta.” Questo incontro, secondo Romano, apre un solco
irrevocabile tra la memoria (il passato) e il presente, frutto
di tutti questi stimoli che la comunità gli ha dato.
Secondo Romano il prete incontrato alle Piagge corrisponde ad
una citazione di Tonino Bello, che diceva: “Non fidatevi
dei cristiani autentici che non incidono la crosta della civiltà.
Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi con san Francesco
d'Assisi che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava
di partire...” ecco. È da queste considerazioni
che Romano parte per avviare la seconda parte del libro, quella,
appunto, dedicata ad un colloquio/intervista ad Alessandro Santoro.
In questa seconda parte tra i due si parla di temi che accomunano
i due personaggi al terzo, il sempre presente De André.
La prima domanda è decisamente rivelatoria di quello
che sta per succedere. In pratica si tratta di verificare se
la scelta del sacerdozio fatta da don Alessandro, comporti (come
molti pensano) solo “risposte indiscutibili” oppure
ci sia spazio per “liberare le nostre domande”.
La risposta è quasi temeraria “Sono convinto infatti
che ciò che priva le persone della libertà è
soprattutto il confezionarsi risposte, o accettare di essere
“confezionati” da risposte che uccidono la possibilità
di creare varchi attraverso i quali, sia in entrata che in uscita,
possa passare qualche cosa...”
Dopo la libertà e l'anarchia si passa alla guerra, alla
“gente che muore e nessuno si domanda più perché...”
dove Alessandro Santoro oltre che citare il messaggio del discorso
della montagna (“Se saluti soltanto chi ti saluterà,
che merito ne avrai? E se starai soltanto con quelli che sono
simili a te, che merito ne avrai?”) nota come le persone
che dalla vita hanno subito un impoverimento, sono quelle più
sensibili a farsi delle domande, a differenza di chi si è
ormai assuefatto e pensa solo a sé.
Ne “un telecomando al fosforo nascosto tra cuore e volontà”
Romano sottolinea come la nostra società è spesso
basata su un totalitarismo culturale, che fa in modo che non
ci siano mai scelte veramente libere... qui nella risposta c'è
una diretta citazione di Fabrizio De André, con la necessità
assoluta di andare sempre in direzione ostinata e contraria...
De André entra spesso nei loro argomenti, perché
Alessandro, che da quando aveva dieci anni cominciò a
sentire queste canzoni dai dischi del fratello maggiore, racconta
come ne fu subito colpito, per molti motivi... “crescendo
ho cominciato a percepire in quelle parole una grande libertà
dal punto di vista etico e morale. Io odiavo il giudizio, la
morale sulle persone, ero istintivamente un libertario. Ecco,
De André per me è stato illuminante, perché
per la prima volta ascoltavo raccontare quelle storie, quei
mondi, senza nessun tipo di giudizio, di stigma, di dogma.”
Gli argomenti si susseguono stringenti: ladri e tipi strani,
mai giocare con gli zingari, le mille scritture del Libro del
Mondo, quando si è cuccioli giocare alla lotta è
normale, la morte che non muore mai, l'odio, la violenza...,
Dio è stanco o troppo occupato quando non ascolta il
nostro dolore?, gli occhi belli delle donne, tra gli altri uguali,
la pietà in tasca, l'ingiustizia e le tranquille superbie
di chi sta a guardare. Le risposte fanno sempre riflettere,
ed aprono la mente ad altre domande....
Mi piace concludere con un bel pensiero di Alessando Santoro
che, riferendosi alle persone della Comunità, fa una
considerazione su Fabrizio che ben spiega il suo esserci: “De
André è stato capace, in maniera assolutamente
non retorica, assolutamente vera, di cogliere il lato più
umano e più vero di questa umanità, di questa
realtà, di queste persone.” In conclusione si tratta
di un libro ricco di spunti di riflessione, mai superficiale,
a tratti decisamente coinvolgente.
Walter Pistarini
www.viadelcampo.com
La devianza
come malattia?
 Il
saggio ben documentato di Chiara Gazzola (Fra diagnosi e
peccato. La discriminazione secolare nella psichiatria e nella
religione, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2015, pp. 276,
€ 24,00) pone sotto la lente focale, in una dialettica
passato-presente e in un'ottica globale, le interferenze delle
istituzioni mediche e religiose nelle scelte dei singoli “
Da sempre esistono individui che hanno l'esigenza di sottrarsi
all'omologazione. Troppo spesso le istituzioni interpretano
i bisogni altrui attraverso giudizi dentro i quali si nasconde
il potere per discriminare ed esercitare un controllo emotivo”. Il
saggio ben documentato di Chiara Gazzola (Fra diagnosi e
peccato. La discriminazione secolare nella psichiatria e nella
religione, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2015, pp. 276,
€ 24,00) pone sotto la lente focale, in una dialettica
passato-presente e in un'ottica globale, le interferenze delle
istituzioni mediche e religiose nelle scelte dei singoli “
Da sempre esistono individui che hanno l'esigenza di sottrarsi
all'omologazione. Troppo spesso le istituzioni interpretano
i bisogni altrui attraverso giudizi dentro i quali si nasconde
il potere per discriminare ed esercitare un controllo emotivo”.
L'autrice, di formazione antropologica, dimostra attraverso
un approccio storico, sociologico, antropologico come la diversità
sia considerata indice di irrazionalità e insensatezza,
una minaccia al corretto funzionamento dell'ordine morale e
sociale. Sottolinea il carattere ambiguo, soprattutto nell'ambito
della classificazione delle malattie mentali in psichiatria:
l'anomalia, come antitesi di normalità, è irretita
da attributi morali. L'ambito psichiatrico contribuisce ad alimentare
il nostro pregiudizio rispetto a ciò che per noi è
alienazione mentale, follia. Per altre culture, invece, rappresenta
l'esternazione di uno spirito che porta ad agire al di sopra
della volontà delle persone, l'anomalia sociale è
interpretata in funzione del bene della collettività
e inserita in un contesto di credenze condivise.
Ogni cultura sviluppa i propri valori di riferimento attorno
a ciò che desta meraviglia.
Per le società arcaiche, ogni deficit di salute è
una carenza di armonia, un'interruzione del flusso vitale.
La curatrice o il curatore -strega, sibilla, sciamano, stregone-
è figura ammantata da una sorta di “diversità”
ed è indispensabile alla comunità, ma non ha potere
decisionale. Il potere si fonda sul prestigio.
Lo studio della “cultura popolare” dimostra che
la sopravvivenza collettiva dipende dalla condivisione del sapere,
un forte legame con la natura e un vitale rispetto tra gli individui.
Per Joyce Lussu, la ricerca dovrebbe far uscire dal silenzio
la “storia negata”. In particolare: “La storia
della medicina popolare è un aspetto della storia generale
che mette in rilievo l'inventiva e la creatività delle
donne pur nella loro condizione subalterna”. Ancora: “Recuperare
la storia delle donne nella storia generale dell'umanità
vuole dire in primo luogo ritrovare la fiducia nelle capacità
di costruire un avvenire diverso”.
La civiltà tecnologica, supportata dalla ricerca scientifica,
ha dato un nome alla patologia e una logica razionale alla cura
e ci ha inserito in un contesto di rottura dell'equilibrio.
Per un approccio alla terapia, la fiducia è indispensabile
all'efficacia della cura stessa. Nella voce corale delle testimonianze
raccolte, ricorre la richiesta di ascolto, conforto alla sofferenza.
Si chiede Gazzola: “Quando la relazione tra individui
è disturbata da burocrati, agenti di controllo e giudici
o si attua all'interno di progetti nei quali il poter fare si
basa su rapporti di forza, può avviarsi un rapporto di
reciprocità?” Le ingiustizie evitabili generano
un dolore spesso impossibile da accettare.
Il tentativo di risolvere una sofferenza è un percorso
di resistenza interiore. Per Jacques Lacan, lo stato di crisi
esistenziale mette nella condizione il “folle”,
nel disordine del mondo, di imporre la legge del proprio istinto,
che è la legge della libertà. C'è una sottile
e discriminatoria linea di confine fra prendersi cura e gestire
l'aiuto, come ben dimostra l' analisi su etnopsichiatria e flussi
migratori, presentata nel terzo capitolo: quando l'aiuto si
risolve nell'indirizzare la persona straniera ai servizi psichiatrici,
anche una certificazione può tradurre una difficoltà
esistenziale in una diagnosi. Così il pregiudizio può
essere sintetizzato nell' “innata incapacità di
adattamento alla cultura ospitante”.
L'assistenzialismo è il volto buono delle istituzioni
totali. L'esclusione viene attuata ogni volta in cui si crea
una categoria o una situazione che susciti scandalo, un risentimento
sociale al quale si abbina una giustificazione “scientifica”.
Le aree di studio dell'etnopsichiatria pongono attenzione ai
fattori ambientali e sociologici, ma giustificano una cura farmacologica
chiamando ogni conflitto con il nome di una patologia. Pertanto
si esclude una soluzione attraverso un approccio culturale e
relazionale.
Difficoltà di comunicazione e divergenze culturali si
risolvono incanalando corpi e menti attraverso regole imposte.
Quando testimonianze di donne stuprate ricoverate in ospedale
psichiatrico vengono smentite dai responsabili della violenza,
si ricorre alla diagnosi di “delirio di persecuzione”.
Allo stesso modo, il lessico psichiatrico traduce un'esperienza
drammatica in un disagio da curare, così il timore di
essere fraintese si trasforma in una sofferenza inascoltata.
Il saggio riflette altresì sulla non completa comprensione,
da parte di osservatori esterni, delle esigenze con le quali
culture subalterne plasmano la propria spiritualità.
Ne scaturisce l'esigenza di imporre uniformità e consenso
rendendo “omogenea” ogni spiegazione, credenza o
scelta etica. La Chiesa, con la contrapposizione tra anima e
corpo, da sempre ha indotto a disprezzare i bisogni di quest'ultimo.
Il Malleus Maleficarum sarà lo strumento ideale
degli inquisitori per la caccia alle streghe, personificazioni
di tutti i mali del mondo, validi capri espiatori per l'unica
entità politico-religiosa mediatrice verso il bene. In
seguito, nuove esigenze di razionalità formuleranno definitivamente
la devianza in termini di malattia. Con il tempo, il termine
“isteria” si diffonderà anche negli organi
di informazione attuali, fino a definire “manifestazioni
isteriche” azioni di protesta dei movimenti dell'antagonismo
sociale. Estasi e visioni si tradurranno in “deliri dell'ascesi”,
a donne che abbiano ricevuto la canonizzazione della santità
verrà abbinata una diagnosi di isteria e nevrosi.
Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, tra i vizi
capitali, il peccato teologico dell'accidia -abbattimento, pigrizia
- è dovuto a un venir meno della fede per un'assuefazione
dei piaceri esteriori. E se in altre culture il vuoto emotivo
è “ozio creativo”, la psichiatria lo cura
come depressione. Pur in assenza di risultati esaustivi delle
ricerche neuroscientifiche, per le donne si continua ad asserire
una maggior predisposizione dovuta a componente ereditaria genetica.
Gazzola evidenzia come si trascuri il condizionamento culturale
in una società contraddittoria omologante, nella quale
è facile percepirsi inadeguate, soprattutto se il contesto
affida valore a una persona solo per il ruolo che svolge.
Ancora: la religione istituzionalizzata sintetizza in superstizione
ciò che la psichiatria riconduce a malattia. Ne sono
un esempio i riti, dalla forte valenza simbolica, elaborati
nelle culture popolari: dal tarantismo salentino alla possessione
dell' argia in Sardegna, dai culti agrari, alle cerimonie vudu
- ormai sparse in tutto il mondo - alla macumba brasiliana e
all'hadra magrebina, capaci di allontanare spiriti maligni con
musica e danze vorticose.
Nelle conversazioni riportate a conclusione del saggio - pregevole
quella con Giorgio Antonucci - Michela Zucca, antropologa, commenta:
“La condivisione, la solidarietà, la spinta ideale
collettiva aiutano a superare le sofferenze individuali. Se
una persona è coinvolta e impegnata in un progetto riuscirà
più facilmente a non cadere nel malessere: in questo
senso la lotta è terapeutica”.
Giorgio Antonucci, medico, in Diario dal manicomio scrive:
“Non è detto che una persona debba attenersi per
forza alla vita empirica invece che essere fantasiosa, specialmente
se il sognare a occhi aperti le è utile per vivere, e
non è detto che debba rispettare i pregiudizi e le convenzioni
della società quando queste le divengono intollerabili”.
Un saggio, dunque, degno di interesse e attenzione per la rinnovata
fiducia riposta nella capacità di elaborazione insita
nel nostro pensiero: “Quando il desiderio di libertà
ispirerà l'elaborazione emotiva e la volontà di
riscatto, abbracceremo le nostre utopie riqualificando l'esistenza”.
Claudia Piccinelli
Geoffrey Ostergaard,
l'anarchico gentile
Pilota della RAF “convertito” all'anarchismo durante
la seconda guerra mondiale, docente universitario, pubblicista,
attivista per la pace e il disarmo, Geoffrey Ostergaard (1926-1990)
è stato negli anni del dopoguerra un protagonista del
rinnovamento del movimento anarchico inglese e, per oltre 30
anni, un suo esponente di punta. Ha collaborato regolarmente
a Freedom, Anarchy, The Raven e Peace
News. È stato inoltre un apprezzato amministratore
dei Friends of Freedom Press e della Commonweal Collection,
una biblioteca indipendente specializzata nei temi della pace
e del cambiamento sociale nonviolento. Il suo pensiero è
il frutto di un'originale ibridazione tra la tradizione anarchica
occidentale (Kropotkin e Landauer, soprattutto) e la nonviolenza
di ispirazione gandhiana, di cui Ostergaard ha messo in evidenza
gli aspetti libertari. In un commosso ricordo pubblicato su
Freedom il 24 marzo 1990, Colin Ward ha sottolineato
la sua coerenza e forza morale, la sua strenua difesa della
libertà di pensiero e di insegnamento, la sua ironia
nei confronti delle assurdità del mondo accademico e
la sua capacità di analizzare senza pregiudizi ideologici
la realtà.
Le ricerche di Ostergaard si sono concentrate soprattutto sulla
storia del movimento operaio e socialista britannico e sui movimenti
gandhiani e post-gandhiani in India, di cui è stato uno
dei più profondi conoscitori e su cui ha scritto due
volumi fondamentali, The Gentle Anarchists (1971) e Nonviolent
Revolution in India (1985). Da segnalare anche Latter-Day
Anarchism: The Politics of the American Beat Generation
(1964), uno studio pionieristico sullo stile di vita libertario
e il messaggio anarchico dei beatnicks americani.
Una raccolta dei suoi scritti di impronta anarco-sindacalista,
The Tradition of Workers Control, e il pamphlet anarco-pacifista
Resisting the Nation State, sono scaricabili liberamente
ai seguenti indirizzi:
https://libcom.org/history/tradition-workers-control-geoffrey-ostergaard
http://www.ppu.org.uk/e_publications/dd-trad8.html
L'articolo che presentiamo, pubblicato per la prima volta in
Anarchy. A journal of anarchist ideas, n. 20, ottobre
1962, con il titolo Anarchism: contracting other relationships
(L'anarchismo: sviluppando altre relazioni), rappresenta
un'interessante sintesi del suo pensiero.
Ivan Bettini
Fin dai giorni di Marx, e in gran parte proprio a causa dell'influenza
di Marx, il socialismo è stato concepito in termini di
proprietà. Almeno fino a poco tempo fa, infatti, un socialista
veniva definito come uno che crede nella proprietà comune,
solitamente nella proprietà statale, in quanto opposta
alla proprietà privata. Tuttavia, con l'esperienza della
Russia, e non solo di questo paese, a farci da guida, sta diventando
sempre più evidente, come è sempre stato evidente
per gli anarchici, che un semplice cambio di proprietà
non produce un cambiamento radicale nelle relazioni sociali.
Quando la proprietà comune prende la forma della proprietà
statale, infatti, tutto ciò che accade è che lo
Stato diventa il datore di lavoro universale, e le possibilità
che si instauri una tirannia sono moltiplicate dall'unione,
nelle stesse mani, del potere economico e di quello politico.
I valori che soggiacciono al capitalismo non sono cambiati:
il lavoratore rimane essenzialmente una cosa, una merce, un'unità
di lavoro. Egli ha solo cambiato una classe di padroni –
i capitalisti – con un'altra classe di padroni –i
burocrati politici e amministrativi.
Un cambio di proprietà nei mezzi di produzione è
probabilmente una condizione necessaria per passare da un ordine
sociale capitalistico ad uno cooperativo, ma non è –come
la maggior parte dei socialisti ha ritenuto erroneamente- una
condizione sufficiente.
Ciò che è importante per l'operaio non è
chi possiede la fabbrica in cui lavora, ma “le condizioni
materiali e concrete del suo lavoro, la relazione con il suo
lavoro, con i suoi compagni operai e con chi dirige la fabbrica”
(E. Fromm).
È per questa ragione che gli anarchici rimangono convinti
sostenitori del controllo operaio dell'industria- una condizione
in cui tutti parteciperebbero in modo paritario a determinare
l'organizzazione delle loro vite lavorative, in cui il lavoro
diventerebbe attraente e ricco di significato, in cui non sarebbe
il capitale a impiegare il lavoro ma il lavoro ad impiegare
il capitale.
L'anarchismo - qualcuno potrebbe obiettare- funziona molto bene
nella teoria ma fallisce, o fallirebbe, nella pratica. Gli anarchici,
tuttavia, non accettano questa implicita opposizione tra teoria
e pratica: una buona teoria, infatti, conduce ad una buona pratica,
e una buona pratica è basata su una buona teoria. Non
dico che agire da anarchico sia facile: la tentazione di agire
in modo autoritario -imporre soluzioni invece che affrontare
e risolvere insieme le difficoltà- è sempre molto
grande. E può anche essere che, almeno nel breve periodo,
le organizzazioni di carattere autoritario siano più
efficienti nei loro risultati. Ma l'efficenza -esaltata tanto
dai capitalisti che dai socialisti moderni- è solo uno
dei valori, e per essa si rischia di pagare un prezzo troppo
alto.
Più importante dell'efficienza è la dignità
dell'individuo responsabile, e non si dovrebbero cercare soluzioni
a quella che viene comunemente definita “la questione
sociale” che non siano rispettose della dignità
e della responsabilità dell'individuo.
Il compito di un anarchico non è tuttavia quello di sognare
la società futura. Piuttosto è quello di agire
quanto più possibile in modo anarchico all'interno della
società attuale: evitare il più possibile situazioni
in cui sia costretto ad obbedire o a comandare, e impegnarsi
a costruire relazioni di cooperazione reciproca e volontaria
tra gli esseri umani suoi compagni.
Nel mondo moderno lo Stato è la più importante
manifestazione del principio di coercizione. Dunque, per raggiungere
l'anarchia, lo Stato deve essere eliminato. Ma sarà eliminato
nella misura in cui gli uomini diventeranno capaci di vivere
senza di esso. Come ha detto l'anarchico tedesco Gustav Landauer,
“lo Stato è una condizione, una particolare relazione
tra gli esseri umani, una modalità di comportamento.
Noi lo distruggiamo contraendo relazioni di altro tipo, comportandoci
in modo diverso”.
In ultima analisi, un anarchico non è una persona che
sottoscrive un particolare corpo di dottrine o un insieme di
principi. Un anarchico è una persona che si comporta,
o si sforza di comportarsi, in modo diverso-in un modo
che consiste nel rispettare l'individuo che è presente
in tutti gli esseri umani.
Goffrey Ostergaard
traduzione di Ivan Bettini
Il potere sovversivo
dell'immaginazione
In questi giorni, vedendo, tra le tante immagini raccapriccianti
che scorrono sul video durante i telegiornali, gruppi fondamentalisti
dell'Isis prendere a picconate interi musei e siti archeologici
in Irak, ho pensato che quella non era altro che la cuspide
(la parte condivisa come negativa un po' da tutti) di un processo
di devastazione culturale più subdolo che accade ovunque
e a cui pochi, invece, oppongono resistenza.
Ovunque è in atto un processo di controllo attraverso
l'annullamento del pensiero critico individuale che, come ben
sappiamo, si forma culturalmente. C'è addirittura chi
dice che a confronto di questo la schiavitù era un'impresa
ingenua, perché ora stanno lavorando alacremente per
renderci sempre più, e in sempre più gran numero,
“oggetti” dello sviluppo, con il corpo ma anche
e soprattutto con le emozioni e con l'intelletto. Oggetti partecipi
volontariamente, complici sottomessi e adattati alla megamacchina.
 Pensavo
a questo e mi venivano in mente le genti del Rojava –
soprattutto le donne - con quel loro meraviglioso progetto di
vita per cui – e non certo solo per difendersi –
vale la pena combattere. Sono state quelle donne a ricordarmi
un libro, uscito in Italia circa dieci anni fa, assolutamente
attuale oltre che bello. Pensavo
a questo e mi venivano in mente le genti del Rojava –
soprattutto le donne - con quel loro meraviglioso progetto di
vita per cui – e non certo solo per difendersi –
vale la pena combattere. Sono state quelle donne a ricordarmi
un libro, uscito in Italia circa dieci anni fa, assolutamente
attuale oltre che bello.
Contro ogni buona regola che insegna come si facciano recensioni
ai libri freschi di stampa, è proprio di quello che voglio
parlare. Se per qualcuno sarà una rilettura, questo non
farà altro che confermare il valore dello scritto.
Sto parlando di Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, Milano,
2004, pp. 379, € 18,00) della scrittrice iraniana Azar
Nafisi, uscito per quelli di Adelphi nel 2003 e di cui ora si
trova anche l'edizione economica. Lo riapro a caso e trovo queste
parole sottolineate: “La migliore letteratura ci costringe
sempre a interrogarci su ciò che tenderemmo a dare per
scontato, e mette in discussione tradizioni e credenze che sembravano
incrollabili. Invitai i miei studenti a leggere i testi che
avrei loro assegnato soffermandosi sempre a riflettere sul modo
in cui li scombussolavano, li turbavano, li costringevano a
guardare il mondo, come fa Alice nel paese delle meraviglie,
con occhi diversi.”
È stata, per me, una lettura appassionante di un libro
appassionato, scritto bene, con partecipazione e sentimento,
un libro avvincente come fosse un romanzo e che romanzo non
è, perchè è storia vera. Storia personale
dell'autrice, iraniana e insegnante universitaria di Letteratura
Inglese a Teheran, in quella che divenne, ed è tuttora,
Repubblica Islamica dell'Iran.
Non è un romanzo ma parla di romanzi e della vita di
tutti quegli studenti che insieme alla loro insegnante condivisero
la passione per la letteratura rischiando sulla propria pelle,
in una realtà che arrivò a proibire l'insegnamento
della letteratura e a mettere al bando il libri.
“Il romanzo per sua stessa costituzione dà voce
a una molteplicità di punti di vista diversi, a volte
opposti, in un rapporto di dialogo e scambio reciproco, senza
che una voce distrugga o elimini l'altra. Esiste forse una sovversione
più pericolosa di questa democrazia delle voci?”
È un libro d'amore, amore per l'arte, la bellezza, la
libertà e la dignità degli esseri umani. Un libro
interessante da cui partire per riflettere sulla differenza
tra i luoghi dove la proibizione è violenta, plateale,
e il nostro, della capillare, occulta, persuasione quotidiana,
apparentemente senza proibizioni. In Leggere Lolita a Teheran
non si parla della libertà di scrivere ma della libertà
di leggere, di esprimere le proprie emozioni e reazioni a ciò
che si è letto, del diritto di immaginare e di realizzare
il tipo di vita che si desidera vivere. ”La ricerca
di conoscenza può diventare pericolosa, può stuzzicare
il nostro senso di ribellione, quel desiderio invincibile che
rovescia tutte le convenzioni e trasforma qualunque affermazione
in un punto interrogativo”. Perché, come ci
ricorda Nabokov, ”la curiosità è insubordinazione
allo stato puro”.
Il libro inizia col racconto di quando, essendole proibito l'insegnamento
all'università, l'autrice organizzò degli incontri
di studio settimanali, nel soggiorno di casa sua, per un gruppo
di studentesse. Di come leggere Lolita nella Teheran
degli ayatollah abbia dato un nuovo significato al libro, di
come la storia letteraria entrasse nella realtà di quelle
giovani donne costrette a nascondersi per studiare, di come
le parole di quello e altri libri divennero sostegno morale
negli anni di prigionia e soprusi che alcune di loro dovettero
subire per la colpa di essere donne intelligenti.
Dopo il romanzo di Nabokov: Il grande Gatsby di Scott
Fitzgerald, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, le
opere di Henri James... e tutti riprendono vita e attualità
attraverso le storie delle molteplici figure - soprattutto femminili
ma non solo - che parteciparono alle lezioni domestiche della
Nafisi. Realtà del romanzo e realtà della vita
si influenzano reciprocamente grazie al puro, sensuale e genuino
piacere di leggere, scoprendo i molteplici livelli di opere
che non si limitano a riflettere la realtà ma ne svelano
la verità. In nessuno di quei classici della letteratura
europea si critica o si fa riferimento alla repubblica islamica
eppure, per loro stessa costituzione, si trovano ad andare contro
l'essenza di tutte le mentalità totalitarie.
“E anche noi, come Lolita – ed era la cosa peggiore
di tutte – finivamo per sentirci in colpa, come fossimo
complici dei crimini che venivano commessi contro di noi. Il
semplice gesto di uscire di casa ogni giorno diventò
una bugia colpevole e complicata, perché significava
mettere il velo e trasformarsi così nell'immagine di
un'estranea, come lo Stato ci richiedeva. [...] Avevamo bisogno
di ricreare noi stesse. Per ricostruire la nostra identità
sequestrata e salvare la nostra integrità individuale,
dovevamo resistere all'oppressore usando le nostre risorse creative.
[...] La resistenza in Iran è arrivata a nutrirsi non
solo dei violenti scontri, non solo di proteste e rivendicazioni
politiche, ma anche del rifiuto di adeguarsi da parte dei singoli
individui, del rifiuto di essere trasformati in un prodotto
dell'immaginazione del regime”.
Risorse creative, rifiuto di adeguarsi, rifiuto di essere trasformati
in un prodotto immaginato da altri: l'attualità è
evidente, anche per noi.
Col suo libro la Nafisi non vuol certo dirci che la letteratura
basti a salvare dalla brutalità delle tirannie e nemmeno
dalla crudele banalità della vita, ci racconta di quelle
persone che quando si trovarono a dover sottostare alle peggiori
umiliazioni, quando si videro togliere quello che dava loro
valore e integrità, si aggrapparono istintivamente alle
creazioni dell'immaginazione, a ciò che si appella al
senso della bellezza, dell'armonia, della memoria, celebrando
quel che è umano, originale e unico.
Le ragazze di cui Azar Nafisi ci parla - alcune delle quali
dalle prigioni iraniane non sono più uscite - raccontano
proprio di questo, come prima di loro fecero grandi autori quali
Primo Levi e Osip Mandel'stam, e per loro studiare un autore
come Nabokov significò comprendere le verità che
si nascondono dietro affascinanti facciate. La verità
che dice come i mostri spesso siano abili e seducenti camuffatori,
uomini di Dio ad esempio, come i religiosi dell'Iran che uccidono
e torturano parlando di religione.
Leggere – e rileggere - Lolita a Teheran
è uno di quei gesti utili affinchè la possibilità
di cambiare si mantenga viva dentro ognuno di noi, attraverso
il mutare dei tempi e col passare degli anni, insieme a quello
spirito di libertà che esige il reciproco ascolto e la
consapevolezza che nulla di ciò che esiste è mai
assoluto e tutto ha sempre un'infinita possibilità di
mutamento, a cui noi possiamo contribuire grazie al potere sovversivo
dell'immaginazione.
Silvia Papi
|

