
Disabilità/
Il nuovo film di Silvano Agosti
Il cinema per voi è spettacolo,
per me è una visione del mondo,
il cinema è un atleta,
il cinema è portatore di idee,
il cinema svecchia la letteratura.
Ma il cinema è malato,
l'industria gli ha gettato
negli occhi una manciata d'oro.
Abili imprenditori,
con storie lagrimose
ingannano la gente...
Wladimir Majakovskij
Si tratta di un'opera che mi ha impegnato per circa due anni
per offrire una visione diversa del Disabile e soprattutto del
modo unico e raro adottato da Luigi Orazio Ferlauto, protagonista
del film, per togliere dalla segregazione delle cantine o di
locali appartati nei quali “parcheggiare” i soggetti
emarginati dalla cosiddetta “Normalità”.
Gli esseri umani sono tutti uguali ma è la loro diversità
che li rende unici e grandi.
Silvano Agosti
È uscito da pochi mesi Il fascino dell'impossibile
(2015, documentario), film che segna il ritorno al cinema di
Silvano Agosti, o meglio un ritorno al “suo” cinema.
Dico “suo” cinema perché prima di tutto il
film non è uscito nella moltitudine di sale italiane,
ma solamente in due: il cinema Azzuro degli Scipioni di Roma
e il Piccolo Cinema Paradiso di Brescia; ovvero nei due cinema
di Silvano Agosti. È già questo è un segnale
di come Agosti non rientri negli schemi dell'industria cinematografica.
“Suo” cinema soprattutto perché Silvano si
definisce Autore cinematografico (con la A maiuscola); si difenisce
autore di un cinema “indipendente”, nel vero senso
della parola, quindi indipendente non per necessità,
ma per un voler esser coscientemente sganciato dal denaro
e dal “sistema cinema”; si definisce inoltre autore
di un cinema “artigianale”, Agosti dice: “Io
sono tutta la mia troupe”; non c'è neppure il regista
in un certo senso, essendo anche il regista – secondo
Agosti – risultato di una scomposizione che è stata
fatta già agli albori del cinema, quando l'Autore è
stato scomposto nelle varie particine (sceneggiatore, direttore
della fotografia, direttore delle luci, del suono, del montaggio)
e con la figura del regista-gerarca a fare da collante, e a
doversi inserire in uno schema imposto dall'industria del cinema;
schema che è rimasto inalterato col passare del tempo
e delle “mode” cinematografiche.
Pensando al cinema di Agosti (e alla sua “teoria radicale”),
mi continua a venire alla mente il cinema anticonformista e
radicale di Guy Debord, che amo molto. Ad esempio, diceva Debord,
di come la plebe degli spettatori - che nel corso dei decenni
ha visto cambiare così tanto e sempre in peggio “il
pane che mangia e l'aria che respira” – venga rispettata
solo quando si tratta del cinema di cui ha l'abitudine.
E in effetti dall'istituzione dell'industria cinematografica
fino al “Quo Vado” di oggi, può variare di
volta in volta il risultato finale (ovvero la bontà del
prodotto-film), ma l'essenza del cinema è cambiata molto
molto poco (solita trama, soliti ruoli, soliti schemi, soliti
trucchetti).
Se ho voluto citare il film “Quo Vado” non è
per caso, ma in quanto film uscito a poca distanza (in termini
temporali) da “il fascino dell'impossibile”, e film
di cui si è parlato molto per via dello strepitoso incasso
che ha conseguito (oltre 7 milioni di euro); non c'è
bisogno di guardarlo per giudicarne il merito artistico o qualsiasi
altro merito, che non sia quello di portare a riflettere su
cosa è il cinema, o cosa potrebbe essere.
 Interpellato
da un fan che gli chiede un commento sul film “Quo Vado”,
Silvano Agosti dirà: “Responsabile del successo
di questo ragazzo col suo “Quo Vado” è soprattutto
il regime, lui, l'autore del film, vive l'innocenza di chi non
sa o coltiva la lieve colpa di chi non ha da sempre alcun interesse
a sapere”. Interpellato
da un fan che gli chiede un commento sul film “Quo Vado”,
Silvano Agosti dirà: “Responsabile del successo
di questo ragazzo col suo “Quo Vado” è soprattutto
il regime, lui, l'autore del film, vive l'innocenza di chi non
sa o coltiva la lieve colpa di chi non ha da sempre alcun interesse
a sapere”.
In fondo il vero autore del film “Quo Vado” è
quello che Agosti chiama il regime e che invece Debord aveva
chiamato “società dello spettacolo” (”è
una società, e non una tecnica, che ha reso il cinema
così com'è” dice molto chiaramente Debord).
Non solo “Quo vado” è film del regime, perché
come tutta la produzione industriale, anche la produzione di
film è variegata e volta ad attirare a sé ogni
tipo di consumatore; non solo quando si tratta di commedie.
Per questo si puo generalizzare dicendo che tutti i film dell'industria-cinema
sono prodotti del regime, per usare sempre il termine di Agosti.
E infatti lo stesso Agosti (che nei suoi cinema proietta, oltre
ai propri film, anche tanti “capolavori” del cinema,
tra cui “Il sale della terra” di Wim Wenders, tanto
bello secondo Agosti che verrà proiettato nel suo cinema
per sempre), ammette di non riuscire ad individuare più
di 7-8 film all'anno meritori di esser proietatti, tra le migliaia
di film che in tutto il mondo vengono prodotti ogni anno.
Cosa sono questi film? Debord, riferendosi ai film di fiction
con cui generalmente viene identificato il cinema, lo ha ben
detto: un film “è l'imitazione insensata di una
vita insensata, una rappresentazione ingegnosa per non dire
nulla; abile ad ingannare la noia per un'ora con il riflesso
della stessa noia”.
Il documentario è una sorta di sottogenere, una categoria
minore del cinema, proprio perché mal si adatta al sistema-cinema
inteso come industria e come strumento ideologico; il genere
“documentario” è anche una “gabbia”
dove l'industria del cinema include e rinchiude tutto ciò
che sfugge a quello che “deve” essere il cinema
nella società dello spettacolo. E Agosti sceglie, o così
gli è capitato, di tornare al cinema con un documentario
- seppur anomalo così come lo sono altre sue opere non
di fiction (”Matti da slegare”, “D'amore si
vive”). Come in un “vero documentario” non
c'è una trama, non ci sono attori, e c'è un soggetto,
però “Il fascino dell'impossibile” ha elementi
che non appartengono al documentario, soprattutto l'essere un
film “anti-spettacolare”. Intendo con questo: Agosti
riesce a non fare spettacolo, ancora similmente a Debord, preferisce
usare a suo modo la tecnica del cinema anziché aggiungere
uno spettacolo di più al cumulo di immagini prodotte
da una società. Questo a rischio (o “pagandone
il prezzo”) di realizzare un film che non arriva al “grande
pubblico”. Agosti dice che un Autore può e deve
essere innanzi tutto un poeta, nel senso etimologico di “colui
che fa” (poiesis). Quindi anche ne “Il fascino
dell'impossibile”, Agosti cerca di fare, ma fare
come poesia, non come spettacolo. [...]
Possono essere dette molte cose sul film, sui suoi protagonisti,
sul progetto dell'Oasi, sulle musiche di Ennio Morricone, su
come Agosti riesce a immortalare questo piccolo micro-mondo.
Mi limiterò a sottolineare solamente due cose. La prima
è un discorso sul ruolo. Silvano Agosti da tempo muove
una sua critica alla società di oggi, e una parte di
questa critica riguarda il tema del ruolo: “Oggi
ci sono politici, medici, ingegneri, pittori, imbianchini, operai
(ecc...) e non ci sono più essere umani”. Il protagonista
del film, Luigi Orazio Ferlauto, sarebbe (ed è) un prete,
ma nessuno se ne può accorgere; non perché venga
occultato un dato di fatto, ma semplicemente perché Ferlauto
passa per ciò che è: un essere umano. O almeno
così lo riesce a “rendere” Silvano Agosti,
essere umano al pari di tutti gli altri protagonisti disabili
e abili, pazienti e volontari, tutti equiparati, appaiono ugualmente
abili e ugualmente disabili nella “diversità che
li rende unici e grandi”.
L'altra cosa è invece questa: in un certo senso c'è
poco da dire sul film in sè, perché - e qui sta
il bello del film -, il vero film inizia quando si spegne il
grande schermo e si “ritorna” alla vita. E si torna
più ricchi, più stimolati, più umani. Si
spegne uno schermo e se ne accende un altro, o si “accende”
uno specchio per vedere se stessi. Lì dovrebbe iniziare
la sfida del fascino dell'impossibile, o meglio il fascino di
un impossibile che però ora sappiamo essere possibile.
Concludo riportando un estratto dal libricino di Silvano Agosti
intitolato “Come fare un film”; importante notare
come una riflessione di Agosti sul tema dell'utopia, nel cinema
ma anche nella vita, riflessione che ben si addice all'utopia
realizzabile e realizzata de “Il fascino dell'impossibile”,
film che “rappresenta la potenza del fare”:
“Per realizzare un'utopia creativa è essenziale
collegarsi all'utopia della libertà. L'utopia della riconquista
di tempi di vita nuovi, vasti quanto debbono essere i tempi
del sogno. Insomma liberiamo il cinema, e gli esseri umani,
da imposizioni e ritmi che sono industriali e riconduciamo la
vitalità sia del cinema che dell'essere umano, a ritmi
naturali, quindi creativi. Così l'utopia si celebra nell'evidenza
di un'umanità finalmente in grado di creare e di vivere.
E il cinema, specchio innalzato di fronte alla natura, rifletterà
finalmente il mistero dell'essere, nella sua interezza e profondità”.
A questa concezione “utopica” del cinema sembra
corrispondere “Il fascino dell'impossibile”, messaggio
di vita e amore gettato in un mare di mediocrità. [...]
Michele Salsi
Carlo Cafiero/
Alle origini del socialismo
Su “A” ci siamo già occupati della biografia
di Carlo Cafiero scritta da Pier Carlo Masini pubblicando, in
concomitanza con l'uscita della prima edizione del volume, un'intervista
all'autore (“A” 30, giugno-luglio 1974) oltre a
una recensione della seconda edizione pubblicata dalle edizioni
BFS (“A” 392, ottobre 2014).
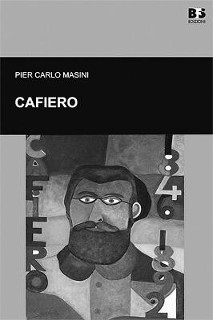
Perché pubblicare, a cura di Franco Bertolucci e di Furio
Lippi, per le Edizioni della Biblioteca Franco Serantini, una
nuova edizione della biografia di Carlo Cafiero, scritta da
Per Carlo Masini (Cafiero, BFS, Pisa, 2014, pp. 280,
€ 20,00) e perché proporne la lettura?
Certamente perché la biografia risulta essere stata aggiornata
dall'autore, rispetto alla prima edizione del 1974, pressoché
introvabile. Ovviamente non soltanto per questo, sebbene, nel
panorama editoriale della bibliografia sull'anarchismo si sentisse,
per conoscere la sua figura e la sua opera, la mancanza della
unica biografia di Cafiero.
Prima dell'odierna edizione e non avendo a disposizione la precedente
edizione, chiunque si avvicinasse alla vasta letteratura sull'anarchismo
ottocentesco in Italia, avrebbe potuto documentarsi su Cafiero
dalla “Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta”
e dalla “Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli
attentati”, entrambi testi di Pier Carlo Masini, oppure
da “Carlo Cafiero nella storia del primo socialismo italiano”
di Franco Damiani e da “Carlo Cafiero” di Gianni
Bosio, riferimenti bibliografici che non sono la biografia,
ma che sono comunque essenziali per collocare Cafiero nella
sua epoca.
Un altro motivo della riedizione potrebbe essere porre a disposizione
del lettore una componente fondamentale, quale la vita e l'opera
di Cafiero è stata, dell'affresco, alla cui realizzazione
Masini ha dedicato con dedizione la sua vita di storico, costituito
dall'azione internazionalistica antiautoritaria in Italia e
dal socialismo libertario. Perciò suggerire con questa
riedizione un ulteriore approfondimento, attraverso la copiosa
produzione storiografica di P. C. Masini, di un'epoca storica
posta alle origini del socialismo in Italia, alla quale riferirsi
idealmente, nella vita di ogni giorno, per i temi di giustizia,
di uguaglianza e di solidarietà umana, dai quali era
caratterizzata.
Un altro motivo ce lo dice Franco Bertolucci quando, nella postfazione
del libro dedicata a Pier Carlo Masini, gli studi su Cafiero
e la Prima Internazionale, che è uno studio dettagliato
e completo per comprendere la genesi della biografia ed il ruolo
che svolse Gianni Bosio negli studi su Cafiero, scrive il suo
motivo: “Leggere e studiare l'affascinante e sofferta
vicenda biografica di Carlo Cafiero, qui raccontata magistralmente,
è utile non solo per comprendere la storia originale
della diffusione in Italia del primo socialismo, in particolare
di quello di matrice antiautoritaria, ma anche per capire il
suo autore e il suo metodo di studio. Masini, infatti, iniziò
a pensare e scrivere quest'opera ben 25 anni prima della sua
pubblicazione, e la sua preparazione lo ha accompagnato per
buona parte della sua vita: fino a poco prima della scomparsa
aveva lavorato a una nuova edizione, rivista e aggiornata, e
che ora viene alla luce.”
Che nella biografia di Cafiero vi sia la storia del primo socialismo
italiano, nato nel e dal Risorgimento, e che, in quanto socialismo
antiautoritario, si definì prendendo le distanze dal
mazzinianesimo e dal garibaldinismo, grazie e soprattutto all'
acuta produzione teorica di Cafiero, Franco Bertolucci lo ha
ribadito recentemente. In occasione della presentazione del
libro, che ha tenuto il 24 ottobre del 2015, presso lo Spazio
19 Luglio a Roma, nell'ambito delle iniziative del Gruppo Cafiero
della Fai. Il Risorgimento fu il terreno dal quale nacque come
movimento del tutto popolare il movimento anarchico in Italia,
grazie alla predicazione di Bakunin ed alla sua traduzione,
nella realtà italiana, da parte di Cafiero prima e di
Malatesta successivamente.
Nell'ambito di questo movimento corale Cafiero svolse la sua
azione sfolgorante e prodigiosa per elaborazione intellettuale,
passione, devozione e sacrificio, come meglio non potrebbe essere
narrato da come lo è in questo libro.
Cafiero, va sicuramente letto, attraverso l'interpretazione
umanamente partecipe di Masini, per quanto di generoso e di
nobile, il “figlio del sole” seppe infondere nella
lotta per il socialismo. Ma è evidente che le tesi dell'ultimo
Cafiero della cosidetta rivoluzione per manipoli sparsi, velleitarie
oltre che dannose e nocive, come Malatesta ebbe modo di rilevare,
come tutta l'impostazione insurrezionale di Cafiero e di Malatesta
e del primo Costa, appartengono alla storia dell'anarchismo.
Queste e quella non hanno più senso attuale, come argomentato
più volte in modo convincente su questa rivista da Andrea
Papi e come rappresentato dalla visione di un anarchismo pluralista,
del quale la rivista è interprete.
Enrico Calandri
Flavio Costantini/
L'impossibilità di evadere dalla storia
Diciamo che devo sentire la nostalgia di qualcosa di irrimediabilmente
perduto. Il presente, l'attimo che sto vivendo mi lascia sbalordito.
Devo lasciar correre il tempo per goderne o soffrirne e, in
definitiva, prenderne possesso.
Flavio Costantini
 Uscito
a fine 2015 dalla penna di Roberto Farina, il libro che presentiamo
(Flavio Costantini, L'anarchia, molto cordialmente, Milieu
edizioni, Milano, 2015, pp. 240, € 18,90) apre con un episodio
analogo a quello sopracitato: il ricordo dell'autore della propria
passione infantile per le immagini di un libro illustrato, “Io
e gli altri”, andato perso per un capriccio durante le
vacanze, che riaffiorò poi per caso in un peregrinare
adolescenziale, quando ritrovò il libro perduto nelle
vetrine di una libreria, scoprendo così che quei ritratti
che tanto affascinavano la sua innocente curiosità di
bambino fossero in realtà personaggi del calibro di Sacco
e Vanzetti; l'illustratore di quegli occhi buoni era il signor
Costantini. Uscito
a fine 2015 dalla penna di Roberto Farina, il libro che presentiamo
(Flavio Costantini, L'anarchia, molto cordialmente, Milieu
edizioni, Milano, 2015, pp. 240, € 18,90) apre con un episodio
analogo a quello sopracitato: il ricordo dell'autore della propria
passione infantile per le immagini di un libro illustrato, “Io
e gli altri”, andato perso per un capriccio durante le
vacanze, che riaffiorò poi per caso in un peregrinare
adolescenziale, quando ritrovò il libro perduto nelle
vetrine di una libreria, scoprendo così che quei ritratti
che tanto affascinavano la sua innocente curiosità di
bambino fossero in realtà personaggi del calibro di Sacco
e Vanzetti; l'illustratore di quegli occhi buoni era il signor
Costantini.
Seppur “molto cordialmente”, grazie alle splendide
opere che ha lasciato, Flavio Costantini è un personaggio
quanto meno controverso nel panorama libertario. Se da un lato
è riuscito, con i suoi quadri dedicati agli anarchici,
agli operai, agli ultimi, con le sue copertine per le pubblicazioni
delle edizioni di Stuart Christie a lasciare un segno nell'immaginario
artistico contemporaneo e a dar volto e dignità a personaggi
scomodi nella storia ufficiale, dall'altro si è reso
impopolare nell'ultima parte del suo operato, quando iniziò
manifestare un'insofferenza e presa di distanza dalle idee anarchiche
con dichiarazioni quasi provocatorie e spiazzanti, rinnegando
la possibilità di un mondo diverso e allontanandosi sempre
più da quello che lo circondava. “Non credo più
nell'utopia. Solo gli ottusi non cambiano mai idea” si
legge già nelle prime pagine.
Roberto Farina però ha il potere di introdurci gradualmente,
in questo scritto, nel sederci faccia a faccia con l'artista,
ormai ottantenne, a conoscerlo personalmente attraverso dieci
anni di dialoghi a più voci, con chi lo conobbe e lo
frequentò mentre nel contempo si dipanano le storie di
personaggi di un secolo prima, che prendono forma nelle opere
artistiche di un uomo che ha apparentemente abbandonato l' ideale
di libertà a cui si era così fervidamente ispirato
a favore di considerazioni ciniche, disilluse e spassionate
che lo rendono, almeno alla lettura, comunque interessante pur
nelle ideologiche contraddizioni. Affascinato sin da giovane
dalla sua arte e forse dai segni del destino, Farina decise
di intraprendere una ricerca sul pittore, all'epoca ancora in
vita, ma subito si scontrò con la riservatezza e l'elusività
dell'artista, che viveva appartato e irraggiungibile a Zoagli,
vicino a Rapallo.
La caparbietà di Roberto nel ricercare un incontro con
questo personaggio così noto eppure così dimesso
darà luogo a molteplici colloqui e una relazione profonda,
forse grazie anche al fatto che l'autore stette subito simpatico
a Gip, il Welsh Terrier di Flavio Costantini, la prima volta
che andò a trovarlo, chissà; fatto sta che i due
finirono per stringere un rapporto di dialogica complicità,
filo conduttore che accompagna la lettura di un viaggio articolato
nel tempo e nello spazio; un viaggio fatto di immagini e storie,
quelle dei quadri e dei personaggi lì raffigurati da
un lato e, contemporaneamente, quelle dei due interlocutori
che si confrontano sul mondo, seduti tra i ricordi nella casa
del pittore, come in una stanza di specchi dove ogni immagine
riflette una storia indipendente eppur connessa con le altre.
[...]
Costantini spesso mentre si racconta riesuma libri, manifesti,
almanacchi, film dell'orrore, stampe e tavole con cui omaggia
sempre le visite del suo discreto interlocutore a cui dedica,
per togliersi dall'imbarazzo di non saper cosa scrivere, un
“molto cordialmente” a mo' di dedica e alcuni stralci
del suo vissuto e della sua arte, che al lettore giungono dalla
rielaborazione e ricostruzione storica di Farina, il quale restituisce
un'agiografia di personaggi che si susseguono immortalati nelle
opere di Costantini, in una carrellata di biografie che irrompono
nella biografia principale.
Uno scenario di rivolte, regicidi, rapine e prigioni si intervalla
con aneddoti della vita quotidiana, oscillando continuamente
tra presente e passato, procedendo per titoli incalzanti, a
volte quasi a commento di ciò che sta per raccontare,
a volte come macchine del tempo in grado di far piombare il
lettore dalla mansarda-laboratorio di Zoagli dritto nella folla
che attende l'esecuzione di Ferrer, o di Sante Caserio, immortalata
sulla tela. Il volume edito da Milieu edizioni, casa editrice
indipendente che già nella scelta della propria identità
nominale indica la volontà di ricerca all'interno di
micro ambienti, luoghi, substrati di culture così unici
e interessanti nelle proprie esperienze artistiche o esistenziali
riesce a renderci proprio questo.
|
| Flavio Costantini, La fucilazione di Ferrer, serigrafia |
La generosa appendice in quadricromia ci regala un'ampia panoramica
delle sue opere, che stimola una lettura interattiva tra corpus
del testo e immagini, in cui il lettore si trova a navigare
con continui rimandi. Tra narrazione e rappresentazione visiva
il volume ricrea l'ambiente dell'artista e al contempo i milieu
dei personaggi protagonisti delle opere, in un susseguirsi di
capitoli rapidi che rendono l'esegesi delle diverse sfaccettature
della storia nella storia, in uno spazio spezzattato, ambienti
disarticolati, e mostrati simultaneamente sotto ogni angolazione.
[...]
Nei suoi quadri nessun punto di fuga, perché la sua arte
è una visione raggelata, che rende la scena reale e surreale
al contempo, dove i volti diventano maschere impassibili, testimoni
di un' epoca che li vorrebbe ridurre a cose, ma che Costantini
innalza a ritratto morale. La serie completa dei soggetti dedicati
alla storia e ai protagonisti del movimento anarchico tra fine
Ottocento e primo Novecento include una sessantina di dipinti
realizzati a tempera e consente all'autore di riesumare una
galleria di rivoluzionari di professione, elevati alla statura
di eroi tragici, simboli di una rivolta ora evoluta, ora brutale,
ma sempre libertaria, soffermandosi sui loro volti che ci fissano
impassibili mentre il mondo intorno a loro raggiunge il punto
di ebollizione. Come nelle icone sacre, l'imperturbabilità
dei volti diventa la chiave per accedere alle passioni dell'uomo.
Si tratta di un vero e proprio ciclo di opere che inizia nel
1963 e termina nel 1979. “Ravachol, Jacob, Lucetti, Bresci..
sono colti pittoricamente sul fatto. Nessuno spazio al dubbio:
sono proprio loro i colpevoli, eppure la narrazione della vicenda
non li condanna.” Asserisce Luciano Caprile a commento
dei quadri riprodotti. In questi anni Costantini si dedica a
un'intensa ricostruzione storica degli eventi, acquisendo da
tutto il mondo molta pubblicistica dedicata, incontrando alcuni
degli ultimi testimoni ancora in vita e recandosi spesso di
persona a fotografare i luoghi degli avvenimenti.
La ricerca dell'artista ha prodotto un'importante biblioteca
tematica e un ampio apparato di documenti, tra cui fotografie,
appunti e ricostruzioni derivate dalla stampa periodica dell'epoca.
Un contesto di studi strettamente connesso alla realizzazione
di ogni singola opera che rappresenta quindi il punto finale
di un approfondimento storico e iconografico compiuto. Leonardo
Sciascia commenta magistralmente questo ciclo di personaggi:
“l'anarchico rappresentato nel gesto micidiale, quello
in cui si assommava la propria vita e la propria morte: piccolo,
sparuto, commiserevole -in piccolezza sproporzionato all'avvenimento
tragico che col suo gesto creava. Patetico, fino a sfiorare
il comico, irrompeva da intruso in quelli che Macchiavelli chiama
i luoghi alti. I luoghi alti della tragedia: e la rigenerava”.
Nella ricerca di Costantini, dagli anni Ottanta in poi, l'impossibilità
di evadere dalla storia e dalle sue conseguenze coinvolge i
carnefici come le vittime, o è il risultato della semplice
casualità degli eventi. Una condizione sostanzialmente
assurda e permeata di un progressivo scetticismo nella “salvazione”
politica e personale che l'artista esprime nella serie di opere
dedicate all'uccisione dei Romanov come in quelle sul disastro
del transatlantico Titanic. Unica possibilità di sopravvivenza,
l'espressione artistica in tutte le sue forme: Costantini, sempre
dagli anni Ottanta in poi, realizza una serie di ritratti -
a tempera e collage - di scrittori e poeti, ritornando così
all'origine della sua ispirazione, la letteratura. Uno dei suoi
ultimi temi di ricerca sono stati alcuni eventi e protagonisti
della Rivoluzione francese. Bello il commiato finale tra Farina
e l'artista, sempre denso di racconto quasi pittorico e variegato
di memorie personali. Conclude il testo un'analisi di Stuart
Christie, datata 1975, in cui forse va colto lo spirito che
mosse il pittore, senza soffermarsi troppo alle amare considerazioni
disilluse; gli eventi che Costantini raffigurò sono episodi
di una lunga odissea verso la libertà, in cui purtroppo
spesso per combattere la repressione, la miseria e le ingiustizie
sociali perpetrate dallo Stato le lotte accorsero alla violenza.
Ed è proprio sugli eventi di questa lotta contro l'oppressione
che si sofferma lo sguardo di Flavio Costantini.
Gaia Raimondi
Il germe pericoloso
della diserzione
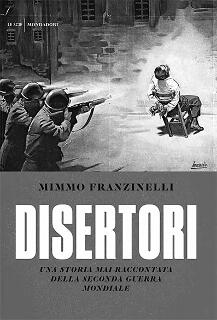 Nella
sovracoperta del nuovo libro di Mimmo Franzinelli (Disertori.
Una storia mai raccontata della Seconda guerra mondiale,
Mondadori, Milano, 2016, pp. 390, € 22,00) c'è un
cupo disegno di Gino Boccasile (1944) che illustra la fucilazione
alla schiena di un “traditore sabotatore”. È
un modo scioccante, ma efficace, per introdurre i vecchi temi
delle ribellioni anti-belliciste. E allora: “Bentornati
fantasmi della diserzione!” direbbe Wu Ming 1. Nella
sovracoperta del nuovo libro di Mimmo Franzinelli (Disertori.
Una storia mai raccontata della Seconda guerra mondiale,
Mondadori, Milano, 2016, pp. 390, € 22,00) c'è un
cupo disegno di Gino Boccasile (1944) che illustra la fucilazione
alla schiena di un “traditore sabotatore”. È
un modo scioccante, ma efficace, per introdurre i vecchi temi
delle ribellioni anti-belliciste. E allora: “Bentornati
fantasmi della diserzione!” direbbe Wu Ming 1.
Se riguardo alla giustizia militare nella grande guerra gli
studi e la saggistica si sono fatti ultimamente più densi
e circostanziati, dopo un secolo o quasi di mordacchia, ancora
in massima parte insondato rimane invece il medesimo tema riferito
al secondo conflitto mondiale. Del resto, trattandosi di contesti
e modalità belliche assai differenti, tutto cambia anche
nel sistema repressivo militare. Alla codardia, indisciplina
e sbandamento, derivati spesso da comportamenti refrattari contingenti
e improvvisati della truppa o dei singoli militari, tipici reati
da prima linea di fuoco, si sostituiscono piuttosto “mancanze”
connaturate più alla modernità della nuova guerra
come la diserzione in presenza del nemico, l'insubordinazione
accompagnata a vie di fatto, il supposto tradimento della patria,
il vilipendio sovversivo, il disfattismo e la guerriglia. È
questa la resistenza alle imposizioni della nuova guerra totale,
guerra senza trincee, rapida e di manovra, condotta con spirito
cinico dai vertici delle forze belligeranti perfino contro le
inermi e innocenti popolazioni civili (vittime predestinate
di stupri, rapine, saccheggio, devastazioni e internamenti).
Il conflitto del 1939-1945, presentatosi sul proscenio mondiale
come epica partita risolutiva tra fascismi e democrazie –
vulgata e semplificazione propagandistica che accomunò,
ricordiamolo, Churchill e Stalin – ha lasciato ai sopravvissuti
ed ai posteri tracce di memoria “ufficiale” e pubbliche
narrazioni spesso sovrastate dal discorso ideologico. La guerra,
puro esercizio della tirannia degli Stati (almeno nella visuale
libertaria) e grande evento tragico nella memoria collettiva
delle nazioni, si è così convertita o in intimo
e recondito vissuto esperienziale soggettivo o in avulso tema
canonico per la storiografia politica e militare. Relegati nell'indifferenza,
ricondotti nel limbo dell'irrilevante, i comportamenti ribelli,
anomali e controcorrente, sono rimasti talvolta sottotraccia:
paure e vergogne dell'indicibile. E, anche fuori dall'ufficialità,
la rimozione ha riguardato tutta la sfera emozionale e dei sentimenti,
comprese le ferite mai risarcite e i dolori incommensurabili
per i lutti, le distruzioni e le ingiustizie patite da milioni
di esseri umani, ma soprattutto da ciascuno di essi. Paura,
odio, violenza, Shoah, campi di concentramento e di sterminio,
eccidi di popolazioni civili, bombardamenti indiscriminati,
bomba atomica: la barbarie degli anni Quaranta ha marcato indelebilmente
un secolo (il cosiddetto “secolo delle masse”) e,
a seguire, le generazioni del secondo Novecento.
Nella gamma vasta delle possibili contro-storie “mai raccontate”,
anomale e controcorrente, ci sono senza ombra di dubbio le diserzioni.
Franzinelli, storico di successo, ci squaderna un repertorio
di facile lettura e di grande impatto, ricerca rigorosa e coinvolgente
condotta sulla base dei documenti reperiti presso l'Archivio
storico dello Stato maggiore dell'Esercito, compulsando le carte
dei Tribunali di guerra, i diari inediti e ascoltando preziose
testimonianze di parenti.
Il libro si apre con due fotografie belle di giovani innamorati,
Cosimo e Violetta; la didascalia ci riporta alla cruda realtà
di un sogno interrotto: “L'artigliere Cosimo Ricchiuti,
disertore in Croazia per antifascismo e per amore di Violetta,
figlia di un comandante partigiano iugoslavo. Viene fucilato
dalle Camicie nere il 4 agosto 1943”.
Nel collage, triste e avvincente, delle tante storie di vita
che si incrociano nel volume si possono riconoscere vicende
“qualunque” di persone “qualsiasi”:
c'è il vissuto familiare di ciascuno di noi, ci sono,
come tipologia, quei racconti di guerra che abbiamo ascoltato
direttamente dalla viva voce dei testimoni e dei protagonisti
quando eravamo ancora bambini. È davvero questa l'altra
memoria della nazione. E ci siamo tutti.
Accorgersi di combattere dalla parte sbagliata e buttare l'odiata
divisa, opporsi alle prepotenze del militarismo sempre e comunque.
Una sorta di genealogia della ribellione attraversa gli ultimi
due secoli, prima e dopo la seconda guerra mondiale e tutti
ci coinvolge: dalla renitenza alla leva dei nostri avi contadini
e dalle disobbedienze sanzionate dagli inflessibili tribunali
militari del 1915-1918 fino all'età contemporanea e ai
giorni nostri. Si pensi ad esempio al fenomeno degli obiettori
di coscienza di qualche decennio fa (obiettore è stato,
ad esempio, l'autore di questo libro!) o magari alla semplice
militanza nei “Proletari in divisa” durante il servizio
di leva (è il caso del recensore). Chi scrive queste
brevi note ricorda anche, con grande commozione, un proprio
familiare – Giovanni Sacchetti, classe 1911 – partito
come caporale di fanteria della divisione “Firenze”
operante sul fronte greco-albanese e finito, dopo l'8 settembre
1943, come partigiano combattente nella brigata “Gramsci”
attiva in Albania. Scelta di paura e di coraggio fatta, seguendo
l'istinto, insieme a tantissimi altri commilitoni: per questioni
di principio e non di mero opportunismo, per non essere più
complici degli oppressori, per un generoso spirito di sacrificio
che non si basava certo su possibili speranze di ricompense
(che, fra l'altro, non ci saranno mai).
Il libro, coinvolgente e ben strutturato sul piano narrativo,
analizza il fenomeno seguendo una scansione temporale e una
sequenza di scenari che sembra cinematografica. Le motivazioni
dei disertori, insieme alle dinamiche repressive, emergono in
maniera nitida. L'autore, seguendo i percorsi esistenziali di
persone comuni, li contestualizza con grande efficacia rappresentativa:
dai prodromi della “non belligeranza” al “caleidoscopio
balcanico”; dalla tragica campagna di Russia all'Africa
e all'Albania; sotto la dittatura militare di Badoglio, nel
Regno del Sud oppure nella Repubblica Sociale Italiana. In appendice
ci sono poi molti documenti da consultare, e c'è anche
un “epilogo” dedicato al dopoguerra: perché
“La guerra non termina a fine aprile 1945, per i disertori.
Quando le armi tacciono, scatta la caccia ai fuggiaschi dal
Regio esercito...” (p. 295).
Già alla caduta del fascismo, nell'estate 1943, con il
precipitare della situazione militare e le sconfitte sui vari
fronti, i tribunali militari avevano continuato ad essere utilizzati
per la difesa dell'ordine pubblico e per reprimere i reati di
sedizione, abbandono del servizio o del posto di lavoro, violazione
di ordinanze.
Colpisce, ad esempio, la lugubre vicenda della “fucilazione
arbitraria” in Calabria di cinque disertori mandati a
morte dopo l'armistizio, puniti fuori tempo massimo! Sì
perché la persecuzione degli ex-disertori non avrà
mai fine e non conoscerà confini. Anche nella repubblica
democratica la magistratura militare continuerà, per
decenni, a inquisire i ribelli della seconda guerra mondiale,
persino rinchiudendoli in manicomio! Il libro evoca, oltre ai
ricordi familiari di ciascuno di noi, anche la storie parallele
misconosciute ancora da raccontare, come ad esempio quelle dei
centomila tedeschi antinazisti che disertarono (alcuni unendosi
anche ai partigiani), un fenomeno questo non trascurabile e
ancora da soppesare nel suo complesso.
Nel film “Gott Mit Uns” di Giuliano Montaldo il
generale Snow (interpretato dall'attore Michael Goodliffe),
rivolgendosi ad un ufficiale subalterno che si dimostra turbato
per l'imminente fucilazione di due soldati che hanno disertato,
argomenta: “...quello che noi rappresentiamo, alla divisa,
non ci pensi? [...] dove credi si nasconda il vero nemico per
noi? Nel contagio dell'indisciplina, figliolo, che genera odio
per la divisa, l'odio per tutte le divise. È necessario
stroncarlo subito, questo germe pericoloso...”.
Giorgio Sacchetti
Operaismo italiano
e mito del partito
 Suppongo
che i compagni di “A” Rivista anarchica mi abbiano
proposto la recensione del libro Elogio della militanza -
Note su soggettività e composizione di classe (di
Gigi Roggero, Derive Approdi, Roma, 2016, pp. 208, € 13,00).
in considerazione del mio interesse, che data non da oggi, per
la cosiddetta Scuola della composizione di classe, conosciuta
anche come operaismo italiano, e cioè quell'area politico-intellettuale
che prende le mosse da alcune interessanti riviste degli anni
Sessanta, in particolare Quaderni Rossi e Classe operaia, e
che ha avuto una rilevante influenza sia su gruppi della sinistra
extraparlamentare degli anni settanta, in primo luogo Potere
Operaio ma anche Lotta Continua, e, più avanti, su quella
che venne definita area dell'Autonomia. Effettivamente il libro
di Gigi Roggero è, almeno per me, l'occasione di riprendere
vecchie questioni, vecchie ma sicuramente non prive di interesse
anche perché furono sollevate nel fuoco dello sviluppo
delle lotte operaie e di ampi settori della società che
allora si svilupparono. Suppongo
che i compagni di “A” Rivista anarchica mi abbiano
proposto la recensione del libro Elogio della militanza -
Note su soggettività e composizione di classe (di
Gigi Roggero, Derive Approdi, Roma, 2016, pp. 208, € 13,00).
in considerazione del mio interesse, che data non da oggi, per
la cosiddetta Scuola della composizione di classe, conosciuta
anche come operaismo italiano, e cioè quell'area politico-intellettuale
che prende le mosse da alcune interessanti riviste degli anni
Sessanta, in particolare Quaderni Rossi e Classe operaia, e
che ha avuto una rilevante influenza sia su gruppi della sinistra
extraparlamentare degli anni settanta, in primo luogo Potere
Operaio ma anche Lotta Continua, e, più avanti, su quella
che venne definita area dell'Autonomia. Effettivamente il libro
di Gigi Roggero è, almeno per me, l'occasione di riprendere
vecchie questioni, vecchie ma sicuramente non prive di interesse
anche perché furono sollevate nel fuoco dello sviluppo
delle lotte operaie e di ampi settori della società che
allora si svilupparono.
In realtà il testo di Roggero si colloca esplicitamente
in una delle possibili linee di sviluppo dell'operaismo italiano
e cioè a quella che fa riferimento all'opera di Mario
Tronti, un importante intellettuale del Partito Comunista Italiano,
alle cui tesi hanno continuato a fare riferimento per decenni
anche intellettuali “estremisti” come Toni Negri
che anche recentemente, nella sua monumentale autobiografia,
ricorda come abbia praticamente imposto ad una serie di gruppi
intellettuali stranieri la traduzione di “Operai e Capitale”
dello stesso Mario Tronti. Si tratta di comprendere, credo,
qual è l'obiettivo polemico del testo e quali obiettivi
si ponga a partire dal proprio dichiararsi un testo militante.
Il primo ed evidente bersaglio di Mario Tronti e dei trontiani
è quella che argutamente Roggero definisce la patristica
e che nel linguaggio che allora usava la corrente trontiana
veniva chiamato terzinternazionalismo.
Mario Tronti, Toni Negri e gli altri trontiani compiono un'operazione
per alcuni versi classica per altri scandalosa: utilizzare Marx
contro il marxismo e Lenin contro il leninismo per produrre
una nuova teoria politica e una nuova forma di militanza pur
rivendicando un legame forte con i fondatori della ditta.
Ma che cos'è esattamente la patristica, o il terzointernazionalismo,
che dir si voglia?
Molto sinteticamente è una grande narrazione basata su
una divisione rigorosa fra classe operaia e coscienza di classe,
fra lotta economica e lotta politica, fra sindacato e partito
le cui radici si possono rinvenire nell'opera allora famosa
di Karl Kautsky alla quale si ispirò esplicitamente Lenin
nella stesura dell'articolo “Tre fonti e tre parti integranti
del marxismo”, una narrazione che valorizzava il ruolo
degli intellettuali dirigenti dei partiti socialdemocratici
dei quali gli stessi partiti comunisti non furono, a ben, vedere
che una derivazione in aree economicamente meno sviluppate rispetto
all'Europa occidentale e agli USA.
Gli operaisti di scuola trontiana, negli anni Sessanta individuano,
la secca separazione fra lotta di classe effettivamente esistente
e movimento operaio istituzionale, fra comportamenti operai
e ideologie della sinistra, comuniste o socialiste che fossero,
e si schierano in maniera secca dalla parte della “rude
razza pagana” nel suo carattere rigorosamente anti ideologico.
Non vi è però in loro un opporre la spontaneità
all'organizzazione, cosa che li avrebbe condotti a posizioni
di tipo consiliare luxemburghiano o anarchico, al contrario
riaffermano con forza la necessità di una direzione forte
del conflitto e parleranno, casomai, di spontaneità organizzata.
Il partito di tipo nuovo che propongono quindi è un partito
che sa stare dentro lo scontro di classe, che ne sa cogliere
le tendenze, che sa anticipare le mosse di parte capitalista
e lo stesso livello medio del conflitto, che sia insomma una
direzione all'altezza della violenza dello scontro sociale che
in particolare allora si andava disegnando.
Ma vi è nel trontismo qualche cosa di più, qualche
cosa che secondo i marxisti e leninisti ortodossi lo pone fuori
dal marxismo e dal leninismo, l'idea che lo stesso sviluppo
del capitalismo sia determinato dalla forza e dall'iniziativa
della classe operaia, che in questa stessa iniziativa vi sia
la strategia dell'azione rivoluzionaria mentre al partito viene
riservata la tattica. Schematizzando al massimo si potrebbe
dire che l'impianto classico del marxismo-leninismo non viene
contestato in radice né tanto meno superato ma paradossalmente
rovesciato e riaffermato come neoleninismo.
Ciò che singolarmente infatti manca in tutta quest'elaborazione
è la definizione della natura storico-sociale del partito,
che nel suo sparire come struttura, come forma, come apparato,
riappare come un'intelligenza capace di plasmare e trasformare
la stessa realtà storica, proprio perché liberata
dalla pesantezza della tradizionale organizzazione di partito.
Un'idea a modo suo affascinante, che ricorda la famosa frase
di Mario Tronti, quella che sintetizza efficacemente tutto il
trontismo: “..il partito è lo sguardo di Lenin
che dalla finestra dell'Iskra osserva il marciapiede antistante”.
Il partito insomma come demiurgo, se non proprio come divinità.
Per concludere una proposta indubbiamente affascinante, una
proposta che va, la cosa è evidente, in una direzione
radicalmente che nulla ha a che vedere con quella dell'autorganizzazione
dei lavoratori così come l'ha intesa ed elaborata la
tradizione libertaria. Per Gigi Roggero infatti l'autonomia
della classe si esprime essenzialmente come mera negazione dell'esistente,
non a caso cita spesso la classica formula trontiana per cui
alla classe è assegnata la lotta, al capitale lo sviluppo,
disegnando in fondo una sorta di estetica del conflitto di classe
che, oltre a fondare la stessa classe operaia, sembra destinato
ad esistere per l'eternità sia pure in forme continuamente
nuove.
Ora, non si tratta, a mio avviso, di negare chiesasticamente
la possibile congruenza della tesi, ma di ammettere che, se
la si assume, si arriva in una forma diversa alla medesima apologia
del capitalismo che caratterizza il tanto disprezzato marxismo-leninismo,
visto che qualunque sia la forza motrice dello sviluppo sempre
di capitalismo si tratta. Se invece ipotizziamo che in forma
contraddittoria, ma non delirante-desiderante, il proletariato
possa, non debba, come ci insegna l'Internazionale quando afferma
“l'emancipazione dei lavoratori sarà opera dei
lavoratori stessi. O non sarà..” possa non semplicemente
premere sulle classi dominanti in una sorta di infinito pingpong
ma, negando se stesso, negare l'ordine dominante. E negare se
stesso da un punto di vista rivoluzionario significa espropriare
gli espropriatori ed assumere il controllo della produzione.
Tertium non datur.
È interessante rilevare peraltro come nella figura del
militante disegnato da Roggero, vi è una suggestiva somiglianza
con quanto ha elaborato la tradizione bakuniniana e, sulla strada
aperta da Bakunin, quella sindacalista d'azione diretta, ma
anche, sebbene in forme diverse, quella malatestiana, dell'individuazione
delle minoranze agenti come prodotto e produttrici di contraddizioni,
come rete di soggetti che praticano quotidianamente il conflitto
sui luoghi di lavoro e nella società, come organizzazione
reale più che formale della rivolta.
Ed è forse in questa somiglianza che si possono trovare
le ragioni del fatto che nel corso degli anni Settanta l'area
dell'autonomia abbia visto l'agire assieme, il confrontarsi,
e perché negarlo?, lo scontrarsi fra culture politiche
per altri versi apparentemente incompatibili, quella libertaria,
quella consiliare, quella luxemburghiana, quella operaista non
trontiana che affondava le sue radici in una rivista come “Quaderni
Rossi” ma non nel gruppo trontiano di “Classe operaia”
che ne sortisce, e quella negriana di “Rosso” e
scalzoniana di “Senza tregua” ed altre fra cui persino
gruppi maoisti.
Per provvisoriamente, credo, concludere, in tempi assolutamente
diversi da quelli che videro la breve estate del trontismo le
questioni che Gigi Roggero pone restano di un rilevante interesse
anche per dei rivoluzionari e possono fornire chiavi di lettura
per la valutazione dello stato del conflitto sociale oggi e
delle prospettive di un progetto sovversivo.
Cosimo Scarinzi
Animali/
Un'eterna Treblinka
Auschwitz inizia ogni volta che qualcuno guarda
a un mattatoio e pensa: sono soltanto animali.
Theodor W. Adorno
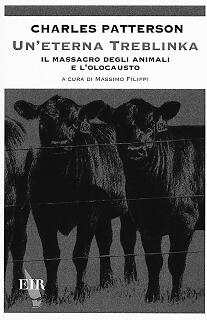 Il
titolo dato a questo libro può sembrare una provocazione.
Un'immagine azzardata per scuotere la nostra immaginazione un
po' assopita e renderci più attenti rispetto al modo
in cui vengono trattati soprattutto gli animali “da reddito”
e quelli usati per la “ricerca scientifica”. Non
è così. Niente provocazioni. Si tratta invece
di un'analisi lucida, anche dal punto di vista storico, condotta
con metodo, che indaga, pone a confronto e trae le debite conclusioni
rispetto alla vita, quando non viene più riconosciuta
come tale in uno o più soggetti che, di conseguenza,
divengono oggetti e come tali utilizzabili per molteplici scopi
e interessi. Il
titolo dato a questo libro può sembrare una provocazione.
Un'immagine azzardata per scuotere la nostra immaginazione un
po' assopita e renderci più attenti rispetto al modo
in cui vengono trattati soprattutto gli animali “da reddito”
e quelli usati per la “ricerca scientifica”. Non
è così. Niente provocazioni. Si tratta invece
di un'analisi lucida, anche dal punto di vista storico, condotta
con metodo, che indaga, pone a confronto e trae le debite conclusioni
rispetto alla vita, quando non viene più riconosciuta
come tale in uno o più soggetti che, di conseguenza,
divengono oggetti e come tali utilizzabili per molteplici scopi
e interessi.
Analisi sostenuta e avvalorata, nella seconda parte del testo,
da racconti personali di ebrei - sopravvissuti o comunque coinvolti,
per storie familiari, nella Shoah - che hanno preso posizione
rispetto allo sterminio animale.
Paragonare lo sterminio degli animali nei mattatoi alla Shoah
viene spesso considerato scandaloso e lo scandalo è
ciò di cui non si deve parlare o perché così
evidente che non merita aggiunta di parole o perché talmente
fuori luogo che è più giusto lasciar perdere,
precisa Massimo Filippi nella prefazione al testo, mentre per
capire se del confronto tra Olocausto e condizione animale sia
possibile parlare è necessario arrestare le risposte
immediate, causate dall'indignazione umanitaria, e provare a
comprendere che cosa questo confronto mette in gioco. Questo
è ciò che efficacemente viene fatto da Charles
Patterson in Un'eterna Treblinka – Il massacro degli
animali e l'olocausto, (editore Eir, Roma, 2015, pp. 321,
€ 16,00). È bene stabilire una cosa - chiara per
tutti – e cioè che le molteplici differenze biologiche
del mondo animale sono di grado e non di genere. Non esiste
una caratteristica biologica capace di separare in maniera netta
e definitiva un gruppo di individui di una specie da un altro;
il che in parole semplici significa che gli umani altro non
sono che altri animali e quindi “ciò che dovrebbe
provocare orrore è che, costantemente e indipendentemente
dalla specie di appartenenza, il vivente venga smembrato, che
la carne viva sia trasformata in carne da macello [...] smembramento
che certamente non ha risparmiato e non risparmia gli animali
umani”. E, a ben guardare, lo smembramento si estende
- dico io – in tutti quei luoghi dove il corpo vivente
della terra viene trivellato, disboscato, cosparso di sostanze
tossiche sempre per lo stesso identico motivo economico.
Tornando al libro direi che non è semplice cercare di
riassumere tutte le sfaccettature che vengono analizzate e attraverso
le quali Patterson mostra i mille volti dello sfruttamento.
Dall'inizio della schiavitù umana nelle prime civiltà
mesopotamiche che andò di pari passo con l'addomesticamento
animale, attraverso il passare dei secoli e l'evolversi delle
culture, con la connivenza delle religioni e il colonialismo
quale premessa al nazismo: “L'etica della dominazione
umana che promosse e giustificò lo sfruttamento degli
animali rese legittima l'oppressione di quegli esseri umani
ritenuti più vicini alla condizione animale [...] Gli
europei consideravano il colonialismo la naturale estensione
della supremazia umana sul regno animale, dato che sembrava
chiaro che la razza bianca aveva dimostrato la propria superiorità
sulle razze inferiori tenendole sotto il proprio dominio, esattamente
come la specie umana aveva dimostrato la propria superiorità
sugli altri animali dominandoli e soggiogandoli.”
Quindi l'analisi storica dell'oppressione e dello sfruttamento
- animale e umano - partono da lontano e arrivano all'Ottocento
per comprendere, a quel punto, anche la nascita dell'industria
e l'innovazione costituita dalla catena di s-montaggio. Fu proprio
Henry Ford a rivelare, nella sua autobiografia, che l'idea della
catena di montaggio gli venne in mente quando visitò
un mattatoio. In quei luoghi, il processo che solleva gli animali
su catene e li spinge, di stazione in stazione, fino all'ultima
tappa della riduzione in “tagli di carne”, introduce
un elemento nuovo per la moderna civiltà industriale,
vale a dire la neutralizzazione dell'atto di uccidere, con un
grado di distacco fino ad allora sconosciuto.
Il XX secolo dimostrerà tristemente che da lì
allo sterminio di massa organizzato dalla Germania nazista non
c'è che un piccolo passo perché le due cose non
sono poi così diverse: “Nei centri di uccisione
rapidità ed efficienza sono elementi essenziali per il
buon esito dell'operazione” e “riducendo la necessità
di pensare e di prendere decisioni, la meccanizzazione del massacro
diminuisce la possibilità che chi vi partecipa riconosca
la dimensione morale delle azioni che esegue”, così
“una volta che un manzo è salito sulla rampa, il
suo destino è segnato” e così anche “quando
erano nel cosiddetto tunnel, che portava dalle baracche al campo
di sterminio, per loro non c'era più scampo”.
Ho provato vergogna leggendo questo libro, vergogna per la specie
a cui appartengo. Sentimento forse non inutile ma che comunque
serve a poco quando rimane fine a se stesso. Invece mi è
sembrata interessante la domanda che, sempre nella prefazione,
pone Filippi, vale a dire se pensare politicamente non inizi
proprio da qui. Da questo punto zero.
C'è verità nel dire che il punto a cui siamo giunti
nella nostra storia di specie è lo zero. Proseguire sempre
nella stessa direzione, come sembra intenzionata a fare una
gran parte dell'umanità, significa scendere al di sotto
dello zero e quindi innescare un processo di non ritorno. Partire
da zero, invece, come punto da cui non si può prescindere,
con cui non si può non fare i conti - non rendersi conto
- per il pensiero e la prassi di coloro che si muovono onestamente
in direzione della liberazione o, meglio, delle liberazioni,
mi sembra importante. Così come è certamente importante
non fare di ogni erba un fascio, vedere le diversità
di fenomeni che rimangono ugualmente gravi e, quindi,
è importante riuscire a stare in ciò che disturba
- ci disturba – e osservare la realtà che abbiamo
non solo di fronte.
Assumersi la responsabilità delle cose significa anche
smettere di fare finta che le stesse non accadano e provare
a porvi rimedio. C'è una brutta tendenza insita in noi
esseri umani ed è quella di banalizzare, alzare le spalle,
girare lo sguardo, per questione di comodità, perché
scegliere costa impegno e fatica quotidiana. Dico così
perché questo atteggiamento è latente in me, mi
coinvolge in prima persona, sebbene io non sia né meglio
né peggio di tanti altri, ma soprattutto lo dico perché
è con questa umana debolezza che va ed è sempre
andato a nozze il lato più oscuro della violenza del
potere. Mi viene in mente Hannah Arendt e penso che ci potrebbe
essere utile tornare a riflettere (e tornarci spesso, a vari
livelli, perché non è mai abbastanza) sulla questione
di come il male possa proprio non essere un fatto radicale,
ma anche semplicemente la mancanza di radici e di memoria, che
consista fondamentalmente nel non avere quel dialogo interiore
che permette non certo di essere perfetti, ma di poter pensare
se stessi (essere due in uno), rivedersi, ritornare sulle proprie
azioni e quindi poter compiere delle scelte morali. E' una questione
di grande attualità ed è l'argomento che, in maniera
sottesa, secondo me attraversa tutto il libro di Patterson.
A suo tempo la Arendt fu molto esplicita nel dire come persone
spesso banali si trasformino in terribili persecutori e come
fu proprio questa banalità a rendere, nella Germania
nazista, quasi un intero popolo, se non del tutto almeno in
gran parte, complice dei più terribili fatti della storia,
senza il minimo senso critico e quindi senza sentirsene responsabile.
Quello che sta accadendo oggi, esattamente in questo momento,
in Europa, in America e non solo, è lo stesso - ma in
misura enormemente più estesa in quantità - di
quello che accadde nei campi di sterminio voluti dalla follia
nazista, ma come ebbe a dire Adorno, sono soltanto animali..
Animali da reddito.
Silvia Papi
Faber/
Un antidoto alla religione
Non penso di essere eretico se considero De
André il mio Quinto Evangelo.
Don Andrea Gallo
 Il
celebre prete di strada Don Andrea Gallo, concittadino e carissimo
amico di Fabrizio De André, si è spinto a dichiarare
che Faber, soprannome del cantautore, è stato come un
evangelista, portatore di una profonda coscienza e capace di
rendere tutti consapevoli della propria energia vitale, umana,
rivoluzionaria. Il
celebre prete di strada Don Andrea Gallo, concittadino e carissimo
amico di Fabrizio De André, si è spinto a dichiarare
che Faber, soprannome del cantautore, è stato come un
evangelista, portatore di una profonda coscienza e capace di
rendere tutti consapevoli della propria energia vitale, umana,
rivoluzionaria.
Il cantautore e poeta Fabrizio De André è considerato
il Bob Dylan italiano, per la straordinaria capacità
di spaziare con audacia e lirismo su temi eterni e universali,
tra cui quello religioso, senza per questo essere ingabbiato
nell'alveo di una confessione religiosa e nemmeno definito predicatore
o eletto ad ateo devoto ante litteram. Don Andrea Gallo,
dopo il concilio Vaticano II, arriva a dire a Fabrizio De André,
con ammirazione dichiarata: “Tu sei tra i giovani Teologi
della Liberazione”.
Il volume di Brunetto Salvarani La Bibbia di De André
(Claudiana editrice, Torino, 2015, pp. 100, € 9,50) si
pone l'obiettivo di individuare, a più riprese, le tracce
bibliche che affiorano nella produzione deandreiana, soffermandosi,
dapprima, sinteticamente, sulla vita corsara e anarchica di
Faber e i suoi temi sociali, attraverso una ricostruzione biografica
sapientemente amalgamata e intrecciata con scelte artistiche
ben precise, ossia controcorrente, “in direzione ostinata
e contraria”.
Di seguito, il libro pone e propone attente riflessioni sulle
canzoni maggiormente impregnate di domande sulla religione e
sulla scrittura.
L'ultimo capitolo si concentra sull'episodio discografico più
rilevante del poeta genovese, a proposito di tema religioso,
il long playing “La Buona Novella” del 1970,
un'autentica pietra d'angolo o miliare, che dir si voglia, non
solo sul piano musicale, ma anche su quello del costume del
nostro Paese e della società.
L'autore Brunetto Salvarani, in una delle tante note bibliografiche,
ringrazia, per i consigli e l'incoraggiamento, l'amico Odoardo
Semellini, detto Odo, compagno di innumerevoli scorribande sui
sentieri della musica pop, deandreiano raffinato e di lungo
corso.
La personalità artistica di Fabrizio De André
si sposa bene con l'ispirazione che gli deriva dal cantautore
francese prediletto Georges Brassens, per l'influenza di quel
dichiarato e anarchico individualismo libertario. Faber avvicina
le storie musicate di Brassens alle vicende dei carrugi genovesi,
fra prostitute, gente di malavita e emarginati di ogni sorta.
Brassens per De André era “un modello nitido, rappresentava
il superamento dei valori piccolo-borghesi”. Così
il poeta genovese, nonostante le ottime possibilità finanziarie,
intreccia le personali esperienze esistenziali e storie di vita
con un'esplorazione sempre più intensa dei vicoli di
Genova e della vita grama degli ultimi, degli emarginati, dei
diversi, dei quali ammirava soprattutto la solidarietà
corporativa e la profonda umanità.
L'album di Fabrizio De André, “La Buona Novella”
del 1970, è un felice antidoto al clima religioso e subculturale
attuale del nostro Paese e alla voga dell'ateismo devoto, ossia
di coloro che si dichiarano solo pubblicamente cattolici e genericamente
cristiani, ma che poi, nella morale privata, adottano ben altri
stili di comportamento. Il contesto culturale dell'album “La
Buona Novella” si collega con la stagione della contestazione.
In quel periodo il rapporto tra la Chiesa cattolica romana e
le istanze dell'epoca moderna stava giungendo a un punto di
svolta cruciale: si era da poco concluso il Concilio Vaticano
II, in cui la Chiesa manifesta il tentativo di venire a patti
con la modernità e con i problemi sociali.
Il 1970, anno di uscita del disco, è quello successivo
alla strage di Piazza Fontana, all'omicidio Pinelli, con le
grandi manifestazioni studentesche, i sit-in dei movimenti pacifisti
e la crescente avversione per la guerra in Vietnam. Un periodo
dominato dalla cosiddetta “strategia della tensione”,
con una lunga serie di attentati terroristici e una progressiva
dismissione di quegli alti ideali di trasformazione politica
del Paese che avevano contrassegnato gli anni Sessanta.
“La Buona Novella” è un'allegoria, oltre
ogni canone, anacronistica, ma non separata dalla storia, fuori
sincrono rispetto alle proposte più impegnate e militanti,
e troppo riflessiva e intellettuale per gli amanti delle canzonette
sanremesi. Questo album si trova a incrociare un bisogno di
spiritualità che le chiese cristiane ufficiali faticano
a intercettare. Un disco anacronistico perché, anche
se composto in pieno clima sessantottino e nel pieno della contestazione
e rivolta studentesca, parlava degli insegnamenti di Gesù:
abolizione delle classi sociali, fine dell'autoritarismo, creazione
di un sistema egualitario.
Il brano “Il Testamento di Tito” fu composto sul
declinare degli anni Sessanta, quando nel nostro Paese non si
argomentava ancora di pluralismo religioso.
Dunque non è forzato ammettere che Fabrizio De André
si è rivelato addirittura profetico, perché ha
colto, in netto anticipo, quella dimensione di pluralizzazione
di riferimenti religiosi, che, in seguito, è diventata
uno dei tratti caratteristici della nostra società, come,
per esempio, il fenomeno migratorio che coinvolge attualmente
gli scenari urbani italiani.
Ormai nel 18° anno dalla sua scomparsa, la figura di Fabrizio
De André continua a suscitare un'innumerevole e felice
fioritura di iniziative, tanto da far pensare che il cantautore
genovese sia riuscito a intercettare e a compensare un immenso
vuoto di senso e a colmare un innato bisogno di poesia e una
profonda e umana necessità di legami sociali, solidali,
comunitari, derivata da una crisi non solo economica e politica,
ma anche strutturale, nella perdita di senso e significato di
valori autentici e non piccolo-borghesi e benpensanti.
Laura Tussi
Quel pugile sinto,
eliminato dai nazisti
All'inizio dell'anno sono usciti in libreria, a distanza
di un giorno, due libri, due romanzi che ripercorrono la vita
di Johann Rukeli Trollmann, un pugile zingaro, sinto, tedesco,
che dal ring dette non poco filo da torcere al nazismo. Finì
deportato e poi ucciso nel lager di Nevengamme, vicino ad Amburgoa
Pubblichiamo qui una recensione di ciascun libro. Claudia
Piccinelli si occupa di Razza di zingaro, di Dario
Fo. Nicoletta Vallorani, a sua volta, di Alla fine di
ogni cosa di Mauro Garofalo.
Sempre di Johann Rukeli Trollmann si è occupato, in
“A” 382 (estate 2013) Giorgio Bezzecchi (“Il
pugile zingaro che sfidò il Terzo Reich”) recensendo
il volume di Roger Repplinger Buttati giù, zingaro
(edizione Upre Roma, Milano, 2013, pp. 292, €
12,00).

1/ Il
linguaggio e le tavole di Dario Fo, dalla parte dei sinti
 Si
apre con “Allenamento in palestra” la prima pagina
del libro Razza di zingaro di Dario Fo (Chiarelettere,
Milano 2016, pp. 160, € 16,90), storia vera di Johann Trollmann,
detto Rukeli, sinto tedesco campione di boxe. Altre dieci tavole
dell'artista illustrano la storia del pugile, che si vedrà
negato il titolo di campione dei pesi medio-massimi perché
indegno di rappresentare la Germania ai giochi olimpici. Verrà
fagocitato dalla spietata macchina nazista. Si
apre con “Allenamento in palestra” la prima pagina
del libro Razza di zingaro di Dario Fo (Chiarelettere,
Milano 2016, pp. 160, € 16,90), storia vera di Johann Trollmann,
detto Rukeli, sinto tedesco campione di boxe. Altre dieci tavole
dell'artista illustrano la storia del pugile, che si vedrà
negato il titolo di campione dei pesi medio-massimi perché
indegno di rappresentare la Germania ai giochi olimpici. Verrà
fagocitato dalla spietata macchina nazista.
La narrazione di Dario Fo ha l'andamento di una fiaba zingara.
Nell' avvincente affabulazione, si avverte la musicalità
del linguaggio parlato, fedele alla cultura orale del popolo
zingaro.
Nella tavola “Il pugile danzante” è dipinto
il talento di Rukeli, Albero, in lingua romaní: albero
maestoso, forte e agile, flessuoso, per questo capace di resistere,
mai piegato dal vento.
Johann, bambino musico, suona il violoncello. Sogna di fare
il pugile. A otto anni, si rivela un caso di talento unito all'intelligenza.
Verrà addestrato nella boxe come nella doma dei cavalli:
niente carezze, niente zucchero. A quattordici, mostra già
di avere stoffa. A ventuno, campione dei pesi medi della Germania
nordoccidentale, ma a suo carico una denuncia per aggressione.
Un equivoco. Scartato in realtà perché non ritenuto
degno di rappresentare la Germania ai giochi olimpici di Amsterdam.
Nel 1932, a Berlino nel parco del Saalbaus Friedrichshain, davanti
a millecinquecento spettatori mette fuori combattimento Walter
Sabbotke.
Anni Trenta: lo sport deve forgiare la razza pura del popolo
tedesco.
1933: anno della parabola con discesa repentina, per il pugile
sinto. A soli due mesi dal giuramento come cancelliere del Reich,
e dopo l'incendio del Reichstag, il palazzo del parlamento,
Hitler decide di eliminare da ogni manifestazione pubblica comunisti,
anarchici, ebrei, ritenuti a torto i responsabili. Fine della
carriera del pugile ebreo Erich Seelig. Johann di Hannover lo
sostituisce nella gara per il campionato dei pesi medi, contro
Hans Seifried di Bachum. E Johann: “Ha tutta l'aria di
essere una beffa: uno zingaro che sostituisce un ebreo. Evidentemente
è un avviso: ora tocca a voi, fra poco toccherà
a noi”. L'incontro non sarà valido per il titolo
di campione.
Altra possibilità negata a Johann di Hannover, in un
incontro truccato, per il titolo di campione tedesco dei medio-massimi.
Georg Radamm, presidente della federazione pugilistica, ossequioso
alle indicazioni e criteri dati da Hitler nel Mein Kampf
per lo sport prediletto dal Führer, definirà Johann
animale da circo, non un pugile. Il titolo è reso libero.
Solo nel 2003, la Germania riconoscerà il valore e l'autenticità
di questa storia consegnando alla famiglia Trollmann la corona
di campione dei pesi medio-massimi negata a Johann.
Luglio, l'ultimo incontro decisivo: “devi combattere da
tedesco o sei fuori”. Con la caricatura da ariano, capelli
tinti di biondo, corpo imbiancato di borotalco, Rukeli, 71,8
kg, si presenta sul ring. La maschera tragica, battuta da Gustav
Eder, 66,2 Kg, va al tappeto in una nuvola di borotalco.
|
| Dario Fo - “Allenamento in palestra” |
Hannover, primavera del 1934. Per guadagnarsi da vivere partecipa
a incontri di pugilato da luna park. Sarà depennato dalla
lista dei membri della federazione pugilistica tedesca. Fine
definitiva della carriera. Abbandonato anche da Ernst Zirzow,
il manager col cravattino. Futuro direttore dello sport di Berlino,
allestirà grandi manifestazioni per l'organizzazione
nazista “Forza attraverso la gioia”.
Rukeli si improvviserà cameriere alla Kreuzklappe
e Olga aspetta una figlia. Fa la domestica, ricama per una casa
di moda, cuce i vestitini con stoffe a fiori per le nipotine.
Dopo una settimana dalla nascita, il matrimonio all' ufficio
del comune. Ma dovranno divorziare, perché in seguito
alle persecuzioni naziste, iniziate nel 1936 con il censimento
completo di tutti i sinti e i rom della Germania, sarebbero
state arrestate per prime le donne che avessero contratto matrimonio
con uno zingaro. Storia di atavica discriminazione ed esclusione,
inscritta negli eventi della grande storia. Dal segnale dell'ultimo
rifiuto di ottenere la nazionalità ed essere accettati
come cittadini tedeschi, alle “disposizioni per la deportazione”
a Dachau, in Baviera, dei primi 400 zingari, nel 1936. E in
occasione dei giochi olimpici di Berlino, l'istituzione dello
Zigeunerlager di Marzahn, a est della città. Zingari
schedati, sottoposti a torture, esperimenti, sterilizzazione
legalizzata, condizione per diventare individui liberi, e internati
nei campi di lavoro insieme a ebrei, zingari di sangue misto
e renitenti al lavoro.
|
| Dario
Fo - “Evviva, abbiamo un pugile, speriamo
diventi
un campione” |
Con l'inizio della guerra, Johann verrà assegnato alla
trentunesima divisione di fanteria, in seguito mandato a combattere
sul fronte della Loira. “Ci disprezzano, noi sinti, perché
siamo di una razza diversa, ma poi quando servono uomini per
rafforzare l'esercito diventiamo subito indispensabili. Come
sempre, gli unici che ci guadagnano sono i costruttori di cannoni”.
Allo stesso modo, gli zingari con un contratto di lavoro sono
indispensabili per l'economia del Reich. Come il fratello Lolo,
addetto alla ferrovia del Reich, oppure il padre Wilhelm, suonatore
di violino, in passato anche ombrellaio per la polizia fluviale.
Oppure il fratello Carlo, mastro minatore. Mentre ora Johann
è al lavoro obbligatorio: spalatore di carbone a Hainholz.
16 dicembre 1942, il decreto Auschwitz equipara sinti e rom
agli ebrei. Nel 1943, deportazione ad Auschwitz di tutta la
famiglia Trollman. Rukeli viene riconosciuto come pugile, gli
assegnano un lavoro da giardiniere, meno pesante: le sue energie
devono essere risparmiate per allenare uomini delle SS.
Ma lo porteranno al massacro. Uno del comitato clandestino dei
prigionieri: “Tenete conto che tutti i sinti del campo
lo ammirano. Se lo ammazzano, il morale e la resistenza di tutti
si abbattono. Johann deve essere salvato”.
Con uno scambio di persona, viene trasportato nel lager di Neuengamme,
nel nord della Germania. Un nuovo numero, 9841, gli permette
di passare in un altro campo vicino, Wittenberg. Lo chiameranno
a sfidare il kapò Emil Cornelius. Per allietare gli ospiti,
l'esibizione in un incontro di boxe sul piazzale dell'appello,
delimitato come un ring.
Johann vs Cornelius. Il kapò viene battuto. Cornelius,
per vendicarsi, massacrerà Rukeli con un bastone.
Dalla ricerca rigorosa e ben documentata di Paolo Cagna Ninchi,
Dario Fo offre un grande contributo alla divulgazione di questa
tragica vicenda umana e collettiva, inserita in uno degli stermini
dimenticati, il Porrajmos: persecuzione e annientamento di più
di 500mila tra rom e sinti nei campi di sterminio, durante la
Seconda guerra mondiale. Ma lo scrittore tratteggia in filigrana
anche tradizioni e cultura del popolo sinto.
La grande famiglia allargata, solidale, sempre pronta a mobilitarsi
in carovana, e dedita allo spettacolo viaggiante. Sono circensi
i cugini della madre di Rukeli. Il fratello del nonno campa
suonando il violino ai funerali come a una festa. Oppure sono
allevatori. Lo zio insegnerà cura e rispetto per il cavallo,
animale sacro, capace di tradurre il suono delle parole, motivo
ispiratore della tavola “Dialogo col cavallo sapiente”.
|
| Dario
Fo - “Il pugile danzante” |
Lo sguardo sensibile e profondo di Fo conferisce un'impronta
particolare alle figure femminili che animano la narrazione.
L'attitudine all'ascolto e al confronto delle diversità
di Margarete. Giovane ricercatrice per le cure dei malati mentali
verrà considerata tra i nemici del programma di sterminio
nazista dei disabili, denominato “eutanasia”, e
costretta a riparare in Camargue.
La madre, guaritora, con la sua autorità ferma e indiscutibile.
Johann dirà: “finora il solo padre che ho avuto
è mia madre”. Le sorelle, ricamatrici, merlettaie,
con le sciarpe di seta da vendere al mercato del mese di Wunstorf,
vero sostentamento per la famiglia. La moglie Olga, cosacca,
capace di resistere e colonna di sostegno per Johann.
La storia unica di Rukeli credo fornisca un'ulteriore opportunità:
gettare uno sguardo anche sulle attuali discriminazioni e radicati
pregiudizi, che ammantano la popolazione sinta dedita allo spettacolo
viaggiante. Circensi, giostrai - mestieri tramandati da lontane
generazioni di origini indoeuropee - da sempre vengono definiti
in modo spregiativo “zingari”, “girovaghi”.
Una presenza documentata in centro Europa e nella Penisola italiana
fin dagli inizi del Quattrocento.
La peculiarità dello spettacolo viaggiante costringe
al nomadismo per raggiungere le piazze nei piccoli e medi centri
urbani o alle periferie delle città, nelle ricorrenze
di feste, sagre o per allestire uno chapiteau. Il rituale dei
cavilli burocratici e, spesso, il rifiuto delle amministrazioni
alle concessioni delle aree, in molti casi senza comprovate
motivazioni, rappresentano una consolidata normalità
affrontata nel più totale isolamento.
Storie quotidiane di tanti Rukeli invisibili, da portare alla
luce. Come da acuto osservatore da sempre Dario Fo ha saputo
disvelare.
Per la sua penna ironica e sferzante, l'attenzione alla storiografia
non ufficiale, la satira sociale e politica - tra le altre opere
Morte accidentale di un anarchico sul caso Pinelli -
un meritato riconoscimento dal premio Nobel per la letteratura
nel 1997, con la seguente motivazione: “perché,
seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il
potere restituendo la dignità agli oppressi.”
Claudia Piccinelli
2/ Scegliere.
Anche quando l'unica scelta è la morte
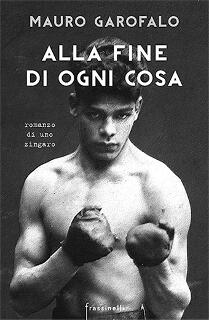 “Un
equilibrista sul filo incerto dell'esistenza”. Per Mauro
Garofalo, autore di Alla fine di ogni cosa (Frassinelli
edizioni, Segrate - Mi, 2016, pp. 264, € 18,50), Johann
Rukeli Trollmann è soprattutto questo: un equilibrista
in bilico sui tempi difficili del Porrajmos. Nella ricostruzione
narrativa della vicenda del pugile zingaro che vinse il titolo
di campione per perderlo subito dopo per ragioni razziali, l'olocausto
dimenticato dei sinti e dei rom prende il passo e il respiro
di un pugile sul ring, lo spazio circoscritto e protetto, almeno
per un po', nel quale la divisione dello spazio che si manifesta
in ogni forma di repressione e controllo è un processo
più lento, seppure inesorabile. “Un
equilibrista sul filo incerto dell'esistenza”. Per Mauro
Garofalo, autore di Alla fine di ogni cosa (Frassinelli
edizioni, Segrate - Mi, 2016, pp. 264, € 18,50), Johann
Rukeli Trollmann è soprattutto questo: un equilibrista
in bilico sui tempi difficili del Porrajmos. Nella ricostruzione
narrativa della vicenda del pugile zingaro che vinse il titolo
di campione per perderlo subito dopo per ragioni razziali, l'olocausto
dimenticato dei sinti e dei rom prende il passo e il respiro
di un pugile sul ring, lo spazio circoscritto e protetto, almeno
per un po', nel quale la divisione dello spazio che si manifesta
in ogni forma di repressione e controllo è un processo
più lento, seppure inesorabile.
Occorre andare per ordine. La vicenda del pugile zingaro sarebbe
incomprensibile senza il recupero storico del Porrajmos.
L'olocausto dimenticato di sinti e rom viene di rado menzionato,
eppure non è diverso da quello più conosciuto
degli ebrei, quasi fosse un genocidio di importanza secondaria,
per quanto si edifichi anch'esso su base razziale, e poggi sullo
stesso inaccettabile fondamento che permette al regime nazista
di esercitare il diritto di uccidere.
Le tappe storiche coincidono. Si comincia in sordina con la
deportazione di circa 400 rom e sinti a Dachau, nel 1936. È
lo stesso anno in cui a Berlino si preparano le Olimpiadi. Ed
è esattamente questa preparazione che consente di ripulire
la città, relegando più di 500 rom e sinti a Marzahn,
luogo di segregazione ancora non formalizzato come tale eppure
perfettamente funzionante. L'apertura di campi di concentramento
ufficialmente definiti tali anticipa di poco il decreto che
sancisce la necessità di una “soluzione finale”
anche per la “questione zingara”. Dal 16 dicembre
1946, e dopo l'ordine di internamento e sterminio firmato da
Himmler, uccidere rom e sinti è legittimo, allo stesso
modo in cui lo è per gli ebrei. Complessivamente, il
genocidio all'interno del quale si collocano la vicenda esistenziale
e la morte di Johann Trollmann produce qualcosa come 500.000
vittime, ma fatica ad emergere come delitto, non figura nel
processo di Norimberga e non determina la punizione di chi aveva
di fatto innescato lo sterminio: il dottor Robert Ritter e la
sua assistente Eva Justin.
Entrambi compaiono fuggevolmente nel romanzo di Garofalo, ganci
con la storia per un testo che è – lo ribadisce
risolutamente l'autore anche nella sua nota conclusiva –
prima di tutto un romanzo, un'opera letteraria piuttosto che
un reportage. È una chiave importante, questa: “Ho
scritto tenendo a mente i nomi di tutti della generazione perduta
– scrive Garofalo. - Pesando ogni sillaba, cercando la
precisione più di ogni altra cosa”. Utilizzando
una sintassi deliberatamente singhiozzante – “personale,
misurata, pesata in ogni tasto” – Alla fine di
ogni cosa racconta una bella storia, forse non del tutto
dimenticata, ma di certo raccontata qui con un piglio da scrittore
maturo che in questa storia trova una sua voce precisa.
Per Garofalo, questa è la voce del suo personaggio, come
sua è la ricorrente ossessione del Tempo: una dimensione
maiuscola, molto insistita in tutto il romanzo, e che si stratifica
nel processo costruttivo della personalità di Rukeli
e nel farsi laborioso e poi bruscamente accelerato del “ragno
nero nel cuore della coscienza europea” (I. Sinclair).
Il Tempo si qualifica in modi diversi, frammentandosi in dimensioni
spesso coesistenti: il tempo di fare le cose, il tempo di restare,
il tempo di essere marito e padre, e infine il tempo giusto
per uscire di scena.
La storia è scandita senza sbavature, i fatti e il loro
resoconto si incasellano in 3 “round”, con un inizio
preciso - luglio del 1929 – in un luogo preciso –
la palestra dell'Associazione sportiva dei lavoratori BC Sparta
Linden, ad Hannover. L'incontro con Zirzow, gli allenamenti,
il trasferimento a Berlino, la progressiva convinzione che in
questa cosa della boxe si poteva credere sono forse la parte
più riuscita del romanzo. I combattimenti sono descritti
con la potenza visiva e la fluidità di chi conosce la
boxe non solo in teoria. Due scelte concettuali, in particolare,
emergono con chiarezza: la volontà di restituire la dinamica
dei combattimenti attraverso la musica del linguaggio, e l'aspirazione
a costruire una scrittura che “respira” col pugile.
Rukeli è bravo perché è veloce, perché
è mobile ma soprattutto perché è in grado
di vedere, di anticipare le mosse dell'avversario e dunque
di identificarne la debolezza. La tensione verso il “make
you see” conradiano è del tutto evidente, affiancata
a una sensibilità cinematografica che Garofalo possiede
per natura e per mestiere.
“Nel tempo, poi, il bianco e nero aveva lasciato il posto
ai colori. Duravano un niente, un millesimo di secondo appena.
Eppure, lì dentro, Johann guardava accadere ciò
che sarebbe stato.”
La storia collettiva si costruisce anch'essa con un ritmo misurato,
in piccoli scorci sempre molto documentati e appoggiati a una
quotidianità sempre più compressa, a partire dalla
prima menzione di Mein Kampf da parte di Amos, il sarto
ebreo di Rukeli, fino alla decapitazione, nel ‘34, di
Marius van der Lube, capro espiatorio per l'incendio del Reichstag.
Da quel punto in avanti, tutto precipita.
Simbolicamente, la caduta comincia, per Rukeli, con l'adempimento
transitorio del desiderio (la conquista del titolo, e la sensazione
che tutto sia compiuto, ora e per sempre) e la sua immediata
negazione (perché il combattimento non è stato
condotto secondo le regole della boxe ariana, il Faustkampf).
Rukeli è di fatto vittima di un processo storico: a partire
dal gennaio del '33, i club di pugilato vengono riorganizzati,
per ordine del nazionalsocialismo in modo da escludere progressivamente
tutti gli atleti non ariani. Molti fuggono, e Trollmann viene
incoraggiato a farlo: dalla sua donna, Olga; da Zirzow; dai
fatti che la storia gli disegna intorno. Sebbene si rifiuti
sempre di farlo, la convinzione che prende corpo in Rukeli è
la sensazione di “una vita passata a inseguire un sogno
che spettava ad altri. La sensazione di non meritare niente,
se non la propria esistenza senza patria. Senza padri”.
L'assenza del padre è fortissima in questo romanzo, di
per se stesso molto maschile (le figure femminili son poche,
spesso appena visibili sullo sfondo, e le figure di Olga e della
madre, sebbene molto caratterizzate, patiscono qualche compressione
e restano, agli occhi del lettore, inafferrabili, come forse
l'autore voleva che fossero). Ma i padri, appunto, sono figure
sostitutive di un'assenza. Rukeli se la cava da solo. Mette
in gioco il proprio corpo, proprio nel momento in cui quello
stesso corpo diventa infetto, inferiore, pericoloso e pertanto
legittimamente violabile
La questione nodale dell'olocausto sta nella riduzione del corpo
etnico a oggetto; questa reificazione consente di esercitare
il diritto di uccidere. Come scrive Michel Foucault, per mettere
a morte qualcuno, occorre definire le condizioni di accettabilità
di questo atto, trasformare l'altro in un intralcio genetico,
un ingombro da eliminare delegittimandone il diritto stesso
di stare al mondo. E l'espressione più estrema di potere
– scrive Achille Mbembe proprio a proposito dell'Olocausto
- consiste proprio nella capacità di decidere chi deve
vivere e chi deve morire. Nell'economia del biopotere, la funzione
del razzismo è quella di regolare la distribuzione della
morte e di rendere possibile la funzione omicida dello stato.
La degenerazione di questo processo prevede numerosi preliminari,
tutti ben visibili per Rukeli e per le persone che lo circondano.
Molti riescono ad andarsene, manifestando in alcuni casi anche
l'assoluta incomprensione per l'ostinata decisione di Trollmann
a restare. Dopo il combattimento-beffa contro Eder, e dopo aver
scelto da che parte stare, scappa anche il giornalista e amico
Marc Weil. Prima però è testimone attivo dell'ultima,
potente ribellione di Rukeli: costretto a combattere di nuovo
per il titolo, seguendo le regole del Faustkampf, contro
il pugile ariano Gustav Eder, Rukeli sceglie di rispondere alla
recita con un'altra recita, di straordinaria potenza:
“Rukeli aveva i capelli dipinti d'oro tirati indietro
e la pelle traslucida sotto i riflettori. Il pugile si era cosparso
di farina (...) Gli occhi neri di Rukeli. L'unica traccia
di umanità dell'angelo”.
La repressione e il controllo implicano, lo abbiamo detto, prima
di tutto una divisione dello spazio. Nel contesto del nazionalsocialismo,
il ring rimane per un po' un luogo circoscritto e protetto,
dove Rukeli può ancora consumare una possibile vittoria.
Il FaustKampf rappresenta l'invasione di questo spazio. Una
volta che esso sia stato profanato, Rukeli non può che
optare per un solo atto di libertà: far sì cioè
che la profanazione più scandalosa sia la sua, la recita
di una purezza ariana sovrapposto al corpo di uno zingaro.
La sconfitta di Rukeli chiude il Round 2 e segna l'inizio del
percorso verso la morte. Garofalo dedica tutto sommato poche
pagine ai momenti peggiori. È come se il Tempo –
quel tempo così importante nella storia – subisse
un'accelerazione improvvisa, soprattutto dopo il divorzio da
Olga e l'abbandono di ex-moglie e figlia. L'internamento avviene
a poche pagine dalla fine del romanzo. La servitù e la
morte vengono descritti con tratti lievi, quasi che si avesse
paura di ferire il campione più di quanto sia necessario.
Tutto rallenta e si riproduce nella tragica pantomima della
soluzione finale. Trollmann muore quasi per sbaglio, per mano
di un kapò che ha messo a tappeto quando l'hanno costretto
a indossare di nuovo il ruolo del pugile. Come nei combattimenti,
“vede” in anticipo quel che succederà. Oltrepassa
il mucchio di scarpe vuote ricordando il suo stesso viaggio.
Sceglie.
Che è poi questo il nodo centrale: sceglie anche quando
l'unica scelta possibile è la morte. E resta libero.
Nicoletta Vallorani
|

