
Storia (1870-1926)/
Sapessi com'è strano essere anarchici a Milano
Dal coacervo delle grandi correnti risorgimentali e operaiste
prende forma l'identità e l'antropologia degli anarchici.
Grande città con forti connotazioni borghesi, riformiste
e proletarie, socialmente e politicamente irrequieta, laboratorio
culturale a vocazione mitteleuropea, la Milano “sabauda”
dell'età liberale si conferma quale formidabile punto
di osservazione per raccontare l'Anarchia e i suoi protagonisti,
per farne rivivere miti, speranze e sogni rivoluzionari.
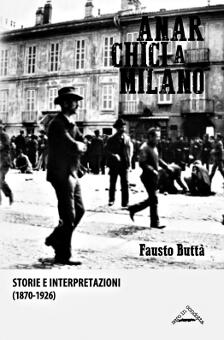 Fausto
Buttà, storico professionale e ricercatore all'università
del Western Australia, ha fino ad ora rivolto in prevalenza
la sua attenzione di studioso proprio alle vicende otto-novecentesche
dell'anarchismo milanese (Anarchici a Milano (1870-1926)
storie e interpretazioni, Zero in Condotta, Milano 2016,
pp. 368 + ill., € 20,00). Questa è infatti la sua
seconda importante monografia (che segue Living Like Nomads,
edita nel 2015 e dedicata al medesimo argomento). Nel nuovo
libro l'autore, da vero specialista, ha saputo ben focalizzare,
all'interno di un impianto narrativo convincente, non solo le
“storie” ma, almeno in qualche misura, anche le
“interpretazioni”, così come promette il
sottotitolo. Fausto
Buttà, storico professionale e ricercatore all'università
del Western Australia, ha fino ad ora rivolto in prevalenza
la sua attenzione di studioso proprio alle vicende otto-novecentesche
dell'anarchismo milanese (Anarchici a Milano (1870-1926)
storie e interpretazioni, Zero in Condotta, Milano 2016,
pp. 368 + ill., € 20,00). Questa è infatti la sua
seconda importante monografia (che segue Living Like Nomads,
edita nel 2015 e dedicata al medesimo argomento). Nel nuovo
libro l'autore, da vero specialista, ha saputo ben focalizzare,
all'interno di un impianto narrativo convincente, non solo le
“storie” ma, almeno in qualche misura, anche le
“interpretazioni”, così come promette il
sottotitolo.
Benché la dimensione spaziale dell'ambito complessivo
di ricerca prescelto possa apparire circoscritta, tuttavia i
risultati mettono in evidenza efficacia e profondità
dell'approccio che è stato seguito. Si tratta di una
metodologia basata sull'incrocio delle biografie, sull'inquadramento
della trattazione per mappe ideologiche, sull'utilizzo –
soprattutto – di una visuale davvero transnazionale. È
bene sottolineare come tutto questo rispecchi l'evoluzione ultradecennale
di una storiografia, quella appunto sull'anarchismo, che, superate
ormai le vecchie colonne d'ercole del militantismo e del localismo,
è finalmente approdata alla sua fase virtuosa. In tal
senso lo stesso Buttà premette di essersi metodologicamente
ispirato, per quanto riguarda l'influenza dei contesti transnazionali
nella storia dei gruppi anarchici locali, ai lavori di Davide
Turcato (apprezzato studioso, conosciutissimo in area anglofona,
curatore fra l'altro dell'Opera omnia di Errico Malatesta, in
corso di pubblicazione).
“Gli anarchici milanesi risposero ad avvenimenti traslocali
producendo esperimenti pratici originali di anarchismo in azione
[...] Nel rispondere col proprio attivismo a eventi locali,
nazionali e internazionali, il movimento anarchico milanese
dimostrava la sua determinazione a superare la propria apatia
politica, causata dalla repressione e dalle lacune interne.”
(p. 14).
Le fonti compulsate, davvero qualificate e ricche, coprono un
ampio spettro: dal fondo Questura alle carte della Prefettura
e alle sentenze penali presso l'Archivio di stato di Milano;
dal Casellario politico centrale ai vari fondi PS dell'Archivio
centrale dello stato; dalle testate giornalistiche coeve ai
saggi e alle copiose fonti di letteratura. Il menù
del libro costituisce di per sé una “mappa”
in sequenza delle presenze libertarie nel capoluogo lombardo,
dall'epoca postunitaria fino al consolidarsi del fascismo-regime:
internazionalisti, organizzatori, individualisti, anarchici,
educatori libertari, sindacalisti, antimilitaristi, rivoluzionari
del dopoguerra, antifascisti. Le varie componenti appaiono ben
bilanciate, mentre si ridimensiona il peso della corrente individualista
che una certa vulgata avrebbe da sempre indicato come la dominante
rispetto a quella malatestiana anarco-comunista.
Nell'arco temporale considerato, peraltro sufficientemente lungo,
si registrano eventi e situazioni peculiari che fanno di Milano
e del suo territorio un vero epicentro politico e un catalizzatore
socioculturale di portata nazionale e oltre. Si pensi, ad esempio,
alle cannonate di Bava Beccaris e alle revolverate di Bresci;
si pensi alla scapigliatura letteraria e alle avanguardie artistiche
primonovecentesche, alle riviste anarco-futuriste e individualiste
che nascono in città; si pensi al peculiare sindacalismo
corridoniano che vede la luce proprio nel milieu operaio meneghino;
si pensi al terribile attentato al teatro Diana e ai suoi sventurati
effetti.
Da sempre capitale italiana ed europea del giornalismo, nel
giro di pochi anni vede susseguirsi – nel proprio ambito
urbano – due direttori di quotidiani proletari di grande
notorietà: il socialista Mussolini con l'«Avanti!»
e l'anarchico Malatesta con «Umanità Nova».
Prima ancora, nella parabola che va dal bakuninismo all'individualismo,
avevano visto la luce «Gazzettino Rosa», «Il
Martello», «L'Amico del Popolo», «Il
Grido della Folla», «La Protesta Umana». Tra
i protagonisti che popolano la Milano anarchica e libertaria
(e il libro di Buttà) sono senz'altro da rammentare anche
Pietro Gori, Leda Rafanelli, Giuseppe Monanni, Carlo Carrà,
Filippo Corridoni, Bruno Filippi...
Condivisibile infine l'analisi dell'autore sul primo antifascismo
(“lotta di sopravvivenza” più che “sogno
rivoluzionario”). Nell'attentato al Diana poi si individua
“una linea di separazione nella storia dell'anarchismo
milanese e italiano”.
Più problematico invece si dimostra l'esame sui destini
e sul futuro stesso dell'Anarchia. Buttà, nelle conclusioni
(p. 316), individua – sebbene con un ragionamento forse
eccessivamente semplificato e sbrigativo – le ragioni
dei fallimenti e della “principale debolezza” dell'anarchismo
proprio nella contraddittoria ricchezza del suo pensiero, nella
sua incapacità a rimodellarsi sui nuovi parametri della
modernità incombente. Ossia il Novecento, secolo per
antonomasia delle masse nel quale si era palesata l'assoluta
necessità di un rapporto continuo ed emozionale tra capi
e soggetti subordinati, si dimostrava assolutamente inadatto
a chi, in maniera quasi anacronistica, sembrava rifiutare a
priori perfino l'idea stessa di leadership.
Giorgio Sacchetti
Una fiaba/
Una bimba di 7 anni, un toro marchiato 2896, un albero e altri animali
Immagineresti un mondo senza animali?
 Socrate
è stato filosofo nell'antica Grecia dove, per comprendere
lo stato delle cose, era solito dialogare coi suoi allievi su
problemi d'importanza morale. Socrate
è stato filosofo nell'antica Grecia dove, per comprendere
lo stato delle cose, era solito dialogare coi suoi allievi su
problemi d'importanza morale.
Socrate – nel piccolo libro scritto da Margherita D'Amico
(Socrate 2896, Bompiani, Milano 2016, pp. 87, €
13,00) – è un toro da riproduzione marchiato col
numero 2896, che dialoga, nel breve tempo di una notte, con
una bambina, un albero e altri animali. Una storia breve e poetica
che inizia e finisce nel macello dove la vita del toro avrà
termine. La bambina si chiama Lucilla, ha sette anni, come il
toro, e si conoscono dalla nascita poiché abitano nella
stessa fattoria. Lucilla, bambina dall'intelligenza speciale,
comprende il silenzioso linguaggio di animali e piante che la
destinano ad essere loro portavoce verso l'umanità a
cui lei appartiene, le affidano il loro messaggio per la salvezza.
“(...) Voglio immaginarti vittoriosa nel ricordare all'uomo
lo strumento per vivere in un cane o nella rosa nella polvere,
nel vento libera il messaggio priva di timore taciterai i perché
ti parlo senza rumore e tu parlerai per me.”
Un libro sull'evidente violenta assurdità di ciò
che sta accadendo, a causa del comportamento umano, che mi ha
immediatamente riportato alle immagini di un Pulcinella vestito
di bianco che cammina, cammina attraverso la campagna, alla
ricerca di una collocazione per un piccolo bufalo che si porta
appresso. Sono immagini di Bella e perduta il bellissimo
film di Pietro Marcello che documenta la storia del pastore
Tommaso Cestrone il quale per anni, fino alla morte, dedicò
la sua esistenza alla salvaguardia dell'abbandonata Reggia di
Carditello, in quella, una volta meravigliosa, provincia di
Caserta oggi tristemente nota come “terra dei fuochi”
per via della devastazione che la distrugge.
Tommaso Cestrone recuperava anche i piccoli bufali – maschi
e quindi non utili per la produzione di latte – abbandonati
con le zampe legate in mezzo alla boscaglia e li teneva nella
stalle della reggia. Il film, seguendo il procedere fantastico
delle fiabe, racconta che dopo la sua morte fu affidato a un
pulcinella il compito di trovare alloggio per il bufalotto Sarchiapone
la cui voce fuori campo accompagna chi sta guardando il film.
Se Bella e perduta si riferisce al nostro paese –
quella patria di cui canta l'inno di Mameli e sulla quale si
è abbattuta la malasorte –, gli stessi aggettivi
potrebbero riguardare l'intero pianeta che la medesima sorte
subisce. La possibilità di aiuto, se non di salvezza,
nel libro come nel film, è affidata a chi è in
grado di comunicare all'anima; non a caso una bambina e un pulcinella,
figure simboliche che fanno da tramite tra noi e l'invisibile.
Il libretto in questione non raggiunge certo la levatura del
film, ma sicuramente ci sono affinità: come facessero
entrambi riferimento a una favola di Esopo o Fedro; ad esempio,
hanno in comune la poetica degli animali parlanti e saggi, ed
entrambi sottendono il pensiero che i guai nei quali ci troviamo
vengono da una malattia dell'anima che tutti patiamo, ma che
ancora può, o potrebbe, essere curata. Da parte di animali
e piante a una figura bambina è affidata la luminosa
chiave capace di mutare il destino dell'umanità e del
pianeta.
Come tutte le fiabe si legge senza soste e delle fiabe possiede
l'efficacia lieve; pur denunciando le stesse cose di animalisti,
antispecisti ed ecologisti lo fa senza pressioni invadenti,
lascia il segno senza farsi accorgere, ed è un grande
pregio.
Silvia Papi
Note autobiografiche/
I vicoli di Ragusa, i ricordi, l'umanità, l'impegno anarchico
C'è chi scrive per diletto, chi lo fa per vanità,
alcuni per soldi. Sembrerebbe che Gurrieri non scriva per nessuno
di questi motivi. Lo fa piuttosto perché ci sono cose
che hanno bisogno di essere raccontate, messe su carta, stampate,
trasmesse. Infaticabilmente su Sicilia Libertaria, parsimoniosamente
nei pochi (non pochissimi) libri pubblicati tra i quali ultimo
arriva questo Le verdi praterie. Passato e presente (Sicilia
Punto L edizioni, Ragusa, 2017, pp. 124, € 8,00) un titolo
ostico che fa pensare a un romanzo sul selvaggio west che invece
non c'entra niente.
 Come
sottolinea l'autore non si tratta di una vera autobiografia
– anche perché far stare tutta l'intensa vita di
Pippo Gurrieri in poco più di cento pagine sarebbe stata
impresa davvero ardua – ma “una raccolta di ricordi,
discontinui, incompleti, non sempre lineari”. Premessa
eccessivamente cauta in quanto il risultato è invece
una narrazione tutt'altro che irregolare ma dotata, al contrario,
di una solida coerenza interna, risultato di idee chiarissime
e di uno stile asciutto ed essenziale ma niente affatto arido.
Anzi, siccome la storia c'è – le storie
ci sono – la sobrietà della scrittura permette
di percepire forte e limpido il dipanarsi di un trascorso che
parte dai vicoli di Ragusa e arriva dall'altra parte dell'Italia,
sulle montagne piemontesi, a mezzo metro dalla Francia. E poi
ritorna giù, dove sta Tunisi, solo un po' più
a destra. Come
sottolinea l'autore non si tratta di una vera autobiografia
– anche perché far stare tutta l'intensa vita di
Pippo Gurrieri in poco più di cento pagine sarebbe stata
impresa davvero ardua – ma “una raccolta di ricordi,
discontinui, incompleti, non sempre lineari”. Premessa
eccessivamente cauta in quanto il risultato è invece
una narrazione tutt'altro che irregolare ma dotata, al contrario,
di una solida coerenza interna, risultato di idee chiarissime
e di uno stile asciutto ed essenziale ma niente affatto arido.
Anzi, siccome la storia c'è – le storie
ci sono – la sobrietà della scrittura permette
di percepire forte e limpido il dipanarsi di un trascorso che
parte dai vicoli di Ragusa e arriva dall'altra parte dell'Italia,
sulle montagne piemontesi, a mezzo metro dalla Francia. E poi
ritorna giù, dove sta Tunisi, solo un po' più
a destra.
Avete presente un nostalgico? Quelli che “com'erano belli
quegli anni là che eravamo tutti rivoluzionari e capelloni”?
Nulla di più distante da quello che si trova ne Le
verdi praterie, dove molto spazio è dedicato alla
Ragusa dei primi anni sessanta vista dagli occhi di un bambino,
viva, accogliente, piena di scoperte alle quali dedicarsi ma
anche povera e aspra (la storia del gatto che cacava nel posto
sbagliato non ve la racconto per non rovinarvi la lettura -
per non spoilerare, direbbero i giovani d'oggi). Retorica
non pervenuta, senso dell'umorismo brillante e spassosa autoironia
sempre dietro l'angolo rendono la lettura lieve e appassionante
anche quando gli argomenti trattati sono macigni - come gli
incidenti sul lavoro.
È una storia personale, certo, ma anche collettiva, generazionale
e a suo modo epica e condivisa. Chi ha avuto la sorte di nascere
e crescere in paesi o cittadine del sud non potrà evitare
di trovare somiglianze o diversità e di sentire che in
fondo ciò che ti lega alle tue radici e magari ti spinge
altrove è roba fatta della stessa materia. Nel graduale
e continuo espandersi di quel mondo che da uno “spicchio
di quartiere” si proiettava verso l'universo esterno c'è
un guadagnare e un rimetterci. L'allontanamento dalla chiesa,
l'attivismo per il partito comunista del quale il padre Angelo
era elemento di spicco a Ragusa, assieme ai piccoli miracoli
del '68 come la proiezione gratuita di Helga, un film
commissionato dal ministero della salute tedesco capace di svelare
reconditi misteri della riproduzione umana, sembrano tutti passi
verso l'incontro fatale con i due hippy francesi, veri anarchici
sessantottini.
Al Gurrieri sedicenne toccò di fare da traduttore, “solo
che quelle parole che mi entravano nelle orecchie poi non ne
uscivano facilmente”, e infine andavano accompagnati da
Leggio che gli consigliò un libro sull'anarchismo di
Daniel Guerin – “e la frittata fu fatta”.
Al contempo, individualmente e socialmente, andavano avanti
il lavoro, lo sviluppo economico, l'emigrazione – ma non
quella da fame della generazione precedente, si andava via per
aver vinto un concorso, quello di Gurrieri nelle ferrovie (attività
orgogliosamente rivendicata, nonostante a qualcuno non piaccia).
Si acquistava indipendenza, chissà, forse libertà,
si facevano via via più lontani gli anni in cui la carne
era preziosa e arrivavano quelli delle lotte per il miglioramento
delle condizioni lavorative.
L'altra faccia della medaglia era la perdita progressiva di
quel “microcosmo di umanità” che viveva di
scambi, di solidarietà, di litigi, dove non c'erano schermi
ai quali stare incollati, ma gente in carne e ossa che condivideva
il quotidiano. Un mondo ormai scomparso o quasi, che Pippo Gurrieri
fa rivivere con amore e senza sentimentalismi attraverso il
mezzo che gli è più congeniale, capace di farci
sentire gli odori e i rumori di via Pezza e di tutto ciò
che cospirò affinché il bambino che nella banda
dei Garibaldini era l'unico soldato semplice diventasse quel
rivoluzionario maniaco di libri che tutti conoscono (o dovrebbero
conoscere), incessantemente all'opera per riuscire a fare, come
fece con lui Franco Leggio, molte altre frittate.
Giuseppe Aiello
Ferlinghetti e gli altri/
Gente che voleva abolir le frontiere
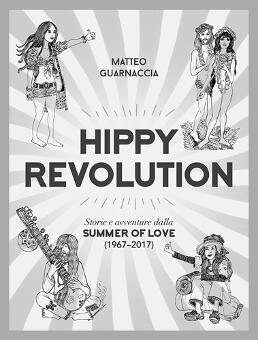 24
ore Cultura ha recentemente pubblicato, di Matteo Guarnaccia,
Hippy Revolution – storie e avventure della Summer
of love, 1967 – 2017 (Milano 2017, pp. 158, €
19,90). Il Saggiatore ha pubblicato, a sua volta, di Lawrence
Ferlinghetti, Scrivendo sulla strada – Diari di
viaggio e di letteratura (Milano 2017, pp. 464, €
42,00) All'autore del primo libro, e grande esperto di Beat
Generation & dintorni, abbiamo chiesto 5.000 battute spazi
compresi, libere in tutti i sensi. E Matteo ci ha inviato questo
testo. 24
ore Cultura ha recentemente pubblicato, di Matteo Guarnaccia,
Hippy Revolution – storie e avventure della Summer
of love, 1967 – 2017 (Milano 2017, pp. 158, €
19,90). Il Saggiatore ha pubblicato, a sua volta, di Lawrence
Ferlinghetti, Scrivendo sulla strada – Diari di
viaggio e di letteratura (Milano 2017, pp. 464, €
42,00) All'autore del primo libro, e grande esperto di Beat
Generation & dintorni, abbiamo chiesto 5.000 battute spazi
compresi, libere in tutti i sensi. E Matteo ci ha inviato questo
testo.
Nel turbolento lasso di tempo compreso tra la guerra di Corea
e quella del Vietnam, gli anni della “perdita dell'innocenza”,
una serie di sottili libretti stampati da una piccola casa editrice
di San Francisco, contribuirono, in maniera decisiva, ad alimentare
i dubbi e le visioni di una generazione di giovani ribelli che
si era svegliata di soprassalto dal sogno americano.
La lettura di quei piccoli austeri gioielli cartacei, rigorosamente
in bianco e nero, faceva parte del curriculum di ogni sovversivo
e sognatore del periodo. La casa editrice si chiamava - in omaggio
al famoso film di Charlie Chaplin - City Lights, ed i suoi “uffici”
si trovavano nell'omonima libreria del quartiere bohemien di
North Beach, San Francisco, tra vecchi bar italo-americani.
Le scricchiolanti assi del pavimento del City Lights Bookstore
- diventato una sorta di avamposto del dissenso - erano incessantemente
consumate da poeti, curiosi e poliziotti allarmati dall'offerta
di opere “proibite”. Beatnick e altre creature arruffate,
cercavano sollievo e carburante psichico rovistando nel catalogo
della City Lights che offriva ospitalità a Céline
e a Buddha, a Ghandi e Lautremont, ma il cui piatto forte erano
le opere degli esponenti della beat generation, di cui l'editore-proprietario,
un ex militare della marina, un brillante poeta di origine italiana
Lawrence Ferlinghetti, era sodale e amico.
La famosa foto di gruppo degli artisti e poeti beat e proto-hippie,
scattata da Larry Keenan nel 1965, davanti alla libreria che
lo ritrae - vestito con una djellaba marocchina - nell'atto
di proteggere tutti sotto un ombrello, è una perfetta
rappresentazione simbolica del ruolo da lui svolto in quella
comunità artistica e esistenziale.
Nel 1957, la pubblicazione dello “scandaloso” e
amabilmente osceno Howl di Allen Ginsberg, trasformò
il coraggioso editore in un bersaglio della legge. Lui venne
arrestato e trattato come un delinquente, l'opera sequestrata
e il processo che seguì segnò la storia della
giurisprudenza statunitense in merito al concetto di libertà
di espressione.
|
| Luoghi ed eventi della San Francisco Beat. Disegno di Matteo
Guarnaccia dal suo libro Hippy Revolution |
|
| La
libreria City Lights a North Beach nei primi anni '60.
Disegno di Matteo Guarnaccia dal suo libro Hippy Revolution |
Oggi Ferlinghetti è un pimpante e affascinante signore
di novantotto anni, un artista dagli occhi che ridono, che non
ha ancora appeso al chiodo la sua voglia di “sovvertire
il paradigma della realtà dominante”, di abbandonare
quella guerriglia poetica che i beat intrapresero per salvare
“quel mandorlo fiorito e quell'orrore per la guerra che
albergano in ogni cuore d'uomo”. È uno degli ultimi
superstiti di quel gruppetto di disadattati, di amici strampalati,
beati e sbattuti - Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs,
Jack Cassady, Gary Snyder, Peter Orlovsky - che alla fine della
Seconda guerra mondiale, guizzando selvaggiamente controcorrente,
si era messo in testa di celebrare la vita, sfidando l'american
way of life armato solo di poesia e faccia tosta. Una confraternita
letteraria che si è inventata uno stile di vita leggendario
capace di stregare le menti di milioni di persone, divenuta
senza volerlo, portabandiera della ribellione contro la segregazione
razziale, il militarismo rampante, i diritti civili negati alle
minoranze etniche e sessuali, la caccia alle streghe maccartista,
la devastazione della natura, la scelta tra il morire di noia
o di olocausto nucleare.
Gente che voleva abolire le frontiere, i controlli, la distanza
tra gli esseri umani. Ferlinghetti lavora ancora dalla sua libreria,
contro il clima di paranoia e sospetto che inquina i rapporti
quotidiani e che, oggi come negli anni Cinquanta, è in
larga parte da addebitarsi alla politica dell'amministrazione
guidata dal “Grande Padre Bianco che sta nella Casa Bianca”.
L'arsenale poetico di Ferlinghetti, si poggia non solo sulla
parola scritta ma anche sulla forza disarmante della sua produzione
grafica e pittorica.

Chi non si ricorda degli appunti visivi che costellavano le
sue opere della City Lights, come “Her” o “The
Mexican Nights”? Schizzi asciutti che rimandano agli stilemi
della tecnica pittorica zen, così amata da tutti gli
scrittori della beat generation. Ideogrammi allusivi, che vibrano
ancora del gesto che li ha composti e che fanno inevitabilmente
venire alla mente i grandi tazebao della rivoluzione culturale
cinese (anche se la sua rivoluzione culturale è stata
sicuramente più gioiosa e pacifica). Fluidi ideogrammi
alati, eloquenti come vessilli barbarici issati dopo un'aspra
battaglia. Odorano di preistoria e luci al neon; posseggono
la forza destabilizzante dei saluti lasciati col rossetto da
amanti clandestini sullo specchio di un motel anonimo.
L'inesausta energia emotiva del poeta, ancora oggi ci spinge,
con ferma gentilezza, a seguire Basho e Coltrane a spasso per
Coney Island. La sua poesia generosa ha contribuito a posticipare
la fine del mondo – anche se solo per il tempo di un'altra
lettura e di un altro scarabocchio in barba ad ogni assurda
interdizione. E ogni giorno, sorridendo con gli occhi, Lawrence
Ferlinghetti continua a tenere accese le luci della città.
Matteo Guarnaccia
Joan Puig Elias/
L'educatore dimenticato
Se Francisco Ferrer i Guàrdia è personaggio universalmente
noto (non foss'altro che per la sua tragica morte) un educatore
libertario del calibro di Joan Puig Elías era fino ad
oggi praticamente sconosciuto persino negli ambienti libertari,
in Italia e non solo.
 A
colmare questo vuoto è giunta oggi la documentata ricerca
di Valeria Giacomoni, Joan Puig Elías: Anarquismo,
pedagogía y coherencia (Descontrol, Barcelona, 2016
pp. 265, € 10,00). A
colmare questo vuoto è giunta oggi la documentata ricerca
di Valeria Giacomoni, Joan Puig Elías: Anarquismo,
pedagogía y coherencia (Descontrol, Barcelona, 2016
pp. 265, € 10,00).
L'autrice ricorda di essere stata stimolata a questa ricerca
da Abel Paz (Diego Camacho), che di Puig Elías era stato
allievo entusiasta alla “Escuela Natura” del Clot,
un rione di Barcellona, e che si meravigliava che nessuno, fino
ad allora, si fosse occupato della sua figura.
Dal libro apprendiamo che “una delle caratteristiche fondamentali
di Puig Elías” era proprio quella di voler mantenere
un basso profilo personale, di “pasar desapercebido”
(passare inosservato), “questa volontà di non richiamare
l'attenzione, di non fare grandi proclami, di non fare direttamente
propaganda ideologica ma di considerare l'anarchismo come un
modo di vivere e cercare di trasmetterlo con l'esempio, con
la coerenza, giorno per giorno” (p. 51)
Proprio la credibilità conquistata sul campo fanno sì
che dopo la rivoluzione del luglio 1936 gli venga affidata la
direzione del CENU (Consell de l'Escola Nova Unificada)
che estende la pedagogia libertaria a tutte le scuole catalane.
La stima universale verso di lui non viene meno neppure dopo
i sanguinosi scontri, provocati dagli stalinisti, del maggio
1937.
Sintomatico un episodio emerso durante la presentazione del
libro alla libreria La Rosa de Foc di Barcellona (20
aprile 2017).
Uno dei presenti ha ricordato che suo padre, maestro in pensione
e “liberale di destra”, allo scoppio della guerra
civile aveva ripreso a lavorare collaborando con entusiasmo
al progetto pedagogico di Puig Elías, e anche negli anni
seguenti dichiarava (pur non avendo modificato la propria fede
politica) che “se si fosse presentata un'altra rivoluzione
del genere vi avrebbe senz'altro partecipato”.
Puig Elías è stato un maestro prima di tutto.
Sconvolto dalla condanna di Ferrer, decide ancora bambino di
dedicare la propria vita all'insegnamento, ma dal libro emerge
anche l'originalità della sua proposta pedagogica, che,
se parte da Ferrer, va ben oltre attribuendo un ruolo basilare,
oltre che alla “razionalità”, anche all'aspetto
socio-affettivo, alla centralità del bambino, all'educazione
a diretto contatto con la Natura. Si passa così dalla
“Escuela Moderna” alla “Escuela Natura”.
La storia del maestro anarchico diventa però storia corale
del movimento libertario, che l'autrice ricostruisce passo passo,
perchè dalla ricerca emerge l'assoluta internità
di Puig Elías alla CNT, dalla sua adesione ancora giovinetto,
alla rivoluzione, all'esilio, ricoprendo sempre incarichi organizzativi
(anche di rilievo).
Emerge anche la maturità della CNT che, fin dall'inizio
del secolo, aveva compreso la centralità del tema educativo
per forgiare una società rivoluzionaria.
La stessa scuola del Clot di Barcellona (divenuta dopo il 1921,
sotto la direzione di Puig Elías, “Escuela Natura”)
era una creazione della CNT del quartiere, ospitata in locali
confinanti con la sede sindacale. Dai ricordi degli allievi
emergono importanti squarci delle lotte di quegli anni: le discussioni
tra i figli dei carcerati politici, l'espediente utilizzato
dagli insegnanti di tenere chiusa la scuola in occasione di
moti rivoluzionari con il pretesto che fosse un giorno “festivo”,
l'arrivo a scuola dei figli degli scioperanti di Saragozza ospitati
dalle famiglie operaie di Barcellona (1934), il continuo andirivieni
di compagni che devono parlare col maestro, Federica Montseny
che giunge improvvisamente a scuola a chiamare Puig Elías:
García Oliver è stato arrestato con un carico
di bombe (1933) e si teme per la sua vita...
Il 19 luglio 1936 Puig Elías, membro del Comité
revolucionario del Clot, partecipa attivamente alla lotta
sulle barricate. Sono Durruti ed Ascaso a convincere lui e gli
altri insegnanti a lasciare il fucile per dedicarsi ad un'opera
ancora più importante: l'educazione delle giovani generazioni.
Qui inizia la storia del Consell de l'Escola Nova Unificada
(a cui il libro dedica ampio spazio), composto da insegnanti
e pedagogisti dei sindacati della CNT (libertari), UGT (socialisti)
e della Generalitat (il governo autonomo catalano) che - sotto
la direzione di Puig Elías - riorganizza completamente
la scuola catalana.
A chi lo critica per i compromessi con organi statali risponde
orgogliosamente che, grazie alla CENU, la pedagogia anarchica
è diventata la base di tutto il sistema scolastico. Le
polemiche sulla scelta “ministeriale” della CNT
inducono comunque numerose scuole razionaliste a non aderire
alla CENU.
I risultati conseguiti in pochi mesi sono impressionanti: 60.000
bambini in più scolarizzati, 151 edifici espropriati
ed adibiti a scuole, insegnamento iniziale nella lingua materna
(catalana o castigliana che fosse), formazione di un nuovo corpo
di insegnanti, creazione di colonie scolastiche (per educare
i bambini al contatto con la natura ma anche per sottrarli ai
bombardamenti).
Puig Elías è infaticabile, è dovunque,
sembra essere passato dal “pasar desapercibido”
al “ponerse en primera lìnea” (p.
146). Ma dal giugno 1937 l'involuzione della situazione politica
è evidente, col prevalere dei comunisti la “guerra
antifascista” prende il sopravvento sulla rivoluzione.
Anche la nomina di Puig Elías a Sottosegretario all'Istruzione
Pubblica nel governo della repubblica (aprile 1938) sembra a
chi legge una sorta di “promuovere per rimuovere”.
Con la vittoria di Franco iniziano i lunghi anni dell'esilio.
L'autrice ripercorre le vicende dei 30 bambini della colonia
scolastica “Mon nou” (Mondo nuovo) animata da Emilia
Roca (anche attraverso il carteggio tra la Roca ed Emma Goldman)
prima nei Pirenei a 3000 m. di altitudine, poi nell'esilio francese.
Anche in Francia Puig Elías è infaticabile, dopo
aver partecipato alla Resistenza nel battaglione “Libertad”,
composto da anarchici spagnoli, ricopre ancora importanti incarichi
organizzativi nella CNT.
Dal 1952 si trasferisce a Porto Alegre, in Brasile, dove suo
figlio Floreal progetta di creare una Comune. Sono anni durissimi
punteggiati dalle difficoltà economiche e dalla persecuzione
della chiesa che riesce ad impedire a Puig Elías di esercitare
l'insegnamento, infine dalla malattia. Questo non impedisce
al maestro anarchico di proseguire nell'impegno pubblicando,
due anni prima di morire, il suo unico libro: El hombre,
el medio y la sociedad. Los factores determinantes de la conducta
del individuo, Porto Alegre, Grafica Editóra Vértice,
1970.
Con la speranza di vedere presto una versione italiana del libro
di Valeria Giacomoni concludiamo queste note ricordando il giudizio
di Emma Goldman sulla rivoluzione spagnola: “La vostra
rivoluzione distruggerà per sempre [l'idea] che anarchismo
voglia dire caos” (p. 204).
Mauro De Agostini
L'album “Mare nero”/
Alessio Lega, un narratore di storie in musica
 “Mare
Nero” è l'ottava uscita discografica del cantautore
pugliese Alessio Lega, la terza 'd'autore': sono quasi tutte
canzoni sue, fatta eccezione per “Fiore di Gaza”
di Paolo Pietrangeli e “Hanno ammazzato il Mario in bicicletta”
di Dario Fo e Fiorenzo Carpi; due cover niente affatto
slegate dal filo che tiene insieme gli altri brani di questa
opera. Ci viene spiegato che non si tratta di un Concept
Album, ma di un disco fatto con canzoni a cui non si era
riusciti ancora a dare un abito sonoro adeguato per un'incisione,
oppure con brani rimasti fuori da precedenti lavori discografici
e con pezzi che per loro natura erano nati per restar “solitari”. “Mare
Nero” è l'ottava uscita discografica del cantautore
pugliese Alessio Lega, la terza 'd'autore': sono quasi tutte
canzoni sue, fatta eccezione per “Fiore di Gaza”
di Paolo Pietrangeli e “Hanno ammazzato il Mario in bicicletta”
di Dario Fo e Fiorenzo Carpi; due cover niente affatto
slegate dal filo che tiene insieme gli altri brani di questa
opera. Ci viene spiegato che non si tratta di un Concept
Album, ma di un disco fatto con canzoni a cui non si era
riusciti ancora a dare un abito sonoro adeguato per un'incisione,
oppure con brani rimasti fuori da precedenti lavori discografici
e con pezzi che per loro natura erano nati per restar “solitari”.
Lega ci tiene proprio a ribadirlo: si tratta di “avanzi”,
come quelli del pranzo della domenica, rielaborati in una nuova
pietanza da una mamma, o magari, perché no, da un qualche
chef di grido; in effetti l'uomo ha sempre dato molta importanza
al cibo, ma in un altro tempo e in un altro spazio mangiare
era un rito sociale e significava sopravvivenza. In questo tempo
e nel nostro quotidiano, mangiare è diventato molto di
più: ovunque guardiamo, ci scopriamo circondati da carboidrati
proteine e vitamine, siamo minacciati dai sali minerali che
ci guardano dalle vetrine, siamo ottenebrati dai profumi dei
forni e delle rosticcerie, come i canti delle sirene ottenebravano
Odisseo... e purtroppo non abbiamo l'accortezza di legarci all'albero
di una vela. Per questa volta allora potremmo provare a trovare
una similitudine nuova. La migliore – quella più
vicina in fondo all'anima di Alessio Lega – o almeno così
ci appare – è quella della coperta. Una di quelle
fatte a mano con gli avanzi dei gomitoli con cui venivano realizzate
maglie, centrini, tendine, centrotavola, calzini, berretti per
la notte. Di quelle coperte di tutti i colori, fatte a quadrettoni,
a rombi, ad ovali. Proprio quelle che faceva la nonna.
“Mare nero” è un po' come quelle coperte
calde, con cui ci si avvolge in certi pomeriggi d'inverno: l'effetto
è quello delle madeleine proustiane, perché subito
affiorano ricordi, storie e possibilità. E infatti Alessio
Lega è un narratore di storie in musica; è un
moderno cantastorie in piena regola e quella è proprio
la sua dimensione migliore, nella quale riesce ad esprimere
il meglio del suo pensiero e del suo cuore; quando Lega si esprime
in forma canzone sa trovare la parola, che senza risultare minacciosa
o pretenziosa o arrogante o definitiva, appare, molto semplicemente,
vera. Di quella verità che sa di umanità, di giustizia,
di condivisione e di solidarietà. E che sa anche di leggerezza,
di quella particolare leggerezza delle cose serie e con la quale
non sempre è facile trovare la misura.
Ogni persona creativa conosce l'elemento indispensabile per
la sua personale forma di espressione. Con gli anni Lega ha
affinato il suo e ogni volta diviene sempre più consapevole
– è evidente – che può osare ed essere
sfacciato, come il giullare che sbeffeggia il potente. Un giullare
che non è stato invitato a Corte, naturalmente, e che
non ci vuole nemmeno andare. Un giullare che il potere lo ammonisce
e lo minaccia sotto le finestre, cantando ad altissima voce.
C'è molto popolo dentro questo disco e anche molta ricerca.
E c'è anche un'ottima direzione artistica, quella di
Rocco Marchi e Francesca Baccolini; l'insieme – come in
quella coperta di cui parlavamo prima – è un collage
di suoni diversi e di rimandi musicali da tutte le parti del
mondo.
Partiamo da “Mare Nero” perché è il
brano più facile: è infatti un “modernissimo
inno antico” all'anarchia e chi scrive si chiede fino
a che punto Lega non si sia un po' divertito a giocare con il
facile rimando canzonettistico e mogoliano che questo titolo
porta immediatamente alla mente. Sappiamo bene però che
questo pezzo - scritto molti anni fa (quasi venti) - è
un cavallo di battaglia dei suoi concerti ed è importante
che abbia finalmente trovato, non tanto la veste sonora per
il disco, quanto il coraggio di metterci finalmente un punto
(Verba volant Scripta manent).
Come pirata che solca il Mare Nero, al quale beninteso appartiene,
il giullare cantastorie anarchico viaggia nel tempo e nello
spazio, avvicinando storie di oggi, storie di ieri e anche storie
dell'altroieri e di domani. La prima è personale, ma
riguarda anche tutti noi; c'è sempre infatti una “Angelica
matta” che si incontra al momento opportuno, quando il
cuore e la vita sono affaticati e cercano salvazione; c'è
gratitudine e amore in questo pezzo, raccontati con pudore e
levità.
Ma è solo un inizio, perché l'ambiente sonoro
del secondo brano “Povero Diavolo” muta all'improvviso
e si incupisce, nell'incontro di chi Angelica non l'ha ancora
incontrata o forse l'ha perduta all'inseguimento di risposte:
è la storia inquieta di ogni artista, di ogni giullare,
di ogni matto; in fondo, forse, è proprio la storia di
Angelica.
O la storia di quell'amore finito a suon di marcetta raccontato
in “Non sarai più sola”.
Ma ecco che il giullare abbandona i panni del clown triste e
scende in strada a raccontare storie, quelle di sangue e prevaricazione
che hanno colpito la povera gente, gli umili, i diseredati,
quelli che mettono insieme coperte con gli avanzi dei gomitoli.
Una storia poco nota: quella dell'uccisione a Lecce di tre manifestanti
disarmati davanti alla Chiesa di Santa Croce. Era il 25 settembre
del 1945. La guerra era finita. I lavoratori però cercavano
di combattere per i loro diritti.
Lecce è la città natale di Alessio Lega, Milano
quella d'adozione. In “Stazione Centrale” l'anima
da contestatore del cantautore pugliese si svela totalmente,
senza compromessi: la trasformazione della Stazione di Milano
(come del resto di quasi tutte quelle delle grandi città)
in un enorme centro commerciale nasconde in realtà il
muoversi ostinato del pendolare, del lavoratore, della gente
oscura travolta da una civiltà malata. L'andamento musicale
accompagna in un crescendo di angoscia (quasi disperazione)
l'immagine. È uno dei pezzi più potenti del disco.
Più attuali. E se forse razionalmente la realtà
è meno drammatica e più complessa, il dubbio arriva
alle viscere.
Da Milano ci si trasferisce in Val Susa, la terra ormai nota
solo per le vicende della Tav; La Val Susa diventa “Maddalena”,
prigioniera; il giullare le fa una serenata, mentre il racconto
si sposta dal passato lontano a quello appena recente; l'incedere
è quello delle serenate o delle ninne nanne.
Non cantavano invece gli zingari quando venivano trucidati e
gassati dai nazisti. Lo fa allora Lega nella ballata dal profumo
balcanico “Porrajmos”; non cantavano nemmeno i vecchi
le donne e i bambini gassati dagli Italiani andati ad occupare
le terre e a fare guerra, come viene raccontato in “Ambaradan”.
Perché si sa, noi gli africani li aiutiamo a casa loro.
Il disco si chiude con “Zolletta”, dedicata ad Enzo
Baldoni, e con una gustosa “petizione” a favore
dell'adozione di bambini da parte delle coppie omosessuali.
L'idea di fondo che rimane all'ascolto è che questo album
sia molto amato da Lega: lo si capisce perché quella
coperta di avanzi di gomitolo alla fine – e a sorpresa
– si scopre essere un autoritratto, filato grazie anche
all'apporto di musicisti di alto livello, quali Guido Baldoni,
i produttori Rocco Marchi e Francesca Baccolini, Enzo Cimini,
Rocco Rosignoli, Roberto Zamagna e Gigi Biolcati.
Ce li immaginiamo tutti vestiti come nelle bande di paese, sotto
le finestre della bella Maddalena, prigioniera delle trivelle,
di Angelica, prigioniera della sua pazzia, dei lavoratori, prigionieri
dei padroni, del Povero Diavolo, prigioniero di se stesso. E
non siamo preoccupati perché, fino a che qualcuno canterà,
nessuno sarà mai davvero prigioniero.
Elisabetta Malantrucco
Ecologia/
Le proposte di Murray Bookchin e John Zerzan
 Anarchia
verde. Murray Bookchin e John Zerzan a confronto (di Marco
Piracci, BePress, Lecce 2015, pp. 150, € 11,00) è
un testo che oseremmo definire necessario; necessario perché,
senza nulla perdere in quanto a profondità analitica,
mostra con estrema chiarezza e semplicità le divergenze
ma anche le complementarità intellettuali delle due figure
maggiormente influenti nel panorama libertario contemporaneo. Anarchia
verde. Murray Bookchin e John Zerzan a confronto (di Marco
Piracci, BePress, Lecce 2015, pp. 150, € 11,00) è
un testo che oseremmo definire necessario; necessario perché,
senza nulla perdere in quanto a profondità analitica,
mostra con estrema chiarezza e semplicità le divergenze
ma anche le complementarità intellettuali delle due figure
maggiormente influenti nel panorama libertario contemporaneo.
Il testo di Marco Piracci si snoda partendo da una panoramica
biografica dei due teorici, premessa fondamentale per comprenderne
i rispettivi campi d'azione, per poi passare ad un approfondimento
di tematiche quali la tecnologia e le società primitive
che si collocano alla base delle differenti proposte politiche.
Ma proprio le proposte politiche rivestono un'importanza non
indifferente in un momento storico nel quale il capitale opera
in maniera pressoché incontrastata per riprodurre se
stesso ed accrescersi, portandosi dietro disastri ecologici,
povertà, diffuso senso di precarietà e disagi
psichici.
Le proposte di Bookchin e Zerzan partono sostanzialmente da
una diversa considerazione dello spazio. Il primo, come evidenzia
molto bene Piracci, punta ad un suo rimodellamento tramite una
radicale decentralizzazione. Così Piracci:
“Bookchin è convinto che il recupero dell'idea
di democrazia partecipativa si concentri sulla rinascita delle
assemblee cittadine, sia a livello municipale nei piccoli comuni,
sia a livello di vicinato e di quartiere nelle città
più estese.”1
È uno spazio vivo e dinamico quello concepito da Bookchin,
uno spazio in grado di rivestire un ruolo decisivo all'interno
di un processo rivoluzionario proprio in quanto premessa di
un differente tipo di socializzazione e di politica:
“La municipalità è la sola area geografica
entro cui può avvenire un confronto intellettuale ed
emotivo.”2
Ciò che l'anarchico di New York City intravede tra le
maglie sempre più stringenti e soffocanti delle metropoli
contemporanee è la possibilità di invertire la
rotta autodistruttiva che le società umane hanno intrapreso.
Non è però tutto da buttare quello che fin qui
è stato realizzato. Bookchin stesso afferma come la città
rappresenti quella premessa spaziale per un diverso concetto
di humanitas, una humanitas finalmente universale.
E l'evoluzione verso un'umanità più “organica”
non può che coinvolgere anche il modo in cui l'umano,
concepito come animale tra gli animali pur se con qualche vizietto
idealistico3 – vizietto
idealistico che Steven Best sottolinea puntualmente nel suo
Liberazione totale4 –,
si rapporta alla natura. La comunità finalmente ritrovata
è un'eco-comunità perfettamente integrata e interagente
con lo spazio che abita, ed essendo, questo, soggetto dell'evoluzione
naturale, la comunità stessa intesa come società
umana organica si reinserisce armoniosamente all'interno del
processo evolutivo.
Se Bookchin quindi concepisce lo spazio civilizzato come soggetto
di un possibile rimodellamento, Zerzan fa partire la sua proposta
politica da un momento diverso e solo apparentemente antitetico:
“Zerzan è convinto che occorra innanzitutto
intraprendere un processo di liberazione individuale dai pervasivi
meccanismi del controllo sociale. Convinto che il potere si
fondi sull'incapacità dei singoli di ribellarsi ai suoi
dettami, l'anarchico statunitense sostiene che il primo passo
verso la liberazione debba essere compiuto dalla singola persona.”5
Per Zerzan è quindi il corpo che occupa lo spazio e che
lo determina a dover essere “rimodellato”. Lo stile
di vita del singolo è, ad oggi, intrinsecamente distruttivo
e soltanto la consapevolezza di questo fattore garantisce una
minima possibilità di ribellione. Lo spazio urbano è
perciò messo momentaneamente da parte in favore della
difesa degli ultimi spazi naturali che l'industrializzazione
non ha ancora inghiottito. Piracci riporta la cronaca di un
evento emblematico, simbolo del processo di liberazione cui
mira Zerzan:
“Ad esempio, nel territorio di Eugene nell'Oregon,
dove vive Zerzan, alla metà degli anni Novanta si verificò
un incontro tra persone unite dal desiderio di proteggere la
natura. La riuscita azione di difesa della foresta di Warner
Creek attrasse una folla di giovani disposti a lasciare le proprie
città per andare a vivere in un villaggio dove le case
erano costruite sugli alberi.”6
La difesa dello spazio incontaminato è fonte di un nuovo
senso di appartenenza nei confronti della natura. Soltanto a
partire da qui può svilupparsi un movimento collettivo
di difesa e liberazione degli spazi urbani, come la difesa del
sito archeologico nata dall'alleanza tra gli attivisti di Earth
First! e la comunità degli indiani Mendota7.
Nonostante il pensiero dei due teorici affondi le radici in
premesse differenti, non per questo i due punti di vista sarebbero
inconciliabili nel corso di un ipotetico processo di liberazione.
Piracci stesso mostra come, ad esempio, Zerzan sostenga “l'idea
di coltura nei perimetri urbani che è un altro aspetto
della transizione in termini pratici”8;
coltura che necessariamente dovrebbe rifarsi ai dettami della
permacultura la quale “riproduce sé stessa senza
consumare i terreni”9 e
che si trova perfettamente in linea con l'idea di Bookchin di
un nuovo sodalizio evolutivo tra umano e natura fondato sul
rispetto, la difesa e la valorizzazione dei cicli biologici
ed inserito in un contesto in cui la distanza tra città
e campagna si è assottigliata.
È perciò nella pratica che le due impostazioni,
pur puntando ad obbiettivi divergenti, possono arrivare ad intrecciarsi
e a costituire una forza antagonista realmente scomoda per il
capitale e le sue dinamiche collaterali: l'individuo ha la possibilità
di liberarsi e di modificare il proprio stile di vita arrivando
ad incidere sullo spazio circostante tramite la difesa e il
rimodellamento dello stesso ma è anche vero che le possibilità
di liberazione individuale crescono laddove lo spazio ricade
sotto il potere di autodeterminazione delle popolazioni che
lo abitano e che quindi già operano processi rivolti
ad una sua ridefinizione in senso ecologico e direttamente democratico.
“Anarchia verde” è perciò un testo
di fondamentale importanza sia per quanto riguarda l'approfondimento
del pensiero di due influenti personalità, sia per ottenere
utili e fresche indicazioni pratiche che integrino, nella lotta
allo Stato, al capitale e a tutte le forme istituzionalizzate
del delirio antropocentrico, le lotte ecologiste in difesa degli
spazi ancora vergini e la “ricostruzione” creativa
e a forte impatto sociale di quelli oramai irrimediabilmente
deturpati.
Danilo Gatto
- Cfr. M. Piracci, Anarchia verde. Murray Bookchin e John Zerzan a confronto, Edizioni Bepress, 2016, p.89
- Ibidem, p.94
- Cfr. M. Bookchin, L'ecologia della libertà, Elèuthera, Milano, 2010, p.488. In particolare Bookchin afferma: “Finchè l'umanità è stata libera di esprimere la soggettività della natura e i significati che sono in essa latenti, la natura stessa ha rivelato tramite l'umanità la propria voce, la propria soggettività, la propria fecondità.” In tal modo Bookchin non fa che ribadire l'assunto (specista) secondo il quale l'umano rappresenti il vertice dell'evoluzione e l'unica specie in grado di far parlare la natura tramite, ovviamente, i suoi attributi specie-specifici (razionalità, linguaggio, arte ecc...)
- Cfr. S. Best, Liberazione totale, Ortica Editrice, Aprilia, 2017, pp.165-169
- Cfr. M. Piracci, Anarchia verde. Murray Bookchin e John Zerzan a confronto, Edizioni Bepress, 2016, p.98
- Ibidem, p.100
- Ibidem, p.101
- Ibidem, p.105
- Ibidem, p.105
Antropologia/
I mille modi dell'abitare
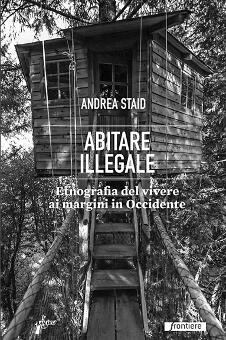 Il
ricco ha il tetto doppio. Così recita un detto andino,
ricordandoci come spesso coloro che una casa la sanno costruire
non hanno mai avuto un tetto proprio sulla testa; al contrario
di altri, che invece ne possiedono una insensatamente grande.
Realtà inconfutabile, e non solo nelle periferie sovrappopolate
di una delle tante megalopoli latinoamericane. Sembrerebbe infatti
esistere una tendenza inarrestabile a trasformare le città
in anonimi spazi densamente urbanizzati, funzionali più
alla perpetrazione di logiche di controllo e profitto che alla
vita dei loro abitanti. Da un lato periferie cementifere, sovrappopolate
e malsane; dall'altro, edifici lussuosi, giardini verticali
e tutte le comodità concesse dal privilegio. Eppure,
a dispetto di tale nocività, le città crescono
costantemente e la maggior parte della popolazione mondiale
vive o gravita intorno alle periferie di un grande insediamento
urbano. Il
ricco ha il tetto doppio. Così recita un detto andino,
ricordandoci come spesso coloro che una casa la sanno costruire
non hanno mai avuto un tetto proprio sulla testa; al contrario
di altri, che invece ne possiedono una insensatamente grande.
Realtà inconfutabile, e non solo nelle periferie sovrappopolate
di una delle tante megalopoli latinoamericane. Sembrerebbe infatti
esistere una tendenza inarrestabile a trasformare le città
in anonimi spazi densamente urbanizzati, funzionali più
alla perpetrazione di logiche di controllo e profitto che alla
vita dei loro abitanti. Da un lato periferie cementifere, sovrappopolate
e malsane; dall'altro, edifici lussuosi, giardini verticali
e tutte le comodità concesse dal privilegio. Eppure,
a dispetto di tale nocività, le città crescono
costantemente e la maggior parte della popolazione mondiale
vive o gravita intorno alle periferie di un grande insediamento
urbano.
Uno scenario che sembra presagire una tendenza all'omogeneizzazione,
all'isolamento, alla naturalizzazione di precise forme abitative,
il più delle volte imposte. Discorso chiuso? Non esattamente.
Esistono infatti realtà, dentro e fuori le città,
che sovvertono queste logiche e intaccano l'idea di una presunta
– e per molti auspicabile – uniformità, anche
all'interno dei muri dell'Occidente benestante. Ciò avviene
attraverso l'appropriazione di spazi collettivi, la creazione
di esperienze abitative autonome e la valorizzazione di luoghi
complessi che sfuggono alla ripetizione seriale, perché
espressione di coloro che vi abitano.
Sono proprio queste realtà, veri e propri «avamposti
d'ipotesi sociali», che Andrea Staid indaga nel suo libro
Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente
(Milieu edizioni, Milano 2017, pp. 182. € 14,90); e lo
fa servendosi di una sensibilità etnografica che dialoga
con i protagonisti, restituendo al lettore le voci di quanti
oggigiorno animano esperienze che rifiutano l'omologazioni e
disinnescano le pressioni normalizzanti.
Se l'abitare non è semplicemente l'atto di risiedere
in un luogo, bensì un processo attivo di sperimentazione,
allora la volontà di occupare e condividere uno spazio
che chiamiamo casa – come raccontano alcuni occupanti
a Milano, Barcellona e Berlino – oppure l'esperienza di
autocostruzione usando mani e creatività – come
per Lauren e Logan al Black Butte Center For Railroad Culture
in California – acquistano una carica rivoluzionaria che
si scontra con la cultura dominante sull'abitare.
Certo, non tutti i margini però sono uguali. E Staid
lo precisa lucidamente, senza indulgere a facili romanticismi;
bensì evidenziando come esista una distinzione fondamentale
tra chi questi luoghi marginali li vive per scelta e quanti,
invece, vi si trovano costretti, in attesa di attraversare una
frontiera o confinati per necessità in un campo, come
nella Jungle di Calais o nel Ghetto di Foggia.
Nonostante questa importante distinzione, sembra però
esistere un comune e insopprimibile desiderio di autodeterminazione
che avvicina realtà spesso diverse tra loro, e che si
traduce nella costruzione condivisa di spazi significativi in
grado di rinnovare continuamente se stessi, rifiutando in modo
radicale la cristallizzazione e sovvertendo ogni ordine formale.
É Sandy, che risiede in un campo rom e sinti a Pavia,
a spiegare con estrema efficacia come l'animato dibattito circa
le strategie più efficaci di inclusione sociale non possa
prescindere da una ridefinizione del concetto stesso di abitare.
La vita del campo mette spesso in luce criticità e problematiche
legate alle condizioni precarie o alla esiguità dei servizi,
delle quali un certo tipo di immaginario si è costantemente
alimentato per rifiutare una realtà assai più
complessa, fatta di villaggi ed esperienze di costruzione autogestita.
Se la retorica del superamento del campo è da molti suoi
abitanti vista con diffidenza, è proprio perché
questa nega il diritto di costruirsi da sé una casa,
di risiedere in spazi aperti e di viverli in comunità.
|
| Barcellona - Casa occupata |
I temi dell'autocostruzione e della gestione condivisa che
caratterizza ecovillaggi e comuni, esperienze nate da un profonda
riflessione critica circa il sistema economico neoliberista
e i suoi effetti a livello sociale e ambientale, dimostrano
tutto il loro valore anche in contesti di emergenza, come ci
insegna l'esperienza di Mina e di altri che, come lei, dopo
il sisma emiliano hanno creduto nella ricostruzione autonoma
organizzata collettivamente.
|
| Berlino - Teepee land
(foto di Francesca Cogni) |
Tutti questi esempi ci parlano in modo estremamente diretto:
ognuno di noi contribuisce con la propria specificità
alla costruzione, tanto fisica quanto sociale, del luogo che
abita. Riconoscere questo fondamentale apporto significa non
rinunciare alla diversità e a tutto il potenziale di
trasformazione che fa dell'abitare un processo mai concluso.
Proprio questo, forse, è uno degli spunti di riflessione
più efficaci che emerge dallo straordinario arcipelago
di vite ai margini descritto da Andrea Staid, esperienze che
non hanno rinunciato alla spontaneità, alla costruzione
diretta di soluzioni concrete e alla conflittualità che
si cela in una processo meravigliosamente instabile. Come trattò
di evidenziare con il proprio lavoro l'architetto Giancarlo
de Carlo, è proprio la scintilla del conflitto che il
discorso egemonico sull'abitare ha provato a spegnere. L'obiettivo,
perseguito tenacemente, è di pacificare, limitare o reprimere
l'appropriazione di spazi collettivi, che si alimentano del
confronto costante tra gli attori coinvolti e la cui forza dimora
in una irriducibile complessità.
Ma qual è allora il modo migliore di abitare una città,
un territorio, un luogo? Come per una casa, anche in questo
caso la risposta migliore non può essere prefabbricata
– e il libro di Andrea Staid ce lo dice chiaramente! –
ma si costruisce attraverso una discussione collettiva e nell'esplorazione
di tutte le risorse offerte dal disordine e dalla spontaneità.
Emanuele Fabiano
Alabastrai a Volterra/
“Ostenta un fiocco nero svolazzante”
Le vicende di cui si occupa questa recensione si può
dire che siano tornate alla luce anche grazie ad “A-rivista
anarchica”, quando un paio d'anni fa pubblicò un
articolo sull'anarchismo
a Volterra (“A” 400, estate 2015).
Quell'articolo fu letto da Viviane, nipote di Erminia Del Colombo
e Guelfo Guelfi, che prese poi contatto col Collettivo Distillerie,
associazione volterrana che da anni si occupa della riscoperta
e valorizzazione del mondo degli alabastrai, con particolare
attenzione alla loro spiccata vocazione libertaria.
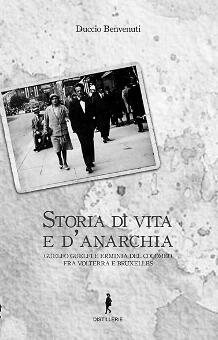 A
quel contatto sono seguite lettere, telefonate, scambi di foto
e documenti, incontri che hanno portato ad iniziare un progetto
di ricerca sull'anarchico volterrano Guelfo Guelfi, alabastraio
e scultore, e sulla sua compagna Erminia Del Colombo, in cui
elemento centrale è stato il viaggio a Bruxelles del
Collettivo Distillerie per incontrare e conoscere direttamente
la famiglia Guelfi, le tante opere di Guelfo e i luoghi dove
Erminia e lo scultore dal fiocco nero avevano trascorso la maggior
parte della loro vita. Del non facile riassunto di queste vite
militanti si è poi fatto carico Duccio Benvenuti, ampliando
e proseguendo le ricerche e concretizzandole nel volume qui
recensito Storia di vita e d'anarchia. Guelfo Guelfi e Erminia
Del Colombo fra Volterra e Bruxelles (Edizioni Distillerie,
Volterra 2016, pp. 72, € 10,00). A
quel contatto sono seguite lettere, telefonate, scambi di foto
e documenti, incontri che hanno portato ad iniziare un progetto
di ricerca sull'anarchico volterrano Guelfo Guelfi, alabastraio
e scultore, e sulla sua compagna Erminia Del Colombo, in cui
elemento centrale è stato il viaggio a Bruxelles del
Collettivo Distillerie per incontrare e conoscere direttamente
la famiglia Guelfi, le tante opere di Guelfo e i luoghi dove
Erminia e lo scultore dal fiocco nero avevano trascorso la maggior
parte della loro vita. Del non facile riassunto di queste vite
militanti si è poi fatto carico Duccio Benvenuti, ampliando
e proseguendo le ricerche e concretizzandole nel volume qui
recensito Storia di vita e d'anarchia. Guelfo Guelfi e Erminia
Del Colombo fra Volterra e Bruxelles (Edizioni Distillerie,
Volterra 2016, pp. 72, € 10,00).
Non lo si consideri un lavoro di mera storia locale, perché
leggendo questa ricerca ci si ritroverà ad attraversare
l'intero novecento e le vicende cruciali che hanno segnato tutta
l'Europa nel secolo breve. E, attraverso la vita della
famiglia Guelfi, si avrà anche una preziosa e originale
testimonianza delle attività del movimento anarchico
nelle lotte sociali e antimilitariste di primo novecento, nell'opposizione
al nascente fascismo, nella prosecuzione delle lotte contro
il regime di Mussolini nell'esilio antifascista all'estero,
nell'impegno nella Rivoluzione libertaria della Spagna del '36,
nella Resistenza al nazifascismo e nella ripresa delle attività
nel secondo dopoguerra. La militanza libertaria per Guelfo Guelfi
inizia nel Gruppo Germinal di Volterra, le carte di polizia
ci parlano di questo giovanissimo che “sempre ostenta
al collo un fiocco nero svolazzante”, mentre diffonde
Volontà o distribuisce manifestini antimilitaristi
contro la Prima Guerra mondiale e in solidarietà coll'anarchico
Masetti, che aveva rivolto il fucile contro i propri ufficiali.
L'arrivo del fascismo e il consolidarsi del regime costringono
Guelfo ad espatriare in Belgio, dove trova lavoro come scultore
e dove Erminia e i figlioli lo raggiungeranno. Duccio Benvenuti
ha saputo rendere bene al lettore l'atmosfera della capitale
belga di quegli anni, in cui i Guelfi si vengono a trovare e
con cui iniziano ad interagire nelle sue diverse dimensioni,
quella politica del fuoriuscitismo antifascista, quella dei
lavoratori immigrati, ma anche quella artistica e culturale.
C'è un luogo che ben riassume tutto ciò ed è
la Maison du Peuple o Maison des huit heures
(la durata della giornata lavorativa), lì si incontrano
gli anarchici e i socialisti, si organizzano raccolte di fondi,
momenti di convivialità e di solidarietà, si ragiona
di politica e si preparano iniziative antifasciste.
La Bruxelles di quegli anni è un crocevia di militanti
antifascisti e libertari italiani ed europei, da Camillo Berneri
ad Hem Day, vi si stampa anche un giornale anarchico in lingua
italiana, Bandiera nera. Tante e diverse sono le figure
di compagni con cui la vita militante di Erminia e Guelfo si
incrocia e che frequentano la loro casa nel quartiere di Schaerbeek:
Mario Mantovani, Vittorio Cantarelli, Pietro Montaresi, solo
per citarne alcuni. Nomi che ritroviamo nei racconti della figlia
Ovidia e che Benvenuti fedelmente riporta, con particolari che
magari nelle schede di questura non avremmo trovato, come la
grande passione di Montaresi per la bicicletta. Segue poi il
triste racconto della separazione di Guelfo dalla famiglia nel
1941, arrestato dai tedeschi e ricondotto in Italia, incarcerato
a Volterra. Ma la famiglia, fortunatamente, poi si ricongiungerà.
|
| Opera di Guelfo Guelfi al cimitero
monumentale di Schaerbeek – Bruxelles |
L'attività artistica di Guelfo Guelfi dà prove
straordinarie ad esempio nelle opere che si trovano nel cimitero
monumentale di Schaerbeek e delle quali Benvenuti riporta anche
le interpretazioni psicanalitiche di Luc Richir. Ma Guelfi mise
la propria arte anche al servizio del movimento anarchico e
operaio. Prova ne sono la lapide di Nestor Machno al Père-Lachaise
di Parigi o quella di Francisco Ferrer a Volterra. Quest'ultima
viene apposta nel 1969, su iniziativa del Gruppo anarchico Germinal,
con una manifestazione popolare ed unitaria a cui parteciperà
Umberto Marzocchi. E quella sarà l'ultima volta che Guelfo
rivedrà la sua città natale. La narrazione di
quella memorabile giornata verrà riportata sull'intera
terza pagina di Umanità Nova (Francisco Ferrer ricordato
a Volterra nelle sue opere e nel suo sacrificio, «Umanità
nova», n. 38, 25 ottobre 1969, p. 3).
|
|
|
|
|
Da sinistra, in senso orario: Guelfo Guelfi (a sinistra) apprendista a sedici anni;
Guelfo Guelfi ventenne; Guelfo Guelfi, foto segnaletica dell'arresto del 1941 |
Erminia e Guelfo sarebbero di certo contenti nel vedere come
quella lapide sia ancor oggi viva, dato che da qualche
anno gli anarchici e i libertari volterrani sono tornati a festeggiare
il 1° maggio, colle loro bandiere e le loro canzoni, recandosi
ad apporre un mazzo di garofani rossi a fianco dell'immagine
del pedagogo e rivoluzionario catalano.
Pietro Masiello
reclusvod@gmail.com
Massimo La Torre/
Trent'anni di studi su anarchismo, diritto, liberalismo
 L'ultimo
lavoro di Massimo La Torre, filosofo del diritto e studioso
del pensiero anarchico e antiautoritario (Nostra legge è
la libertà. Anarchismo dei moderni, DeriveApprodi,
Roma 2017, pp. 288, € 20,00) ci propone una cavalcata attraverso
il “canone” dell'anarchismo dei moderni,
avvertendo però il lettore come di canone in senso stretto
non si possa correttamente parlare (pp. 13-14), dato che il
pensiero anarchico sviluppatosi sul finire del secolo dei Lumi
si articola attraverso molteplici declinazioni, a volte fra
loro distanti, che ritrovano un comune denominatore non certamente
nell'ossequio ad una linea di pensiero predefinita (quella sorta
di ipse dixit che caratterizza ad esempio la prospettiva
marxista), piuttosto in un radicale “dubbio metodologico
cartesiano” (p. 225). Attraverso questo spettro è
possibile collegare pensatori distanti sia da un punto di vista
cronologico (dalla fine del Settecento sino al Novecento inoltrato),
che contenutistico (dall'individualismo stirneriano al comunismo
bakuniniano per giungere, attraverso Proudhon e Kropotkin, ad
analizzare il controverso rapporto fra Malatesta e Merlino volgendo
lo sguardo verso l'anarchismo attualista di Berneri). L'ultimo
lavoro di Massimo La Torre, filosofo del diritto e studioso
del pensiero anarchico e antiautoritario (Nostra legge è
la libertà. Anarchismo dei moderni, DeriveApprodi,
Roma 2017, pp. 288, € 20,00) ci propone una cavalcata attraverso
il “canone” dell'anarchismo dei moderni,
avvertendo però il lettore come di canone in senso stretto
non si possa correttamente parlare (pp. 13-14), dato che il
pensiero anarchico sviluppatosi sul finire del secolo dei Lumi
si articola attraverso molteplici declinazioni, a volte fra
loro distanti, che ritrovano un comune denominatore non certamente
nell'ossequio ad una linea di pensiero predefinita (quella sorta
di ipse dixit che caratterizza ad esempio la prospettiva
marxista), piuttosto in un radicale “dubbio metodologico
cartesiano” (p. 225). Attraverso questo spettro è
possibile collegare pensatori distanti sia da un punto di vista
cronologico (dalla fine del Settecento sino al Novecento inoltrato),
che contenutistico (dall'individualismo stirneriano al comunismo
bakuniniano per giungere, attraverso Proudhon e Kropotkin, ad
analizzare il controverso rapporto fra Malatesta e Merlino volgendo
lo sguardo verso l'anarchismo attualista di Berneri).
Un volume d'interesse, sia per la precipua ricostruzione della
prospettiva anarchica, che per un ricco e non sempre usuale
apparato bibliografico con ampi riferimenti alla letteratura
straniera.
La Torre raccoglie, rielabora e ricollega in questo volume una
serie di studi apparsi nel arco di più di un trentennio
presentando al lettore il pensiero anarchico in tutta la sua
complessità ed in tutte le sue (principali) sfaccettature;
e lo fa (anche) con un intento giustamente polemico nei confronti
della letteratura accademica ufficiale, che o non menziona affatto
l'anarchismo quale dottrina politica da annoverarsi tra le prospettive
di pensiero occidentali, oppure ne offre delle rappresentazioni
alquanto pittoresche o, ed è questo il caso della
storiografia marxista, del tutto strumentali e fuorvianti.
Quel dibattito tra Malatesta e Merlino
L'anarchismo preso sul serio implica, come La Torre sottolinea, il collocarsi al centro della modernità politica e giuridica ed in particolare problematicizzare “le pretese di comando dell'autorità politica”, porre in radicale discussione la legittimità dell'ente Stato, così come si è venuto concretamente a costituirsi dalla rivoluzione francese in poi. Il libro offre dignità scientifica alla nostra corrente di pensiero che non è teorizzazione di caos antisociale, né vano richiamo ad idilliache e bucoliche utopie, ma precisa e coerente problematizzazione del potere e della gestione sociale su questo fondata. Un pensiero che sin dal suo sorgere ha posto in discussione ogni assioma di domino, primo fra tutti – ed è questo il caso di Godwin – il domino dell'uomo sulla donna. Un pensare anarchico proteso irresistibilmente verso la libertà; Nostra legge è la libertà, titola il volume.
Certo la prospettiva anarchica non appare lineare, molte volte quando si incarna nella realtà sociale offre delle risposte non soddisfacenti – si leggano in proposito le pagine dedicate allo scontro fra Malatesta e Merlino vuoi sulla questione elettorale, vuoi sulla questione criminale. Qui l'autore pare esca dal ruolo di osservatore non partecipante, di puro ed obiettivo testimone degli avvenimenti, per assumere (forse involontariamente) i panni del polemista, schierandosi di fatto con uno dei contendenti: l'avvocato partenopeo.
Vi è una tensione sotterranea che offre energia al lavoro di La Torre, una tensione data dalla ricerca, all'interno dell'intelligente riproposizione del pensiero anarchico classico, d'una via verso l'anarchia possibile, più che un'esaltazione dell'anarchia completa. Un percorso questo che necessariamente per l'autore passerebbe attraverso l'opera di Merlino.
La ricerca di risposte alla nodale questione: “è possibile un anarchismo politico che [...] possa pensare alla società come a una struttura retta da norme?” (p. 228), deve avvenire nel terreno solcato da Merlino, il quale (se l'anarchismo si rifà alla tradizione della democrazia classica – l'isonomia ateniese in buona sostanza, p. 200) “più che una revisione dell'anarchismo ne rappresenta piuttosto la restaurazione «repubblicana». Invece di un «tradimento» – come si affettano a sentenziare i puri di «partito» – è la riconferma di antiche dimenticate fedeltà. [...] La morale merliniana è così ricerca delle norme, non rivolta contro queste, volontà di limite, non di potenza” (p. 201 e 204). Si intravvede pertanto nel pensiero di Merlino una necessità, pienamente colta (e, forse, accolta) da La Torre, di dialettizzarsi con le istituzioni politiche, al fine di organizzare in autonomia la vita sociale. La politica non è insolubilmente legata alle dinamiche di potere, “è piuttosto discorso o prassi, dibattito o controversia e anche lotta ovviamente, intorno alla produzione e alla applicazione delle norme di una comunità e più in generale intorno alla determinazione dei contenuti della «buona vita» di questa (altrimenti detto bene collettivo)” (p. 218).
Per la comprensione del pensiero anarchico
In questo vi sarebbe una stridente incompatibilità con una prospettiva romantica, incarnate ad esempio da Bakunin, che vedrebbe, all'incontrario, nella politica l'esplicazione del domino. Prospettive divergenti, quindi non accomunabili sotto un unico canone, che non sia, come già osservato, la radicale problematizzazione della legittimità del potere. Il lettore (anarchico) è indotto a riflettere sui nodi centrali ponendolo di fronte a ineludibili domande e, a volte, a sorprendenti – nel senso di inusuali – tratteggi. Si veda il riferimento (esplicito) al pensiero classico (aristotelico, direi), quanto si argomenta intorno all'idea di giustizia in Merlino (e, implicitamente, nell'anarchismo – stessi riferimenti si riscontrano nelle parti dedicate a Proudhon): “il giusto per il Nostro ha a che fare con la questione della convivenza. È ciò che rende possibile il bene, la persecuzione dei piani di vita individuali e collettivi e la realizzazione di ciò che individui e gruppi ritengono essere la loro «buona vita»” (p. 210).
Un contributo importante quello offerto da La Torre alla comprensione (ed alla diffusione) del pensiero anarchico, che pur tuttavia lascia un inquietante dubbio.
L'anarchismo dei moderni è o meno di schietta derivazione liberale? Ovvero, fermo restando il sorgere dell'anarchismo nella modernità politica (l'era che vede l'imporsi della forma Stato quale unico modello di gestione sociale), questo è pensiero politico moderno alla stessa stregua del liberalismo e del socialismo (che concorrono a fondare – sia pur in diverso modo – l'assolutismo dello Stato), oppure si colloca in una prospettiva diversa, quindi non riconducibile a quella modernità politica che si coagula intorno al binomio politica-potere?
La Torre pare optare per la piena complementarietà del liberalismo e dell'anarchismo; di fatto apre e chiude il suo lavoro argomentando a favore della stessa (“il liberalismo annuncia l'anarchismo [...] il liberalismo è il punto di arrivo di motivi anarchici”, p. 15; “l'anarchismo è [...] in misura eminente critica e superamento del liberalismo mediante il liberalismo stesso”, p. 242), e nel bel mezzo rileva come “si è detto talvolta che gli anarchici sono solo dei «liberali impazziti». Ora, se quell'«impazzito» lo si intende come «estremo» o «radicale», non potrebbe esservi una valutazione più acuta dell'anarchismo” (p. 70).
Però è lo stesso autore a suggerirci come “per il liberalismo, a differenza dell'anarchismo, il potere è un dato, non un problema, una necessità, non una eventualità. Si può discutere della sua giustificabilità, ma la sua struttura ontologica è assunta come perenne, niente affatto capace di destrutturazione o di riforma” (p. 26), per cui, “i princìpi liberali valgono per le relazioni tra privati [...] ma dentro il recinto del potere politico [...] essi decadono. In quest'àmbito rimane vigente il principio di autorità” (p. 25). Infatti, “la filosofia politica liberale, quella eminentemente moderna, ha uno spinoso problema da risolvere. Come rendere possibile che il potere politico sia soggetto al diritto [...] l'ostacolo contro cui urta è la concezione del diritto come comando, e comando di un superiore politico [...] che non riconosce superiori a lui superiori” (p. 228). Ecco comparire l'idea di sovranità che pervade e qualifica tutta la modernità politica, ma che non intacca in alcun modo l'anarchismo. Pare dunque che anarchismo e liberalismo si collochino su orizzonti diversi, collegati solo da una dimensione temporale.
Pertanto, nel delineare i rapporti fra anarchismo e liberalismo, quindi tra il primo e la modernità politica è bene procedere con cautela al fine di evitare quelle Blendungen che hanno fatto perdere al povero sinologo Kien (p. 45) l'intera biblioteca in un autodafé! Ma questa è questione che riguarda tutti i lettori dell'ottimo libro di La Torre.
Marco Cossutta
Agricoltura/
Salerno, la Piana del Sele, ricordando Danilo Dolci
Il saggio di Gennaro Avallone, Sfruttamento e resistenze.
Migrazioni e agricoltura in Europa, Italia, Piana del Sele
(Ombre Corte, Firenze 2017, pp. 136, € 13,00), partendo
dalla constatazione che «l'agricoltura neoliberale si
muove in spazi transnazionali e si articola attraverso enclave
globali di produzione inserite in catene di trasformazione e
distribuzione definite da specifici rapporti di potere al loro
interno», si propone di indagarne le caratteristiche e
i problemi relativamente all'area europea in generale, a quella
italiana in particolare e alla zona della Piana del Sele, nel
Sud Italia, in modo più diretto e partecipato, con una
ricerca sul campo.
 Precisando,
della sua analisi, che «l'agricoltura è stata osservata
concentrandosi sulla produzione, cioè sui rapporti sociali
tra gli uomini e le donne che all'agricoltura danno corpo, assumendo
l'idea, teorica e metodologica che è il lavoro che fa
l'agricoltura, è il lavoro in carne ed ossa che produce
il cibo, prima che venga assorbito dal marketing e subordinato
ai super profitti delle grandi imprese nazionali o multinazionali
finanziarizzate», Avallone punta l'attenzione sul lavoro
dei migranti, tanto determinante nella produzione agricola e
nel profitto che ne deriva quanto volutamente misconosciuto
e brutalmente sfruttato. Il cambiamento, sempre più marcatamente
globalizzato e capitalistico del lavoro agricolo, che ha dissolto
le antiche e piccole forme di conduzione familiare dei campi,
ha favorito la formazione di grandi aziende che producono localmente
per un mercato globale, il cibo essenziale alla vita. Precisando,
della sua analisi, che «l'agricoltura è stata osservata
concentrandosi sulla produzione, cioè sui rapporti sociali
tra gli uomini e le donne che all'agricoltura danno corpo, assumendo
l'idea, teorica e metodologica che è il lavoro che fa
l'agricoltura, è il lavoro in carne ed ossa che produce
il cibo, prima che venga assorbito dal marketing e subordinato
ai super profitti delle grandi imprese nazionali o multinazionali
finanziarizzate», Avallone punta l'attenzione sul lavoro
dei migranti, tanto determinante nella produzione agricola e
nel profitto che ne deriva quanto volutamente misconosciuto
e brutalmente sfruttato. Il cambiamento, sempre più marcatamente
globalizzato e capitalistico del lavoro agricolo, che ha dissolto
le antiche e piccole forme di conduzione familiare dei campi,
ha favorito la formazione di grandi aziende che producono localmente
per un mercato globale, il cibo essenziale alla vita.
Ma per quanto queste siano ultrameccanizzate e ipertecnologizzate,
hanno bisogno di una rilevante quantità di manodopera:
oggi, questa è costituita in gran parte da migranti,
perché ha un costo bassissimo dato che sfrutta la loro
condizione di clandestini, la loro necessità di avere
una retribuzione, seppure insufficiente e iniqua, la loro speranza
di ottenere, un giorno, cittadinanza e diritti, in quanto uomini,
indipendentemente dal loro “stato” economico. Avallone
indaga i meccanismi della produzione, della distribuzione e
del consumo dei beni che provengono dall'agricoltura, diventata
ormai mondiale e ormai migrante. E, a paradigma di tale assunto,
Avallone pone al centro del suo testo e al centro della sua
ricerca, le risultanze dell'indagine, condotta in pesa diretta,
nel salernitano, nella Piana del Sele.
La realtà e le caratteristiche dello sfruttamento e dell'illegalità
(lavoro nero e sottopagato, assenza di diritti e tutele, anzi...
minacce e soprusi) che regna sovrana, in quest'ampia pianura,
a sud di Salerno, vengono fuori dalle parole degli stessi migranti,
intervistati da Avallone, che, alla maniera di Danilo Dolci
(quando, negli anni '50 andava ad osservare e faceva conoscere
la miseria e la sofferenza dei contadini siciliani), ha voluto
raccogliere dalla loro viva voce, i dati e le notizie sulla
loro vita e la loro storia, sulle condizioni del loro lavoro
e sulle aspettative, i desideri e i sogni che li hanno spinti,
spesso a rischio della vita, a lasciare terre lontane (India,
Marocco, Ucraina, Romania) per venire disumanamente smistati
e impiegati - spesso dal caporalato, che nella Piana del Sele
impera - nelle aziende agricole e zootecniche che produrranno
ortaggi e latticini - tra l'altro - che assicureranno tanta
ricchezza a pochi e grandi proprietari e una mera e sempre precaria
sussistenza a loro.
Il documentato saggio di Avallone, mostra e denuncia le politiche
mondiali ed europee che tutelano e valorizzano, dell'agricoltura,
i capitali e la terra e non gli uomini che la lavorano, togliendo
doppiamente l'esistenza e l'identità ai migranti, non
considerati come lavoratori, non riconosciuti come cittadini:
costretti, quindi, ad una legittima difesa e resistenza, che,
però, trovando solamente un debole e insufficiente aiuto
e supporto organizzativo nei sindacati, si concretizza quasi
esclusivamente nella “mobilità”, nell'abbandonare
il campo, la terra, l'azienda dove lo sfruttamento diventa esasperante
e insopportabile, per offrire la propria forza lavoro in altri
luoghi, in altre campagne o allevamenti, ad altri padroni. La
necessità, quindi, che i migranti occupati nelle campagne
europee vengano aiutati a dare forma organica e strutturata
alla rivendicazioni dei diritti, a loro negati in ragione del
profitto o della xenofobia retriva e razzista, è attuale
e urgente.
Anche in considerazione del fatto che, soprattutto nel meridione
d'Italia, i migranti sono generalmente e “normalmente”
considerati, ormai, «una sorta di bancomat delle società
ed economie locali», un'utile riserva di «manodopera
a basso costo» e di «consumatori redditizi di beni
- quali, ad esempio, gli alloggi - altrimenti senza mercato
o con mercato ridotto».
Silvestro Livolsi
convegno su educazione e libertà
domenica
22 ottobre • Castel Bolognese (Ra)
Teatrino del vecchio mercato, via
Rondanini 19
sessione del mattino / ore 9.30-13
Andrea Papi
Primi passi: dal seme al fiore
Francesco Codello
L'educazione libertaria: dalla storia all'attualità
Giulio Spiazzi
Un cammino nell'educazione libertaria: dalla scuola autogestita
alla comunità auto-educante non adulto-centrica
Raffaele Mantegazza
La scuola dei borghesi si abbatte e non si cambia. O no?
sessione del pomeriggio / ore
14.30-17
Filippo Trasatti
Mirabili contraddizioni: esperienze di libertà
in uno spazio chiuso
Maurizio Giannangeli
L'educazione che ribolle: 10, 100, 1.000 scuole
Thea Venturelli
I fiori delle comunarde a Urupia
dibattito / dalle ore 17 ad esaurimento
info: papiandrea1221@gmail.com |
|

