|
Parecchie decine di
migliaia di prigionieri, accusati di aver partecipato al genocidio
del 1994, marciscono nelle carceri ruandesi. Il caso del Ruanda
è unico al mondo a causa della natura dell’accusa,
del numero dei detenuti in rapporto alla popolazione –
il Ruanda detiene il rapporto percentuale più elevato
del mondo – e alla capienza del sistema penitenziario,
e della quasi totale distruzione dell’apparato giudiziario
dovuta al genocidio e alla guerra che ne è seguita. Quattro
anni dopo il genocidio, c’erano ancora 130.000 detenuti.
Un certo numero è stato liberato, naturalmente, ma pochi,
e si continua ad arrestarne altri. Nel 2002 la situazione carceraria
in Ruanda era praticamente identica a quella della fine del
1994 ed è destinata a durare.
Le autorità, nell’intento di trovare una soluzione
a questo rompicapo, hanno inviato la direttrice dell’amministrazione
penitenziaria dell’epoca a rappresentare il Ruanda al
seminario panafricano di Kampala sulle condizioni di detenzione
in Africa, organizzato da Penal Reform International
nel settembre 1996. Ma il primo contatto diretto tra la PRI
e lo Stato ruandese si è verificato soltanto nell’aprile
1997, dopo che la Commissione europea ci aveva chiesto di inviare
una missione sul posto, al fine di studiare la possibilità
di dare un contributo all’amministrazione penitenziaria
nella gestione del sistema carcerario del Paese. Tale missione
ha consentito alla PRI di constatare l’esistenza di un’autentica
volontà politica delle autorità ruandesi ad affrontare
la questione, cosa che l’ha convinta a intervenire, tanto
più che l’Unione europea, cui si sono ben presto
aggiunti britannici, olandesi, svizzeri e svedesi, ha fornito
i mezzi per farlo.
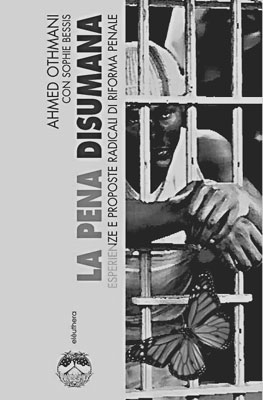 |
 Situazione abnorme
Situazione abnorme
Questa missione ha portato alla luce un’abnorme situazione
carceraria. In Ruanda ci sono diciannove centri di detenzione
ufficiali, più una moltitudine di altri definiti “galere”.
I diciannove centri, distribuiti su tutto il territorio, funzionano
come prigioni centrali e sono posti sotto la sorveglianza di
militari smobilitati con la sovrintendenza dei servizi di sicurezza
militare; per questi motivi l’amministrazione penitenziaria
non ha avuto accesso a tali strutture, almeno nei primi anni.
Gli altri luoghi di detenzione, organizzati in edifici di fortuna
nel periodo dell’emergenza, sono totalmente sprovvisti
di infrastrutture adeguate. Inizialmente si prevedeva che queste
sarebbero state strutture provvisorie, ma con il passare degli
anni si sono trasformati in carceri permanenti. Poiché
ospitano migliaia di persone (vi risiede metà della popolazione
carceraria), sono diventati immondezzai a cielo aperto e una
autentica catastrofe per l’ambiente. A causa delle tonnellate
di rifiuti accumulati, da quelle zone si sprigiona un odore
pestilenziale che si avverte a chilometri di distanza. A ciò
bisogna aggiungere che il personale penitenziario, composto
perlopiù da militari smobilitati, ignora pressoché
tutto delle mansioni cui dovrebbe ottemperare, rivelandosi del
tutto incompetente.
Nessuna prigione dispone di personale qualificato, e il poco
disponibile è del tutto insufficiente: solo 300 guardie
adibite alla sorveglianza di più di 100.000 detenuti!
Il carcere di Nsinda, per esempio, che da solo rinchiude 12.000
persone, è sorvegliato e gestito solo da 40 persone,
dal direttore al piantone! Per rendere la propria quotidianità
meno insopportabile, i detenuti si sono dedicati di propria
iniziativa all’agricoltura, coltivando i campi fino a
40 chilometri attorno alla prigione e vendendo i prodotti nel
mercato più vicino. Con il ricavato delle vendite hanno
persino acquistato un camion. La prigione è in effetti
organizzata come una vera e propria autogestione e, malgrado
la scarsezza di guardie, sono state registrate pochissime evasioni.
Dal che si deduce che la maggior parte dei detenuti non è
composta da individui da tenere per forza di cose sotto chiave.
Inizialmente l’amministrazione penitenziaria era ridotta
all’osso: la direttrice disponeva soltanto di tre collaboratori.
I mezzi sono sempre stati drammaticamente esigui. All’epoca
della mia prima visita, i detenuti non ricevevano i pasti. Quelli
delle prigioni ufficiali erano totalmente a carico del CICR
(Comitato Internazionale della Croce Rossa, N.d.R.).
Ancora nel 2001 quest’ultimo forniva la metà del
vitto delle diciannove carceri centrali, mentre gli altri detenuti
erano nutriti totalmente dalle famiglie. Infatti, all’epoca,
il CICR aveva rifiutato di farsene carico per non incoraggiare
il mantenimento di quelle strutture.
La situazione è leggermente migliorata dal periodo della
prima missione, ma è ancora lungi dall’essere normalizzata.
Le cose tuttavia si muovono, nonostante il fatto che nel 1999
le carceri siano passate sotto la tutela del ministero dell’Interno,
mentre prima dipendevano dal ministero della Giustizia. Con
l’aiuto internazionale il sistema giudiziario ha cominciato
a ricostituirsi, come la professione di avvocato. Nel 1995 in
Ruanda erano rimasti soltanto venticinque avvocati, dei quali
uno solo era hutu; per questo l’associazione Avocats
sans frontières si è fatta carico di una
parte della difesa degli accusati e delle vittime. Oggi gli
avvocati ruandesi sono più di sessanta.
 Condizioni deplorevoli
Condizioni deplorevoli
Ma, per il momento, soltanto 2.500 imputati sono stati processati,
una goccia d’acqua nell’oceano dei detenuti! La
lentezza è il problema più grave che la giustizia
ruandese deve affrontare. Nel frattempo centinaia di detenuti
muoiono ogni anno in prigione a causa delle condizioni di vita
deplorevoli, segnate principalmente dalla fame e dalle malattie
contagiose. Secondo fonti ufficiali, nelle carceri ruandesi
si registra ogni anno un totale di decessi stupefacente. E ci
sono poche speranze che il numero dei prigionieri diminuisca
in maniera significativa a breve termine.
La situazione è ancor più preoccupante in quanto,
dal 1994, il Ruanda non costruisce più alcun nuovo penitenziario.
Uno solo è stato ricostruito e altri sono stati ristrutturati
grazie all’aiuto internazionale, in particolare un carcere
femminile che si trovava in uno stato particolarmente deplorevole.
È in corso, con il finanziamento dei Paesi Bassi, la
costruzione di un grande complesso carcerario, destinato ad
accogliere i detenuti processati e condannati a pene di lunga
durata.
A partire dal gennaio 1998, la PRI ha cominciato a intervenire
concretamente per migliorare la situazione carceraria. La nostra
associazione ha prima di tutto provveduto a una formazione sistematica
del personale penitenziario, dalle guardie ai direttori. Grazie
allo smobilizzo di contributi finanziari, abbiamo consentito
all’amministrazione penitenziaria di assumere nuovo personale
specializzato, formato da noi. In questo modo tutte le carceri
hanno potuto disporre di cancellieri e contabili.
Poi abbiamo incoraggiato lo sviluppo di attività produttive
nelle carceri. In parecchie tali attività erano cominciate
prima del nostro arrivo, per iniziativa degli stessi detenuti,
intenzionati a mettere a frutto le proprie competenze e migliorare
il magro rancio. In tal modo, alcuni agronomi incarcerati hanno
cominciato a organizzare colture e allevamenti attorno ai centri
di detenzione. In altri luoghi, grazie all’esistenza di
specchi d’acqua, è stata privilegiata la piscicoltura.
Abbiamo anche contribuito allo sviluppo della produzione artigianale
in carcere, organizzando laboratori di falegnameria, sartoria,
autoriparazioni e dando ai prigionieri la relativa formazione
professionale.
Il nostro primo obiettivo è stato quello di professionalizzare
l’amministrazione e il personale penitenziario e di promuovere
lo sviluppo di attività produttive. Attualmente, la nostra
azione è entrata in una seconda fase, nel corso della
quale riduciamo il sostegno alle microattività produttive
per investire in progetti più importanti.
 Alternative
al carcere
Alternative
al carcere
Dal 2000 il governo ci ha interpellati per organizzare soluzioni
alternative al carcere. Infatti le autorità ruandesi
si sono rese conto che, se si lascia che le cose procedano senza
intervenire, il passaggio in giudizio di tutti gli imputati
occuperebbe parecchi decenni. Per questo stanno riportando in
auge procedimenti giudiziari tradizionali, chiamati gaccaca,
che consentiranno di accelerare i processi e di comminare pene
alternative al carcere. Con questo intento è stata votata
una legge, i cui decreti applicativi sono stati promulgati nell’agosto
2001. Tra le altre cose, la legge precisa che le persone che
confessano potranno godere di circostanze attenuanti e si vedranno
dimezzare la pena da scontare in carcere, mentre l’altra
metà sarà trasformata nell’obbligo a un
lavoro di pubblica utilità. Per la prima volta nella
storia, persone accusate di crimini contro l’umanità
saranno semplicemente condannate a pene sostitutive. La PRI
ha contribuito a concepire tale legge organizzando in Ruanda
un seminario con esperti provenienti da parecchi Paesi e partecipando
alla stesura del decreto applicativo sul lavoro di pubblica
utilità.
Il nostro intervento in Ruanda ha dunque cambiato natura, in
ragione dell’evoluzione delle necessità e delle
richieste delle autorità. C’è da sperare
che il ricorso a questa forma modernizzata di giustizia tradizionale
permetterà di chiudere le carceri di fortuna, liberando
gli imputati la cui colpevolezza non si è riusciti ad
accertare e trasferendo i condannati nelle prigioni normali.
 Ahmed Othmani
Ahmed Othmani
(tratto dal volume La pena disumana)

Ahmed
Othmani |
Elèuthera
Ahmed
Othmani con Sophie Bessis
LA
PENA DISUMANA
esperienze e proposte radicali di riforma penale
Prefazione di Giuliano Pisapia
Presentazione di Mary Robinson
144 pp. / euro 12,00
Ahmed
Othmani, tunisino, è stato torturato e incarcerato
(dal 1968 al 1979) per le sue idee politiche di sinistra.
Uscito di prigione si trasferisce a Parigi, dove segue
corsi universitari di Economia. Dal 1984 al 1989 è
il responsabile di Amnesty International per i Paesi arabi
e, dal 1991 al 1993, membro del Comitato esecutivo internazionale.
Nel 1989 partecipa alla fondazione della ong Penal Reform
International e ne diviene dapprima tesoriere e poi, dal
1994, presidente. È autore di varie pubblicazioni
sul tema dei diritti umani.
Sophie Bessis, storica e giornalista francese, è
autrice di vari libri, tra cui La Dernière
Frontière (Parigi, 1983) e L’Occident
et les autres (Parigi, 2001).
|
Ruanda:
L’eredità del genocidio e della guerra del
1994 ancora tutta da affrontare, denuncia Amnesty International.
A
dieci anni dai fatti del 1994, il genocidio, la guerra
e l’Hiv/Aids hanno prodotto una generazione di bambini
orfani che vivono in condizioni disperate e sono soggetti
ad abusi e sfruttamento.
Amnesty International ha diffuso oggi un rapporto (“Marchiate
per morire: le sopravvissute allo stupro con l’Hiv/Aids
in Ruanda”) in cui denuncia come gli scampati al
genocidio del 1994 rimangano terrorizzati e traumatizzati,
spesso ridotti ai margini della società e con scarso
accesso ai servizi medici.
“Le premesse per un ulteriore conflitto e per
l’insicurezza resteranno in piedi fino a quando
il governo del Ruanda non onorerà il suo proclamato
impegno a rispettare i diritti umani” –
ha affermato Amnesty International.
L’organizzazione per i diritti umani chiede al governo
ruandese e alla comunità internazionale di risarcire
e ricompensare le vittime del genocidio e di prendere
dovutamente in considerazione le richieste di giustizia
provenienti dal Ruanda. La comunità internazionale,
in particolare, dovrà dedicare risorse finanziarie,
tecniche e politiche alla protezione dei diritti umani
nel paese.
Nel 1994, la popolazione ruandese assistette a una delle
più orribili manifestazioni di violenza dello scorso
secolo. Fino a un milione di persone vennero uccise nel
corso del genocidio portato avanti dalle milizie interahamwe
e delle rappresaglie del Fronte patriottico ruandese.
Le sopravvissute allo stupro sono tra i gruppi più
colpiti dal genocidio. Secondo stime delle Nazioni Unite,
nel 1994 vennero perpetrati da 250.000 a 500.000 stupri.
Molte delle vittime soffrono oggi di malattie a trasmissione
sessuale, come il virus dell’Hiv/Aids, e nutrono
ben poca speranza di ricevere cure mediche o un risarcimento.
L’80% delle sopravvissute allo stupro è ancora
fortemente traumatizzata.
Sebbene l’accesso ai trattamenti medici sia migliorato
rispetto al passato, la grande maggioranza di queste donne
possono solo sperare che, una volta decedute, qualcuno
riesca a occuparsi dei loro figli. Amnesty International
chiede al governo del Ruanda di garantire, con l’aiuto
dei paesi donatori, la fornitura di cure mediche a tutte
le sopravvissute alla violenza sessuale.
È emblematica una delle storie raccolte da Amnesty
International nel corso delle sue missioni in Ruanda:
“Il mio primo marito venne ucciso nel corso del
genocidio, quando mio figlio aveva tre mesi. I miliziani
mi stuprarono. Quando seppi che avevo contratto il virus
dell’Hiv/Aids, il mio secondo marito divorziò
lasciandomi sola con tre figli. Ora non so dove trovare
i soldi per il cibo, l’affitto, la scuola. La mia
più grande preoccupazione è che cosa accadrà
ai miei figli se morirò”.
“Il Ruanda si trova di fronte a sfide enormi
nell’amministrazione della giustizia. Ciò
nonostante, senza indagare e punire le violazioni commesse
tanto dal governo genocida quanto da quello in carica
del Fronte patriottico ruandese, i diritti dei ruandesi
continueranno a essere violati e si creeranno le condizioni
per una instabilità e una impunità durature”.
Roma,
6 aprile 2004
Il
rapporto “Marchiate per morire: le sopravvissute
allo stupro con l’Hiv/Aids in Ruanda” è
disponibile presso il sito www.amnesty.org
e l’Ufficio stampa di Amnesty International Italia.
Per
ulteriori informazioni, approfondimenti e interviste:
Amnesty International Italia – Ufficio stampa
Tel. 06 4490224 - cell. 348-6974361 - email: press@amnesty.it
|
|

