|
Mi chiamo René Lourau e sono
attualmente professore di sociologia all'Università di
Paris 8, cioè un'università inaugurata nel '68
a Vincennes. Mi occupo ormai da molto tempo di un filone di
ricerca denominato "analisi istituzionale", in stretto
rapporto con l'autogestione e con le idee libertarie in quanto
si tratta di analisi e critica dello Stato.
È appunto nel '68 che ho cominciato queste ricerche,
quando ero assistente di Henri Lefevre all'Università
di Nanterre. È noto che molti degli eventi del '68 sono
cominciati nel dipartimento di sociologia di Nanterre, dove
non c'erano soltanto docenti come Henri Lefrevre o Jean Baudrillard,
ma c'erano anche degli studenti, come un certo Cohn-Bendit o
come Duteuil e qualche altro. Quindi il '68 è per me
non un simbolo ma una realtà.
Ora, una delle idee uscite dal movimento del '68, e non soltanto
nel campo dell'educazione, è stata l'idea dell'autogestione;
idea assolutamente non nuova, ma già messa in pratica
dai repubblicani spagnoli nel '36-'38 e da altri movimenti anarchici
dall'Ucraina alla stessa Francia, che però appariva nuova
perché caduta nell'oblio.
Un'altra cosa che mi ha colpito del '68, nella pratica stessa
del movimento - del quale ben preso abbiamo fatto parte anche
noi insegnanti, anche se dal punto di vista statutario eravamo
diversi dagli studenti - è stata la reinvenzione delle
forme sociali. Dico "reinventate" perché non
esistono mai nella storia invenzioni pure e semplici e perché
ci sono periodi di oblio - più o meno lunghi - che danno
l'impressione di scoprire nuove forme sociali di ribellione
che invece sono sempre esistite.
 Un movimento molto più vasto
Un movimento molto più vasto
Un terzo elemento di cui mi piacerebbe parlare - ma ce ne sarebbero
molti di più - è il fatto che non siamo stati
subito consapevoli che si trattava di un fenomeno non solo francese.
Eravamo naturalmente informati di quanto era successo negli
Stati Uniti dal '66, di tutto il movimento della controcultura,
nata in parte dalla contestazione politica contro la guerra
in Vietnam, di quanto era avvenuto in Germania l'anno prima.
Ma è solo un po' più tardi che ci siamo accorti
che si trattava di un movimento veramente mondiale; si è
saputo delle forme, certamente molto più militariste,
che aveva preso in Giappone con i zengakuren. In Messico c'erano
stati più di 200 morti nella Piazza delle Tre Culture:
lì non erano militaristi, ma erano stati i militari,
il governo, a massacrare la gente. In Italia e in molti altri
Paesi europei, in tutti i continenti, perfino in alcune università
africane - l'abbiamo saputo soltanto in seguito - erano successe
cose. Per la prima volta dopo le rivoluzioni del 1848 ci siamo
resi conto che non eravamo soltanto noi francesi a manifestare
contro il governo, che - senza saperlo e senza ancor oggi poter
analizzare le cause planetarie del fenomeno - facevamo parte
di un movimento molto più vasto.
In assenza di un'ideologia precisa - cosa di cui, naturalmente,
i politici e in particolare i comunisti e i marxisti si rammaricavano
- in assenza di un'ideologia predominante e di uno stato maggiore
(cose che vanno insieme) nel movimento, bisogna accettare l'idea
che esisteva all'epoca, creata da condizioni che sarebbe troppo
lungo analizzare, tutta una produzione di immaginari sulla società
- come era, come non doveva essere, come avrebbe dovuto essere
- senza che però ci fosse, salvo nei gruppuscoli più
organizzati di tipo trotzkista o marx-leninista, un programma
"chiavi in mano", una società di sostituzione
(nello stesso modo in cui si riceve un'automobile di rimpiazzo
quando si è avuto un incidente e si ha una buona assicurazione).
Questa è davvero un'originalità sociologica del
movimento del '68: il fatto che per qualche settimana l'immaginazione
ha preso il potere, anche se ha poi dovuto cedere il posto,
dopo le elezioni di fine giugno, alla dura realtà; che
in effetti non era la realtà bensì anche in quel
caso l'immaginazione, ma l'immaginazione della paura, cioè
della Francia profonda che aveva voglia di ritornare all'ordine
e che ha dato un'inaspettata maggioranza alla destra.
È difficile fare un bilancio trent'anni dopo. Ho cercato
di mostrare che non era una rivoluzione come le altre: non si
è prodotta come le altre, non si è svolta come
le altre ed ha avuto, in fondo, conseguenze molto più
importanti delle rivoluzioni omologate dalla storia. Le rivoluzioni
omologate sono quelle che corrispondono ad un cambiamento degli
uomini politici, cioè quelle che iniziano un processo
d'istituzionalizzazione, e come Max Weber ed Hegel hanno dimostrato,
interviene la negazione, cioè si assiste ad una specie
di rinnegamento - programmato ed orchestrato - del progetto
rivoluzionario iniziale.
Naturalmente anche molti protagonisti del '68 sono "entrati"
in questa istituzionalizzazione neo-liberale che ha cominciato
a manifestarsi negli anni Settanta. Ma non c'è stato,
né in Francia, né in altri Paesi, un processo
d'istituzionalizzazione concretizzatosi in una dottrina sociale
o in un cambiamento di uomini politici. Quindi, ancora una volta,
c'è qui una grande originalità dalla quale discende
la difficoltà di fare un bilancio.
 Programma anarchico classico
Programma anarchico classico
Tenderei però a non ripetere, come tutti, che c'è
soprattutto un'eredità culturale. Non ne sono così
sicuro, perché la cultura è qualcosa che cambia
molto spesso, che possiede una temporalità abbastanza
frammentaria, abbastanza rapida, soggetta alle mode. Tra l'altro,
la nozione di cultura - che è una nozione da selvaggi,
in quanto consiste nel rigettare le altre culture - non mi piace
affatto. Ci sono stati, nel campo culturale (senza insistere
troppo su questo termine) cambiamenti profondi. Non per niente
molti artisti sono stati implicati nel movimento: ricordiamoci
dell'occupazione dell'Odéon da parte di Jean-Louis Barrault.
Anche in questo caso c'è stata quella che definirei "un'autorizzazione",
una libertà data all'immaginazione. In definitiva, si
trattava del programma anarchico classico (già ideato
da Bakunin, che aveva molta immaginazione e senso estetico),
ma non costituiva il nucleo dei programmi anarchici contemporanei
agli eventi. Io credo che la vita artistica - definita vita
culturale, ma che è soprattutto artistica poiché
in letteratura ce ne sono meno tracce - resta ancora oggi largamente
tributaria di quel terremoto del '68.
Castoriadis aveva scritto in un articolo che il '68 è
soprattutto la critica delle istituzioni. Ci si rende conto
che c'è l'istituzione, che non ci sono soltanto i governi,
gli uomini politici, i partiti, ma che c'è qualcosa di
più profondo, qualcosa di fondamentale che permea tutti
gli aspetti dell'esistenza. E l'idea che si possa (traduco alla
mia maniera) analizzare l'istituzione - come tanti operai, contadini,
studenti hanno fatto nel '68 e anche dopo, sul posto di lavoro
o d'attività - è qualcosa che è rimasto,
pur se in maniera molto meno netta e visibile. Tuttavia, secondo
me è proprio questa la fibra che si può chiamare
libertaria (anche se forse si fa troppo onore a certi libertari
che non hanno dato l'esempio nella misura in cui si sono anch'essi
istituzionalizzati, cosa normale del resto) e che è veramente
un'eredità inalienabile, pur se può divenire oggetto
di contestazione e di processi, o essere resa completamente
invisibile, cosa che avviene in quelle epoche che spingono al
pessimismo (non è il mio caso).
Dietro quest'idea, generale e sociologica, secondo la quale
c'è qualcosa contro cui ci si può ribellare (il
proprio capo, il direttore, la burocrazia o qualsiasi altro
organismo), c'è l'altra idea profondamente sociologica
- che mi ha fatto dire in precedenza che tutti, in quei momenti,
erano sociologi e tutti possono ridiventarlo in qualsiasi momento,
perché il '68 ha sparso semi ancora vivi - dell'istituzione-Stato
e della critica, sempre più necessaria, dello Stato in
tutte le sue metamorfosi. E questo in un pianeta in corso di
mondializzazione, dove l'economia sembra regnare su tutto; cosa
che scontra continuamente con delle contraddizioni perché
assolutamente falsa. Se l'ultima crisi, nata a Hong Kong, è
in via di soluzione, lo è per ragioni politiche e non
economiche: due frasi di Clinton sono bastate perché
questo sedicente flusso economico non si sia esteso e non abbia
inondato il pianeta intero. Più che mai, sotto forme
che sia gli anarchici che i sociologi dell'analisi istituzionale
devono analizzare, è sempre la forma-Stato che - anche
se si crede che stia deperendo o che bisogna farne a meno o
che ce ne voglia il minimo possibile - è veramente la
forma della sovranità, la forma, direi, quasi mistica,
in cui tutto finisce per convergere, in cui tutto attraversa
le istituzioni. Ed è cercando di capire che cosa rappresenta
per noi l'istituzione, il gioco di poteri in cui siamo implicati,
che si può capire questa trasversalità statuale,
questo vero e proprio modus vivendi, queste modalità
con cui lo Stato vive e sopravvive a spese nostre, aggrappandosi
a noi, alle nostre vene giugulari come Dracula, e spesso in
maniera implicita, invisibile o addirittura inconscia (compresi
quegli intellettuali che si credono grandi sociologi, grandi
politologi, convinti di conoscere il funzionamento della società).
Ecco, quello che resta del '68 è una grande lezione di
sociologia, di cui vedo ancora delle tracce, anche se questa
lezione è lungi dall'essere vistosa e squillante come
allora. Ma l'estate e la primavera ritornano periodicamente.
Non credo assolutamente alla fine della storia, che sia di taglio
neoliberale o di taglio nichilista di sinistra: tutto ciò
mi è completamente estraneo e se sono portato a pensare
così, non è a causa di origini intellettuali specifiche,
ma è perché è proprio questa la grande
lezione sociologica e politica del '68.
 René Lourau
René Lourau
tratto dal Bollettino Archivio G. Pinelli n°
13
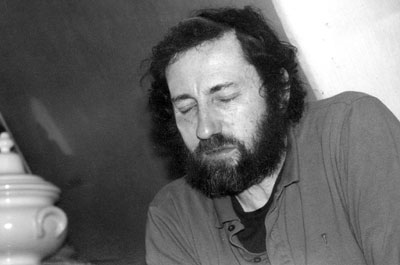
|
Un
grande sociologo libertario
Con René
Lourau, stroncato da un infarto l'11 gennaio scorso, se
ne è andato un grande sociologo libertario. Lourau
era il caposcuola dell'analisi istituzionale: un metodo
d'intervento per studiare i rapporti che le diverse parti
sociali intrattengono con il sistema palese e occulto
delle istituzioni. Un intervento che vede l'analista non
in posizione esterna al gruppo, alla collettività,
all'organizzazione, ma come soggetto implicato e coinvolto
nella rete delle istituzioni che analizza. Così
si può sintetizzare il nucleo centrale della socioanalisi
(con l'avvertenza che tutte le sintesi non possono, per
definizione, cogliere i molteplici aspetti di una teoria).
Di Lourau era stato pubblicato un solo libro in Italia:
Lo Stato incosciente, nel 1980 per i tipi delle Edizioni
Antistato, poi nel 1988 da Elèuthera. Mentre sei
suoi articoli sono apparsi su Volontà, la rivista
trimestrale (laboratorio di ricerche anarchiche) chiusa
nel 1996. Tra i 19 libri scritti da Lourau vanno ricordati:
L'instituant contre l'institué (1969), L'analyse
institutionelle (1970), Le gai savoir des sociologues
(1977), Autodissolution des avant-gardes (1980),
Le lapsus des intellectuels (1981), Le principe
de subsidiarité contre l'Europe (1997).
Luciano Lanza
|
|

