|
I rapporti tra marxisti e anarchici
sono sempre stati particolarmente ambigui. Alcuni sottolineano
momenti ed eventi particolari - i dissidi nella Prima Internazionale
e Saint Imier, la rivoluzione bolscevica, la guerra di Spagna
- per illustrare lo stacco incolmabile tra la visione della
rivoluzione dei seguaci di Marx e quella dei seguaci di Bakunin.
L'argomento forte di tali teorici della "separazione"
è il seguente: ogni qualvolta i comunisti marxisti hanno
raggiunto il potere, una delle loro prime preoccupazione è
stata quella di "far fuori" gli anarchici, sia dal
punto di vista culturale sia dal punto di vista propriamente
"fisico". È un'argomentazione probabilmente
definitiva, ma nasconde un problema ulteriore. Infatti, i marxisti
- in Russia come in Cina, a Cuba come nell'ex Jugoslavia - non
si sono limitati a "far fuori" solo gli anarchici,
ma hanno fatto la stessa cosa con altri radicali: i socialisti,
i socialdemocratici, i liberali, i populisti, i "borghesi
rivoluzionari", i vari "eretici" a sinistra,
eccetera. Tra questi gruppi di "eliminati" registriamo
reazioni diverse. Alcuni la prendono, per così dire,
con calma; se l'aspettano; è nell'ordine naturale delle
cose. Altri strillano, berciano, fanno polemica. Insistono su
un tema ricorrente: il "tradimento" dei comunisti,
sia della rivoluzione, sia dei loro "compagni di strada".
Non mi risulta che esista molta letteratura sul trattamento
riservato dai bolscevichi, che so, ai socialisti nel '17 e successivi
o nel '37 e successivi. Invece, i libri sul "tradimento"
nei confronti degli anarchici (sia nel '17 che nel '37) sono
parecchi. Insomma, se proprio dovessi descrivere l'atteggiamento
di fondo di buona parte della cultura libertaria di orientamento
comunista nei confronti delle varie repressioni bolsceviche,
parlerei di "sorpresa esistenziale non del tutto inaspettata":
da un lato la presa d'atto di un contrasto tra due visioni del
mondo, dall'altro una sorta di stupore di fronte alle iniziative
di chi sembrava condividere, fino a ieri, immaginario e progettualità.
Ed è proprio questo il punto sul quale a mio parere occorre
riflettere. Mettere in luce le differenze di fondo tra il comunismo
marxista e quello anarchico è un esercizio di indubbia
utilità; si possono prendere in considerazione il diverso
giudizio sulla "dittatura del proletariato", sulla
natura della pianificazione, sulla transizione rivoluzionaria,
sulla relazione tra mezzi/fini, eccetera. Ma nel contempo bisogna
tener conto del quadro generale in cui si svolge tale confronto,
che è quello di una sostanziale condivisione complessiva
di un preciso immaginario: la rivoluzione, la "nuova"
storia, la "nuova" società, il comunismo, e
così via. È questo l'elemento che spiega la ricorrenza
dell'accusa di tradimento.
 Necessità storica e rivoluzione
Necessità storica e rivoluzione
Il socialismo anarchico e quello marxista hanno ovvie radici
storiche in comune. In primo luogo, l'ethos rivoluzionario
e insurrezionalista che scaturisce dalla Rivoluzione francese
e che modella sia il pensiero dei teorici sia l'azione dei movimenti
nel corso dell'Ottocento. In secondo, la comune matrice nell'area
socialista (lasciamo stare quelle tendenze dell'anarchismo che
risalgono a prospettive differenti). In terzo, la fucina dell'In-
ternazionale: per quasi un ventennio (grosso modo, dagli inizi
degli anni Cinquanta agli inizi degli anni Settanta) proudhoniani,
lassalliani, marxisti, tradeunionisti, socialisti cristiani
e comunisti utopisti costituirono un bacino condiviso di esperienze
e di elaborazioni. Le differenziazioni ebbero luogo in un secondo
momento. Solo dalla metà degli anni Settanta comincia
ad avere pienamente senso discutere di un movimento socialista
che va articolandosi in tendenze divergenti. È questo
il periodo decisivo per comprendere la natura profonda del dissidio
tra marxisti e anarco-comunisti: condivise le matrici; condiviso
l'obiettivo di fondo (l'abbattimento della società capitalista
e l'instaurazione del comunismo); differente l'orientamento
etico-politico. Di recente Nico Berti si è chiesto se
"la divergenza sui mezzi per raggiungere il socialismo
sia così profonda da rendere del tutto secondario ed
apparente il fine teorico che li accomuna".1
Dal punto di vista della teoria Berti ha ragione nell'affermare
la differenza tra le due tendenze, che ci permette peraltro
di comprendere la distanza che oggi le separa; ma dal punto
di vista storico tale conclusione obnubila quel terreno comune
che le ha contraddistinte nel loro sviluppo concreto. E non
dobbiamo fare grande fatica per identificare un preciso elemento
ideologico che spiega non solo affinità teoriche e vicinanza
negli obiettivi, ma anche - cosa più importante - quella
condivisione di immaginario che resta, a mio parere, la componente
più significativa della connessione marxismo/anarco-comunismo.
Il passaggio di Marx dalla prospettiva hegeliana a quella del
materialismo storico avvenne tra il 1844 e il 1846, grazie anche
a un confronto serrato con gli anarchici Stirner e Proudhon.2.
Nel manoscritto su Feuerbach che apre l'Ideologia tedesca
si trovano le prime elaborazione sul tema. Ne emergono - ancora
a uno stadio non del tutto sviluppato - i punti fermi della
filosofia della storia marxiana, così riassunti, in un'opera
più tarda, dallo stesso autore: "Nella produzione
sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti
determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà,
in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato
grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali"
3. Da questo presupposto si evince una serie di altri
postulati, che nel Manifesto del 1848 troveranno l'esposizione
più nota e diffusa: le fasi rivoluzionarie si aprono
quando i rapporti di produzione consolidati entrano in contraddizione
con l'evoluzione economica della società; la storia è
quindi frutto di una costante lotta tra le classi; stato, diritto,
persino tecnologia sono sovrastrutture; il potere politico è
solo "il potere organizzato di una classe per l'oppressione
di un'altra" 4. Marx (qui in collaborazione
con Engels) concludeva il ragionamento con la scoperta "scientifica"
della necessità storica di una rivoluzione proletaria,
destinata a essere diversa, per natura, dalle precedenti: il
proletariato, infatti, al contrario dei movimenti precedenti,
"di minoranza o nell'interesse di minoranze", era
"il movimento indipendente dell'enorme maggioranza nell'interesse
dell'enorme maggioranza"5; ne sarebbe conseguita
l'abolizione delle classi e l'estinzione, di fatto, dello stato.
Negli anni successivi Marx avrebbe dedicato gran parte delle
sue energie a precisare le implicazioni economico-politiche
del materialismo storico, partendo dalla teoria del valore-lavoro
e sviluppando le idee del plusvalore, della caduta tendenziale
del tasso di profitto, eccetera. In sostanza, la sua concezione
della storia valorizzava istanze classiste, che situavano la
riflessione sull'oppressione del proletariato in una cornice
di fatalismo rivoluzionario; sul piano filosofico esprimeva,
sotto una copertura "scientifica", una potente tendenza
al dogmatismo; sul piano politico diveniva una giustificazione
della "dittatura" del proletariato.
Le teorie marxiane ricevettero un colpo fatale sin dalla fine
del secolo scorso, quando filosofi ed economisti misero in luce
l'insufficienza del valore-lavoro come spiegazione del meccanismo
della società capitalista, anche perché le principali
predizioni di Marx - in primo luogo quello di una progressiva
polarizzazione sociale, con l'aumento di capitalisti e proletari,
i primi sempre più ricchi e i secondi sempre più
poveri, e la scomparsa delle classi intermedie - non si erano
affatto avverate Inoltre, i sociologi e gli studenti di scienze
sociali colsero - soprattutto a partire dal successo bolscevico
- il sostrato religioso della filosofia della storia marxiana,
che sembrava costituire la più perfetta laicizzazione
dell'ideale cristiano dell'avvento del paradiso in terra; la
strumentazione concettuale del leninismo, con l'accento sulla
superiore "sapienza" scientifica degli iniziati riuniti
in "partito", ricordava in particolare gli antichi
gnostici6. La cosa più interessante da discutere
è se sia possibile rintracciare nel materialismo storico
una delle matrici dell'esperienza totalitaria del comunismo
reale. Sarebbe ovviamente anacronistico addossare direttamente
a Marx tale responsabilità; tuttavia, nella sua teoria
sono presenti elementi che avranno una funzione importante nel
plasmare l'ideologia totalitaria: la funzione di "guida"
delle avanguardie; la necessità "storica" della
rivoluzione proletaria; l'azzeramento della storia nella società
comunista; l'esaltazione della violenza "liberatrice";
e così via
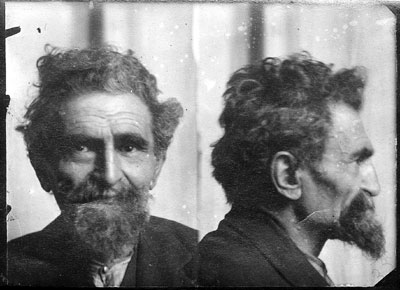
Milano, 1921.
L'anarchico Errico Malatesta durante lo sciopero della fame
nel carcere di S. Vittore
 Materialismo storico e immaginario
Materialismo storico e immaginario
Giungiamo al punto. Il materialismo storico ha esercitato
un'influenza per certi versi maggiore di quanto abbiano fatto
le teorie economico-politiche di Marx. Non ha fornito semplicemente
il linguaggio della redenzione a tutti i socialisti (per le
meno sino ai primi revisionisti degli anni Ottanta e Nova-nta),
ma ha plasmato un immaginario fondato sulla "classe",
la "ri-voluzione", la "nuova storia". Un
immaginario che è stato ed è ampiamente condiviso
da buona parte de-gli stessi anarchici. Poco conta, da tale
punto di vista, insistere sulle differenze teoriche e pratiche
tra comunismo "autoritario" e comunismo "libertario":
la comune matrice materialista, con i suoi corollari classisti
e insurrezionalisti - con un lessico incentrato su categorie
marxiste (quali "struttura", "merce", "capitale",
"proletariato" e così via) non tanto (e non
solo) obsolete, quanto prive ormai di contenuto reale - modella
quasi per necessità una forma mentis fondata sullo
scontro, la violenza, la coartazione e, nei casi limite, la
mistica della rivoluzione proletaria, con i suoi sogni da millennio
rigeneratore. In altri termini, gli anarco-comunisti, lungi
dal rivelarsi diversi dai loro "compagni di strada"
autoritari, ne condividono in parte le premesse storiche, epistemologiche
ed antropologiche. Il percorso verso la società comunista
immaginata dagli anarchici pare cioè riprodurre, nella
sua impostazione unanimistica, fatalistica e azzeratrice della
storia, gli stessi temi e le stesse fallacie che i libertari
sono usi attribuire ai loro avversari/compagni di parte marxista.
La letteratura e la pratica degli anarco-comunisti dimostrano
più che a sufficienza, a mio parere, la presenza di questo
immaginario di matrice materialista. Sugli internazionalisti
non credo sia possibile nutrire dubbio alcuno. Cafiero chiude
il suo Compendio del Capitale - di per sé prova
della mia argomentazione - con un avvertimento ai piccoli proprietari,
"inevitabilmente ridotti tutti, dalla moderna accumulazione
capitalista, alla trista condizione: o vendersi al governo per
la pagnotta, o scomparire per sempre fra le dense file del proletariato"7
Le pagine del primo Malatesta testimoniano un'analoga fedeltà
ai capisaldi dell'interpretazione materialista; facendo qualche
esempio concreto, nell'Anarchia riprodusse quasi perfettamente
la concezione dello stato offerta da Marx ("In tutto il
corso della storia, così come nell'epoca attuale, il
governo, o è la dominazione brutale, violenta, arbitraria,
di pochi sulle masse, o è uno strumento ordinato ad assicurare
il dominio e il privilegio a coloro che […] hanno accaparrato
tutti i mezzi di vita"); in Fra contadini sposò
con tanta convinzione la tesi della progressiva concentrazione
della ricchezza da ritrovarsi costretto ad aggiungervi, a partire
dall'edizione del 1913, una dissociazione da tale tesi, spiegando
che il testo era stato scritto "nel 1883, quando ancora
era indiscussa fra i socialisti la teoria di Marx sulla concentrazione
della ricchezza"8 Nei giornali e nella libellistica
anarchica l'enfasi sulla retorica materialista dello scontro
tra le classi e della rivoluzione rigeneratrice era ancora più
marcata. Persino in un pensatore sofisticato come Kropotkin
fanno capolino le premesse materialiste.
Intendiamoci, non intendo sostenere che gli anarchici - neppure
quelli di tendenza comunista - siano materialisti loro malgrado.
Intendo dire che le tesi di Marx, diffuse in tutto il movimento
socialista, hanno attecchito, per lo meno in parte e ma in modo
precipuo, proprio tra coloro che ne condividevano l'obiettivo
ultimo, l'edificazione della società comunista. E la
migliore testimonianza di questa presenza sta nello sviluppo
del revisionismo anarchico negli anni Venti e Trenta di questo
secolo, che in massima parte costituisce un tentativo di "epurazione"
dall'anarchismo di quei tratti maggiormente associati all'immaginario
materialista e che ha visto impegnarsi nell'impresa Malatesta,
Berneri, Fabbri, Borghi, Rocker e altri. Anzi, proprio Rocker
ha tentato esplicitamente, con la prefazione a Nazionalismo
e cultura, di dare all'anarchismo una filosofia della storia
- fondata non sulla "guerra di classe", ma sulla "volontà
di potenza" - alternativa a quella di derivazione marxiana.
 revisionismo
e libera sperimentazione revisionismo
e libera sperimentazione
Il dopoguerra ha segnato una nuova involuzione. La marginalizzazione
degli anarchici e l'apparente successo dei bolscevichi ha in
sostanza riconsegnato il movimento alle parole d'ordine del
materialismo storico. Nel 1955 Luce Fabbri ha offerto il seguente
commento:
Un'innegabile influenza marxista su tutti i movimenti italiani
(e, possiamo dire, europei) di "sinistra", specialmente
nei loro settori giovanili, dovuta a circostanze di carattere
materiale come la potenza politica della Russia, ha prodotto
un acuirsi della mentalità classista vecchio stile, proprio
quando le classi stano cambiando rapidamente di natura. Ha portato
ad esaurire la lotta nell'azione anticapitalista in un momento
in cui il capitalismo decade e non certo a vantaggio delle soluzioni
socialiste, e nuove forme di assolutismo statale anneriscono
l'orizzonte a oriente e a occidente. La suggestione che esercitano
le "realizzazioni pratiche" (più immaginarie
che reali) […] fece (anche in mezzo agli anarchici) fermentare
variamente i residui dell'educazione marxista ricevuta nell'atmosfera
infuocata della resistenza, nel senso dell'accentuazione di
motivi autoritari e perfino, in alcuni casi estremi, di un avvicinamento
ideologico al trotzkismo. 9
Per certi versi il '68 ha prodotto un effetto analogo, rinforzando
ancora una volta quella tentazione materialista che abbiamo
visto esser presente nell'anarchismo di orientamento comunista
sin dagli esordi.
I revisionisti degli anni Venti e Trenta e i loro pochi seguaci
nei decenni successivi hanno tentato di confutare le premesse
classiste e materialiste dei loro compagni, seguendo percorsi
diversi e per certi versi persino divergenti10. Il
superamento del problema della relazione materialismo storico/comunismo
anarchico è avvenuto attraverso il potenziamento del
tema della libera sperimentazione, grazie al quale la concezione
comunista libertaria ha perso le connotazioni classiste ed escatologiche.
Concepita da Malatesta e Fabbri come il metodo per conciliare
il rifiuto anarchico della coartazione con la prospettiva di
una società libera, la libera sperimentazione pareva
configurare un sistema di interrelazione sociale ed economico
fondato sul pluralismo, in cui il comunismo diveniva soluzione
tra tante. Certo, Malatesta e Fabbri erano convinti - o, per
meglio dire, speravano - che essa, paragonata alle altre, uscisse
vincitrice dal confronto e si affermasse a seguito della libera
scelta di ognuno. In questa prospettiva restavano saldi due
principi: la vittoria del comunismo libertario non avrebbe precluso
la possibilità di scegliere altrimenti in futuro; la
situazione della "transizione", ovvero una "società
aperta" caratterizzata dalla libera sperimentazione, era
di per sé favorevole allo sviluppo della libertà.
Luigi Fabbri aveva toccato il punto nevralgico dell'argomentazione
anarchica già nel 1922, quando aveva giudicato della
massima importanza che, "qualunque sia il tipo di produzione
adottato, lo sia per libera volontà dei medesimi, e non
sia possibile la sua imposizione"; nel 1926 spiegava poi
che il programma dell'Unione anarchica italiana del 1920 "affermava
implicitamente la tolleranza verso la piccola proprietà
non sfruttante il lavoro salariato, rivendicando la libertà
dei produttori di non far parte delle associazioni di produzione"11.
Tali argomentazioni illustravano con chiarezza quale tipo
di comunismo era qui concepito: se si fosse negato il principio
della libera scelta del produttore, si sarebbe piombati nel
totalitarismo; se fosse stato accettato pienamente, ciò
avrebbe condotto a una società caratterizzata dalla concorrenza
possibile, e quindi dal mercato. In effetti, non si può
fare a meno di rilevare che è proprio questa la soluzione
prospettata da Malatesta, Fabbri e dagli altri "comunisti"
disposti alla "revisione". Postulando la possibilità
della differenza (anche economica), essi abbandonavano la posizione
rigidamente classista; auspicando una società in cui
erano ammessi il mutamento, lo sviluppo e la possibilità
d alterare la scelta sullo stile di vita (e sullo stile di "produzione",
ovviamente), evitavano lo scivolamento nell'escatologia e in
quell'azzeramento della storia che costituiva il prodromo inevitabile
del totalitarismo. In questo tragitto i "revisionisti"
si erano allontanati parecchio dal materialismo storico e dalla
versione più diffusa del cosiddetto comunismo libertario;
nel contempo, si erano avvicinati a quelle tendenze dell'anarchismo
che si erano sempre definite anticomuniste e che nel tema dell'inevitabiltà
della rivoluzione proletaria avevano colto, più che un'istanza
di liberazione, la possibilità di una soluzione autoritaria.
 Pietro Adamo
Pietro Adamo
1 G. Berti, Il pensiero anarchico dal Settecento
al Novecento, Manduria-Bari-Roma 1997, p. 526.
2 Per una sintetica descrizione dello sviluppo del pensiero
di Marx in questo frangente si veda D. McLellan, "La concezione
materialistica della storia", in Storia del marxismo.
Vol. I. Il marxismo ai tempi di Marx, tr. it. Einaudi, Torino
1978, pp. 35-55.
3 K. Marx, Per la critica dell'economia politica, tr.
it. Editori Riuniti, Roma 1984, p. 5.
4 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista,v
tr. it. Editori Riuniti, Roma 1971, p. 89.
5 Ivi, p. 74.
6 Si veda la rapida ma suggestiva rassegna di interpretazioni
storiografiche dell'antica gnosi in G. Filoramo, L'attesa
della fine. Storia della gnosi, Laterza, Roma-Bari 1993,
pp. IX-xxiii.
7 C. Cafiero, Compendio del Capitale, Editori Riuniti,
Roma 1996, p. 5.
8 I due testi di Malatesta sono riprodotti in Gli anarchici,
a cura di G.M. Bravo, Torino, Utet 1971 (le citazioni sono rispettivamente
a p. 815 e p. 879.
9 L. Fabbri, Sotto la minaccia totalitaria, Edizioni
RL, Napoli 1954, p. 13.
10 Mi si permetta, a questo punto, di rimandare ad altri miei
scritti dedicati all'argomento: L'anarchisme entre ethos
et projet, in La culture libertaire, a cura di A Pessin
e M. Pucciarelli, Atelier de creation libertaire, Lione 1997,
pp. 181-201 (vers. rid. L'anarchismo tra ethos e progetto,
in "A rivista anarchica", n. 233, 1997, pp. 32-39);
Il revisionismo di Camillo Berneri, "Il presente e
la storia", n. 53, 1998, pp. 105-129; La crisi dell'anarchismo
e l'ethos liberale, "A rivista anarchica", n.
250, 1998/1999, pp. 43-45; Presentazione a L. Fabbri,
Libera sperimentazione, in "A rivista anarchica",
256, 1999, pp. 42-44.
11 L. Fabbri, Anarchia e comunismo "scientifico"
(1922), in N. Bucharin, L. Fabbri, Anarchia e comunismo
scientifico, Altamurgia, Ivrea 1973, p. 43; L. Fabbri, "I
comunisti libertari e la terra ai contadini", manoscritto
custodito all'Istituto storico della resistenza di Firenze,
con copia nell'Archivio Berneri di Reggio Emilia.
|

