|
 Anarchia a Florianapolis
Anarchia a Florianapolis
La chiamano Floripa, ed è la capitale dello stato di
Santa Catarina. Città balneare, meta del turismo di élite
del meridione brasiliano, ha sviluppato in pochi anni il proprio
bosco di grattacieli e seconde e terze case. "Qui non ci
sono poveri né vagabondi", ci spiegano "perché
la polizia non ce li lascia stare". Alcuni anni fa, un
sindaco intraprendente promosse una versione locale della "tolleranza
zero" del più celebre collega newyorkese. Floripa
possiede una piazza opulenta, da poco inaugurata, illuminata
a giorno e sorvegliata non stop da zelanti funzionari, che con
un sorriso di gesso ti redarguiscono al solo posare un piede
sulle impeccabili panchine.
Anche questo, ma non sembra, è Brasile. E in questa terra
di stravaganti sperimentazioni micro totalitarie, tra il 4 e
il 7 settembre, si è svolto lincontro internazionale
dei libertari. In realtà le delegazioni straniere rappresentavano
una piccola componente, ma si deve pur cominciare. "Solo
pochi anni fa" puntualizza uno degli organizzatori, "per
accogliere i partecipanti sarebbe stato sufficiente un pulmino;
oggi due autobus non sono bastati".
Giorno dellinaugurazione: aula magna delluniversità
gremita. Colpiscono leterogenità e la giovane età
dei presenti. Provengono in gran parte dal sud del Brasile e
da San Paolo, ma non mancano contributi dal nordest. Eterogeneità:
professorini alternativamente azzimati, anarcopunk, ecologisti,
indigenisti, zapatisti, Sem terra, vecchi militanti e accademici.
Ognuno portatore di un proprio linguaggio, di una identità
esibita. Lattacco è diretto e forse un poco presuntuoso:
"Prospettive del movimento anarchico per il secolo XXI".
Gli anarchici usciti dallombra vogliono intervenire. E qui
si evidenzia la prima difficoltà: "come trovare
una linea comune tra tanta varietà?". Dilemma epocale,
la questione dellorganizzazione sembra spaccare la sala ancor
prima che si sviluppi il dibattito. Si delinea la proposta di
costituire una federazione anarchica brasiliana - ma non era
un convegno internazionale e libertario? Limpressione è
che il movimento stia uscendo solo ora dagli anni della clandestinità
e necessiti, bruciando le tappe, di riorganizzarsi.
Tra i partecipanti si respira ancora paura, frequenti gli accenni
alle azioni delle milizie private contro i militanti di base,
alla repressione poliziesca. Le manifestazioni per i 500 anni
della "scoperta" hanno registrato la presenza attiva
dei libertari, quanto un livello di scontro inquietante. In
Brasile la seconda metà degli anni 80 sono stati lepoca
della riemersione delle rappresentanze democratiche. Riemersione
concessa, pilotata dalle caste militari, ora orientate alla
normalizzazione. Come negli altri paesi latinoamericani colpiti
dalla peste, il ritorno al potere dei partiti ha comportato
una relativa rimozione del passato e degli orrori recenti. Le
strutture repressive sono rimaste intatte; i responsabili impuniti.
Contesto in cui si situa la tarda rinascita di un movimento
che, per sua natura, sfugge alle logiche dei poteri, quanto
del sistema detto "democratico".
Un aspetto importante del convegno riguarda la presenza, o meglio
lassenza, di altri movimenti politici. E come se per la sinistra,
lanarchismo quale espressione di progettualità sociale
non esistesse. E questo isolamento, questo abbandono da parte
di ciò che fu il più ampio fronte socialista,
costituisce un elemento per la comprensione delle dinamiche
in atto. Gli anarchici rappresentano un soggetto scomodo nel
percorso di riappropriazione di spazi e poteri da parte della
sinistra legittimata. E qui si ripropone il dilemma dellanarchismo
contemporaneo tra necessità organizzative e rifiuto delle
istituzioni. Dilemma esacerbato nel processo di transizione
democratica, dal confronto con le strutture e gli appoggi su
cui i partiti hanno potuto contare. Si crea una zona dombra
dove lanarchismo, pur non riconosciuto, viene collocato in
attesa -per fortuna vana- della sua definitiva estinzione.
Un atteggiamento rilevato in più gruppi di lavoro, e
speculare al vissuto di rimozione, riguarda la legittimità
dellutilizzo delle strutture pubbliche da parte degli anarchici.
Luniversità non viene percepita nella funzione di elaborazione
culturale e scientifica che gli è propria, quanto come
articolazione del sistema di potere. Dinamica che se radicalizzata
potrebbe mettere in discussione il diritto dei libertari -tra
laltro costretti a pagare le tasse- di fruire di ospedali,
scuole, addirittura piazze e strade. Ma dinamica che nello stesso
tempo testimonia la difficoltà di percepirsi come soggetto
legittimo e propositivo della comune vita sociale e culturale.
Leterogeneità di fondo rischia di provocare incrinature
e alimentare polemiche, ma rispecchia anche la vitalità
del movimento. Vitalità che colpisce losservatore europeo,
abituato ai noti contesti crepuscolari. Se una definizione di
questo convegno è possibile, riguarda la presenza giovanile,
lampiezza e il livello del dibattito. I gruppi di lavoro e
le tavole rotonde rivelano spessore e preparazione teorica.
Lincontro propone più momenti di riflessione, sviluppando
in particolare alcuni aspetti dellopera proudhoniana. Il fuoco,
in funzione della proposta federativa, tende a concentrarsi
sulle forme organizzative, quanto sulla storiografia del movimento.
A lato si profila la prospettiva di utilizzare le nuove tecnologie,
vedi internet, per dar vita a una rete libertaria. Gli interventi
esprimono lesigenza di incrementare lo scambio tra esperienze,
metodologie, superando lattuale frammentazione.
Il percorso favorisce lemergere di alcuni punti critici. In
primo luogo la relazione tra movimento libertario e movimento,
o proto federazione, anarchica. Difficile conciliare lesigenza
di convogliare le energie verso obiettivi comuni e quella di
considerare la differenza quale valore. Frequenti gli interventi
mirati a definire il campo, e destinati a innescare polemiche:
le società indigene rappresentano realtà libertarie
o forme ancestrali di organizzazione economica? Movimenti di
base come i Sem terra, aventi una matrice marxista e legati
al cattolicesimo, possono essere considerati libertari?
Più che ai criteri di definizione e analisi, il problema
conduce a due concezioni alternative. Da un lato lanarchismo
viene inteso come orientamento del pensiero politico moderno,
scaturito dal più ampio contesto degli ideali della Rivoluzione
dell89. Orientamento connaturato alla questione sociale e in
particolare alle lotte operaie del mondo occidentale. Dallaltro
lanarchismo rappresenta un anelito alla libertà e alla
eguaglianza peculiare alla specie umana. Una caratteristica
indipendente dal tempo e dal luogo, che accomunerebbe contesti
lontani ed eterogenei. La concezione degli uni rispetto ai movimenti
libertari rivendica la necessità di una matrice teorica
postilluminista, quella dei movimentisti una comune visione
della vita sociale e dellintervento. Esisterebbero una pratica
dazione diretta e organizzativa caratterizzanti. I movimenti,
in quanto tali e fintanto non involvano in istituzioni, sarebbero
da considerarsi realtà libertarie.
Dai gruppi emerge frequente lappello alla valorizzazione delle
istanze sociali dinamiche, alla loro interpretazione in senso
di processo e potenzialità. Rinuncia al "purismo
anarchico", assunzione di una visione dialettica capace
di gestire le contraddizioni del presente. Le modalità
dellagire dei Sem terra divengono carattere fondamentale, sul
quale si innestano variabili ideologiche e prassi istituzionalizzanti.
Il movimento, quale espressione di bisogni collettivi, è
un frutto della creatività popolare cui approcciarsi
in termini di complessità. Sforzo dinterpretazione e
intervento nel vivo tessuto sociale che riporta a ciò
che Luis Mercier Vega definiva "pratica dellutopia".
Il convegno registra una significativa presenza di associazioni
ambientaliste. La tematica ecologica non appare tuttavia, come
in Europa, circoscritta. Frequente il caso di collettivi impegnati
nellorganizzazione di lotte di quartiere o di favela. Negli
ultimi anni in America latina si è registrata una reazione
allintervento "paternalista" delle Ong, con conseguente
ripresa di prassi autogestionarie. Il collegamento con i movimenti
indigenisti assume significato di proporre modalità di
vita in armonia con il mondo naturale. Lapproccio catechizzante
del razionalismo occidentale al "primitivismo" della
selva appare capovolgersi. Una dinamica che ricorda la parabola
degli zapatisti, convertiti alla cultura india dallesperienza
di vita nella selva lacandona. Argomento, lafflato libertario,
particolarmente dibattuto. Si enfatizza la contraddizione, comune
alla maggioranza dei movimenti di massa, tra prassi dazione
diretta e tentativo di acquistare credibilità inserendosi
nel gioco politico. Interessante da questo punto di vista, la
riflessione del Elnz e le relative dichiarazioni: "non
vogliamo il potere".
La difficoltà ad acquisire una comune identità,
oltre che nel confronto con i movimentisti, emerge nella divergenza
di obiettivi. La prassi dei Sem terra viene accusata da alcuni
di focalizzarsi sulla conquista del campo a detrimento delle
tematiche ambientaliste. Polemica che si è fatta scontro
a proposito delle invasioni in aree appartenenti alle riserve.
I partigiani della riforma agraria, da parte loro, accusano
gli indigeni di usufruire di spazi enormi e di lasciare le terre
improduttive. Una concezione, la "produttività",
antitetica allo spiritualismo naturalista degli ultimi abitanti
delle foreste. Una insperata composizione, è avvenuta
durante le celebrazioni dello scorso aprile. Indigeni e Sem
terra hanno marciato insieme contro una polizia legittima erede
della dittatura, determinata a impedire qualsiasi turbamento
alla grande festa.
Una presenza numerosa, bizzarra e poco loquace riguarda gli
anarcopunk. Si tratta di un movimento parallelo a quello europeo,
nato, per evidenti condizionamenti, con un decennio di ritardo.
Il contrasto con gli indigenisti appare profondo, quanto quello
tra realtà metropolitane e regioni interne di questo
enorme paese. Il Brasile ha sviluppato città e megalopoli
su di un modello più vicino allefficientismo statunitense
che alle disastrate realtà latinoamericane. La povertà
e il dolore tendono ed essere negati; emblema di tale rimozione,
gli impeccabili centri cittadini. Gli anarcopunk, la loro simbologia
apocalittica, le carni trafitte, rappresentano una reazione
estrema alla cultura del benessere unilaterale.
 Massimo Annibale Rossi
Massimo Annibale Rossi
 Argentina: il commercio dellinsicurezza
Argentina: il commercio dellinsicurezza
"Hai paura di dio e del diavolo, del prete e del vicino,
del tuo datore di lavoro e del capo, del politico e del poliziotto,
del giudice e del carceriere, della legge e del governo. Tutta
la tua vita è una lunga catena di paure..."
- Alexander Berkman (da Che cosè il comunismo anarchico?,
1929).
"Senza luso della violenza, non esisterebbe nessuno stato"
- Max Weber (Saggi sulla sociologia, 1958).

Sono violenti questi tempi in cui viviamo. E stanno peggiorando.
é vero questo, o è solo una nostra percezione?
Qualunque cosa sia, non è un fenomeno unico a questo
paese o a questo continente. Al contrario, la percezione del
rischio della violenza è più forte dovè
più grande il bisogno del capitale di crearla e sostenerla:
nei "paesi emergenti" del mondo, dove la vera fame
allo stomaco rischia di minare le gioie molteplici del nuovo
circo virtuale di capitalismo.
Uno di quei paesi è lArgentina. Il nuovo governo dellAlleanza
di Fernando De la Rúa è virtualmente indistinguibile
da quello precedente di Carlos Menem, in quanto rispetta umilmente
i dettami del FMI e delle multinazionali straniere, come faceva
il suo predecessore. Seguendo le formule standard dei programmi
di aggiustamento strutturale, sta alzando le tasse per pagare
il debito estero, mentre taglia i posti di lavoro, taglia le
pensioni, svende tutto tranne laria stessa, provocando la disperazione.
Il divario tra ricchi e poveri sta crescendo ad una velocità
allarmante, e la gente ha paura; come laveva ai tempi della
campagna elettorale lanno scorso, quando De la Ra si presentò
in uno dei suoi spot televisivi sgambettando fiduciosamente
verso il futuro, circondato da una banda misteriosa di accoliti
con mitra in mano e vestiti di pelle nera. Era luomo che avrebbe
pulito il paese! In America Latina oggi, i politici devono essere
machos, come possono testimoniare Chavez con la sua tenuta
di corvé e Fujimori il killer di sequestratori.
Per quanto lo riguarda, Menem, quando presidente, lanciò
due grandi offensive allinsegna della "durezza contro
i delittuosi". Prima accusò gli immigranti (qui
quale politico civilizzato mai farebbe una tal cosa?) e poi
una "onda della violenza" di origine misteriosa gli
ha permesso di affermare che solamente applicando "la tolleranza
zero" e dando più poteri alla polizia viene eliminato
il crimine. Come Rudolf Giuliani testimonierà, non cè
niente di nuovo nel mondo della polizia moderna.
De la Rúa si è installato, sano e salvo; e ora
il periodo della luna di miele è finito, e ancora una
volta, come prima, la paura mangia lanima. La paura è
quella di essere vittime del crimine. Le statistiche ufficiali
differiscono per quanto riguarda lestensione del problema:
secondo il Ministero dellInterno, nel 1998 - lanno più
recente per il quale gli archivi sono disponibili - furono registrati
960.000 crimini (1 al minuto) in Buenos Aires e i suoi sobborghi.
Il governo di Buenos Aires indica la cifra di 138.200 (1 ogni
4 minuti). Per la Polizia Federale - dipendente dal Ministero
dellInterno - il numero di crimini per quel anno fu 199.148
(1 ogni 2,5 minuti). Non possono mettersi daccordo sulla quantità
di crimine commesso, ma non negano che ce nè tanto in
giro.
Secondo Marcelo Ciafardini, direttore della Politica contro
la Criminalità durante il governo di Menem, comunque,
"la sensazione generale dellinsicurezza è sempre
più alta della percentuale effettiva della criminalità.
Ciò che accade ad altri ha un effetto di rimbalzo, e
si arriva così al punto dove 90% della popolazione ha
paura di essere attaccato, sebbene questo non voglia dire che
davvero lo sarà".

Nonostante la sua indubbia conoscenza delle tecniche repressive,
la polizia sembra essere molto meno efficace quando si tratta
di trovare i colpevoli. Come dice Ciafardini stesso, "cè
stato un aumento dei crimini contro la proprietà e la
polizia trova i responsabili in solo 5% dei casi". Inoltre,
e stranamente, i sondaggi dopinione indicano che tra 68% e
73% della popolazione ha paura di quelli in divisa. Che cosa
mai avranno fatto per meritare questo?
Il risultato di tutto questo è la privatizzazione della
sicurezza. Ci sono 1.286 imprese di sorveglianza in Argentina,
pressocché tutte gestite da ex-soldati e capi di polizia,
i quali servirono lultima dittatura; si avvalgono di un esercito
di 90.100 uomini, tutti armati, e lanno scorso avevano un giro
daffari di US$ 986 milioni. I muscoli e le armi vengono seguiti
a poca distanza dalle televisioni a circuito chiuso; ci sono
63 imprese dedicate solamente alla sorveglianza elettronica
e via satellite.
I settori più ricchi della popolazione, quelli che hanno
più motivo per temere la scontentezza popolare, si permettono
il lusso di nascondersi lontani dalla pazza folla nelle loro
enclavi: quartieri chiusi con perimetri recintati, televisioni
a circuito chiuso e guardie di sicurezza private ed armate.
In totale, ci sono 412 di queste enclavi nei sobborghi di Buenos
Aires, con altre 87 sotto costruzione, e nella capitale stessa
ce ne sono 68.
Tutto questo è fuori dalla portata dei meno ricchi, ma
loro possono accontentarsi di tutta una serie di prodotti tranquillizzanti
offerta dallindustria di sicurezza: sistemi di allarme ad un
costo di $1.500, finestre di vetro temprato o laminato ($120
al metro quadrato), porte blindate ($2.500), serrature speciali
($220), griglie di ferro ($50 al metro quadrato), fulminatori
($65) e aerosol di gas paralizzante ($9).
(statistiche e quotazioni da Noticias Aliadas, il 24
luglio 2000)
 Leslie Ray
Leslie Ray
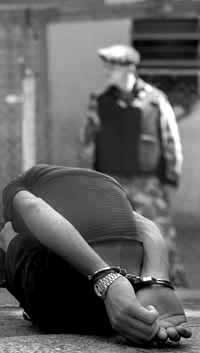
 Albenga: quattro giorni di pane,
more e fisica
Albenga: quattro giorni di pane,
more e fisica
Nei giorni 7-8-9-10 settembre, ad Albenga, si è tenuto
lincontro "LAutogestione". Liniziativa, promossa
dal C.I.R. (Corrispondenze e Informazioni Rurali), dall "Elicriso"
e dal sindacato Arti e Mestieri dellUSI-AIT, si è svolta
in modo piuttosto caotico, con aspetti contraddittori, anche
se rispettando, a grandi linee, il programma che riporto a parte.
é difficile fare, come mi è stato chiesto, un
resoconto di quello che è successo, anche perché
molte cose accadevano contemporaneamente e, spesso, in assenza
di un discorso veramente unificante. Mi limiterò a raccontare
lincontro come lo ho vissuto, scrivendo una sorta di diario.
Altri, probabilmente, lo avranno vissuto in modo diverso.
7 settembre: arrivo ad Albenga insieme a Francois e a Paolo,
due compagni dei Gruppi Anarchici Imolesi. Ci dirigiamo subito
verso Martinetto. Il programma prevede una serie di incontri
sulla salute e siamo curiosi di conoscere il punto di vista
di Stephan Lanke sullAIDS. Nel campo, situato in una località
notevole dal punto di vista paesaggistico, ci sono già
più di duecento persone, in parte intente ad ascoltare
la conferenza.
Lanke è decisamente controcorrente. Non si limita a mettere
in dubbio lattendibilità dei test sul virus HIV, non
si limita a mettere in dubbio la strettezza della relazione
tra AIDS e virus HIV, o lefficacia delle chemioterapie utilizzate
in tutto il mondo. A suo parere il virus HIV non esiste e le
chemioterapie utilizzate sono gravemente dannose. É davvero
difficile credergli. Non si può tuttavia fare a meno
di riconoscere che il suo discorso è basato su dati scientifici,
collegati tra loro in un quadro coerente da articolate argomentazioni.
Niente metafisica, dunque, e molti spunti per la riflessione.
Al termine della conferenza ci trasferiamo nella vicina Ceriale
per piantare la tenda in un campeggio convenzionato che ci ospita
a prezzi molto convenienti. Sono un po preoccupato per la grande
affluenza di compagni. é soltanto il primo giorno; se
continua così finiremo per essere troppi. Sarà
bene indirizzare più persone possibile al campeggio convenzionato.
Mentre a Martinetto, per la cena, funziona una cucina autogestita,
con tanto di forno, a Ceriale siamo ospiti del circolo presso
il quale ha sede la locale sezione dellUSI-AIT.
8 settembre: alle 10 del mattino, alla sala Siccardi, messa
a disposizione dal comune di Albenga, arriva Libereso Guglielmi
per il seminario sulle erbe spontanee di uso alimentare. Guglielmi,
noto ai compagni per il suo impegno nel movimento anarchico
sanremese, e al grande pubblico per essere stato il giardiniere
di Italo Calvino, è un botanico formidabile. Chi, come
me, ha studiato scienze naturali riconosce subito in lui quella
competenza che può avere soltanto un uomo che la botanica
non la ha imparata solo sui libri: un genere di competenza ormai
raro anche tra i docenti universitari. Guglielmi arriva con
un gran fascio di erbe, le stende sul tavolo, le descrive, le
fa toccare, annusare, assaggiare: come facevano i botanici dellOttocento.
Vorrei ringraziarlo, ma non ci riesco. Viene "sequestrato"
da alcuni compagni del CIR che lo accompagnano a Martinetto,
dove è atteso con impazienza. Pare sia stato trattenuto
là per quattro ore.
Io invece resto a presidiare il gazebo che i compagni della
locale sezione dellUSI-AIT hanno allestito di fronte alla sala
Siccardi allo scopo di fornire informazioni alle persone che
giungono in treno. Del resto, alle 18 devo cominciare il mio
seminario sullorganizzazione sociale libertaria. Tanto vale
rimanere lì.
Continuano ad arrivare compagni da tutta Italia (alla fine saremo
più di quattrocento). Mi dicono che a Martinetto il seminario
sui metodi di coltivazione alternativi non si è tenuto.
Si è svolto invece un incontro del CIR, nel corso del
quale si è parlato soprattutto degli interventi da realizzare
a Campanara, sullAppennino Tosco-Romagnolo.
Alla prima parte del mio seminario partecipano una trentina
di persone, tutte molto interessate a dibattere largomento.
Chiusa la sala, torniamo a Martinetto dove incontro la delegazione
della CNT-AIT francese, con la quale, grazie a Francois che
ci fa da interprete, discuteremo per tutta la serata seduti
a tavola, al circolo di Ceriale.
9 settembre: alle 11 a Martinetto inizia il seminario sullenergia
solare condotto da Guido Coraddu. In collaborazione con un compagno
tedesco, e utilizzando i materiali che si sono portati da casa,
ci spiegano come si può realizzare un impianto fotovoltaico.
Vengono rivolte loro numerose domande sia sugli aspetti tecnici
sia sulla legislazione relativa agli impianti autonomi per la
produzione di energia elettrica.
Al termine, si inizia il dibattito su "biotecnologie e
lotte rurali ed urbane". Sono presenti compagni francesi,
inglesi e tedeschi. Il livello della discussione però,
almeno inizialmente, è piuttosto basso. Molti preferiscono
occupare il tempo a raccogliere le more che sporgono dai cespugli
circostanti. Alle 14 me ne devo andare per scendere ad Albenga
dove, alla sala Siccardi, è in programma la prosecuzione
del mio seminario e, subito dopo, la presentazione dellattività
svolta dallUSI-AIT nella provincia di Savona. Nel frattempo,
a Martinetto, continua lassemblea sulle biotecnologie, la quale,
mi dicono, è servita, se non altro, ad approfondire la
reciproca conoscenza tra i gruppi che si occupano dellargomento.
Alle 16, sempre a Martinetto, segue un seminario con gli Elfi
sulleducazione libertaria.
Alle 20, dopo la presentazione dellattività dellUSI-AIT
fatta da Renzo Ferraro e Giampiero Icardo, protagonisti di numerose
e proficue vertenze che negli ultimi anni hanno interessato
la Valbormida, arriva Alessio Lega. Lo invitiamo a venire con
noi a Ceriale, dove, al circolo, ci aspettano per la cena. Alessio
è, a mio parere, uno dei più promettenti tra i
nuovi cantautori italiani: passa con facilità da canzoni
impegnate come "Ai funerali del pirata", dedicata
a Fabrizio de André, a canzoni scherzose come l "Inno
degli anarcociclisti" (senza dimenticare il repertorio
tradizionale anarchico). Dopo la cena, lo accompagnamo a Martinetto,
dove si esibirà brevemente sfruttando lamplificazione
di un gruppo locale che ha appena finito di suonare.
10 settembre: ci si alza pigramente, come è naturale
accada dopo una serata di festa. é in programma lassemblea
conclusiva. Verso le 12 si comincia. Il dibattito è fiacco:
alcuni sottolineano i lati positivi della quattro giorni, altri
sottolineano che la strada verso lautogestione è ancora
lunga. Nessuno però entra nel merito delle carenze organizzative,
quasi che il problema non si fosse mai posto. La mia impressione
è che ci sia poca voglia di toccare argomenti che potrebbero
portare a beccarsi reciprocamente. In realtà, anchio
non ne ho nessuna voglia. Alle 14 viene annunciato il pranzo
che si svolge secondo strani riti tribali.
La festa è finita: andate in pace.
 Luciano Nicolini
Luciano Nicolini
 Petrolio e proteste
Petrolio e proteste
I recenti aumenti dei prezzi alla pompa dei carburanti
meritano qualche doverosa considerazione da parte di chi si
occupa di trasporto sostenibile.
La scarsità dellofferta di petrolio greggio era stata
ampiamente anticipata dallAgenzia Internazionale per lEnergia,
che non è una organizzazione ecologista, ma un organismo
intergovernativo dei G7 nato dopo la crisi petrolifera dei primi
anni 70. Quello che manca non è in realtà il petrolio
tout-court quanto quello che gli esperti definiscono petrolio
a basso prezzo, che è quello che sgorga spontaneamente
dal sottosuolo una volta che il giacimento è stato individuato
e raggiunto dalle trivelle. Un diverso tipo di petrolio è
quello che si trova frammisto a rocce e sabbie bituminose, per
estrarre il quale occorre impiegare energia in misura variabile
a seconda del tipo di lavorazione richiesta. Petrolio di questo
tipo è ancora presente in abbondanza sul nostro pianeta,
ma chiaramente i costi per la sua estrazione sono enormemente
superiori rispetto al petrolio a basso prezzo.
In questottica appaiono chiaramente mal dirette le proteste
di quelle categorie maggiormente penalizzate dagli aumenti del
carburante, che vedono ora nella protervia delle multinazionali,
ora in quella dello stato la causa dei loro problemi, che invece
è da individuare sostanzialmente in banalissimi meccanismi
di mercato.
Altrettanto evidente è la miopia della nostra classe
dirigente che, per motivazioni di puro consenso elettorale,
ha preferito la tattica dello struzzo a quella della messa in
discussione di uno stile di vita che ormai fa acqua da tutte
le parti. Proporre come fa qualcuno di aumentare le produzioni
di petrolio è irrealistico in quanto equivale a chiedere
ai produttori di terminare le proprie scorte di oro nero in
pochi anni a dei prezzi stracciati, ponendo fine a quel minimo
di benessere che i paesi OPEC riescono a garantire ai loro sudditi.
Se si vuole perseguire questa scelta lunica soluzione potrà
essere una seconda guerra del golfo, molto più devastante
della prima e che, bene che vada, porterà come unico
risultato quello di ottenere dei ribassi dei prezzi fino allesaurimento
delle scorte, momento nel quale non avremo più margini
di manovra.
Ma altrettanto miope è lottica che propone qualcuno
dei tanti soloni "instant book" che popolano il nostro
panorama massmediologico, che risuona pressappoco cos":
sono finite le vacche grasse, stringiamo la cinghia. Questo
punto di vista potrebbe tradursi nella pratica di costringere
i consumatori a drastici tagli della loro bolletta energetica,
senza però toccare i meccanismi che stanno alla base
dellattuale situazione, per cui potremmo trovarci un giorno
a bere latte fresco importato dallOlanda, come già facciamo,
e contemporaneamente essere costretti a passare parecchie ore
della nostra giornata in spostamenti su mezzi di trasporto alternativi
allauto che, in una società comunque autocentrica, non
hanno nessunissima possibilità di funzionare in maniera
efficace, finanziando attraverso una perdita secca del valore
duso del nostro tempo la scelta di privilegiare i profitti
di pochi a scapito della qualità della vita di molti.
Appare allora evidente che le soluzioni da adottare per fronteggiare
la crisi petrolifera, che altro non è se non lo specchio
della crisi del modello di vita occidentale, che di fatto poggia
le sue basi sul mito della illimitata disponibilità di
risorse, vanno al di là sia del semplice riproporre miti
consumistici ormai logori, sia di unottica un po bigotta che
vede nel "sacrificio" lunica strada per purificarci
dal peccato originale.
 Enrico Bonfatti
Enrico Bonfatti
 Nonviolenti in marcia
Nonviolenti in marcia
Domenica 24 settembre si è svolta da Perugia ad Assisi
la marcia per la nonviolenza contro tutti gli eserciti e le
guerre promossa dal Movimento Nonviolento e dal Movimento Internazionale
per la Riconciliazione (MIR); vi hanno preso parte alcune migliaia
di persone persuase della necessità di opporsi direttamente
ed integralmente alla violenza e allingiustizia; di lottare
nel modo più coerente ed intransigente contro tutti i
poteri oppressivi; di contrastare la guerra, i suoi apparati,
i suoi strumenti. La marcia del 24 settembre ha segnato una
cesura profonda nella vicenda del pacifismo italiano e nella
tradizione degli appuntamenti in cammino tra le cittadine e
per le campagne umbre sulle orme di due grandi resistenti e
rivoluzionari come Francesco dAssisi ed Aldo Capitini. Una
rottura ed insieme un ritorno alle origini, alla radicalità
ed alla limpidezza di una posizione rigorosa dal punto di vista
intellettuale e morale, quindi anche politico.
Una cesura poiché prende atto delle ambiguità,
e le smaschera e le denuncia, che hanno portato lo scorso anno
alla catastrofe del movimento pacifista italiano così
come sera definito negli ultimi due decenni dopo quel grande
momento di "gruppo in fusione" del tempo dellopposizione
ai missili a Comiso.
Lo scorso anno il movimento pacifista italiano collassò.
Da un lato perché erano prevalse tendenze burocratiche
e per così dire parastatali, subalterne alle trame governative;
e soprattutto era prevalso un atteggiamento pusillanime e colluso
di fronte alla protervia degli stragisti: occorreva fermare
la guerra, ed invece ci si limitava alle lamentazioni ed alle
sommesse richieste agli assassini che erano troppo indaffarati
alle loro opere di bassa macelleria per trovare il tempo di
ascoltare i queruli e garbati signori in attesa nelle anticamere.
Occorreva lazione diretta nonviolenta, occorreva un movimento
nonviolento di massa che andasse a fermare materialmente i decolli
dei bombardieri (un tentativo in questa direzione lo facemmo
ad Aviano con lazione diretta nonviolenta delle mongolfiere
per la pace, di cui su "A" si è già
scritto). Dallaltro perché erano presenti nel movimento
che si opponeva alla guerra, ed emersero in modo flagrante e
dirompente, ambiguità profonde sulla violenza: ma la
violenza è sempre larma dei ricchi, è sempre
lo strumento degli oppressori, è sempre la legittimazione
del forte rispetto al debole, allo sfruttato, alloppresso,
al denegato. La violenza non porta alla liberazione, ma a nuovi
potenti e nuove oppressioni.
Così questanno, accogliendo un invito di Pietro Pinna,
il primo obiettore di coscienza in Italia, i movimenti nonviolenti
hanno chiamato a marciare non le organizzazioni ma le singole
persone, e le hanno chiamate a marciare non genericamente per
la pace, ma specificamente per la nonviolenza. Quella nonviolenza
che è lotta la più intransigente contro tutte
le violenze, contro tutte le ingiustizie; quella nonviolenza
che è rivoluzione aperta che afferma la dignità
di ogni essere umano e la solidarietà di tutti gli esseri
umani contro il male e la morte.
Questa scelta per la nonviolenza ha segnato quindi anche una
novità profonda rispetto alle marce "per la pace"
degli ultimi venti anni, ricollegandosi direttamente ed intimamente
alla prima marcia Perugia-Assisi, quella promossa da Capitini
il 24 settembre 1961. Ed è stata una esperienza forte:
con più momenti di riflessione cui hanno dato voce, tra
altri, persone come Mao Valpiana, Angelo Cavagna, Alberto L
Abate, Beppe Marasso, Sandro Canestrini, Alex Zanotelli: alcune
delle figure più belle dellantimilitarismo intransigente,
della solidarietà concreta, della lotta in cui si paga
di persona, della condivisione della sorte dei più oppressi,
della rivoluzione dal basso (della "omnicrazia" avrebbe
detto Capitini: "il potere di tutti").
La marcia è unassemblea itinerante: per incontrarci
e riflettere insieme, per illimpidire posizioni e definire lotte
e ricerche; essa non finisce ad Assisi: da Assisi comincia.
La nonviolenza è una rivoluzione in cammino.
Per saperne di più: "Azione nonviolenta", 37123
Verona, via Spagna 8, tel. 045/8009803, e-mail:azionenonviolenta@sis.it
http://www.unimondo.org/azionenonviolenta
 Peppe Sini
Peppe Sini
nbawac@tin.it
 Operai da morire
Operai da morire
Sabato 16 settembre si è svolto a Genova il convegno
OPERAIO DA MORIRE (morti in fabbrica e fabbriche di morte) organizzato
da MEDICINA DEMOCRATICA1.
Si è trattato di unimportante occasione per fare il
punto sullo stato delle politiche di prevenzione degli incidenti
e delle malattie da lavoro e, in generale, da produzione, sulla
legislazione che regola la materia, sulle iniziative di parte
operaia contro le fabbriche di morte.
Erano presenti più di cento lavoratori di decine di fabbriche
e di aziende fra le tante, troppe, coinvolte da questordine
di problemi e si è avuto modo di raccogliere informazioni
e scambiarsi valutazioni di grande interesse.
Cercherò di segnalare quelle che mi sembrano essere le
questioni più importanti fra quelle sollevate rimandando
agli atti del convegno per una copiosa massa di informazioni
di carattere particolare che sono state raccolte.
Come era perfettamente prevedibile, ma è bene ribadirlo,
le promesse che il governo di centro sinistra ha fatto, nel
momento del suo insediamento, per quel che riguarda la prevenzione
degli infortuni e delle malattie da lavoro, sono state disattese
e la mortalità e nocività da lavoro hanno continuato
a crescere negli ultimi anni. Regolarmente, quando vengono pubblicati
sui giornali articoli, non troppo evidenti ed estesi, sui morti
ed infortuni da lavoro, veniamo informati del crescere di questo
aspetto del quotidiano svilupparsi della contraddizione tra
lavoro e capitale.
Un fattore importante per laggravarsi della situazione è
stata la precarizzazione del lavoro, precarizzazione che, spostando
i rapporti di forza a favore del padrone, rende sostanzialmente
inefficace la legislazione a tutela del lavoratore. Infatti
un operaio o un impiegato con posti a rischio di licenziamento
sono indotti a non utilizzare nemmeno la limitata legislazione
attuale a propria tutela per il, ragionevole, timore di perdere
il posto di lavoro. Luniverso, poi, del lavoro grigio e di
quello nero, degli appalti e subappalti, sfugge ad ogni controllo
attendibile soprattutto per quel che riguarda gli infortuni
ma anche per i morti sul lavoro e, ancora di più, per
quelli da nocività sul lavoro. Non dobbiamo dimenticare
che molte morti da lavoro derivano dal contatto con sostanze
nocive che determinano la morte a distanza di anni con le evidenti
difficoltà di ottenere anche solo il riconoscimento delle
cause del decesso.
A maggior ragione questa considerazione vale per luniverso
del lavoro nero, degli immigrati, del lavoro autonomo eterodiretto
che sfugge ad ogni rilevazione. Non dobbiamo, poi, dimenticare
che migliaia di aziende italiane operano nei Balcani, in Romania
ed in altri paesi dellest e del sud del mondo dove mancano
anche le limitate garanzie che caratterizzano larea metropolitana
del capitalismo italiano.
La legislazione stessa è resa inefficace da diversi meccanismi
assolutamente non casuali:
a i costi della tutela
legale e di quella medica sono eccessivi per i lavoratori anche
in considerazione del fatto che non è sempre facile provare
in maniera certa le cause delle malattie e dei decessi, che
i periti di parte padronale sono aggressivi e competenti, che
i lavoratori hanno difficoltà ad affrontare cause che
durano, sin troppo sovente, anni. Anche sul terreno giuridico
la disparità di forze fra lavoratori ed imprese incide
pesantemente;
b il fatto che le
sanzioni contro le imprese sono inadeguate, quelle economiche
non sono un deterrente a fronte dei risparmi che ottengono non
investendo in sicurezza, quelle penali sono lievi e basta cambiare
ogni tanto i dirigenti direttamente responsabili della nocività
per rendere inefficace una pena che, consistendo in una condanna
con la condizionale, può essere subita dal singolo dirigente,
lautamente risarcito dallazienda, senza alcun effetto reale;
c le risorse poste
a disposizione delle amministrazioni che devono garantire la
sicurezza sul lavoro sono inadeguate e il coordinamento fra
queste amministrazioni spesso mancante o insufficiente;
d una serie di contratti
aziendali e categoriali, accettati dai sindacati di stato e
imposti con il ricatto della perdita di posti di lavoro se si
applica rigorosamente la normativa attuale, concedono alle imprese
un margine di manovra ancora maggiore rispetto a quello che
la legge prevede;
e le grandi imprese
responsabili del degrado dellambiente di lavoro e del territorio
investono importanti risorse per influenzare il ceto politico,
i media, la scuola, le amministrazioni, la comunità scientifica.
Sempre più e con crescente efficacia viene venduta limmagine
della fabbrica e dellufficio "postindustriali" ove
non vi sarebbero fatica, incidenti, logorio fisico e psichico
e che sarebbe perfettamente integrata nel territorio. La fabbrica
ecologica, insomma.
Siamo di fronte, evidentemente, ad una situazione difficile
anche per la caduta dellattenzione alla questione sociale.
La sinistra istituzionale, ma anche settori di quella che si
vuole antagonista e persino libertaria, ha rimosso lanalisi
concreta della condizione lavorativa, la definizione di precise
proposte e di un autonomo punto di vista sulla produzione e
sembra convinta che le donne e gli uomini che vivono la condizione
di salariato siano scomparsi o siano soggetti di una vaga produzione
immateriale.
Gli stessi dati empirici, la morte, la malattia, la mutilazione
di migliaia di lavoratori rimettono la questione sui piedi.
Il lavoro coinvolge i corpi e le menti, li piega al dispotismo
aziendale, fa di decine di milioni di persone forza lavoro,
merce da utilizzare secondo i criteri delleconomia. La lotta
contro la nocività, di conseguenza, è, in primo
luogo, lotta per affermare un autonomo punto di vista di classe
sul lavoro.
Gli assi di intervento individuati sono precisi:
a Porre al centro
il sapere non specialistico di chi vive la condizione salariata.
I lavoratori e le lavoratrici non sono "tecnici" della
nocività ma possiedono, collettivamente, una conoscenza
del ciclo produttivo, delle sue caratteristiche, dei suoi effetti.
Questo sapere collettivo è il punto di partenza di unazione
efficace contro la malattia, la mutilazione, la morte.
b Questo sapere va
coordinato e diffuso. La relazione diretta fra i collettivi
che si pongono su questo terreno è essenziale. Vanno
prodotte precise campagne di informazione sul lavoro così
come è realmente.
c Settori di tecnici
della malattia e del diritto sono disponibili ad impegnarsi
su questo terreno e da anni lo fanno con impegno generoso. Medici,
avvocati, ricercatori, docenti possono essere interlocutori
privilegiati per una campagna sulla sicurezza del lavoro. La
comunità scientifica, per fortuna, non è compatta.
Dobbiamo essere capaci di operare per spostarne settori consistenti
nella direzione della difesa degli interessi del lavoro salariato,
delle classi subalterne, della vivibilità del territorio.
d Le trasformazioni
dellorganizzazione del lavoro, il decentramento produttivo,
la precarizzazione, rendono necessaria una trasformazione delle
modalità stesse dellinchiesta e dellintervento. Allombra
della grande fabbrica è cresciuto un universo produttivo
che dobbiamo conoscere e, per conoscerlo, è necessaria
lazione quotidiana e la sperimentazione di nuove modalità
di intervento.
Mi sento di fare unultima considerazione, è sempre interessante
notare che quando persone seriamente interessate ad un problema
centrale per la società ne ragionano con passione e rigore,
molti elementi della critica libertaria allordine sociale dominante,
in generale, ed allillusione che vi possa essere uno stato
che opera a favore delle classi subalterne, in particolare,
appaiono in maniera chiara e netta come appare chiara lesigenza
di autonomia nellazione e nel progetto dei soggetti sociali
direttamente coinvolti nelle questioni che si affrontano.
Non si tratta di pretendere alcuna primogenitura ma ritengo
che sarebbe importante valorizzare ogni verifica empirica della
critica anarchica al potere e di costruire tutti i rapporti
che questa comunanza, anche parziale, di sensibilità
permette.
Un impegno importante al quale il convegno di Genova ha dato
un prezioso contributo.
 Cosimo Scarinzi
Cosimo Scarinzi
1- Medicina Democratica, in questoccasione
ha fatto circolare il n. 128-131 della sua rivista dedicato
a unimportante inchiesta sul petrolchimico e montefibre di
Porto Marghera e un "Manuale Critico della legislazione
sui luoghi di lavoro" che si possono richiedere a Medicina
Democratica CP 81, 20100 Milano,tel.024984678

|

