|
"Naturalmente gli Stati Uniti si
preparano a stabilire un regime fantoccio.
Io non ho bisogno che i propagandisti di Milosevic me lo dicano.
Ma oggi cè stata la più stupenda rivolta nella
recente storia di Belgrado! Oltre al fatto che un regime dittatoriale
è stato rovesciato!
Non cè più nessun fottuto governo nel centro
di Belgrado. Le strade sono liberate, i poliziotti si sono arresi
o sono stati disarmati, molte persone si autogovernano.
Le automobili più costose sono state usate per costruire
barricate in tutta la città, metà delle attività
economiche sono in sciopero, gli sbirri hanno preso le più
stupende botte, uffici e negozi dei ricchi sono stati assaltati
e sfasciati e la fottuta TV, fortezza della televisione di stato,
è stata distrutta e bruciata! La stessa fottuta stazione
TV che mi è sempre stata sui nervi fin da quando ero
una bambina, ma non avevo mai potuto farci nulla (tranne lanciargli
qualche porcheria quando ne avevo loccasione). Ora finalmente
non cè più nessuna fottuta televisione di stato!
Se queste non sono ragioni per essere felici, io non so quali
altre possano esserlo! Io so che questa situazione non potrà
durare a lungo, ma sono completamente felice finché ci
sarà. E spero che sapremo mandar via il prossimo regime
democratico allo stesso modo, ma in minor tempo!"
Queste parole immediate, prive di elaborazione letteraria, lanciate
sulla lista a-infos da Mihaela, una giovane anarchica serba,
riassumono in un rapido accecante flash lo spirito della rivolta
che a Belgrado ha portato alla fine del regime di Milosevic.
In esse traspare la chiara consapevolezza della fragilità
del momento di grazia che descrivono ma anche la gioia nel constatare
che le insurrezioni popolari possono vincere, che non sono solo
un retaggio di passati certo mitici ma ormai inattingibili.
Naturalmente sappiamo che il mancato intervento dellesercito,
le pesanti pressioni internazionali, hanno contato tanto quanto
lesasperazione di una popolazione stremata dalla guerra, dai
bombardamenti "umanitari" della NATO e dallembargo.
Ma quel che mi preme sottolineare è il riemergere di
un protagonismo di piazza in Europa.
É la piazza fisica nella quale si esprime la rivolta
e lo scontro contro i poteri costituiti ed è la piazza
virtuale nella quale si colloquia con il mondo intero. Rata,
un giovane anarcosindacalista serbo, studente universitario,
partecipa alla mobilitazione, organizza loccupazione delluniversità,
passa giornate intere senza dormire ma ogni giorno, puntualmente,
passa da casa per spedire in rete la cronaca sempre più
veloce degli avvenimenti. Sa di vivere uno dei rari momenti
in cui la storia accelera ma il coinvolgimento forte, anche
sul piano emozionale, non gli impedisce di aprire la sua finestra
sul mondo, di trasformare la storia in cronaca, la vita in narrazione.
In queste settimane (siamo ai primi di ottobre) molti tra coloro
che seguono lo sviluppo delle varie mobilitazioni internazionali
avranno vissuto un senso di partecipazione e vicinanza congiunto
ad una latente impressione di straniamento.

 Ma quanto mi costi!
Ma quanto mi costi!
Facciamo un passo indietro e altrove. Passiamo da Belgrado
a Praga. Due capitali che assumono oggi un valore emblematico
perché entrambe nella parabola del postcomunismo di stato,
entrambe reduci dalla dissoluzione di unentità statuale
multietnica, entrambe al centro dellattenzione in questo primissimo
scorcio dautunno. Certo a Praga la fine del regime e la dissoluzione
della Cecoslovacchia non sono state accompagnate dalle guerre
feroci, dalle pulizie etniche che hanno segnato la regione balcanica,
ma le cronache delle ultime settimane ci offrono più
di uno spunto di riflessione. Una riflessione sullemergere
prepotente di unopinione pubblica internazionale e sul contestuale
organizzarsi di un apparato repressivo transnazionale assai
efficiente. Ma anche una riflessione sul sempre maggiore ruolo
dellinformazione, sia quella "autogestita" sia quella
degli stati e degli apparati di potere, nella costruzione di
un evento e nella sua "consumazione" simbolica.
Ma torniamo a Praga. Il 26 settembre, è noto, vi si
è svolta una grande manifestazione internazionale contro
il vertice della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.
Era uno degli appuntamenti chiave del movimento di controglobalizzazione
dopo Seattle, Davos, Washington, il MayDay, Melbourne. Anche
questa volta chi non era presente ha potuto seguire in tempo
reale gli avvenimenti tramite internet e con collegamenti diretti
attraverso una fitta rete di cellulari. Ho il sospetto che se
qualche cinico buontempone volesse fare un bilancio economico
di quella mobilitazione troverebbe in buona posizione, dopo
le spese legali, mediche e quelle per la retribuzione degli
straordinari a poliziotti e soldati, le bollette telefoniche
dei contestatori di mezzo mondo. Daltro canto quella dellinformazione
è stata una battaglia rovente tanto quanto quella combattuta
nelle strade della capitale ceca. Una battaglia senza esclusione
di colpi.
Se la rete delle reti è stata la piazza nella quale è
cresciuta e si è organizzata la manifestazione praghese,
i media "classici" - televisioni e carta stampata
- sono stati usati con perizia da avversari ormai consapevoli
di dover fronteggiare un movimento in crescita. Demonizzazione
del movimento nel periodo precedente il vertice da parte di
tutta la stampa e la TV ceca; prudenti dichiarazioni distensive
del presidente Havel, che nellapprossimarsi dellincontro,
invita in TV capitalisti e contestatori, ambientalisti e presidenti
di BM e FMI; definitiva criminalizzazione del movimento dopo
gli scontri di piazza. Dulcis in fundo: assoluto silenzio sulla
feroce repressione scatenata dalla polizia ceca nei giorni successivi:
gli arresti di massa, gli abusi, le violazioni dei diritti,
le molestie sessuali, le torture e le vere e proprie "sparizioni".
Ma la controinformazione entra subito in azione e le testimonianze
atroci di chi aveva sperimentato sulla propria pelle le galere
ceche rimbalzano veloci sulle varie consolle del pianeta: ovunque
si organizzano sit-in di protesta, occupazioni ed assedi delle
ambasciate.
Limportanza della narrazione dellevento eccede, sovrasta al
punto di oltrepassarlo, levento stesso. In quella che Rifkin
definisce "lera dellaccesso" linformazione svolge
un ruolo nevralgico non solo perché, classicamente, "orienta"
lopinione pubblica ma perché diviene fattore decisivo
non solo nella definizione delle regole del gioco ma nellaccesso
consentito o negato al gioco stesso.
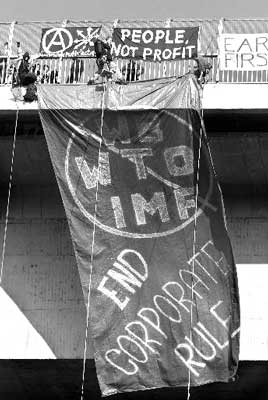
 A Seattle, invece
A Seattle, invece
Facciamo un altro passo indietro e altrove. Passiamo da Praga
a Seattle. Per quello che concerne le dinamiche di piazza le
due manifestazioni appaiono simili: organizzazione per gruppi
di affinità (a Praga addirittura fisicamente individuabili
nei tre colori dei cortei: il rosa, il giallo e il blu), tattiche
nonviolente e di resistenza passiva accanto a tattiche di attacco
diretto e talora violento, forte coinvolgimento internazionale,
lobbiettivo puntato sia sugli aspetti concreti che su quelli
simbolici della presenza di piazza, forte repressione statuale,
sia pure con gradi significativamente diversi quanto a intensità.
Sul piano dellinformazione lo scenario muta invece radicalmente.
A Seattle, nonostante la sorpresa ed alcune eclatanti sconfitte
di piazza, lapparato repressivo si mostra non meno efficiente
di quello schierato nella Repubblica ceca, ma la battaglia dellinformazione
è tutta a favore dei dimostranti. Persino Clinton arriva
a rilasciare dichiarazioni pubbliche in cui riconosce il valore
morale della protesta. Dopo Seattle le organizzazioni più
moderate vengono addirittura invitate a mandare rappresentanti
alle kermesse ufficiali dei vari organismi transnazionali: anche
il WEF (Word Economic Found), che è unorganizzazione
privata, si apre ai contestatori, si dice disponibile al dialogo,
sensibile alle istanze del movimento. A Praga invece abbiamo
visto come, a parte il patetico democraticismo di un presidente
ex oppositore, la guerra dellinformazione trovi ben preparati
i media di regime e su questo piano il movimento, pur assai
vivace in piazza, registra una sostanziale sconfitta. Una sconfitta
che su un piano dolorosamente concreto lascia briglia sciolta
allinasprirsi della repressione.
Credo sia tempo di bilanci. Ad un anno da Seattle, dopo i dubbi
risultati delle manifestazioni italiane contro Tebio a Genova
e contro lOCSE a Bologna, con gli occhi e le orecchie pieni
delle immagini ed i suoni provenienti da Praga e Belgrado e,
sullo sfondo, tragicamente, un conflitto "antico"
come quello in corso in Israele, sempre in bilico tra cronaca
e storia e tra realtà e spettacolo, vediamo crescere
nuovi movimenti nelle piazze, quelle virtuali e quelle materiali.
Oggi più che mai il saper fare deve coniugarsi ad un
narrare che sia azione, relazione, capacità di prefigurare
nuovi mondi.
 Maria Matteo
Maria Matteo
|

