
TV/ Il vice-questore anarchico?
Sarà Giallini, ma fa arrossire
È lunedì 7 novembre quando, sul sito di Repubblica, leggo
Rocco Schiavone, il vicequestore anarchico, è Giallini;
il titolo fa riferimento alla serie Rocco Schiavone,
in onda da mercoledì 9 novembre su RaiDue.
Silvia Fumarola che firma il pezzo, scrive che il vicequestore
della Polizia – l'eroe dei libri di Antonio Manzini editi
da Sellerio – è Anarchico, intelligente...;
nello stesso articolo le dà manforte il protagonista
della fiction, Marco Giallini, che dice: “Schiavone
è a suo modo un anarchico...”.
Da sempre osservo e ascolto molto volentieri tutto quel che
ha a che fare con l'anarchia, e un'occasione così ghiotta,
oltretutto servita a domicilio, metto in conto di non perderla;
è anche vero che difficilmente si resiste alla rivoluzionaria
novità di un antieroe che indaga, cinico, spesso
sgradevole, con una sete di giustizia che non combacia
con la legge, e che – come dice il regista Michele
Soavi – “... è protagonista di un western.
Un cowboy senza pistola più infernale di un bandito e
giudice supremo delle ingiustizie umane.”
|
| Il cast della serie. Al centro, Marco Giallini |
E così, mercoledì 9 – roso dall'invidia
per non esser mai stato capace d'inventare per i miei romanzi
di poca cosa un personaggio così alternativo come il
vicequestore Schiavone, segno indiscutibile di una scrittura
libera e obiettiva – mi accomodo davanti alla TV in attesa
che inizi la fiction, certo che block notes nuovo e lapis accuratamente
appuntito posati sul tavolino accanto a me, dovranno fare gli
straordinari: chissà quante cose interessanti trascriverò...
non vedo l'ora.
Mentre la pubblicità scorre via, mi frulla per la testa
la mail ricevuta l'altrieri dalla casa editrice Sellerio, soprattutto
il passaggio “Un vicequestore nato e cresciuto a Trastevere,
che (...) viene trasferito ad Aosta. Rocco Schiavone ha combinato
qualcosa di grosso per meritare un esilio come questo. È
un poliziotto corrotto, ama la bella vita. È violento
(...) saccente, infedele, maleducato con le donne, cinico con
tutto e chiunque (...)” e visto che la pubblicità
continua, mi alzo, sfilo dalla libreria la mia vecchia copia
sottolineata e piena di appunti de “L'anarchia. Il nostro
programma” di Malatesta, la poso accanto al blocco e mi
risiedo: e se il buon Errico avesse toppato?
Inizia la puntata.
Chissà quante cose interessanti trascriverò...
non vedo l'ora.
Finisce la puntata.
Osservo block notes e punta della matita intonsi; dalla copertina
del libro, noto che l'autore mi osserva con sguardo un filo
stanco, ma benevolo e soddisfatto.
Mentre un nuovo carosello di pubblicità scorre via, mi
frulla per la testa un'immagine: il vicequestore Schiavone colto
da malore attivo che vola da una finestra del quarto piano della
questura di Aosta; non ci fosse, potrebbe andar bene anche un
piano più basso. Non vedo l'ora.
Marco Sommariva
Operaio, cinese, 24 anni, poeta/
Suicida
Un tempo era un villaggio di pescatori, ma Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, è diventata da oltre un ventennio la roccaforte del rampante capitalismo cinese. Nelle tantissime fabbriche caserme della città, (quindici milioni di abitanti), la vita umana vale meno che niente. Una volta risucchiati in quest'inferno, gli operai vengono trattati alla stregua di larve, considerati carne da macello, da sfruttare e spolpare fino all'osso. Un'umanità la loro, che viene annebbiata da uno stordimento precoce, costretta a seppellire sentimenti, dignità. E sogni. “La fabbrica cattura le loro lacrime/ prima che abbiano la possibilità di cadere...” dicono dei versi del poeta Xu Lizhi, il quale prima di suicidarsi nel 2014 a soli ventiquattro anni, era operaio a Shenzhen nello stabilimento della Foxconn, multinazionale che impiega migliaia di maestranze e produce componentistica elettronica per i grandi marchi del settore.
Qualche anno fa la realtà-lager della Foxconn venne portata dalla stampa all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale per numerosi casi di suicidi tra i lavoratori. Xu Lizhi alla Foxconn di proprietà di Terry Gou (“l'imperatore dell'outsourcing”) ci lavorava da quattro anni ma era come se ci avesse passato dentro già una vita intera, tant'è che corpo e psiche non hanno resistito ai ritmi forsennati e bestiali della produzione (“...tutte le ossa del mio corpo non collaboreranno/ posso solo rimanere steso/ in questa oscurità, inviando un silenzioso segnale di pericolo/ ancora e ancora solo per sentire/ ancora e ancora l'eco della disperazione”).
La poesia era per Xu Lizhi l'unica pausa giornaliera per raccogliere e consegnare al vento i suoi pensieri, per gridare il proprio malessere e distanziarsi dallo stato di totale sottomissione a cui lo relegava la fabbrica. Grondanti delle ferite interne e della rabbia di chi vorrebbe ribellarsi ma non può, ad un certo punto hanno cominciato a girare in rete i suoi versi che sono un pugno sono stati raccolti in Mangime per le macchine (Edizioni Istituto Onorato Damen, Catanzaro, 2016, pp. 53, € 5,00) per la curatela di Renato Marvaso e della traduttrice Anna Lavecchia la quale nella prefazione commenta: “Per Xu Lizhi la carta e gli ideogrammi scolpiti sono il luogo della sua protesta, l'unico luogo permesso ed inviolabile, dove non è necessario smussare le parole e la ribellione prende forma”.
La parola di Xu Lizhi si fa così sconforto di una tragedia che è personale e, al contempo, collettiva, urlo di esistenze dimenticate, di “gioventù chinata sulle macchine” su cui il dolore “fa gli straordinari giorno e notte” e spinge a tranciare anzitempo il legame con la vita.
Il canto di Xu Lizhi è quello di un uomo in disperata solitudine, purtroppo la poesia non lenisce né cura questo stato di oscurità e sofferenza, ma può farlo solo conoscere agli altri uomini.
Per questo è vero quello che sottolinea ancora Annamaria Lavecchia: dopo la lettura (scossa) dei versi di Xu Lizhi potremmo anche scegliere di non guardare, di spostare lo sguardo dall'altra parte, ma non possiamo far finta di non sapere che la vita degli operai alla Foxconn di Shenzhen vale nulla. È solo mangime per le macchine.
Mimmo Mastrangelo
Un anarchico a Cutigliano (Pisa)/
Giuseppe, il papà di Gianna
Il 27 agosto 2016 a Cutigliano, tra le montagne del pistoiese
vicino al confine tra la provincia di Pistoia e quella di Modena,
si è svolta in una piazza del centro del paese la presentazione
del volume, scritto a sei mani da Alberto Mori con la collaborazione
di Ermanno Baldassarri e Alessandro Bernardini, Giuseppe
Manzini (Pistoia 1853 - Cutigliano 1925). Storia e scritti di
un anarchico pistoiese (Gruppo di studi Alta Val di Lima,
Cutigliano - Pt, 2016, pp. 128).
Giuseppe Manzini (1853-1925) è stato un militante libertario
della prima generazione, per intenderci quella di Errico Malatesta.
Meccanico, orafo e orologiaio, giovanissimo ha lasciato il liceo
senza conseguire la licenza, abbracciando le idee mazziniane
e frequentando i repubblicani, prima di avvicinarsi agli internazionalisti
antiautoritari. Collaboratore assiduo dei giornali «La
Favilla», il «Sempre Avanti» e «La lotta
di classe», è tra i curatori nel 1883 del periodico
l'«Ilota» di Pistoia. Per la sua incessante attività
di propagandista viene arrestato più volte e sottoposto
a una stretta vigilanza.
Nel 1884 viene denunciato per aver espresso, in un manifesto
pubblico, la propria solidarietà a Errico Malatesta e
a Francesco Saverio Merlino, condannati come malfattori dal
Tribunale di Roma, e il 23 agosto 1884, è condannato
a dieci mesi di carcere e 1500 lire di multa “per reato
di manifestazione di voto e minaccia di distruzione dell'ordine
monarchico costituzionale” e a 4 mesi di reclusione e
400 lire di multa “per offese al rispetto dovuto alla
legge dello Stato; reati commessi a mezzo stampa”. Il
30 giugno 1885 è nuovamente condannato, in contumacia,
ad altri 23 mesi di carcere e a 1400 lire di multa dalla Corte
di Assise di Firenze in quanto “colpevole di reato a mezzo
stampa”. Amnistiato il 10 giugno 1887, è assegnato,
il 20 dicembre 1894, al domicilio coatto per cinque anni dalla
Commissione provinciale di Firenze, in base alle leggi eccezionali
da poco varate dal governo di Francesco Crispi, e tradotto a
Porto Ercole il 22 gennaio 1895. Prosciolto sotto condizione
il 29 luglio 1895, è sottoposto a una stretta vigilanza
speciale. Unitosi con Leonida Mazzoncini, l'anno seguente nasce
Gianna, che diventerà da adulta una nota scrittrice.
Autrice della Sparviera (Premio Viareggio, 1956) e dello
struggente e affettuoso Ritratto in piedi, in cui ripercorrerà
la vicenda di suo padre.
|
 |
| Le
copertine del romanzo di Gianna Manzini su suo padre Giuseppe.
A sinistra
la prima edizione uscita per Arnaldo Mondadori Editore
(1971), a destra
l'ultima edizione, curata da Ortica Editrice (Aprilia,
2011, pp. 208, € 15,00) |
Nei decenni successivi Manzini continua coerentemente la sua
militanza politica divenendo un punto di riferimento per tutto
l'anarchismo, non solo pistoiese ma di gran parte dell'Italia
centrale. A causa di contrasti con la famiglia della moglie
per il suo impegno politico è costretto a una dolorosa
separazione che lo allontana dagli affetti familiari e in particolare
dall'amata figlia Gianna.
Durante la Guerra civile scatenata dai fascisti e dalle autorità
nel biennio nero 1921-1922, le autorità costringono Manzini
a una residenza coercitiva a Cutigliano, dove continuano a sorvegliarlo
attentamente. Alla fine del settembre 1925 mentre rientra a
casa a piedi nei pressi del ponte che attraversa il torrente
Lima all'ingresso della strada che porta al paese è fatto
segno di un agguato da parte dei fascisti locali che vogliono
colpirlo in quanto intransigente antifascista. Rientrato a casa,
il 29 settembre 1925, due giorni dal tentativo di aggressione,
viene colpito da infarto e muore all'istante.
La memoria di questo anarchico si deve soprattutto, come ricordato,
al brillante romanzo Ritratto in piedi scritto dalla
figlia, opera che nel 1971, anno d'uscita del volume per i tipi
della Mondadori, ottenne il primo posto al premio letterario
Campiello. L'opera ha avuto diverse edizioni e ancora oggi si
trova in libreria.
Il libro è un atto d'amore della figlia verso il padre
che attraverso le pagine del romanzo ripercorre anche la propria
vita e quelle dell'anarchico coerente che non si piega di fronte
alle angherie del potere. Al centro dell'opera vi è la
memoria, quello spazio temporale immaginario nel quale la figlia,
attraverso un sofferto percorso recupera il dialogo con il proprio
padre, confronto che si era bruscamente interrotto al momento
della separazione.

E la memoria in questo caso del territorio e della comunità
è il cuore di questa nuova pubblicazione dedicata a Giuseppe
Manzini. I curatori hanno avuto il merito del recupero della
memorialistica legata al contesto del territorio e della comunità.
Hanno di fatto ritrovato un diario collettivo che stava perdendosi
nelle nebbie dell'oblio. Infatti, nel volume, non tanto dal
punto di vista storiografico, ma soprattutto cronachistico vengono
ricostruiti attraverso documenti familiari e letture di giornali
dell'epoca i profili biografici della piccola comunità
di sovversivi, socialisti e anarchici che si erano ritrovati
solidali accanto al feretro dell'amico Manzini.
Un piccolo gruppo di lavoratori che in quegli anni avevano movimentato
la vita politica e sociale del paese portandovi gli ideali di
fratellanza, uguaglianza e solidarietà del socialismo
libertario. Scorrono i nomi di Pietro Tonarelli, Angelo Corsini
detto Bimbino, Oscar Bugelli detto Stagnino, Tito Baldaccini,
Odoardo Antonio Lenzini detto Tonio, Cino Micheli, Zeno e Edilio
Ferrari, Virgilio Baldaccini, Leonetto Monteleoni e Ermenegildo
Reggiannini, artigiani e operai di cui si ricostruiscono le
vite e la storia del movimento operaio locale. Insieme alle
loro fotografie e altri documenti gli autori del libro scattano
un'istantanea della comunità tra Otto e Novecento di
cui si era persa l'immagine e di cui gli ultimi brandelli di
testimonianze venivano conservati gelosamente dagli eredi di
queste famiglie che orgogliosamente il giorno della presentazione
del volume hanno voluto attestare con la loro presenza il forte
attaccamento a questa memoria.
Storie che come un fiume carsico sono riemerse come quella appunto
dell'anarchico Manzini di cui l'amministrazione comunale volle
immortalare nel trentennale della Liberazione in una lapide
dedicata alle vittime civili di un eccidio nazi-fascista dell'ottobre
del 1944 e che ancora oggi si può ammirare in un lato
di un edificio all'ingresso del paese nei pressi del ponte sulla
Lima, uno degli ultimi suoi pensieri: “Non basta averlo
un ideale: bisogna esserne degni, capaci, cioè di sacrificargli
qualsiasi cosa, a cominciare da noi stessi”.
Franco Bertolucci
Tante donne/
Storie uniche
Il libro Donne. Pazze, sognatrici, rivoluzionarie (di Milton Fernández, Rayuela Edizioni, Milano, 2015, pp. 260, € 15,00) prende vita ad Aiguà, un paesello sperduto nella nebbia a sud-ovest dell'Uruguay, in una casa malandata vicino una discarica. Parte da sé, Milton Fernández, dal mistero tenuto nascosto per anni. Di quella sorella capitata un giorno in casa senza preavviso, senza sapere da dove. Una ferita di dolore, poi stemperata nella riconciliazione di una madre e una figlia, dopo cinquant'anni. Un universo ancora tutto da esplorare, per Fernández, quello femminile, insondato nelle sue pieghe complicate e nascoste. Un mondo tuttora debitore di una storia scritta con mano e occhi maschili. E le donne, se compaiono, lo sono come categoria sociale, raramente soggetti autonomi.
L'autore agisce per sottrazione. Toglie il velo e fa uscire dall'ombra biografie ritratte nella loro dignità sofferta. Ampio l'arco cronologico, dalla Francia di Richelieu ai nostri giorni, alle vaste aree geografiche tra i continenti nelle terre più remote. Narrazioni brevi per un racconto della storia da un'angolatura dal basso, per ampliare la prospettiva che si fa più acuta, sottile. Vite di singole donne o vicende di storie collettive di intere comunità. Conosciute oppure anonime, raccolte in trentadue ritratti delineati con cura, dalla scrittura sciolta e misurata, capace di emozionare e restituire testimonianze vive che pulsano e si dischiudono a chi le vuole accogliere.
Un'istantanea fissa lo sguardo veggente di María Sabína. Nel Messico meridionale è la “buffona sacra”. Conosciuta come “Mujer espiritu”, la curandera sciamana, canta in mazateco, mangia i funghi della saggezza e compie miracolose guarigioni. Lo studioso Gordon Wasson, grazie a lei, riuscirà a isolare il principio attivo di quei funghi, utilizzati dieci anni dopo nella medicina psichiatrica.
Lontano, ma eloquente il ritratto di Martine di Bertereau, la prima rabdomante donna, capace di sentire nel suo corpo l'intero corpo della terra. Accusata di essere indemoniata per aver fornito prove sulla trasmutazione dei metalli, sarà reclusa nel 1642 per ordine del cardinale Richelieu, colpevole di voler sovvertire l'ordine naturale del mondo.
Fragile e forte l'immagine di Pina Bausch, la coreografa tedesca amata e detestata, forse perché incompresa nell'innovazione del suo teatro-danza. Intensa e struggente la voce di Violeta Parra. La passione, il recupero della musica popolare cilena. E il congedo dalla sua fragilità, suicida nel 1967 a cinquant'anni. Le note della sua “Gracia a la vida” continuano a risuonare nel mondo.
C'è anche la vita ai margini di Silvie Koffi, la ragazza dall'aria spavalda, il sorriso gentile e la voce scura, morta di freddo di stenti e di alcool a Milano sotto i portici, in piazza XXIV maggio. E quella di Rose Mapendo, di etnia Tutsi, delitto imperdonabile nel Congo del 1998. Scampata all'eccidio, fonderà negli Stati Uniti la Mapendo International, per l'aiuto ai rifugiati provenienti dalle sanguinarie guerre intestine africane. Hadijatou Mani è ancora in attesa del risarcimento dei danni subiti. Venduta nel Niger a 12 anni al suo padrone-marito come si vende una capra, nel 1966 verrà condannata da un tribunale superiore nel rispetto del “diritto della tradizione”, per aver avuto un figlio da un altro uomo.
L'irruenza della colonnella Clara de la Rocha, a 19 anni tra le truppe della rivoluzione messicana, fa da contrasto alle parole felpate e silenziose della poetessa Idea Vilariño, insieme a quelle di Syria Poletti di Pieve di Cadore, classe 1917. Emigrata in Argentina con la famiglia, rimonterà la propria esistenza sotto un'altra lingua, “con quel suo trasmettere la passione del sentirsi a casa in ogni luogo e un po' stranieri in qualunque casa”. E prima di far perdere le sue tracce, scrive un suo libro anche Carolina de Jesus, semianalfabeta. Da una favela di Canindè, in “Quarto de despejo”, La stanza dei rifiuti, denuncia le condizioni di miseria umana degli abitanti delle bidonville brasiliane, mentre scavano nelle montagne di spazzatura.
Salda nei suoi princìpi, a Archham, nel nord-ovest del Nepal, Maheshwari Bista, farà costruire una stanza nel cortile di casa sua, per accogliere donne durante il ciclo. In attesa che la legge emanata dal governo nel 1995 e mai applicata, non porrà fine alla segregazione, lontano dal villaggio, delle donne durante quei giorni. Come vuole la norma non scritta delle più dure tradizioni induiste: la “chaupadi”.
La rassegnazione invece pervade le donne di Codroipo, un paesello friulano. Si vedono rasate a zero e venduti i bei capelli: “si fa perché si deve fare”. Rifiutate come cameriere dai ricchi signori, perché “non se la sentivano di assumere una donna in quelle condizioni”.
Determinata e commovente la resistenza di Azucena Villaflor, argentina, la mamma di Plaza de Mayo col nome di un fiore, sequestrata nel 1977 e poi sparita, mentre insieme alle altre madri, con il fazzoletto bianco in testa, cercava i figli desaparecidos. E ancora, la risolutezza disperata di Reza Gul, di Farah, piccolo villaggio del nord-ovest dell'Afghanistan, che rivendica con le armi il figlio crivellato dalle raffiche dei talebani. Nella sua lotta, perdura anche la novantenne Kim Bok-Dong, da vent'anni nel Consiglio coreano di donne reclutate dal Giappone come schiave sessuali. Raccoglie informazioni per rendere giustizia a se stessa e alle 400.00 Halmoni, le nonne, così le chiamano in Corea. Per il Giappone, invece, sono donne di conforto. Segregate, sottoposte alle più inaudite violenze nelle catene di postriboli su tutto l'impero del Sol Levante, dalla Micronesia alla Birmania durante la seconda guerra, fino alle bombe di Hiroshima e Nagasaki.
Toccante l'energica ribellione di Sojourner Truth, nata schiava in una piantagione olandese dell'America nella cittadina di Esopus, vicino New York, prima donna nera a vincere la causa contro uno schiavista bianco. E poi il caso di Jineth Bedoya. Insignita nel 2012 a NewYork del premio internazionale per le donne di coraggio, ora sotto scorta. Dopo pestaggi e violenza, subisce una condanna a morte per aver portato avanti un giornalismo d'inchiesta a Bogotà, sul traffico d'armi, coinvolti organi paramilitari e polizia della Colombia.
Ma le biografie di Fernández si spingono oltre. Chiamano in causa, trasversale a tutte le culture, la cultura della tradizione, presunta custode della verità assoluta. Leggende, fiabe, miti fondativi e quelli delle origini dei popoli spesso diventano portatori e disseminatori di stereotipi, modelli di violenza e di stupri di massa. Tutto legittimato da una ragione di stato, come nel caso del mito dell'origine del popolo romano, il ratto delle Sabine, uno stupro collettivo. E se anche la scuola tace, si insiste a replicare in modo a-critico la visione maschile con cui è scritta la storia.
Claudia Piccinelli
Roberto Bolaño/
Quando la poesia salva la prosa
“Vivere è un miracolo irripetibile e scrivere, invece, è abbastanza una merda. Se uno scrittore scrive prosa, che è la cosa più noiosa della scrittura, lo fa per i soldi. Tanto più che la cosa meravigliosa della letteratura è essere lettore”.
L'infanzia in Cile, l'adolescenza a Città del Messico con la fondazione del movimento infrarealista, il ritorno in Cile poco prima del golpe di Pinochet, la lotta armata in Perù e in Bolivia e il trasferimento in Spagna, Roberto Bolaño rovescia la sua storia nella geografia latinoamericana diventandone inventore e narratore: “in grande misura tutto quello che ho scritto è una lettera d'amore o una lettera d'addio alla mia generazione”.
2666 (Adelphi, Milano, 2007, pp. 433, € 20,00), ultima sua opera, anziché atto di chiusura si presenta come sfida all'enigma, “romanzo che apre, non sappiamo cosa”, le cui precise istruzioni sulla pubblicazione (le cinque parti che lo compongono dovevano uscire separatamente con cadenza annuale in un determinato ordine per lasciare un'eredità ai due figli) non vennero poi eseguite. Nel 2004, anno successivo alla scomparsa di Bolaño, il libro venne di fatto editato assemblato.
L'invito che 2666 offre al lettore è quello di essere funamboli tra le pagine, in bilico tra l'ipotesi di cadere rovinosamente e la nausea dell'osservare dall'alto paesaggi, spazi, soggetti. Visionare questo pentagono intrecciato con i suoi spigoli nudi, ora concavi ora convessi, lascerebbe supporre che non abbia “struttura” se per struttura si fa riferimento al concetto di linea classica della narrativa a tre atti (inizio, sviluppo e fine). Ecco invece che Bolaño sovverte questa tripartizione, la fa implodere senza possibilità di recupero rilanciandone sullo scarto l'innovazione di un pensiero libertario e selvaggio.
Scrittore incendiario, scavalca il recinto tracciato dai suoi contemporanei latinoamericani - si pensi a Garcia Marquez o Vargas Llosa - ma anche nordamericani come Wallace e Franzen e si rivela in qualità di riapritore di giochi, come lo ha definito Nicola Lagioia.
2666 fa cardine ai concetti della scrittura così come sintetizzati da Calvino in Lezioni americane (testo - anche questo, come quello in questione - pubblicato postumo): leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e consistenza. 2666 difatti sfoltisce le astrazioni pesanti, non si cementifica, pulsa come un organismo mostruoso, coltiva l'immaginario e si affaccia coraggioso - quasi spietato - verso l'imponderabile.
Appare immediato il riferimento al surrealismo argentino di cui Bolaño non fece mai mistero - dire che ho un debito perpetuo con Borges e Cortázar è un'ovvietà senza mai tradursi in un'iperbole dei suoi mentori, ne conservò però i lacci che riguardavano la relazione tra forma breve e forma estesa. In 2666 appare chiaro che un conto è fare narrazione e un conto è fare prosa - che non è la stessa operazione - dato che per scrivere romanzi bisogna prima di tutto sbarazzarsi della rispettabilità che sembra coprire più che svelare. E infatti: “Si scrive al di fuori della legge. Sempre. Si scrive contro la legge, non dalla parte della legge”.
2666 si compone, quindi, di sezioni che, seppur autonome, si trovano bilanciate l'una all'altra sull'asse della cronologia - siamo alla fine degli anni 1990 - e del luogo - la vicenda ruota attorno alla cittadina messicana Santa Teresa - ma c'è qualcosa in più che le percorre ed è il concetto della fuga: si fugge ovunque e si fugge per ricerca. È probabile che fosse lo stesso Bolaño a fuggire dalla morte che di lì a breve lo avrebbe definitivamente preso e di cui lui era consapevole (si portava da anni una pancreatite trascurata) - “si muore e finisce tutto, fanculo” - ed è quindi innegabile che 2666 sia un componimento concepito in una filiera di montaggio, con legami che attraversano tutti i brani, al di là di ogni altalena stilistica che li separa.
Porosa, argillosa, talvolta marmorea, la scrittura di Bolaño si impiglia tra investigatori tenaci, puttane assassinate, scrittori confusi. In più di un'occasione fu lui stesso ad affermare che avrebbe preferito essere un investigatore di omicidi ancor prima che scrittore aggiungendo inoltre che non c'era niente di più vicino alla prostituzione del mestiere della letteratura. Questi tre mestieri (l'investigazione poliziesca, la prostituzione e la scrittura) sono quelli che riscattano i personaggi in 2666.
La platea del libro viene così ad essere popolata da colti, scellerati, assassini, pazzi, disperati - e chi più ne ha più ne metta. Nulla è lasciato fuori e c'è così tanto da sembrare assurdo che invece Bolaño lavora per logica sottrattiva e non aggiunge nulla, anzi sottrae il giudizio e la morale ed espone il dramma delle cose accadute assolutamente a caso. Tutto è presente così come avviene e forse al lettore può sembrare un'insolenza ma non è propriamente così. Bolaño scriveva con lo stomaco e i suoi valori estetici non includevano lo “scrivere bene”, oltre i limiti del buongusto narrava della vita che si trova anche nei rigurgiti di rabbia, di pus, di vomito, di sangue, di sperma, cioè di tutte quelle rotture mutevoli che nel loro aspetto fragile e nella loro determinazione sono radicali e necessarie. Il superamento di 2666 non è quello di esporre la narrativa all'orrore della vita, ma prendere dalla vita stessa quell'orrore per tradurlo in narrativa senza nessuna obiezione.
Bolaño sposta così la letteratura in urgenza. Quasi allucinatorio da sfiorare la psicosi, 2666 fino alla sua 963esima pagina, è struggente e maledettamente poetico. Un memorandum per il privilegio di essere lettori, ma soprattutto per il privilegio di pensarsi scrittori, almeno solo per una volta, e narrare di qualche sacra storia lasciata chissà dove.
Daniela Mallardi
Quella piccola grande donna di Ragusa/
Femminista e antimilitarista
Maria Occhipinti è stata un'anarchica e scrittrice
italiana. Femminista, fu leader del movimento antimilitarista
Non si parte! di Ragusa”
(Wikipedia, voce: Maria Occhipinti).
A quasi 60 anni dalla sua prima pubblicazione per i tipi di Luciano Landi
editore di Firenze, esce ora, nella collana Storia/interventi
di Sicilia Punto L, l'autobiografia di Maria Occhipinti Una
donna di Ragusa (Ragusa, 2016, pp. 168, € 10,00).
È stato un gesto, compiuto il 6 gennaio del 1945, a segnare
per sempre la vita di questa donna del profondissimo Sud e,
in un certo senso, anche la storia della comunità ragusana.
Aveva 23 anni, era già sposata e incinta per la seconda
volta (la prima bimba le era morta appena nata a causa degli
stenti e della fame del periodo bellico), quando si stese davanti
alle ruote del camion con cui l'esercito stava rastrellando
i giovani ragusani, dopo il fallimento del richiamo alle armi
per ricostruire un esercito che avrebbe dovuto schierarsi a
fianco degli “Alleati americani” per liberare il
Centro e il Nord dai tedeschi.
I soldati reagirono a quel gesto sparando sulla folla; ci fu
un primo morto. Chi assistette alla scena andò a manifestare
la propria gratitudine a Maria, che, senza saperlo, era stata
la scintilla di una insurrezione contro la guerra passata alla
storia come rivolta del “Non si parte”.
|
| Roma, capodanno 1980 - Maria Occhipinti protesta
davanti al Quirinale |
Centinaia di cittadini protagonisti di questi moti popolari
spontanei estesi in tutta l'isola e in parecchie località
dell'Italia “liberata”, finiranno in carcere e al
confino; anche Maria sarà deportata all'isola di Ustica,
dove nascerà la sua bambina che chiamerà - da
fervente comunista qual era - Maria Lenina. Trasferita successivamente
al carcere femminile delle Benedettine di Palermo, verrà
liberata solo alla fine del 1946, dopo quasi due anni dall'arresto
e a sei mesi dall'amnistia di Togliatti, che aveva permesso
a quasi tutti i ribelli di tornare a casa. Tutti, tranne due:
Franco Leggio e Maria Occipiti, trattenuti per i loro atteggiamenti
intransigenti durante la carcerazione. Rimarrà schedata
e bollata a vita come sovversiva.
Il ritorno a Ragusa, a 25 anni, la porta a riconsiderare le
sue posizioni politiche, e, se prima della rivolta era iscritta
alla Camera del Lavoro e al Partito Comunista, scandalizzando
ill padre, il marito e gli uomini del vicinato per la sua attività
con le donne del quartiere contro il carovita e il mancato pagamento
dei sussidi alle famiglie con uomini sotto le armi, adesso non
poteva restare in un partito che aveva tacciato l'insurrezione
come un “rigurgito fascista e separatista”.
Tra l'altro, i suoi concittadini, per la grettezza e la chiusura
mentale del periodo, non riusciranno ad accettare questa donna
coraggiosa, troppo lontana dai canoni della figura femminile
subordinata al maschio.
Entra, quindi, a far parte del gruppo anarchico, abbracciando
un ideale che manterrà e sosterrà per tutta la
vita. Gli anarchici, che hanno sempre rivendicato le sommosse
del “Non si parte” - di cui sono stati diretti protagonisti
- riconosceranno in lei l'eroina dei moti del 6 gennaio 1945.
|
| Maria
Occhipinti nel 1975 |
Il libro, 60 anni dopo la sua prima pubblicazione, risulta
ancora di enorme interesse; è un documento storico sulla
condizione delle donne nella Ragusa degli anni venti-trenta
e quaranta, e, più in generale, su quella delle classi
subalterne; Maria riesce a rappresentare la fame di giustizia
e di uguaglianza che attanagliava gli animi del popolo e in
particolare delle donne. La sua forza di volontà la porterà
a scrivere la sua storia nei primi anni cinquanta.
“Angarano non volle scrivere il mio libro, però
mi capì, mi rivelò a me stessa e mi incitò
a scrivere, sicuro che il mio raccontare spontaneo, di popolana
schietta, sarebbe stato più interessante. Ascoltai il
su consiglio: mi misi al lavoro”.
Così una pagina di storia che rischiava di rimanere sconosciuta
o mal compresa nella sua essenza, è potuta rivivere e
ha fatto fiorire interessi, studi e ricerche grazie a cui oggi
quegli avvenimenti sono visti da tutt'altra ottica che non quella
tramandataci dalla storiografia comunista.
Nel libro descrive la sua infanzia e la sua adolescenza come
periodi vissuti senza amore, senza cultura, senza carezze e
senza musica e poesia; grazie alla sua curiosità e alla
sua passione riuscirà, invece, a dare uno sbocco alla
sua fame di conoscenza infinita, che la porterà a girare
il mondo e a coglierne tutti gli aspetti esistenti. A questo
periodo dedica un altro importante testo autobiografico: “Una
donna libera” (Sellerio), continuazione del primo.
Chi ha conosciuto Maria sa che la sua ricerca è durata
tutta la vita; e che quelli sono stati per lei “anni di
incessante logorio” (come si è voluta intitolare
la raccolta dei suoi pensieri poetici, edita nel marzo scorso
sempre da Sicilia Punto L).
Maria Occhipinti è stata, è e sarà sempre
il simbolo di un'epopea femminile lanciata alla conquista del
proprio io e della propria storia, esempio fulgido da seguire
per l'affermazione dell'autodeterminazione della donna, più
che mai necessaria in questi tempi bui.
Letizia Giarratana
La chiesa e il nazi-fascismo/
Storia di un sodalizio
È nel 1558 che Paolo IV crea l'«Indice dei libri proibiti»
perfezionato da Pio V nel 1571. Nonostante il nome che si scelsero,
quei due papi non erano persone «pie»: l'Inquisizione
è roba loro. Erano brutti tempi: certi cristiani volevano
persino leggere da soli Vecchio e Nuovo Testamento, certo il
Vaticano non poteva permetterlo; così si bruciarono libri
e persone. Dell'aggiornamento di quell'Indice si occuparono
poi due papa detti Clemente – altro nome sbagliato –
con un Alessandro, un Benedetto e un Gregorio, un Leone e poi
tre “Pii”: il 9, l'11 e il 12.
L'Indice fu soppresso il 14 giugno 1966. In teoria. Silenziosamente
funzionante ancora nei Paesi cattodiretti, per esempio quello
a forma di stivale dove sto scrivendo. Certi libri scomodi,
anche dopo il 1966, si riuscì dunque a non farli pubblicare.
Come questo Mit Gott und den Faschisten – ovvero
Con Dio e con i fascisti, sottotitolo «Il Vaticano
con Mussolini, Franco, Hitler e Pavelic» – di Karlheinz
Deschner (Massari Editore, Bolsena – Vt, 2016, pp. 208,
€ 20,00) che uscì in Germania nel 1965 ma che in
Italia possiamo leggere soltanto adesso grazie all'editore Roberto
Massari al quale già dovevamo la traduzione, nel 1998,
di un altro volumone – 540 pagine fitte fitte –
di Deschner ovvero Il gallo cantò ancora: storia critica
della Chiesa.
Quando si capirono le dimensioni dello sterminio nazista, molti
credenti – di ogni tipo – si interrogarono su «dove
fosse dio» in quei giorni. Non ho notizie al riguardo,
ma grazie ai documenti che Deschner e altri ci hanno fatto leggere,
posso rispondere dov'era l'ultimo dei papi di nome Pio: fu dall'inizio
alla fine al fianco dei nazisti e dei fascisti, contribuendo
anche – a guerra perduta – a fare fuggire molti
dei loro capi, grazie ai canali del Vaticano.
Nel libro di Deschner si ricorda che l'appoggio del papa di
turno al fascismo italiano è già chiaro il 22
ottobre 1922, dunque 6 giorni prima della marcia su Roma: il
Vaticano esorta le gerarchie a non identificarsi con il Partito
cattolico, che è avverso al fascismo, ma di mantenersi
neutrali. Un bel favore a Mussolini. Poi verranno gli infami
Patti Lateranensi e un mare di soldi al Vaticano per i “risarcimenti”.
Quanto al nazismo, Hitler è in sella da pochi mesi ma
il 20 luglio 1933 può firmare un Concordato con la Chiesa
cattolica. Non un accordo fra i tanti ma la “proclamazione”
di una religione di Stato, un patto fra due poteri.
Si vorrebbe giustificare quel Concordato dicendo che allora
il Vaticano non sapeva dei crimini già commessi dai nazisti.
È una bugia, anche perché Eugenio Pacelli, non
ancora Pio XII ma Segretario di Stato in Vaticano – come
un ministro degli Esteri – è stato a lungo in Germania.
Hitler gli piace e lo favorisce in tutti i modi da cardinale
e poi da papa.
Anche per il fascismo spagnolo – racconta Deschner in
un capitolo documentatissimo – è subito chiaro
da che parte sta la Chiesa di Roma. Sono le gerarchie cattoliche
ad aprire l'ostilità contro la Repubblica, ad aizzare
le rivolte prima, il sabotaggio economico poi e infine ad appoggiare
“la rivolta” dei militari. Prima, durante e dopo
la lunga guerra dei golpisti-fascisti in Spagna, Francisco Franco
viene esaltato dal Vaticano.
Il quinto capitolo del libro di Deschner è dedicato alla
Croazia. Già alla vigilia della seconda guerra mondiale
tutti sanno che Pavelic fiancheggia Hitler e infatti quando
il 6 aprile 1941 i nazisti invadono la Jugoslavia, con loro
ci sono gli Ustascia, un movimento fascista cattolico, molto
amato in Vaticano. Nei massacri contro i serbi del neo-Stato
croato sono in prima fila i francescani. Un solo vescovo croato
(Alois Misic) condanna «gli eccessi». Invece l'arcivescovo
Alojzije Viktor Stepinac fa parte del governo croato e appoggia
gli Ustascia in tutto, orrori compresi. Dopo la guerra Pavelic
si nasconde in Vaticano prima di fuggire in Argentina per morire
infine tranquillo in Spagna, con tanto di benedizione papale
a mo' di “estrema unzione”. E Stepinac sarà
beatificato da Wojtyla, una vergogna che però i grandi
media nascondono. Qualche furbo intanto ha consigliato al Vaticano
di bloccare la “santificazione” di Pacelli, potrebbe
essere la goccia che fa traboccare il vaso anche fra molti cattolici.
Nell'edizione italiana di Con Dio e con i fascisti sono
state aggiunte due appendici importanti, scritte rispettivamente
da Dirk Verhofstadt e da Peter Gorenflos, sull'alleanza fra
Chiesa cattolica e nazifascisti in Ungheria – il Paese
dove la “pratica ebrea” fu sbrigata meglio, come
si felicitò Adolf Eichmann – e in Slovacchia.
È importante leggere oggi questo libro, nonostante i
51 anni trascorsi, per la ricchezza della documentazione ma
anche perché nel frattempo molti si sono “convinti”
– grazie alla disinformazione regnante – che la
Chiesa cattolica si oppose... almeno al nazismo e cercò
di salvare, ovunque possibile, gli ebrei. È vero il contrario.
Sin dall'inizio il Vaticano appoggiò Hitler e lo sostenne
sino in fondo, salvo poi voltar gabbana nel 1945. E raccontar
subito balle. Fra tutte le bugie, la più vergognosa è
appunto di essersi opposta ai nazisti, riappropriandosi indegnamente
della memoria di quei pochissimi cattolici che davvero si opposero,
anche pagando con la vita, e che allora vennero lasciati soli
dalle gerarchie. Del resto fra tutte le menzogne storiche dei
giorni nostri, forse la più incredibile è il martellamento
degli ultimi papi su un Occidente «giudaico-cristiano».
Tacendo ovviamente che l'Olocausto, organizzato dai nazisti,
ebbe ora la collaborazione aperta e ora una silente copertura
di quasi tutte le gerarchie cattoliche, con il sostegno o il
silenzio di quasi tutti i fedeli: e sarebbe stato sorprendente
il contrario vista la secolare campagna d'odio condotta dai
papi contro gli ebrei “deicidi”.
Il 21 settembre, quasi anniversario di Porta Pia, il libro di
Deschner è stato presentato a Roma, in una sala sorprendentemente
piena nel convegno intitolato “Il Vaticano e il fascismo”.
Ad arricchire il quadro disegnato dall'autore tedesco ci sono
state relazioni importanti. Fra le altre quella di Maria Mantello
(intitolata Stereotipi sessisti, dal mito mariano al fascismo),
della svizzera Simone Mosch su Mass neurosis religion
e di Alessandro Portelli su Il papa e le Fosse Ardeatine.
Proprio per l'importanza di questi contributi l'editore sta
realizzando un nuovo libro con gli atti del convegno. Nel frattempo
consiglio alle persone non conformiste di leggere il bel lavoro
di Deschner: per sfogliarlo potete usare l'indice, scritto minuscolo.
Daniele Barbieri
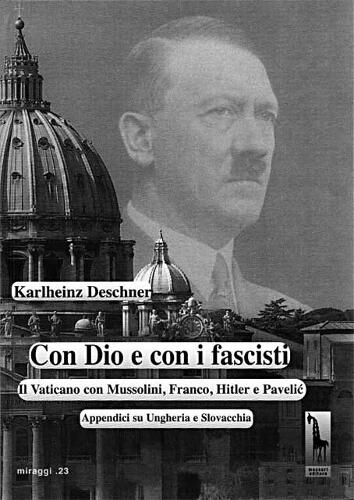
Una
bella storia (durata 15 anni)
Eccola (la storia), iniziata 15 anni fa. E finita lo
scorso mese di ottobre.
Siamo nel 2001, Massimo Torsello viene a trovarci, si
propone di darci una mano facendo qualcosa da casa. Se
ne parla con Alex Steiner, il nostro webmaster, e salta
fuori la possibilità che qualcuno cominci a lavorare
all'archiviazione on-line della rivista. Max e Nadia iniziano,
numero dopo numero, a inviare ad Alex il frutto del loro
lavoro e un po' alla volta l'An-archivio cresce.
Ogni tanto pubblichiamo su “A” un appello
per rintracciare qualcuno che voglia dare una mano. E
in effetti qualcuno si fa vivo, Max lo “istruisce”
ma per una ragione o per l'altra tutti/e dopo poco rinunciano.
Finchè nel 2011 spunta il Sossi, nostro amico dagli
anni ‘70, ormai in pensione, che inizia a venire
due volta alla settimana, per mezza giornata, in redazione,
affiancandosi così a Max (che invece opera a casa
sua).
Risultato finale: nello scorso mese di ottobre il lavoro
è finito. Rispettivamente dopo 15 anni per Max
e dopo 5 anni per Sossi.
Si è trattato di un lavoro ciclopico, in tutto
venti anni di impegno continuativo, part-time, gratuito.
“La mia militanza” ha glissato con modestia
Max, venerdì 28 ottobre, durante la cena nella
trattoria qui vicino – presenti, oltre ai nostri
due “eroi” – la redazione e l'amministrazione
di “A” e i fotocompositori. Mentre Sossi,
al solito taciturno, non ha rilasciato dichiarazioni.
C'era anche Cesare, coltivatore diretto nel Pavese, senza
trattore ma con Carlotta: la sua prima volta in redazione.
Una bella pagina di costanza e volontariato, che permette
a chiunque nel mondo di avere disponibile, grazie al nostro
An-archivio, tutti i (412) numeri finora usciti di “A”.
Da un po' di tempo questo loro lavoro non è più
necessario, visto che quasi automaticamente con
la produzione del numero cartaceo risulta disponibile
anche la versione per l'An-archivio. Quasi, perchè
c'è sempre qualcosa da predisporre. se ne occupano:
Cinzia Piantoni in fotocomposizione, poi Cati Schintu,
che da anni e anni impegna tempo e dedizione per predisporre
i file di “A” per l'archiviazione elettronica,
infine il solito Alex Steiner, che effettua la messa on-line.
E a chi è legittimamente attento (come noi) alle
questioni e alle parità di genere, segnaliamo come
“A” abbia sia una web-mistress (Cati) sia
un web-master (Alex). Mica è da tutti.
Fine (per ora) della bella storia.

|
|

