
Antispecismo/
La caduta degli dèi
Siamo dèi che si sono fatti da sé, a tenerci
compagnia abbiamo solo le leggi della fisica, e non dobbiamo
render conto a nessuno. Di conseguenza stiamo portando la distruzione
tra i nostri compagni animali e sull'ecosistema circostante,
in cerca quasi solo del nostro conforto e divertimento, senza
peraltro essere mai soddisfatti.
Può esserci qualcosa di più pericoloso di una
massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno
neppure ciò che vogliono?
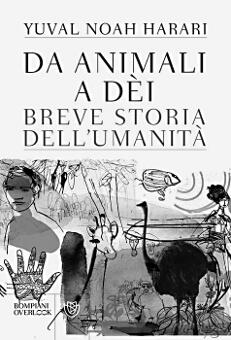
Con queste righe si conclude un poderoso libro che, in poco
più di cinquecento pagine, segue un percorso di centinaia
di migliaia anni, quello compiuto da noi, specie umana, per
arrivare dove siamo adesso.
Con linguaggio facilmente accessibile e senza mai essere semplicistico
Yuval Noah Harari (docente presso il dipartimento di Storia
della Hebrew University di Gerusalemme, specializzato in Storia
Mondiale) autore di Da animali a dèi. Breve storia
dell'umanità (Milano, Bompiani, 2016, pp. 540, €
16,00), ci riporta alle origini della nostra specie –
e ancor prima, alle origini della vita sulla terra - per attraversare,
passo passo, le tappe cruciali che hanno causato le grandi trasformazioni
che ci hanno modellato e attraverso le quali a nostra volta
abbiamo dato forma ai vari habitat in cui ci siamo insediati.
È risaputo, eravamo animali tra gli animali, con caratteristiche
molto simili a ciò che ancora siamo, facemmo la nostra
comparsa sulla terra due milioni e mezzo di anni fa e quei nostri
antenati, che vivevano in Africa Orientale, amavano, giocavano,
formavano amicizie, erano in competizione tra loro... esattamente
come facevano scimpanzè, babbuini, elefanti. Poi, un
giorno, alcuni maschi e femmine di quegli umani arcaici partirono
da lì e incominciarono un viaggio. Si riprodussero, popolarorono
il Nord Africa, l'Europa e l'Asia, nacquero altre specie distinte,
alcune delle quali sopravvissero per ben due milioni di anni.
Abbiamo un sacco di parenti, perduti a ritroso nel tempo, che
ci conducono fino a quella specie che abbiamo chiamato uomo
intelligente, uomo che sa, homo sapiens: l'unica specie umana
rimasta. L'animale caratterizzato da un cervello straordinariamente
sviluppato.
Di questa immensa epopea non viene saltato alcun passaggio,
dalla scoperta del fuoco attraverso le grandi rivoluzioni che
determinarono le trasformazioni nel percorso di evoluzione del
nostro modo di vivere sul pianeta: quella cognitiva con la nascita
del linguaggio, quella agricola con l'addomesticamento di animali,
piante e la costruzione di insediamenti fissi e quella scientifica
che comprende al suo interno anche quella industriale. Coinvolti
in questa meravigliosa e terribile avventura umana leggiamo
i fatti della storia: i primi regni, le prime forme di scrittura
e di moneta, le religioni politeiste. Poi gli imperi, dal primo,
quello Accadico di Sargon, a quello Persiano, quello cinese
degli Han, quello Romano nel Mediterraneo. Quindi il Cristianesimo,
l'Islam, il Buddhismo dell'India. Con la rivoluzione scientifica
i parametri si modificano in maniera sostanziale, la conoscenza
cessa di essere patrimonio divino, la specie umana ammette la
propria ignoranza e incomincia ad acquisire un potere senza
precedenti.
Siamo a cinquecento anni fa, a questo punto le date sono più
facili da tenere sotto controllo, ci si raccapezza meglio e
si individuano con più facilità anche le pecche
di un libro che – ad ogni buon conto - offre la possibilità
di comprendere come è avvenuto il concatenarsi dei fatti
a partire proprio dal principio, da quando materia, energia,
tempo e spazio emersero da quell'evento straordinario che la
fisica – che studia queste nostre caratteristiche fondamentali
– chiamò Big Bang, la grande esplosione. Un dipanarsi
consequenziale di fatti che affascina e appare come uno svelamento.
Libro poderoso dicevo che, quando si avvicina alla contemporaneità,
forse per abitudine a osservare le grandi ere, guarda ai fatti
storici in maniera un po' affrettata, omettendo componenti -
come le importanti trasformazioni avvenute in conseguenza della
volontà di ribellione di interi gruppi sociali –
di non scarsa rilevanza e che qualcosa raccontano.
Un testo importante non perché fornisca risposte o soluzioni
ma perché mai, come nei periodi di spaesamento, l'osservazione
passo per passo degli accadimenti del passato può venire
in aiuto nell'orientarsi, cercando nuovi percorsi, frutto di
intrecci culturali sempre più stretti, usando la conoscenza
di quel che è già stato per stare nel presente
con consapevolezza e decisione.
Poco oltre la metà possiamo leggere così: “Allora,
perché studiare la storia? A differenza della fisica
o dell'economia, la storia non è un mezzo per fare previsioni
accurate. Noi studiamo la storia non per conoscere il futuro
ma per ampliare i nostri orizzonti, per capire che la nostra
situazione presente non deriva da una legge naturale e non è
inevitabile, e che di conseguenza abbiamo di fronte a noi molte
più possibilità di quante immaginiamo. Per esempio,
se studiamo come è successo che gli europei sono arrivati
a dominare gli africani, possiamo forse capire che non c'è
niente di naturale o di inevitabile in merito alla gerarchia
razziale, e che il mondo potrebbe essere ordinato in modo differente.”
E ancora: “Non esiste alcuna prova che la storia operi
a beneficio degli umani perché noi non disponiamo di
una scala oggettiva su cui rapportare tale beneficio. Culture
differenti assegnano una definizione del bene che è differente
(...) I vincitori, naturalmente, credono sempre che la giusta
definizione di bene sia la loro. Ma perché dovremmo credere
ai vincitori?”
C'è chi dice che la storia dell'Homo Sapiens stia
per giungere al termine. Alcuni parlano di sesta estinzione
(cfr. Elizabeth Kolbert, La sesta estinzione, Beat, 2016),
con la differenza che le cinque precedenti non accaddero per
alterazioni profonde della vita sul pianeta causate dal comportamento
di una specie, come sta succedendo ora. Se così fosse
noi apparteniamo a una delle ultime generazioni. Vogliamo lasciar
perdere tutto e tirare a campare oppure domandarci quale strada
percorrere e come vogliamo diventare?
Tentare di influenzare la direzione che stiamo prendendo è
anche il suggerimento che, discretamente, attraverso l'analisi
di tutte le ere ed epoche storiche, l'autore del libro ci fornisce.
Come a dire: le cose sono andate così, avrebbero potuto
anche andare diversamente, molto è stato frutto di scelte
umane. Anche oggi. Anche oggi quella parte di umanità
di cui poco o nulla si parla sui libri di storia, quella considerata
non vincente, quella delle rivolte, che il libro trascura, quella
è l'umanità che già da tempo ha scelto
di invertire la rotta, che sta provando a opporsi cambiando
scelte di vita e che - vogliamo fortemente crederci - può
diventare sempre di più.
Silvia Papi
Perugia/
Storia di un'edicola che vuole proteggere la fiamma
Edicola 518 è uno spazio di cultura indipendente
e libertà, editoria e rivoluzione, sulle scalette di
Sant'Ercolano a Perugia. “Quattro metri quadrati di spazio
infinito” amano definirlo i fondatori, artisti, giornalisti,
scrittori e studenti, che sotto il nome di Emergenze (il loro
collettivo artistico) hanno aperto questo spazio alla cittadinanza
lo scorso 1 giugno. Abbiamo già dedicato loro una
terza di copertina “pubblicitaria” (“A”
410 ottobre 2016). Per approfondire il discorso, abbiamo loro
proposto un'auto-intervista, realizzata da Antonio Brizioli,
che ha accettato senza esitare.

Come è nata l'idea di riaprire un'edicola?
Come collettivo Emergenze da ormai due anni ci dedichiamo corpo
e mente ad azioni che lambiscono il campo dell'arte e dell'editoria
senza risolversi totalmente in nessuno dei due. Pubblichiamo
una rivista, “Emergenze” appunto, di cui sono usciti
al momento cinque numeri e grazie alla quale ci siamo fatti
conoscere prima nella città di Perugia e poi in tutto
il paese. La rivista ha un formato atipico, una distribuzione
missionaria e delle forme piuttosto ardite. Per chiudere il
cerchio di un progetto che curiamo totalmente (ideazione, realizzazione,
stampa e distribuzione), volevamo uno spazio nostro, dal quale
rilanciare quotidianamente la nostra sfida artistica e politica.
E quindi, perché proprio un'edicola?
Non ci piaceva l'idea di aprire una libreria o uno spazio d'arte,
perché come detto, essendo noi un ibrido difficilmente
identificabile e per sua definizione ambiguo, non ci sentiamo
rappresentati da proposte già canonizzate e oltretutto
costose in termini di soldi, energia e burocrazia.
Così vedendo quel baracchino abbandonato in uno dei luoghi
più belli della nostra città, di fronte alla chiesa
del patrono Ercolano (un santo combattente che ha difeso la
città dalle invasioni barbariche ed è stato spellato
vivo e decapitato da Totila) ci siamo documentati sul mondo
delle edicole. In Italia ogni anno ne chiudono a centinaia e
solo nella nostra Perugia ce ne sono una decina abbandonate
in punti davvero strategici del centro storico. Così,
quasi istintivamente, abbiamo compreso che quella era la cosa
da fare.
|
| Perugia, via Sant'Ercolano 42/A - La mitica Edicola 518
foto: Matteo Valentini |
Ma noi abbiamo rovesciato la piramide
Qual è la causa della chiusura delle edicole? L'avvento
dell'online immagino...
Questa è la motivazione più banale e quella che
prevale nell'opinione comune, ma in realtà si tratta
soltanto di una concausa. La motivazione principale è
legata alla struttura piramidale dell'editoria italiana, che
ha relegato l'edicolante al ruolo di passivo intermediario fra
l'editore e il cliente, senza possibilità di ricerca,
selezione del prodotto e personalizzazione del proprio punto
vendita.
Questo tipo di struttura è rimasta in piedi finché
si riuscivano a vendere centinaia e centinaia di quotidiani
al giorno, ma è crollata con la crisi della carta stampata.
Una crisi che, a ben vedere, non è dovuta soltanto all'imperversare
dell'online, ma anche e soprattutto alla perdita d'interesse
dei contenuti, alla mancanza di un'evoluzione grafica, all'incapacità
di rinnovarsi e proporsi a un pubblico giovane. Non a caso vi
sono prodotti che, in controtendenza rispetto a tale crisi,
vendono tantissime copie cartacee proprio in virtù di
un diverso approccio rispetto a queste problematiche, penso
ad esempio a “L'internazionale”, che conta migliaia
di abbonati under 30.
Quindi qual è la vostra ricetta? E quale il vostro
criterio di selezione dei prodotti?
Noi abbiamo ribaltato la piramide editoriale che illustravo
sopra, diventando gli unici edicolanti d'Italia a selezionare
ciascuno dei titoli in vendita nel proprio spazio. Questo è
potuto avvenire grazie ai rapporti attivati in questi anni di
grande lavoro nel campo dell'editoria indipendente e grazie
a un lavoro di ricerca quotidiano e instancabile. Prendiamo
la maggior parte delle nostre riviste e dei nostri libri (perché
siamo anche una piccola libreria di strada) direttamente dagli
editori, o in alcuni casi da piccoli distributori con i quali
è possibile operare in maniera sana e collaborativa.
Abbiamo invece rifiutato categoricamente la grande distribuzione
che serve tutte le altre edicole, rinunciando alla vendita dei
quotidiani italiani e delle riviste di largo consumo. Una rinuncia
tutt'altro che dolorosa, a dire il vero...
Nello specifico, cosa si può trovare in Edicola
518?
Quotidiani, settimanali e riviste da tutto il mondo, che danno
allo spazio un respiro internazionale in linea con la vocazione
storica della città di Perugia, sede della più
antica Università per stranieri d'Italia. Dedichiamo
particolare attenzione alle riviste d'arte, architettura, grafica,
moda, design e viaggio. Di alcuni magazine, siamo gli unici
rivenditori in tutta Italia. A livello di libri distribuiamo
piccoli e medi editori indipendenti con cui abbiamo un rapporto
diretto e confidenziale, come Elèuthera, Johan &
Levi, Abscondita, Humboldt, Lazy Dog Press, Archive Books ed
altri. Infine abbiamo riportato a Perugia, dopo anni d'assenza,
la mitica “A Rivista Anarchica”, che con nostro
grande piacere sta trovando seguito anche e soprattutto fra
i giovani. A uno dei ragazzi che ha recentemente acquistato
la Rivista ho detto scherzosamente: “Ne sto vendendo tante,
l'anarchia sta tornando di moda”. E lui mi ha risposto:
“Effettivamente, oggi come oggi è molto più
accattivante della democrazia”.
E poi ci sono le vostre pubblicazioni...
Sì, come accennavo prima la rivista Emergenze è
mezzo fondamentale di diffusione del nostro messaggio, rilancio
delle nostre battaglie e autofinanziamento del nostro movimento.
L'investimento di Edicola 518 è stato messo in atto solo
e unicamente con i ricavi della vendita della rivista, che nella
sua prima stagione ha contato più di 600 abbonati. Oltre
alla rivista, abbiamo da poco pubblicato “Perugia nascosta”,
una guida psicogeografica della città che rimpiazza la
descrizione didascalica dei luoghi con una serie di derive d'ispirazione
situazionista. Un bell'esperimento, che per nostra fortuna sta
andando a ruba.
Al centro della vita sociale
A quanto ne so avete proposto anche eventi in edicola.
Come riuscite a offrire una programmazione di questo tipo in
soli quattro metri quadrati?
La sfida dei “quattro metri di spazio infinito”
è proprio questa: dimostrare che non servono grandi spazi
o grandi budget per mettere in piedi una programmazione di alto
livello, servono piuttosto grandi idee.
Durante tutto il periodo estivo e poi autunnale abbiamo proposto
una programmazione settimanale di eventi culturali a tutto tondo
nei quali la sfida imposta agli artisti e intellettuali coinvolti
è stata proprio quella di esprimersi nella ristrettezza
spaziale dell'edicola: sono venute fuori discussioni spontanee
e senza regole nello spazio pubblico (penso a quella con Giulietto
Chiesa o a quella con la nutrizionista Anna Villarini), la proiezione
a cielo aperto sulle pareti della chiesa del docu-film “Io
sto con la sposa” con il regista Antonio Augugliaro, un
reading poetico leggendario curato dall'attrice Ilaria Drago
e dall'attore Marcello Sambati direttamente da dentro l'edicola
e tanto altro ancora.
In una città che sperpera budget e maltratta spazi pubblici,
Edicola 518 è diventata in breve tempo il centro della
cultura contemporanea e della vita sociale.
Per concludere, vorrei chiederti come si colloca Edicola
518 all'interno del panorama artistico nazionale?
Ad essere sincero non trovo il panorama nazionale così
stimolante. Non mancano certo delle iniziative interessanti,
ma la maggior parte del fermento culturale si muove entro recinti
ben definiti, all'interno dei quali anche il dissenso rischia
di diventare un compiacente strumento di comodo. La grande possibilità
offerta dall'operare oggi in questo paese è proprio dettata
dalla totale assuefazione dei cittadini a meccanismi culturali
ripetitivi e passivi, che rende di fatto un progetto come il
nostro travolgente.
La gente non è più abituata a sentirsi parte di
un processo culturale, a transitare dalla fruizione passiva
dell'evento a una condivisione continua e rigenerante di stimoli
e energie. Uno dei nostri più grandi punti di riferimento
è l'artista, filosofo, politico tedesco Joseph Beuys,
che per altro tenne un'importante conferenza a Perugia il 3
aprile 1980, illustrata in sei lavagne oggi contenute a Palazzo
della Penna (a pochi passi da Edicola 518). Nel suo ultimo discorso
pubblico Beuys disse “Proteggi la fiamma, perché
se non la si protegge, prima che ce ne rendiamo conto il vento
la spegnerà, quel vento stesso che l'aveva accesa. E
allora povero cuore sarà finita per te, impietrito di
dolore.”
Noi siamo qui per questo, per proteggere la fiamma. Gli incendi
saranno portati dall'improvviso innalzarsi dei venti.
Antonio Brizioli
www.emergenzeweb.it
Integrazione o libertà/
Appunti per una critica antiautoritaria all'oppressione
delle donne romnì
Intervento di Martina Guerrini in occasione della presentazione
del libro di Anina Ciuciu Sono rom e ne sono fiera. Dalle
baracche romane alla Sorbona (Edizioni Alegre, Roma,
2016, pp. 208, € 15,00), promosso dall'Associazione
donNesi/Corea di Livorno.

Quelle di seguito sono, più o meno, le questioni che
avrei voluto proporre per riflettere, non tanto sul libro, quanto
a partire dalla condizione più generale delle donne romnì
oppresse in Europa.
Come sapete, a Livorno ho proposto nelle mie lezioni di formazione
alle volontarie e ai volontari un approccio di analisi delle
condizioni delle comunità rom di tipo “intersezionale”.
Una parola difficile che vale la pena di spiegare brevemente.
Con intersezionalità si intende uno specifico
approccio teorico nato dal tentativo di superare i limiti di
un'analisi centrata sull'asse prioritario della differenza di
genere in cui il sessismo viene considerato come isolato e/o
disgiunto da altri rapporti di dominio (razzismo, classismo,
eterosessismo).
In poche parole, significa che, nel caso delle donne romnì,
nessuna di loro ha mai sperimentato sulla propria pelle una
discriminazione che fosse semplicemente legata all'essere “donna”,
ma anche all'essere “rom” e “povera”.
In realtà questa è una semplificazione, perché
immaginate cosa può sperimentare una donna romnì
di orientamento omosessuale in un mondo come il nostro, che
non rispetta minimamente i diritti di nativi gay, lesbiche o
trans. È evidente che nel caso delle donne romnì
c'è qualcosa in più, e quel qualcosa è
il razzismo e l'oppressione di classe che esse scontano, vivendo
forzatamente nei campi, senza lavoro e prive di scolarizzazione.
Evidentemente, e il caso molto emozionante di Anina Ciuciu lo
testimonia, poter studiare permette alle donne romnì
di trovare una possibile (ma non scontata) via d'uscita dalla
condizione in cui sarebbero destinate a vivere. Si potrebbe
discutere ore sui motivi per i quali – pur lamentandosene
– le istituzioni italiane, ma quelle europee non fanno
eccezione, non dispongono di alcun piano di sostegno alla scolarizzazione
delle giovani romnì e dei giovani rom. Per fare un esempio
a tal riguardo, la femminista romnì Alexandra Oprea,
nata in Romania e ormai newyorkese, molti anni fa metteva chiaramente
in evidenza la questione, riferendosi al caso ormai noto della
sposa-bambina Ana Maria Cioaba. Era il 2003 e Alexandra scriveva:
“Un esempio significativo a riguardo: la BBC ha riferito
che “il caso [di Ana Maria Cioaba] ha spinto il Commissario
degli Affari Sociali della UE Anna Diamantopoulou a dire alle
comunità rom di non implorare aiuti nella lotta anti-discriminazione
finché continuano ad abusare dei diritti delle loro stesse
comunità”.
Oprea denuncia che né l'Unione Europea né la Romania
hanno mai disposto un piano di scolarizzazione per le bambine
romnì, pur sapendo benissimo che il diritto allo studio
è l'unico mezzo per evitare i matrimoni precoci che tanto
li scandalizzano.
Appare quindi quanta ipocrisia e malvagità sia nascosta
dietro alle dichiarazioni dell'Unione Europea dell'epoca: le
comunità rom sono patriarcali e non conoscono i diritti
umani, perché mai dovremmo aiutarle e non discriminarle?
Il “giochino” – se posso chiamarlo così
– delle istituzioni è sempre il medesimo: utilizzare
un'oppressione contro l'altra, in questo caso la discriminazione
di genere contro quella “etnica”, ovvero sostenendo
che poichè i rom violano la libertà delle bambine
e delle giovani adolescenti romnì, non hanno alcun diritto
di pretendere rispetto per la propria “cultura”.
Alexandra Oprea si ribella giustamente al fatto che non si può
pretendere di scegliere tra il proprio genere e la propria appartenenza
ad una comunità etnica, e che si debba capire cosa favorisce
l'emergere di molteplici oppressioni. Né la Romania,
né la UE escono da questa circostanza immacolate, perché
niente hanno fatto affinché le donne romnì potessero
intraprendere e completare un percorso di scolarizzazione –
inferiore, superiore, di alto livello – esattamente come
tutte le altre bambine dei paesi europei.
Non vorrei dilungarmi su questo, sappiamo bene che l'Italia
si comporta esattamente nello stesso modo, e che la Francia
ha recentemente espulso una giovane studentessa romnì
di origine kosovara, Leonarda Dibrani, impedendole di continuare
gli studi, e chiedendole ciò che paventava Alexandra,
ovvero di abbandonare i genitori rimpatriati in Kosovo per diventare
una “brava francese”. Di nuovo, il bivio è
quello di essere rom o di scegliere la libertà delle
donne che gli stati europei si vantano di difendere.
Anche, qui, un inganno in piena regola! Non fosse che per il
fatto che la libertà non è mai calata dall'alto,
ma praticata individualmente, e la storia del mondo (non della
sola Europa!) racconta storie piuttosto sanguinose circa la
guerra dichiarata dagli stati e dai governi contro la oggi tanto
sbandierata “libertà delle donne”!
Ma torno al punto.
Quel che vorrei mettere in evidenza è che esiste chiaramente
uno stereotipo incredibilmente negativo cucito letteralmente
sulla pelle delle comunità rom. In esse, le donne sono
l'elemento più oppresso - e ripeto, è così
in ogni società capitalistica o semi-capitalistica, noi
non facciamo alcuna eccezione - ma esse sono anche l'esempio
creativo di come si può cercare una via di fuga, opporre
resistenza, fregare l'oppressore con i suoi stessi mezzi.
Di questa capacità incredibile delle donne romnì,
le femministe italiane e europee non hanno capito niente, continuando
a ritenerle delle povere ingenue che subiscono vessazioni senza
ribellarsi.
Qualche esempio assai simpatico a riguardo lo riporta di nuovo
Alexandra Oprea, e cito di nuovo le sue parole: “Ho visto
le mie amiche ribellarsi contro genitori autoritari rifiutando
di sposare lo sposo prescelto e sotto altri aspetti tentare
di fregare il sistema utilizzando le sue stesse regole. Numerose
amiche hanno pianificato la loro fuga per adeguarsi a sposare
il compagno scelto dai genitori soltanto per separarsene entro
due mesi o un anno, dopo di che, non più vergini, erano
di fronte a minori restrizioni.
Esistono molti tipi diversi di resistenza. Essa non si verifica
sempre nell'estremo pacchetto “abbandona la comunità,
non tornare mai più”, sebbene alcune romnì
“scelgano” altresì questa strada. Ovviamente,
queste scelte devono essere osservate criticamente nel loro
contesto, e non possono essere considerate vittorie complete.
Il risultato può difficilmente essere considerato un
trionfo, quando una donna è costretta a scegliere tra
separare se stessa dalla gente che ama (e affrontare un mondo
razzista e sessista da sola) e soccombere ai test di verginità
e ai matrimoni precoci”.
Cerco di concludere.
Capisco che di fronte a uno stereotipo tanto insidioso, pervasivo
e, purtroppo, popolare, l'obiettivo possa essere quello di opporre
un'immagine delle comunità rom diversa e positiva. Niente
da aggiungere: nella guerra dell'immaginario ci sta, ed è
forse necessario, come immediato e più rapido “intervento
di primo soccorso”, affinché si interrompa l'emorragia
di fantasiose denunce, sottrazioni ingiuste e ingiustificate
di minori dai campi, aggressioni, pogrom, assassinii.
Tuttavia, non tutto è semplice come appare e mi pare
ci siano degli scivolamenti, dei rischi, in questo approccio,
che forse non sono intravisti o sono sottovalutati.
In primo luogo, ricordiamoci che lo stereotipo negativo non
è nocivo solo perché descrive i rom e le romnì
come la feccia della società, ma perché inchioda
questa immagine al loro corpo, cioè rende lo stereotipo
negativo universale, valido per tutti e tutte, ed è in
questa sua pretesa totale e totalitaria che si insinua il suo
potere.
Se si oppone ad esso un immaginario diverso, opposto, migliore,
positivo, che scivola pericolosamente verso il compatibile,
l'inserito, il legalitario... io qualche problema ce lo vedo.
E lo vedo esattamente nello stesso potere di raccontare tutti
e tutte nello stesso modo, quando sappiamo benissimo che ci
sono comunità rom che desiderano essere nomadi e alle
quali non importa niente di avere una casa, oppure che non vorrebbero
di certo andare a lavorare in fabbrica, se l'alternativa offerta
dal mondo gagio è passare dagli espedienti o dai lavori
di sussitenza all'esercito di schiavitù salariata, come
la definiva Marx ormai moltissimi decenni fa.
Allora il problema, di nuovo, siamo noi.
Nell'estrema generosità che risiede nel tentativo di
difenderli dall'orrore che ogni giorno subiscono, pensiamo di
spingerli a costituire una “quota d'azione” di un
mondo e di un sistema – e qui certamente non tutti saremo
d'accordo – che a me personalmente non solo non piace
affatto, ma ogni giorno con le mie miserabili capacità
e contraddizioni, mi sforzo di cambiare il più radicalmente
possibile. Perché se penso che il salario sia tempo estorto
da un padrone, debbo ritenerlo una soluzione per i rom? Perché
se penso che l'esercito vada abolito, dovrei favorire l'arruolamento
dei rom? Perché se penso che quando lo stato si fa chiamare
patria seguirà una scia di morti, debbo chiedere ai rom
di amarla e servirla?
E ancora, perché se io posso muovermi in (quasi) tutto
il mondo, con un semplice timbro su di una carta, e vivere in
una roulotte nel deserto girando il mondo a far fotografie,
i rom debbono rinunciare al loro nomadismo, se non lo vogliono,
e prendere casa, pagando l'affitto e entrando in quel frenetico
e alienato meccanismo “produci-consuma-crepa” che
era al centro delle lotte dei movimenti antiglobalizzazione
nei quali ho militato per anni?
Sto anche provocando, naturalmente, ma fino a un certo punto.
Io che non vorrei una borghesia ad opprimere una classe subalterna,
non chiederò mai ai rom di tentare la scalata sociale
per tirar su tutti gli altri, in primo luogo perché questo
non avverrà (non è mai avvenuto: Obama non ha
migliorato la condizione degli afro-americani negli Usa, come
sottolinea il movimento Black Lives Matter), in secondo luogo
perché la liberazione di una comunità non può
avvenire a scapito dell'oppressione di classe degli altri e
delle altre, o ci ritroveremmo a parlare e far politica esattamente
come ha fatto la Romania nel 2003.
Come scriveva un mio caro amico e appassionato sostenitore della
causa rom, Lorenzo Monasta:
“Cosa intendiamo con “integrarsi”? Non facciamo
confusione. Non vuol dire assimilarsi. Se per un attimo prendiamo
in considerazione il fatto che in una società integrarsi
significhi convivere civilmente ed essere rispettati nella propria
diversità, allora può andare bene. Purtroppo le
società aperte a questo tipo di integrazione sono rare.
Pur essendo ottimista e considerando l'integrazione possibile
in una società aperta, quando sostengo che i rom e i
sinti vogliono integrarsi provo sempre un forte disagio dovuto
alla tristezza che aleggia in colui o colei che pone la domanda,
e in chi risponde. Proviamo anche solo un momento a dircelo
da soli: “Sono integrato”, “Sono un integrato”,
“Mi sento integrato”, “Mi sento pienamente
integrato”. Deprimente. Non è bastato essere ottimisti”.
Concludo con un esempio attualissimo per spiegare i rischi legati
all'assimilazione di classe delle comunità rom in una
società capitalistica.
L'autoproclamato re dei rom, Dorin Cioaba, ha sostenuto pochi
giorni fa di voler costruire lui il muro di Trump contro il
Messico, e di poterlo fare a prezzi concorrenziali rispetto
alla forza-lavoro gagé.
Ecco, pur nella sua eloquente e kitsch improbabilità,
questo è un esempio di come una borghesia rom non sia
d'aiuto né a proletari gagi né a proletari rom.
Martina Guerrini
Il quartiere pisano del Riglione/
Uno spaccato di umanità e vita sociale
Ogni grande o media città europea, che abbia subito
le trasformazioni traumatiche epocali novecentesche ridefinendosi
magari in area metropolitana onnicomprensiva, ha spesso fagocitato
e inglobato nel proprio grembo paesi del circondario, vecchie
comunità nate dai mestieri e dagli esodi, e identità
antropologiche culturali significative, rendendo infine tutto
livellato e irriconoscibile. E questo sembrava anche il destino
del borgo di Riglione, oggi inghiottito dal tessuto urbano di
Pisa, situato a sei chilometri appena dalla torre pendente,
posto sull'asse viario per Firenze. (Massimiliano Bacchiet,
Riglione. “Questa centrale e laboriosa borgata”.
Vita sociale e politica 1861-1948, BFS edizioni, Pisa, pp.
242, € 18,00) ci racconta una bella storia toscana di paese,
come quelle di una volta; scritta meglio però si direbbe.
Antico luogo di transito, ha sviluppato naturalmente una propria
vocazione all'accoglienza che si esplicitò inizialmente
nelle attività di stallaggio e in osterie approntate
per i viandanti e per i barcaioli dell'Arno.
 Eventi
sociali e politici in dimensione micro si intrecciano, donne
e uomini del popolo escono dall'anonimato facendosi protagonisti
del nascente movimento operaio, tra sovversione socialista,
anarchismo e repubblicanesimo, fra preti e fascisti. Apprezzabile,
e decisamente innovativa, la scelta delle cesure: il classico
e necessario 1861 come terminus a quo, ma in particolare
il 1948 come terminus ad quem. Eventi
sociali e politici in dimensione micro si intrecciano, donne
e uomini del popolo escono dall'anonimato facendosi protagonisti
del nascente movimento operaio, tra sovversione socialista,
anarchismo e repubblicanesimo, fra preti e fascisti. Apprezzabile,
e decisamente innovativa, la scelta delle cesure: il classico
e necessario 1861 come terminus a quo, ma in particolare
il 1948 come terminus ad quem.
Lo scenario nazionale oltrepassa di conseguenza il limite formale
della seconda guerra mondiale, inserendovi per intero il “decennio
della crisi”, ossia la lunga transizione globale dall'età
dei fascismi a quella della guerra fredda. La storia locale
come genere e approccio alla ricerca ha fatto certamente il
suo tempo, almeno in quella accezione subordinata con cui è
stata interpretata per una buona parte del secolo scorso, ma
oggi si deve piuttosto parlare di una dimensione “spaziale”,
indispensabile per cogliere in una prospettiva epistemologica
un campo d'indagine ridotto al fine di una comprensione totale
di ogni aspetto. È polvere di storia e, per dirla con
Delio Cantimori, storico d'altri tempi: sono piccoli fatti che,
ripetendosi, si affermano come realtà seriale; ciascuno
di essi attesta per migliaia di altri che attraversano in silenzio
lo spessore del tempo e durano... Sono le vicende di un microcosmo
culturale toscano viste sul lungo periodo, analizzate e verificate
negli snodi e nei cambiamenti epocali salienti: unificazione
nazionale, industrializzazione e nascita del movimento operaio.
Alle origini di tutto ci sono le passioni della modernità
che incombe e le nuove attività economiche che rimodellano
territori e persone. Nel pisano, come altrove del resto, l'identità
contadina e il sistema mezzadrile erano prevalenti. Una folta
classe di braccianti o “pigionali” popolava i sobborghi
ed il tessuto economico iniziava a caratterizzarsi per la presenza
di piccole manifatture soprattutto nei settori tessile, vetrario
e laterizi. Nascevano inedite culture del lavoro e, insieme,
nuovi stili di vita e identità comunitarie. La tipica
sociabilità e il mutualismo di marca operaia iniziavano
così a manifestarsi tra le classi subalterne, con un
forte impronta sovversiva, preludio a un'epoca che sarà
consacrata alle azioni dirette.
Il volume, suddiviso in dieci capitoli in scansione cronologica,
è corredato da un apparato iconografico di straordinaria
bellezza, fra cui emerge lo stendardo nero con frange rosse
del Gruppo anarchico “Demolizione” di Riglione.
È proprio il caso di dire che c'è davvero “Un'altra
Italia nelle bandiere dei lavoratori”. Una parte importante
del libro è dedicata all'anticlericalismo che, insieme
all'antiautoritarismo e alle lotte sindacali, costituisce la
cifra otto-novecentesca dei movimenti popolari: nel nome di
Ferrer e Giordano Bruno, nel nome di Galileo Galilei.
Dall'albero della libertà inneggiante alla repubblica
il filo narrativo prosegue sostenuto: con “gli opranti
che escono dai telai” e la diffusione dei “pensieri
ribelli”, con la lotta al prete e l'apostolato laico,
con anarchici, clericali e la lontana guerra europea, con Arditi
del popolo e camicie nere, con la nuova guerra mondiale e le
speranze della ricostruzione.
“In questa complessa storia c'è, lo ricordiamo,
– ha scritto il prefatore Mauro Stampacchia – il
nucleo essenziale della storia del paese Italia. Un cammino
di ascesa, della parte di popolazione confinata senza speranza
a un ruolo marginale e non rilevante nella società e
nella politica, che si rovescia nel suo contrario e cioè
nella realizzazione di un percorso di emancipazione.”
Lo storico locale, una volta, era una figura con un preciso
cliché: parroco, farmacista, maestro o comunque figura
di riferimento nel paese che si prefiggeva unicamente di illustrare
memorie civiche e di rinverdire le glorie del campanile.
Poi è stata la volta dei testimoni/protagonisti dei grandi
eventi novecenteschi, spesso militanti politici, tutti tesi
ad inserire il proprio vissuto nell'epopea nazionale. Infine
siamo approdati a studi di questo tipo, basati sulla compulsa
di un'ampia gamma di fonti, condotti da autori che hanno messo
insieme due elementi che sono ormai indispensabili: passione
e ferri del mestiere. È una lettura questa, adatta anche
ai non-pisani.
Giorgio Sacchetti
Cernobyl' e Fukushima/
Dimenticare, perché il nucleare continui
Arkadij Filin non è il nome dell'autore, ma lo pseudonimo
scelto dalle tre persone che hanno scritto questo libro Arkadij
Filin – (Dimenticare Fukushima, Istrixistrix, pp.
208, € 10,00) per rendere omaggio a uno dei cosiddetti
liquidatori di Cernobyl' (quelli che hanno materialmente
cercato di mettere in sicurezza e di ripulire il territorio,
morendo come mosche) e stabilire in questo modo una continuità
tra quelli che sono i due eventi determinanti nello svelamento
delle recondite meraviglie dell'energia nucleare.
 Il
disastro sovietico appartiene a un mondo antico, nel quale Ucraina
e Bielorussia – destinatarie della gran parte delle radiazioni
– erano semplici regioni dell'Urss, tirannico impero notoriamente
dotato di tecnologie arretrate e di incompetenti apprendisti
stregoni che mettevano le mani in un obsoleto quanto pericoloso
giocattolo che scoppiò loro tra le mani. La centrale
Lenin in quel lontano 1986 sparse in giro per l'Europa e per
il mondo intero gli effetti collaterali di uno sviluppo energetico
che si voleva e si vuole progressivo e illimitato, suscitando
una diffidenza diffusa che portò in alcuni paesi come
l'Italia al blocco della costruzione delle centrali e in altri,
come la Francia – da dove provengono gli autori del testo
– all'allestimento di un potente apparato persuasivo volto
al sostanziale oblio della catastrofe, anche grazie all'occultamento
di dati, per riempire il proprio territorio di reattori “puliti
e sicuri”. Il
disastro sovietico appartiene a un mondo antico, nel quale Ucraina
e Bielorussia – destinatarie della gran parte delle radiazioni
– erano semplici regioni dell'Urss, tirannico impero notoriamente
dotato di tecnologie arretrate e di incompetenti apprendisti
stregoni che mettevano le mani in un obsoleto quanto pericoloso
giocattolo che scoppiò loro tra le mani. La centrale
Lenin in quel lontano 1986 sparse in giro per l'Europa e per
il mondo intero gli effetti collaterali di uno sviluppo energetico
che si voleva e si vuole progressivo e illimitato, suscitando
una diffidenza diffusa che portò in alcuni paesi come
l'Italia al blocco della costruzione delle centrali e in altri,
come la Francia – da dove provengono gli autori del testo
– all'allestimento di un potente apparato persuasivo volto
al sostanziale oblio della catastrofe, anche grazie all'occultamento
di dati, per riempire il proprio territorio di reattori “puliti
e sicuri”.
Dopo venticinque anni anche i poveri nuclearisti nostrani avevano
rialzato la testa ed erano ormai proiettati verso un rilancio
della politica atomica quando un brutto giorno di marzo del
2011 a un terremoto si aggiunse un maremoto che investì
la centrale di Fukushima sulle coste del supertecnologico e
democratico Giappone. Tra l'altro i sei reattori gestiti dalla
Tepco, una società giapponese, erano di costruzione della
General Electric, quindi macchinari americani, roba della quale
ci si può fidare. Quello che avvenne nell'impianto non
è in fondo particolarmente degno di nota, essendo la
semplice conferma del fatto che se ci si affida a una tecnologia
scarsamente controllabile questa prima o poi andrà fuori
controllo.
Molto più interessante è ciò che avvenne
– e avviene ancora oggi – fuori dall'impianto.
L'idea di gestione del disastro emerse nitidamente nelle parole
e nelle azioni degli uomini del governo giapponese, della Tepco,
dell'informazione, di tutti gli uomini di potere. Le notizie
sulla gravità della situazione vennero sistematicamente
minimizzate e agli abitanti della regione non fu consentito
di sapere quali rischi correvano, se fosse necessario, opportuno,
inopportuno o impossibile andare via da lì, quali sarebbero
stati gli effetti sui bambini e sulle future generazioni. Nelle
duecento pagine di questo volume il quadro viene dipinto in
maniera sufficientemente dettagliata mettendo in luce aspetti
che se non fossero tragici potrebbero rientrare nelle spirali
comiche di un cabaret dell'assurdo. Voglio solo citare la questione
della “radiofobia” tirata in ballo dal vicerettore
della Facoltà di medicina il quale il 20 marzo 2011 dichiarò
pubblicamente che: “Chi sorride non patirà danno
alcuno dalla radioattività, questa colpirà solo
chi sarà preoccupato. Se affrontate la situazione, per
quanto difficile possa essere, ecco che la radioattività
non vi colpirà. Ad ogni modo 100 µSv/ora non rappresentano
un pericolo per la salute.” Per poi precisare in un'intervista
successiva: “Grazie alla sperimentazione sui ratti sappiamo
chiaramente che gli animali stressati sono quelli più
colpiti dalle radiazioni. Lo stress non fa per niente bene a
gente che sia stata soggetta a radiazioni. “D'altronde
uno stato mentale di stress indebolisce il sistema immunitario
e di conseguenza può favorire l'insorgere di alcune malattie
cancerogene e non.”
Ritengo che ogni commento sia superfluo.
Oggi la parola d'ordine è, come recita il titolo –
Dimenticare. Un oblio necessario per non mettere in discussione
un'idea di benessere dove produzione e consumo di energia possano
essere illimitati e soprattutto diretti dall'alto da tecnici
dall'indiscutibile competenza. Il tutto fino alla prossima centrale
che salta, chissà dove.
Giuseppe Aiello
|

