
Mondo beat/
Ma prima del '68 ci fu il '67
Si avvicina il cinquantenario del '68, l'anno del riversarsi
nelle piazze degli studenti, della ribellione giovanile contro
la società dei papà. Di certo verranno promossi
ovunque eventi ed iniziative e anche gli organi di informazione
non si lasceranno sfuggire la ghiotta ricorrenza per riproporre
analisi di ogni genere: per tessere odi al fenomeno o condannarlo.
Ma prima del '68 ci fu il '67 e gli anni appena dietro in cui
in Italia, specie nelle grandi città, sulla spinta dei
movimenti underground sviluppatisi negli Stati Uniti e in vari
Paesi dell'Europa, emersero gruppi (sempre giovanili) che caratterizzarono
gli inizi della stagione della controcultura.
Un fenomeno minimizzato e trascurato storicamente, che però
anticipò il vortice delle tensioni politiche sessantottesche.
Tra i gruppi più attivi che nel 1967 “scossero”
la Milano del tempo - culla del boom economico amministrata
da giunte di centro-sinistra, “capitale morale”
e della cultura, ma perbenista e rigida nei costumi - ci fu
il “Mondo beat” dei “capelloni”, dei
“figli dei fiori” i quali citavano Henry Miller
(“voi vivete domani e ieri, io vivo solamente oggi. Perciò
vivo in eterno”) e sognavano di dar vita ad una società
nella società, cioè ad un modello di vita comunitaria
impostato sulla pace, l'uguaglianza, l'obiezione di coscienza,
la difesa dell'ambiente, la libertà sessuale.
 A
riaccendere un faro su quel microuniverso della stagione del
ribellismo è il docu-film (anno: 2012) del regista Vincenzo
Galante Il mondo di Papà Beat che è anche
una sorta di ritratto di Antonio Di Spagna, uno dei protagonisti
del movimento, scomparso di recente e che tutti chiamavano “Papà
Beat”. Il lavoro di Galante nasce anche come testimonianza
per rimettere in ordine dei tasselli nella storia della controcultura
del Paese: “Papà Beat” e suoi compagni -
che avevano come punto di ritrovo i gradini sotto la statua
di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo - vennero scambiati
da pezzi della società meneghina e degli organi di polizia
e delle istituzioni per tossicodipendenti e pericolosi sovvertitori
dell'ordine precostituito, ma erano solo dei sognatori di un
mondo-altro, degli idealisti non politicizzati che si ispiravano
a Gandhi e leggevano Bertrand Russell. A
riaccendere un faro su quel microuniverso della stagione del
ribellismo è il docu-film (anno: 2012) del regista Vincenzo
Galante Il mondo di Papà Beat che è anche
una sorta di ritratto di Antonio Di Spagna, uno dei protagonisti
del movimento, scomparso di recente e che tutti chiamavano “Papà
Beat”. Il lavoro di Galante nasce anche come testimonianza
per rimettere in ordine dei tasselli nella storia della controcultura
del Paese: “Papà Beat” e suoi compagni -
che avevano come punto di ritrovo i gradini sotto la statua
di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo - vennero scambiati
da pezzi della società meneghina e degli organi di polizia
e delle istituzioni per tossicodipendenti e pericolosi sovvertitori
dell'ordine precostituito, ma erano solo dei sognatori di un
mondo-altro, degli idealisti non politicizzati che si ispiravano
a Gandhi e leggevano Bertrand Russell.
Frange di intellettuali e di giornalisti li attaccavano, ma
c'era pure chi prese le loro difese come Giorgio Bocca, Camilla
Cederna, Umberto Eco e il poeta Alfonso Gatto il quale scrisse:
“Li trovo esteti, moderati, docili. Cercano un autore:
ma tra loro potrebbe esserci un Messia. E noi certamente lo
metteremmo in croce”. Nel novembre del 1966 Antonio Di
Spagna-Papà Beat e i suoi compagni di avventura, Vittorio
Di Russo, Gerbino Melchiorre, Gennaro De Miranda, avevano dato
alle stampe “Mondo Beat”, la prima testata dell'universo
underground nazionale, pubblicata in ciclostile nei locali del
circolo anarchico “Sacco e Vanzetti” in viale Murillo
a Milano.
Il periodico si presentò non solo da megafono dei “beatniks”,
ma in una libera tribuna mirante, da una parte, a svecchiare
un certo linguaggio delle lettere e dell'informazione e, dall'altra,
a confrontarsi con gli altri gruppi giovanili, a rigettare l'obbligo
di leva, l'egemonia dei due blocchi (Nato e Varsavia), il consumismo
e i modelli della diseguaglianza; su quest'ultimo tema vennero
citate pure parole di Papa Giovanni XXIII: “Gli esseri
umani sono tutti uguali per dignità naturale: nessuno
può obbligare gli altri interiormente”. Intorno
a “Mondo Beat”, che uscì solo in sette numeri,
nacquero una serie di manifestazioni pacifiste e culturali.
Quando giunse la fine delle sue pubblicazioni mensili, “Papà
Beat” e tutti gli altri “figli dei fiori”
presero percorsi separati, ma lasciarono in eredità un
patrimonio di idee e battaglie avanguardiste di cui il '68,
in parte, se ne appropriò senza però farne tesoro
fino in fondo, a custodia degli anni (tremendi) che seguirono.
Mimmo Mastrangelo
Rave/
Una storia pesante
 È
uscita l'opera prima (letteraria) del mitico dj e musicista
milanese Pablito el Drito dal titolo Once were ravers. Cronache
da un vortice esistenziale per la casa editrice AgenziaX
(Milano, 2017, pp. 168, € 14,00). È
uscita l'opera prima (letteraria) del mitico dj e musicista
milanese Pablito el Drito dal titolo Once were ravers. Cronache
da un vortice esistenziale per la casa editrice AgenziaX
(Milano, 2017, pp. 168, € 14,00).
Lo ammetto subito. Quando l'autore me lo ha regalato ho pensato
che io ho sempre odiato i rave e soprattutto quello che si sono
portati dietro, ovvero: droghe pesanti e pochi contenuti, oltre
ad amici che hanno perso cervello e vita; ma leggendo questo
romanzo che corre a 200 all'ora ho dovuto almeno in piccola
parte cambiare idea.
Il libro ha un protagonista, Ernesto, un quasi pischello che
al tramonto dei vent'anni lascia il lavoro e decide di dedicarsi
alla sua passione, la musica, il nomadismo, i rave, oltre -
inutile dirlo - alle droghe pesanti e al sesso. Stupisce molto
pensare che se l'autore del libro è il personaggio principale
oggi sia ancora vivo e capace di parlare e scrivere; significa
che probabilmente era immune a tutte le sostanze buttate giù
senza troppa paura in quel periodo della sua vita.
Il libro è ambientato negli anni del berlusconismo, ma
si focalizza soprattutto nel dopo G8, un periodo di estrema
crisi per movimenti politici e controculturali.
Il testo è scritto bene, molto divertente, anche se in
certi momenti mi sono innervosito molto perché anche
io ho vissuto quegli stessi anni ed ero dalla parte opposta,
quella che cercava di limitare i festoni, che spingeva le feste
libere dalle sostanze, dal sessismo, sperando di far capire
che le droghe pesanti usate in modo massiccio sono un enorme
arma dello stato per tenere le masse giovanili al loro posto
senza critiche, pronte a “brasare” completamente
le loro menti che potrebbero essere ancora non addomesticate
al capitalismo.
Purtroppo sono convinto che in quegli anni Novanta si sia prodotta
proprio una specie di fabbrica del divertimento, che prevedeva
regole precise e che non hanno portato a nulla di buono per
i movimenti politici e per la cultura underground.
L'autore però non è acritico e fa capire al lettore
che non tutto era positivo e divertente e che una volta che
si riesce a uscire dall'onda profonda della droga e del divertimento
ci si rende conto che sotto l'effetto delle sostanze sintetiche
sembrano tutti amici, ma spente le luci psichedeliche, ammutoliti
i sound system e svanita la scenografia fiabesca, si capisce
presto che intorno ci si ritrova ad avere solamente colleghi,
clienti e competitor.
Un romanzo ironico, a tratti poetico e amaro, un punto di vista
originale sul mondo dei rave.
Andrea Staid
USA/
American Psycho ieri e oggi
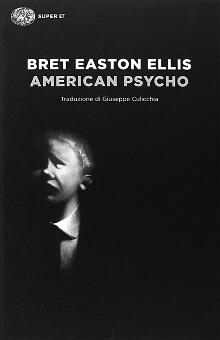 American
Psycho di Bret Easton Ellis (1991) è, secondo me,
un brutto libro. American
Psycho di Bret Easton Ellis (1991) è, secondo me,
un brutto libro.
Delle oltre cinquecento pagine che lo compongono, infatti, almeno
trecento sono superflue, ripetitive ben oltre l'ossessione e
fino alla noia. Di queste trecento, poi, almeno la metà
sono di una violenza gratuita, compiaciuta, orripilante.
Eppure il libro comincia bene. Le prime centocinquanta pagine
sono un vero gioiello di scrittura. Non vi succede praticamente
nulla, ma il mondo degli Yuppies della New York anni '80 è
radiografato con precisione da entomologo e tutta la crudele
ironia che si merita. Il protagonista, poi, è indimenticabile:
difficile trovare un personaggio più spaventoso e comico
(contemporaneamente!) di Patrick Batesman, bravo ragazzo pettinatissimo
e maniaco omicida.
Poi la violenza prende il sopravvento. Sembra chiaro che il
proposito di Bret Easton Ellis consiste nel prendere per la
mano il lettore, accompagnarlo fin poco oltre l'ingresso di
un bel romanzo psicologico, satirico, arrabbiato, per poi lì,
improvvisamente, abbandonarlo nel bel mezzo del peggiore horror
della sua vita. Solo che, una volta realizzato l'effetto-sorpresa,
tutto è tirato un po' troppo per le lunghe. Finiscono
per stufarci le stralunate ossessioni del caro Patrick e sentiamo
sempre più forte la tentazione di saltare pagine e capitoli,
tanto che va un po' sprecato persino l'intelligentissimo finale,
che invece nella trasposizione cinematografica (Mary Harron,
2000) è esposto in tutta la sua irrisolvibile ambiguità.
Ma allora perché rileggerlo oggi?
Perché è difficile non sussultare di meraviglia
e spavento alla lettura di un dettaglio, uno solo, e, a distanza
di mesi, non tornare a sussultare ogni volta che ci torna in
mente. Il protagonista di questa storia, infatti, il broker
macinagrana diplomato in una delle migliori [sic] università
americane; il vicino di casa di Tom Cruise, appassionato di
palestra, moda e ristoranti esclusivi; il “ragazzo della
porta accanto” che nel tempo libero tortura prostitute
e cameriere, sbeffeggia mendicanti e ogni tanto li uccide; Patrick
Batesman, insomma, ha un solo idolo, un solo inarrivabile modello
di comportamento e riuscita: Donald Trump, l'uomo che oggi si
trova a capo del più potente apparato bellico-industriale
al mondo.
Ecco il lettore nuovamente scaraventato nel bel mezzo del peggiore
horror della sua vita. Salvo che non è un romanzo.
Non si possono saltar le pagine o chiudere il libro.
Enrico Bonadei
Berneri/
Non Camillo, ma Giovanna e Maria Luisa
 Il
libro di Giorgio Sacchetti Eretiche. Il Novecento di Maria
Luisa Berneri e Giovanna Caleffi (Biblion, Milano 2017,
pp. 134, € 13,00) contiene un necessario recupero delle
due figure di Maria Luisa Berneri e Giovanna Caleffi, spesso
ricordate semplicemente come figlia e moglie di Camillo Berneri. Il
libro di Giorgio Sacchetti Eretiche. Il Novecento di Maria
Luisa Berneri e Giovanna Caleffi (Biblion, Milano 2017,
pp. 134, € 13,00) contiene un necessario recupero delle
due figure di Maria Luisa Berneri e Giovanna Caleffi, spesso
ricordate semplicemente come figlia e moglie di Camillo Berneri.
Se è vero che portano avanti il suo pensiero, possiamo
dire che il ricordo del loro amato si trasforma nel motore che
le muove: come lui non si fermano davanti a niente, hanno una
grande capacità di analisi dell'attualità ed una
sensibilità non comune. Le loro figure non vivono all'ombra
del Berneri ma sono certamente in grado di camminare da sole:
fanno propria la sua eredità culturale e politica, sviluppano
il suo pensiero e lo arricchiscono della loro visione di genere.
Negli ultimi anni grazie al lavoro dell'archivio Chessa-Berneri
ed ai convegni organizzati, si sono analizzate con più
profondità le personalità di queste due donne
che vissero gli eventi cruciali del Novecento sulla loro pelle.
La loro capacità di analisi dell'attualità di
quel momento, il loro slancio per la condivisione delle idee,
il dibattito collettivo e lo smuovere coscienze, risulta davvero
sorprendente per noi così immersi nel mondo capitalista
ed assuefatti alle sue categorie.
Come ben ricorda l'autore, troviamo nei loro scritti e nel loro
lavoro “un'innaturale continuità figlia-madre”
dato che è per prima la giovanissima Maria Luisa dall'Inghilterra
a farsi notare poichè molto attiva nella propaganda e
nelle pubblicazioni. Già nel 1936 è segnalata
dalle autorità italiane a Londra, e a 18 anni è
una delle più giovani donne schedate dal regime. Insieme
al marito Vernon Richards formano la redazione della rivista
di Spain and the World (1936-1938), poi di War Commentary
(1939-1945) e infine di Freedom (1939-1945). La loro
posizione antibellicista, contraria all'idea di una “guerra
giusta” contro il fascismo, fa guadagnare loro la simpatia
di alcuni settori della sinistra e addirittura dell'esercito;
vengono infatti accusati di attività sediziosa antinazionale:
le loro campagne contro i bombardamenti di massa e la pubblicazione
di Fight! For what? andavano certo contro il sentimento
patriottico e la costruzione di un'identità nazionale
a cui si voleva contribuire con la guerra.
Gli interessi di Maria Luisa spaziano dalle condizioni dei lavoratori
in Russia, sulle quali pubblica nel 1944 una raccolta di scritti,
agli studi di psicologia che si concretizzano nell'analisi dell'opera
di Reich Sexuality and Freedom (articolo pubblicato nel
1945). Il suo lavoro più grande è certo Viaggio
attraverso Utopia, un'accurata disamina delle utopie dal
passato fino ai suoi tempi, pubblicato dopo la sua morte improvvisa
a soli 31 anni nel 1949 a causa di complicazioni post-parto.
Dal 1946 invece la madre Giovanna Caleffi aveva fondato la rivista
Volontà a Napoli insieme a Cesare Zaccaria dove
porta avanti una serie di temi cari anche alla figlia e diventa
negli anni Cinquanta punto di riferimento per il dibattito teorico
sull'anarchismo ma anche per altre correnti di sinistra del
nostro Paese. Oltre che dell'antimilitarismo la rivista si occupa
di temi importanti come l'emancipazione femminile, il controllo
delle nascite e la pedagogia d'avanguardia, argomenti spesso
dimenticati a favore di un dibattito più politico.
Sacchetti studia minuziosamente i contributi alla rivista della
Caleffi per ricostruire la sua figura e ci mette al corrente
del suo metodo di lavoro: riusciamo a farci un'idea delle personalità
di queste due donne non solo grazie all'analisi metodica dei
loro scritti, ma anche attraverso gli scritti minori, o semplicemente
la scelta dei temi e del materiale da recensire. Le loro lettere
poi costituiscono un'inedita mappa dell'esilio negli anni Quaranta
e dimostrano la fitta rete di relazioni sociali, altra eredità
del Berneri.
Gli stralci riportati dalle riviste ci permettono di conoscere
la loro voce in prima persona e l'entusiasmo che le muoveva
nella diffusione delle loro opinioni. Per quanto riguarda Giovanna
la delusione per la riorganizzazione dell'Italia nel dopoguerra
è il leit motiv dei suoi interventi: critica il crescente
potere dello Stato, affermando che si è combattuto contro
il fascismo ma ora ci si abbandona ad uno Stato democratico
che non è tanto diverso. Insiste sulla continuità
del fascismo che avendo forgiato menti gregarie continua ad
essere presente anche nel popolo della sinistra, che si proclama
antifascista ma ancora desidera “essere comandato”.
Contesta fortemente l'ingerenza della Chiesa nello stato e nelle
questioni di tutti i giorni, come “l'etica sessuofobica
religiosa che caratterizza lo stagnante ambiente culturale italiano”.
Una rubrica molto seguita è Conversazioni tra amici,
che ospita personaggi anche illustri come Gaetano Salvemini
o Ignazio Silone, e sottolinea la funzione di dialogo della
rivista, caratteristica delle pubblicazioni anarchiche che non
aspirano a trasmettere una verità bensì fornire
strumenti per il dibattito.
In ricordo della figlia maggiore fonda la Colonia Maria Luisa
Berneri per “sottrarre i figli dei nostri compagni bisognosi
alle varie interessate opere assistenziali” che funziona
non senza difficoltà economiche a Piano di Sorrento dal
1951 al 1957, e poi a Ronchi (Massa Carrara) dal 1960. Questo
progetto di pedagogia antiautoritaria, come sognava Maria Luisa,
termina due anni dopo la morte della sua ispiratrice, nel 1964.
L'instancabile attività di entrambe e la loro capacità
di analisi lega indissolubilmente le loro vite all'attualità
di quegli anni, vicende che abbiamo la possibilità di
ripercorrere attraverso questa importante monografia.
Valeria Giacomoni
A proposito di Iris/
Una cooperativa agricola in Pianura Padana
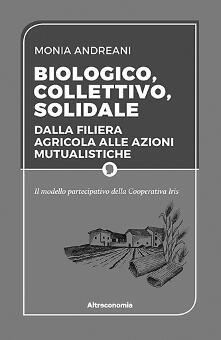 “Quando
stai per arrivare alla cascina Corteregona, la casa di Iris,
la strada diventa una sottile lingua catramata che scorre in
alto, sopra canali che lambiscono dolcemente i campi, e tu che
guidi puoi osservare da una posizione privilegiata, campi coltivati
senza soluzione di continuità da ogni lato... La cascina
ti offre il lato che costeggia la strada, al centro c'è
un murales che rappresenta dei campesinos sudamericani e questo
primo colpo d'occhio colorato e caldo ti svela che questa non
è una cooperativa agricola come le altre.” Le impressioni
descritte da Monia Andreani sono molto simili a quelle che ho
avuto io stesso un mattino di fine giugno varcando la soglia
di questa coop. “Quando
stai per arrivare alla cascina Corteregona, la casa di Iris,
la strada diventa una sottile lingua catramata che scorre in
alto, sopra canali che lambiscono dolcemente i campi, e tu che
guidi puoi osservare da una posizione privilegiata, campi coltivati
senza soluzione di continuità da ogni lato... La cascina
ti offre il lato che costeggia la strada, al centro c'è
un murales che rappresenta dei campesinos sudamericani e questo
primo colpo d'occhio colorato e caldo ti svela che questa non
è una cooperativa agricola come le altre.” Le impressioni
descritte da Monia Andreani sono molto simili a quelle che ho
avuto io stesso un mattino di fine giugno varcando la soglia
di questa coop.
Ero là per partecipare a “Un giorno in cascina”
la festa aperta a tutti che la Cooperativa Iris tiene ogni anno
nella propria sede di Calvatone. C'è da dire che la semplice
cascina, come ce la potremmo immaginare, ha lasciato il posto
ad una ampia e strutturata fattoria. Monia Andreani, professoressa
di Teorie dei Diritti Umani all'Università per Stranieri
di Perugia, ha condotto una ricerca dove ci racconta la storia
di Iris, i suoi esordi e il suo presente, le incognite legate
alle sue attuali trasformazioni. Il testo di questa ricerca
è contenuto nel libro Biologico, Colletivo, Solidale.
Dalla filiera agricola alle azioni mutualistiche pubblicato
dalle Edizioni Altreconomia nel 2016 (Milano, pp. 128, €
13,00).
Andreani per oltre un anno è stata a stretto contatto
con le persone che hanno visto nascere e diventare adulta “la
Iris”, come viene familiarmente chiamata, e ne ha raccolto
le testimonianze. Molte testimonianze che raccontano una storia
lunga quasi 40 anni, sbocciata sul finire degli anni '70, gli
anni che ricordiamo come quelli della grande ondata rivoluzionaria
e creativa, politica ed esistenziale. Anni che vedono protagonisti
un gruppo di ragazzi anarchici, libertari e comunisti della
provincia cremonese che insieme decidono di coltivare la terra
con metodi biologici, ben prima dunque di quella che diverrà
in seguito la “moda” industriale del biologico.
Il loro intento è chiaro: rispettare la natura intima
della terra, la madre che nutre tutti noi umani e non umani.
Una scelta netta, in controtendenza alla diffusione dell'agro-industria
convenzionale. Ma non si limitano a questo, vogliono fare gli
agricoltori seguendo criteri di autogestione e di solidarietà,
condividendo questi valori quando possibile con altri.
Il libro è denso delle testimonianze di coloro che in
qualche misura hanno condiviso e tuttora condividono la vita
della cooperativa: i soci fondatori e quelli lavoratori, i soci
consumatori e quelli finanziatori, e non mancano gli amministratori
e gli abitanti di questa parte di campagna cremonese. Attraverso
le testimonianze in particolare di Maurizio Gritta presidente
di Iris, di Paolo Morelli e Fulvia Mantovani vengono illustrati
gli avvenimenti che nel corso del tempo hanno portato a modificare
l'organigramma della cooperativa. La ricercatrice sottolinea
più volte come Iris a suo giudizio abbia salvaguardato
nel corso del tempo la forma cooperativa come autentica espressione
dell'economia del bene comune, e invita il lettore a farne una
comparazione con le tante degenerazioni avvenute nel mondo cooperativo
agricolo e industriale. A questo scopo vengono citati i princìpi
fondativi di Iris che non solo fanno riferimento all'agricoltura
biologica e al rispetto della fertilità naturale della
terra, ma anche alla forma cooperativa come proprietà
collettiva a capitale non cumulativo, alla solidarietà
e al mutualismo declinati all'ambito lavorativo e produttivo
della cooperativa e della filiera che la rifornisce e la sostiene.
Iris negli anni ha avuto un ampliamento considerevole, la cooperativa
agricola ha assunto anche la veste di coop. industriale nella
produzione di pasta biologica, e recentemente ha avviato un
nuovo pastificio a Casteldidone, a pochi km dalla cascina di
Calvatone. Questa nuova impresa industriale, finanziata anche
con l'emissione da parte di Iris di azioni mutualistiche, affiancata
da una struttura per servizi educativi, culturali, ludici e
la recente costituzione della Fondazione Iris rappresentano
per tutti i soci della cooperativa, e non solo per loro, una
nuova sfida.
Questa recente “metamorfosi” può indurre
noi lettori a porci alcune domande, Andreani ci offre una risposta
esemplificativa: “La cooperativa Iris può essere
considerata una realtà medio-grande nel panorama dell'economia
solidale italiana che è costituita per lo più
da aziende piccole o piccolissime. Quello che è davvero
grande in Iris è il tessuto organico, perchè pulsante
e vitale, una vera e propria rete eco-solidale che la cooperativa
è riuscita con grande caparbietà a tessere negli
anni: con la filiera, con la rete economica tra le cooperative
consociate, con il sostegno alla sperimentazione portate avanti
dai GAS, con il sostegno a chi vuole fare percorsi simili nell'ambito
della cooperazione”.
Un libro scritto con partecipazione, che a tratti forse pecca
di eccessiva enfasi per l'oggetto della ricerca, che ha il merito
di offrire al movimento libertario e solidale degli utili strumenti
di riflessione sui possibili e praticabili percorsi di uscita
dall'economia capitalista.
Orazio Gobbi
L'inventrice del Sistema/
Cronache (on-line) di fantapolitica
 Alessandra
Daniele ha finalmente brevettato il modo di far pagare l'aria.
Da tanto tempo, da prima della Rivoluzione industriale, se ne
parlava. Ma mai nessuno aveva potuto stabilire come sarebbe
successo. L'inventrice scrive su Carmillaonline da quasi dodici
anni, ha iniziato con una serie di schede sugli scrittori di
fantascienza della Golden Age, (Asimov, Sturgeon, Fredric Brown,
Robert Sheckley, Philip K. Dick...) i quali, ci scrive “sono
stati anche la mia principale fonte d'ispirazione, e non mi
stanco di consigliare a tutti di leggerli”. Alessandra
Daniele ha finalmente brevettato il modo di far pagare l'aria.
Da tanto tempo, da prima della Rivoluzione industriale, se ne
parlava. Ma mai nessuno aveva potuto stabilire come sarebbe
successo. L'inventrice scrive su Carmillaonline da quasi dodici
anni, ha iniziato con una serie di schede sugli scrittori di
fantascienza della Golden Age, (Asimov, Sturgeon, Fredric Brown,
Robert Sheckley, Philip K. Dick...) i quali, ci scrive “sono
stati anche la mia principale fonte d'ispirazione, e non mi
stanco di consigliare a tutti di leggerli”.
Le sue cronache di fantapolitica hanno raccolto un pubblico
di entusiasti lettori e di recente sono state collezionate in
un ebook1. Ma la portata dei
“brevetti” di questa scrittrice è tale da
meritare la carta stampata, oggetto ormai feticistico, collezionato
da Previti, bianchi fogli profumati di inchiostro e status,
sprecati per libri bianchi di Fabio Volo.
Lo si capisce da subito, si è di fronte ad una visione
limpida, pitagorica, dello scenario politico italiano (ma alcune
istantanee sono dedicate alla guerra globale). Pensiamo ad esempio
alla geniale previsione del nuovo partito post PD... il PD,
cioè il Partito Demopratico. Oppure alla definizione
del Predariato, mutazione del Precariato, il nuovo rapporto
tra datore di lavoro e lavoratore: un contratto di lavoro a
tutele crescenti che segua criteri evoluzionistici, per cui
appena assunto il lavoratore avrà gli stessi diritti
di un protozoo unicellulare.
L'Era del Cazzaro descritta dall'inventrice è un dejà
vu, un “ritorno al Cazzaro” quale figura ricorrente
(Mussolini, Craxi, Berlusconi) alternata a periodi di quaresima,
personaggio di una sorta di Ubik (dall'omonima opera di P. K.
Dick) in cui si alternano episodi quali “Il paradosso
dei gemelli” (Matteo e Matteo) e si attuano fantasiosi
schemi politici, quali la “Repubblica presenziale”,
quella cioè nella quale diventa premier chi ottiene più
passaggi televisivi.
La “cazzaria” è semplicemente, dunque, l'evoluzione
da un “bi-polmonarismo perfetto” a quello in cui
uno dei polmoni riciclerà smog, grazie al bonus da 80
euro impregnato di un virus mutageno, a tutto vantaggio dell'economia
che così riuscirà a vendere inquinamento. Lo stesso
iperrealistico sistema economico beneficia di un Welfare perfetto,
quello che invia all'italiano che non ha ricevuto dall'Inps
la busta arancione, una busta nera con la comunicazione che
l'importo della sua pensione è un numero negativo, e
che quindi dovrà versare un mensile allo Stato.
Se l'insieme dello stupidario politico riassunto nel Cazzarometro
vi divertirà, l'analisi di Alessandra Daniele vi stupirà
(o preoccuperà) per la sua teoria basica che tende a
definire una “fine del futuro” ed a semplificare
l'universo mediatico-politico in una chiarissima tesi: “...
Renzi dimostra che è ancora Berlusconi il demiurgo morente
del nostro inferno privato, costruito dall'immaginario televisivo
ben prima che politico”.
Francesca Palazzi Arduini
1. L'Era del Cazzaro è disponibile in ebook
con licenza Creative Commons su carmillaonline.com
Utopie concrete/
Né servi né padroni
Tutti quelli che hanno esperienza di militanza (più
o meno calda e intensa) nei gruppi politici (ma anche nel volontariato
sociale) ricordano sicuramente le molte situazioni in cui la
“struttura informale” ha avuto la meglio sulla “struttura
formale” del gruppo causando piccoli e grandi guai. Formalmente
si assumeva che ci fosse una parità tra i membri del
gruppo, che ci fosse insomma un'organizzazione “orizzontale”,
mentre nei fatti e nelle situazioni concrete emergevano relazioni
gerarchiche più o meno occulte.
 A
volte si arrivava a considerare questa situazione come qualcosa
di naturale, altre volte invece imputabile a singoli membri
del gruppo oppure ancora alla pressione del mondo esterno sul
piccolo gruppo. Qualunque fossero le ragioni si creavano dei
conflitti che alla lunga potevano condurre alla disgregazione
e allo scioglimento del gruppo. In effetti non è difficile
capire perché la gerarchia come struttura organizzativa
sembra più stabile: ingessa i partecipanti e limita le
scelte in funzione di obiettivi esterni e di una catena di comando
che difficilmente può essere modificata ai livelli più
bassi della piramide. Ma lo fa appunto a discapito dell'autonomia
degli individui. La sfida di un'organizzazione egualitaria,
veramente orizzontale è davvero ardua ma è ciò
che, con il mai dimenticato Colin Ward, si può chiamare
“anarchia come organizzazione”. A
volte si arrivava a considerare questa situazione come qualcosa
di naturale, altre volte invece imputabile a singoli membri
del gruppo oppure ancora alla pressione del mondo esterno sul
piccolo gruppo. Qualunque fossero le ragioni si creavano dei
conflitti che alla lunga potevano condurre alla disgregazione
e allo scioglimento del gruppo. In effetti non è difficile
capire perché la gerarchia come struttura organizzativa
sembra più stabile: ingessa i partecipanti e limita le
scelte in funzione di obiettivi esterni e di una catena di comando
che difficilmente può essere modificata ai livelli più
bassi della piramide. Ma lo fa appunto a discapito dell'autonomia
degli individui. La sfida di un'organizzazione egualitaria,
veramente orizzontale è davvero ardua ma è ciò
che, con il mai dimenticato Colin Ward, si può chiamare
“anarchia come organizzazione”.
Il libro di Yona Friedman, Come vivere con gli altri senza
essere né servi né padroni (Elèuthera.
Milano 2017, pp. 184, € 15,00), come si spiega nell'introduzione
e nella postfazione, nasce da esperienze concrete: nei kibbutz,
all'università, a contatto con gli organismi internazionali
(ad esempio il Consiglio europeo).
Friedman architetto e urbanista, autore tra l'altro di Utopie
realizzabili (riedito in italiano nel 2016) è stato
protagonista dell'architettura utopica negli anni Sessanta.
Questo libro originale, pubblicato per la prima volta più
di quarant'anni fa e riedito da poco in Francia, è diviso
in due parti dedicate rispettivamente alla dimensione micro
e alla dimensione macro. Nella prima ci troviamo davanti a un
saggio a fumetti in cui l'autore utilizzando grafi e vettori,
visualizza la rete di influenze nel gruppo in modo simile al
metodo dei sociogrammi. Mostra i limiti e le possibilità
dell'influenza del gruppo, la valenza (ossia la capacità
di influenzare gli altri) degli individui in funzione delle
dimensioni del gruppo e del tempo a disposizione, i limiti nella
capacità di trasmissione e arriva a definire alcune caratteristiche
strutturali del gruppo egualitario.
Centrale è la questione delle dimensioni: “un gruppo
umano caratterizzato da una qualsiasi struttura sociale non
può funzionare se non a patto che il numero dei componenti
del gruppo stesso non superi un numero limite che dipende dalla
“valenza” e dalla “capacità di trasmissione”
proprie della specie umana. Questo numero limite lo definiremo
dimensione critica del gruppo” (124).
Da qui segue una conseguenza all'apparenza paradossale che in
un certo senso fa da cerniera tra le due parti e che riguarda
la comunicazione: la comunicazione globale è impossibile.
Ma come, nella società della comunicazione, si asserisce
che la comunicazione è impossibile? Per quanto sia sofisticata
la tecnologia impiegata, il superamento delle dimensioni del
gruppo critico fa sì che non ci sia comunicazione in
senso proprio ma solo trasmissione unidirezionale dall'esito
imprevedibile. È quella che Friedman chiama la sindrome
della Torre di Babele. Qui forse si dovrebbe inserire, ma
non era forse nelle possibilità e nelle intenzioni dell'autore,
una riflessione più approfondita sul ruolo dei social
e degli smartphone oggi che coinvolgono miliardi di persone
nel mondo1.
Nella seconda parte del libro l'autore tenta una sintesi generale
che tragga le conclusioni dalle premesse sulla struttura delle
organizzazioni e delinea quella che può definirsi un'utopia
concreta del mondo povero che, per dirla in breve e in
un modo che è familiare ha il sapore kropotkiniano della
de-centralizzazione2. “Le
grandi organizzazioni sono divenute ingovernabili perché
tutte le istruzioni, che provengano dall'alto o dal basso, vengono
comunque bloccate a un certo punto del loro percorso”
(129).
Ecco la necessità di una de-centralizzazione che crei
dei sistemi economici su base regionale/locale (che definisce
economia di “serbatoi specializzati”), con una distribuzione
di beni e energia basata sul baratto, con una progressiva riduzione
del lavoro parcellizzato e dei trasporti. Un mondo in cui il
commercio è fortemente ridotto, quasi annullato, perché
è venuta meno l'esigenza dell'accumulo e la logica dell'equivalenza.
E in conclusione arriva ad abbozzare quella che definisce una
“economia animale”, che per l'autore non ha nulla
di peggiorativo e che non va confusa con il primitivismo. “Un
“mondo povero” nel quale la scala dei valori quantitativi
non ha alcuna ragion d'essere al pari del commercio, dove non
si mangia più di ciò che è necessario,
dove si prestano e ci si fa prestare gli oggetti di cui si ha
bisogno, oggetti che non vengono più accumulati
per semplici “ragioni di prestigio”, io la definisco
un'economia animale” (134).
La tecnologia continua ad esistere ma in una forma che potremmo
definire con Illich “conviviale” basata sull'autodeterminazione,
sulle conoscenze e sulle necessità dei componenti dei
piccoli gruppi, senza sfruttamento né lavoro salariato.
Alla fine di questo breve e intenso percorso, si resta senza
fiato. Si alzano gli occhi dal libro, ci si ricorda del mondo
in cui viviamo. E ora?
Qui ci aiuta nella postfazione Bunuga ricordandoci che Friedman
parla di utopie concrete e non totalizzanti. Riferendosi al
mutamento significativo tra le due edizioni del 1974 e del 2016,
Comment vivre entre les autres sans être chef et sans
être esclave?, in cui entre è oggi diventato
avec, scrive: “Oggi realizzare utopie concrete
vuol dire produrre modelli ed esperienze in conflitto e in concorrenza
con – avec – altri opposti o alternativi
con i quali bisogna convivere e confrontarsi” (174).
Un buon punto di partenza per non essere schiacciati né
dal senso di impotenza né da quello di onnipotenza.
Filippo Trasatti
- Per un'analisi critica del fenomeno si veda ad esempio Nell'acquario di Facebook del gruppo Ippolita e il più recente Tecnologie del dominio.
- Come ci ricordano i curatori il riferimento diretto dell'autore è a Martin Buber che a sua volta conosceva Kropotkin e il pensiero anarchico.
Identità meridionale?/
Il Sud e le sue specificità
 Un
Sud fuori dai luoghi comuni e dagli stereotipi è quello
che viene fuori da una nutrita serie di saggi, raccolti e curati
da Isabella Loiodice e Giuseppe Annacontini (Pedagogie meridiane,
Progedit, Bari, 2017, pp. 170, € 20,00) che, rivisitando
la natura e le caratteristiche dello spirito pubblico meridionale,
articolano l'idea di una pedagogia “del Mezzogiorno e
che guarda al Mezzogiorno”, volta a dare alla gente del
sud la coscienza delle sue più autentiche, libere e progressive
modalità di vita, di relazione e di lavoro: molto diverse
da come, a lungo ed erroneamente sono state tratteggiate, cioè
come infide, egoistiche, amoralmente familiste, passive, arretrate
e fatalistiche. Perché questo è quanto tanta letteratura
e saggistica mal documentata e tendenziosa ha saputo raccontare
del meridione, etichettandolo come subalterno e arretrato rispetto
ad una presunta modernità. Un
Sud fuori dai luoghi comuni e dagli stereotipi è quello
che viene fuori da una nutrita serie di saggi, raccolti e curati
da Isabella Loiodice e Giuseppe Annacontini (Pedagogie meridiane,
Progedit, Bari, 2017, pp. 170, € 20,00) che, rivisitando
la natura e le caratteristiche dello spirito pubblico meridionale,
articolano l'idea di una pedagogia “del Mezzogiorno e
che guarda al Mezzogiorno”, volta a dare alla gente del
sud la coscienza delle sue più autentiche, libere e progressive
modalità di vita, di relazione e di lavoro: molto diverse
da come, a lungo ed erroneamente sono state tratteggiate, cioè
come infide, egoistiche, amoralmente familiste, passive, arretrate
e fatalistiche. Perché questo è quanto tanta letteratura
e saggistica mal documentata e tendenziosa ha saputo raccontare
del meridione, etichettandolo come subalterno e arretrato rispetto
ad una presunta modernità.
Da un po' di tempo, invece si riscopre e si rivaluta una 'identità
meridionale' fatta di altruismo, benevolenza, capacità
di donare; caratteristiche positive di cui è depositario
l'individuo nel meridione, che in larga misura, nel passato,
viveva i suoi buoni sentimenti dentro un congeniale ambiente
cittadino, dove l'appartenenza sociale era scandita da un 'tempo
locale' fatto di riti, feste, fiere, diverso, più denso
e sensato, dal tempo della storia generale e dove la città
era il luogo dell'appartenenza civica, un reticolo architettonico
in cui tutto, dalle piazze ai vicoli, era memoria di antiche
storie e oggetto degli sguardi incantati dei viaggiatori europei.
Un meridione segnato positivamente dalla solidarietà
che regnava sovrana nei rapporti familiari, parentali e comunitari,
dal senso dell'aiuto attraverso lo scambio di reciproci lavori
e favori, che è stato umiliato, frenato e costretto alla
'delega' da un ceto oligarchico di 'professionisti' della politica,
che, con scopi affaristici, dall'800 in avanti, si è
prepotentemente assunto il compito, non senza profitto, di fare
da intermediario, parassitario e dominatore, tra Stato e Governi
e la gran massa di popolazione del sud, imponendo un modello
di sviluppo capitalistica, che ha cancellato, con la sua logica
del profitto e del consumo, l'autoproduzione e le diversità
locali, sostituendo al senso del limite e della misura, al creativo
'perder tempo' delle comunità meridionali, il credo del
primato economico, della crescita illimitata e ad ogni costo,
del successo e del denaro come fini della vita.
Scopo delle pedagogie meridiane (delle quali, i contenuti, le
analisi e le proposte scorrono convinte e convincenti negli
interessanti e densi saggi di accademici e studiosi degli Atenei
meridionali) sarà quello di ridare stimoli e motivazione
al popolo del Sud per ritrovare un modello alternativo a quello
liberista e fallimentare che nel Sud ha prodotto solo devastazione
ambientale, precarietà occupazionale (la scarsa e disorganica
industrializzazione non è riuscita a dare soluzioni durature
e forti all'economia meridionale, accelerando negativamente
e al contempo, il declino dell'agricoltura) e sterminio dell'
infinito patrimonio delle culture materiali e dei lavori e dei
mestieri popolari.
Senza rimpianto per il mondo arcaico e per il folklore retrivo,
negli interventi presenti nel volume si analizzano le contraddizioni
della realtà meridionale contemporanea e si propongono,
ad ampio raggio, idee e soluzioni che possano ridare speranza
ad un futuro di autonomia e libertà a genti che abitano
terre che furono, e sono, approdi accoglienti e rispettosi delle
diversità.
Per esempio: come scrive, nel suo intervento, a proposito di
didattica plurilinguistica, Rosa Galleli: “occorre immaginare
un insegnamento della lingua scritta che sappia teorizzare la
particolarità espressive dei vernacoli meridiani come
anche dei linguaggi non verbali che qui si concentrano all'incrocio
tra le storie di guerra e di pace; di dono e di furto, di amore
e di tradimento provenienti dalle infinite sponde del Mediterraneo”.
Silvestro Livolsi
Un romanzo sull'Urbe/
Ma a Roma c'è anche “A_”
È sempre notte. A Roma è sempre notte. A Roma
e, probabilmente, ovunque. Una sensazione, un'oggettività?
Roma è l'ultimo romanzo di Vittorio Giacopini
(Il Saggiatore, Milano 2017, pp. 414, € 21,00): ambientato
nel 2014 con rimandi ai decenni precedenti e agganci storici
locali ed internazionali.
Una prima lettura mi ha suscitato quei “crampi del pensiero”
capaci di sviare l'attenzione: che Giacopini abbia voluto omaggiare
l'Urbe e tutto ciò che la caratterizza in modo da rendere
impalpabile il confronto ad elementi più complessi, tracciando
con esilarante sarcasmo un groviglio vischioso dove la quotidianità
inciampa sempre alla presenza ingombrante di politici, suore,
papi, palazzinari, faccendieri di ogni risma? Amore e odio?
Forse sì, ma non è tutto. Roma può
avere diversi codici di lettura.
 In
primo piano si scorgono aspetti dell'esistenza del protagonista
che rasenta una condizione di claustrofobica alienazione (stilisticamente
affidati a lunghi elenchi di assurdi souvenir, gratta e vinci,
passatempi, luoghi deturpati ma santificati, immondizie di ogni
ordine e grado, realtà cadute nell'oblio ecc. quasi a
voler archiviare scampoli di vita senza scampo) tanto da stare
per lo più al buio, in una cripta che è rifugio,
alcova, caverna, covo e dalla quale percorre il suo labirintico
sottomondo: una città segreta, “il gran privilegio
di attraversare Roma senza salire allo scoperto” e di
incontrare, soltanto per necessità, alcuni - e alquanto
romanescamente strambi – personaggi. Per Lucio
Lunfardi, “l'abominevole ex giornalista e come tale titolare
di informazioni riservate”, che via via acquisisce ogni
sorta di appellativo, tutto è fastidio, rumore, interferenza:
nella memoria del suo vissuto trova alibi e conferme, speranze
e disillusioni, affetti e passioni. “Essere adeguati significa
solo accettare, accettare tutto”. In
primo piano si scorgono aspetti dell'esistenza del protagonista
che rasenta una condizione di claustrofobica alienazione (stilisticamente
affidati a lunghi elenchi di assurdi souvenir, gratta e vinci,
passatempi, luoghi deturpati ma santificati, immondizie di ogni
ordine e grado, realtà cadute nell'oblio ecc. quasi a
voler archiviare scampoli di vita senza scampo) tanto da stare
per lo più al buio, in una cripta che è rifugio,
alcova, caverna, covo e dalla quale percorre il suo labirintico
sottomondo: una città segreta, “il gran privilegio
di attraversare Roma senza salire allo scoperto” e di
incontrare, soltanto per necessità, alcuni - e alquanto
romanescamente strambi – personaggi. Per Lucio
Lunfardi, “l'abominevole ex giornalista e come tale titolare
di informazioni riservate”, che via via acquisisce ogni
sorta di appellativo, tutto è fastidio, rumore, interferenza:
nella memoria del suo vissuto trova alibi e conferme, speranze
e disillusioni, affetti e passioni. “Essere adeguati significa
solo accettare, accettare tutto”.
No, lui non si adegua, ha le sue utopie, i suoi riferimenti
ideali e agisce. Il Lunfa ha un piano, svelato fin dalle prime
pagine. Roma deve essere distrutta, sommersa dalle sue stesse
acque, inciampare per sempre nella melma informe: tanto che
differenza c'è fra i sorci e tutti gli invasori che l'hanno
trasformata in un luogo di pellegrinaggio per appetiti conformisti
o affaristici dove la violenza peggiore si consuma nelle stratificazioni
di una legalità ad uso e consumo di un mondo iniquo,
dove ogni speculazione ha la sua aureola, dove vige “l'intrallazzo
eretto a regola e sistema, metodo, dogma”?
Come nel suo precedente romanzo La mappa, Giacopini inserisce
una co-protagonista femminile: un'antieroina che assume un ruolo
fondamentale, non tanto per ciò che fa, ma per ciò
che comunica, per il carisma che emana, perché sa suggerire
un'interpretazione differente della realtà, anche quando
tutto appare immerso in una bieca linearità. In Roma
c'è Ariela, graffitara dalla firma “A_” (variante
della A cerchiata?) che riesce a superare le inevitabili e subdoli
difficoltà di chi sceglie di “vivere contro”
grazie a quel qualcosa in più che finge di non cogliere
ma sa regalare, grazie alle sue sfide artistiche, alla ricerca
di spazi perduti, sempre sospettosa nei confronti del potere,
“tutti i poteri, quelli ufficiali – contro cui era
schierata da una vita – quelli ribelli complottardi parolai,
artistico-furiosi, avanguardistici”. In Ariela c'è
l'energia della bella Zoraide de La mappa, anche se il
richiamo esplicito è alquanto fugace.
A_ disegna ovunque “Uccellacci e uccellini” (il
rimando pasoliniano è un motivo conduttore di questo
libro ricco di citazioni letterarie, filosofiche, musicali o
cinematografiche a titolo di omaggio o di sberleffo tanto da
rendere la prosa particolarmente ironica) e sono proprio i volatili
e la loro capacità di guardare tutto dall'alto, a suddividere
in sezioni i capitoli del romanzo, a differenziare le “claustrofobie
all'aria aperta” dell'oggi e di un passato recente alla
ricerca di una comprensione meno didascalica, a scandagliare
il tempo inglobato nello spazio, a svelare le dimenticanze.
É così che – ad esempio - gli anni '90,
anni di cornacchie, sono gli anni dei simulacri, delle fiction
inesorabili, della guerra in diretta televisiva che appiattisce
i sentimenti e li rende virtuali nell'alternanza fra spot pubblicitari
e massacri, che pianifica l'abitudine: “la rarefazione
delle immagini di guerra (...) finiva per creare un'immane,
un'assoluta, una sorprendente carenza di immaginazione”.
Ecco che il romanzo sovverte i canoni narrativi alla ricerca
di linguaggi eretici che diventano parte integrante del racconto,
un amaro sfogo privo di retorica: se la percezione è
continuamente disturbata da interpretazioni indotte e se alla
disfatta sociale si può rispondere con irriverenza, il
tempo degli sconti è finito, bisogna modificare le competenze
comunicative. Giacopini non si discosta dai temi a lui più
cari, il suo ultimo libro – a tratti imprevedibile, epico
o autobiografico – sembra volerci accompagnare, in un'alternanza
di flashback e dissolvenze emotive, nel ritrovare le mappe della
memoria, scovando magari fra i dubbi che emergono quando i sensi
prendono il sopravvento e, accada quel che accada, chiunque
si merita un po' di sana solitudine!
E se il Lunfa guarda il mondo dal basso non è però
incapace di individuare, fra le peculiarità urbanistiche,
un sentire più universale: si può sempre scegliere
fra subire o resistere, fuggire o sparire, distruggere o neutralizzare
tutto un sapere che sapere che non è, ma merce! E che
il “redivivo” possieda le mappe dell'Urbe sotterranea,
che si senta l'unico vivente fra spaventapasseri, che la sua
sia un'utopia indolente, che confonda l'alfa con l'omega o inverta
il principio e la fine, che si strugga fra il Che, Bakunin,
Cagliostro o Nerone, lo ritroviamo a scontrarsi con una “verità
che nasconde il fatto che non c'è alcuna verità”:
diventa prioritario sapersi orientare, eliminare l'annebbiamento
dello sguardo, rendere i pensieri meno rarefatti.
Quanti hanno giocato a Risiko, su quel mappamondo srotolato
ad uso e consumo di istinti bellici? E quanto sarebbe necessario
ridefinire geografie e topografie, uscire dall'ombra dei significanti
di una conoscenza apparentemente oggettiva? Nella sua contraddittorietà
il protagonista ama “vivere la propria autobiografia con
puntiglio cartografico, e con grazia”: una geo-definizione
per cogliere, dai luoghi segnati dal tempo, un respiro critico
purché la geografia non coincida con la piatta descrizione
di una carta.
É così che il centro di Roma, là dove sta
“Giordano l'abbruciato”, cambierà colore
dopo che ne è stato sfrattato, o che il colle di Monteverde
rimarrà associato al “clima sereno dell'infanzia”.
Ma probabilmente mi sono lasciata prendere la mano su riflessioni
dal tono quasi didattico, tono che in Roma è assente.
L'autore lancia sassolini, ma poi sembra divertirsi, ad esempio
elevando ad acronimo le più svariate locuzioni: da GCEM
(Grande Crisi Economica Mondiale) con la sua “fabbrica
di bolle” a GF (no, non il Grande Fratello, ma il Gran
Finale) e poi GTR (Grandi Temi Ricorrenti), CPBDM (Campionato
Più Bello Del Mondo), OVNI (Oggetti Volanti Non Identificati)
e PGR (Per Grazia Ricevuta) o VFGA (Votium Feci Gratiam Accepi)
su gentile concessione del marketing benedetto. “Devoti
e paraculi i romani, come ti sbagli?” e fra turisti, pellegrini
e fascisti è tutta una nave che merita di affondare.
Così l'acqua, per la quale si fanno le “guerre
guerreggiate” e le “guerre striscianti”, ridiventa
“fonte di vita”: il piano “aberrante”,
“liberatorio” e “futurista” di una pace
che è morte, “senza soluzione di continuità
dal Mega-Catto-Bingo al Mega-Fatto” in una giornata speciale
e simbolica per questa città “calamita e tiranna”...
ma, nello sfacelo, rimane un enigma.
E, se preferite, accendete la luce ma sappiate che qui è
sempre notte; nel credere che Il mattino ha l'oro in bocca
si finisce male: Jack (Lunfa) Nicholson di Shining diretto
da S. Kubrick ce l'ha insegnato! Buona lettura, ça
va sans dire!
Chiara Gazzola
|

