
Mujeres libres
Rivoluzionarie, ma in un mondo maschile
La guerra civile spagnola è un tema che mi appassiona
e che mi ha portato a vivere tanti anni in Spagna: ho letto
molto sull'argomento e spesso mi emoziono rivivendo la storia
di quegli anni. Ho avuto anche l'occasione di conoscere vari
personaggi che quella storia l'hanno vissuta in prima persona,
ma forse perchè ero troppo giovane e presa a scoprire
il mondo dell'anarchismo, non ho saputo approfittare per fare
loro delle interviste approfondite, ho più goduto della
loro compagnia. Bisogna dire che molti avevano già lasciato
testimonianza scritta della loro esperienza con delle memorie
ed è sempre difficile far ripetere una storia che è
già stata narrata.
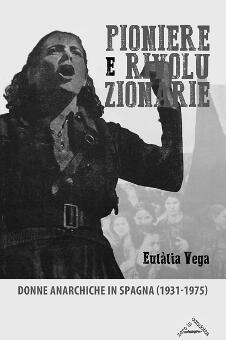 Il
merito di trovare delle voci poco ascoltate e saperne valorizzare
il punto di vista è di Eulalia Vega con il libro Pioniere
e rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975),
Zero in Condotta, Milano 2017, pp. 320, € 23,00: l'autrice
riesce a scavare nelle emozioni delle protagoniste e ad offrire
un quadro di quegli anni molto più completo di quello
che avevo finora. È molto diverso, oltre a conoscere
come sono andati i fatti, riuscire a capire anche come si sentivano
le persone in quel momento, come sono cambiate le relazioni
di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo e come, nonostante
quella situazione si trattasse di una novità, abbiano
saputo reagire con naturalezza ed entusiasmo. Il
merito di trovare delle voci poco ascoltate e saperne valorizzare
il punto di vista è di Eulalia Vega con il libro Pioniere
e rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975),
Zero in Condotta, Milano 2017, pp. 320, € 23,00: l'autrice
riesce a scavare nelle emozioni delle protagoniste e ad offrire
un quadro di quegli anni molto più completo di quello
che avevo finora. È molto diverso, oltre a conoscere
come sono andati i fatti, riuscire a capire anche come si sentivano
le persone in quel momento, come sono cambiate le relazioni
di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo e come, nonostante
quella situazione si trattasse di una novità, abbiano
saputo reagire con naturalezza ed entusiasmo.
La volontà dell'autrice sta proprio nell'approfondire
le motivazioni che hanno in primo luogo avvicinato queste donne
all'anarchismo, dando poi spazio alle loro sensazioni e alla
loro crescita personale, senza fermarsi alla mera riproduzione
dei fatti. Ho trovato molto interessante anche la spiegazione
della metodologia: non basta utilizzare interviste per fare
storia orale; si parla invece di creare le proprie fonti in
funzione degli obiettivi della ricerca storica.
La scelta di seguire l'ordine cronologico ed inserire le testimonianze
poco a poco, ci permette di ricostruire un quadro completo:
le storie personali si trasformano in una vicenda corale; che
si sofferma non solo sulla storia delle donne, ma anche sulla
storia delle strutture anarchiche, di come si diffondevano gli
ideali (il peso di famiglia, amici, inquietudini personali...)
e delle diverse tendenze. Si mette a fuoco il momento della
presa di coscienza di ogni protagonista, che poi lentamente
alza lo sguardo e abbraccia la militanza con entusiasmo cercando
di far aprire gli occhi a più donne possibili.
Erano gli anni Trenta e con la Repubblica in Spagna si iniziava
a parlare di donne, voto e diritti. C'era una generazione di
donne, poche e molto colte, che aveva già preso la parola
e creato un precedente. Furono loro a preparare e ad appoggiare
le giovani che nel 35-36 riuscirono a dare vita ad una struttura
dedicata all'emancipazione delle donne. Non si consideravano
femministe, termine che ricordava le suffraggette, ma lavoravano
appunto per l'emancipazione della donna. È già
del 1934 un intervento di Lucía Sánchez Saornil
sulla rivista Solidaridad Obrera, con contributi quasi
esclusivamente maschili, che polemizzava sulle vite private
degli anarcosindacalisti denunciando come vigesse il patriarcato
anche tra le mura domestiche di chi voleva fare la rivoluzione.
Leggendo la storia con gli occhi degli uomini (come sempre)
sembra di capire che accettassero di buon grado la presenza
di qualche donna emancipata nel sindacato e negli atenei, ma
che non si chiedessero perché la loro compagna o le altre
non facessero altrettanto. Sembrano troppo impegnati nel portare
avanti la rivoluzione per accorgersi delle disuguaglianze dentro
casa loro, e mostrarono anche poco interesse quando le donne
cominciarono ad organizzarsi.
Fu proprio per contrastare questa assenza silenziosa che nasce
quasi contemporaneamente a Madrid e a Barcellona un gruppo femminile
con obiettivi simili: l'esigenza di accompagnare il processo
di emancipazione di ogni donna. È l'inizio di Mujeres
Libres, ramo femminile della CNT mai ufficialmente riconosciuto
come struttura indipendente.
Alcune donne anarchiche non consideravano necessaria un'organizzazione
esclusivamente femminile, come Federica Montseny, che comunque
parteciperà come oratrice e con scritti al movimento,
cogliendone l'importanza. Le poche donne cresciute senza subire
le forti differenze pedagogiche con cui si educavano i figli
dei diversi sessi (spesso in famiglie anarchiche), non trovavano
giusto dividere la militanza femminile da quella maschile; altre
credevano che se l'emancipazione non è fatta insieme
all'uomo non ha senso. Ma Mujeres Libres si proponeva
come una “palestra” per diventare forti prima di
confrontarsi con l'uomo, un gruppo in cui sentirsi libere di
parlare, esprimere le proprie opinioni e rafforzarle. A posteriori
possiamo dire che erano certo avanti per aver capito questa
necessità di consolidare l'autostima femminile e fornire
solide basi culturali alle ragazze prima di mandarle allo sbaraglio
in un mondo rivoluzionario sí, ma ancora prettamente
maschile.
Rispetto alle organizzazioni femminili comuniste e socialiste,
che si svilupparono negli stessi anni, l'originalità
di Mujeres Libres risiede nella lotta non solo al capitalismo
ma anche al patriarcato: portavano avanti un chiaro programma
per avere gli stessi diritti e non rimanere sempre “come
delle minorenni, adulte ma minorenni”.
L'autrice si sofferma sui cambiamenti nella vita quotidiana
di queste donne che dalla sfera privata si aprono a quella pubblica.
Con la rivoluzione cambiarono completamente gli orari (spesso
arrivarono ad avere delle libertà prima impensabili),
l'abbigliamento (uso dei cappelli da parte dei lavoratori, donne
con gonne pantalone oltre alle famose tute da lavoro), le relazioni
amorose: si parla del famoso amore libero, spesso frainteso,
ma inteso semplicemente come unione libera tra uomo e donna,
senza vincoli legali e basata sul consenso di entrambi. Si insiste
anche sull'educazione sessuale ed il controllo delle nascite
con la diffusione dei contraccettivi e la legalizazzione dell'aborto
nel 1936 in Spagna, tra i primi paesi in Europa.
Mujeres Libres organizzò formazioni completamente
gratuite per accedere ad un lavoro e inserirsi nella società;
in questo modo permettevano alle donne di essere indipendenti
economicamente oltre che di supplire ai ruoli lasciati liberi
dagli uomini al fronte. Le insegnanti erano quelle donne di
una generazione precedente che avevano potuto studiare e che
permisero a tutte le altre di imparare non solo contenuti ma
anche un modo libertario di affrontare la vita: professioniste
che misero a disposizione il loro sapere con trasporto ma con
grande umiltà.
Come spesso viene ricordato nel libro, le ragazze erano piene
di buona volontà, ma senza una base culturale non avrebbero
potuto arrivare lontano: i loro fratelli avevano studiato, uscivano
e frequentavano il sindacato mentre loro dovevano pulire ed
aiutare in casa.
Tra le attività organizzate da Mujeres Libres,
oltre a quelle culturali e di propaganda, troviamo i Liberatorios
de prostitución (offrivano una formazione alle prostitute
per poter svolgere un altro lavoro) ed il sostegno morale ai
soldati organizzando servizi di spedizione, lavanderia, ma anche
visite al fronte. In questo frangente non mancano gli equivoci
e chi mette loro le mani addosso o le critica per la futilità
del loro contributo, ma queste donne sanno sempre rispondere
brillantemente: affermano che il loro contributo è portare
avanti la rivoluzione nella retroguardia, fronte fondamentale
come la difesa della prima linea.
Proprio per questo coinvolgimento totale fanno quasi fatica
a rendersi conto dell'avvicinarsi della sconfitta; la solidarietà
continua ad essere il motore che le muove anche nell'esodo verso
la frontiera e i primi durissimi anni di esilio che non diminuiscono
assolutamente il loro impegno. La maggioranza di loro non vuole
lasciare il sud della Francia, e rifiuta l'esilio in America
vedendolo come un allontanarsi da tutto quello per cui avevano
lottato, rifiutano di arrendersi.
Un'ultima nota importante è la testimonianza di una donna
che visse il golpe militare in Andalusia, dove ebbe subito successo,
e in pochi giorni vide fucilare vari membri della sua famiglia
e poi visse gli angoscianti anni della guerra civil cercando
il modo di sopravvivere portando il marchio di “rossa”.
Mancava questo punto di vista, e quello che vissero queste donne
arriva dritto al fondo del cuore, come il frammento di una poesia
di una delle intervistate, che rende l'idea del sentimento che
provavano tanti anni dopo: “...Io sono/ la brace spenta
di un grande sogno./ Io sono/ una foglia staccata di uno splendido
albero./...”
Valeria Giacomoni
Louise Michel/
Una donna anarchica tra esilio e Comune
La vita di Louise Michel, le vicende tragiche ed esaltanti
della Comune di Parigi del 1871, si confondono nella memoria
di persone e popoli, tesi ancor oggi verso libertà ed
emancipazione umana, oltre e contro ogni confine. Per molti
Louise è anima della Comune, per taluni ne è addirittura
“ispiratrice”. Nella storia italiana l'esperienza
comunarda determina la diffusione dell'“Associazione Internazionale
dei lavoratori”, di quasi tutti i movimenti a orientamento
socialista, compreso quello anarchico. Immenso è il debito
verso il popolo di Parigi insorto, e verso Louise Michel, “quasi
sconosciuta in Italia, se non nella cultura anarchica”.
 Sconcertante
è il vuoto in tal senso nella pubblicistica in lingua
italiana, salvo, ci sembra, due pubblicazioni ormai datate,
tratte dal suo scritto “La Commune”. Anche in campo
anarchico la produzione è scarsa, eccezion fatta per
una delle due opere citate, di alcune biografie tradotte dal
francese, e del volume “Louise Michel”, del gruppo
anarchico napoletano a lei intitolato. Sconcertante
è il vuoto in tal senso nella pubblicistica in lingua
italiana, salvo, ci sembra, due pubblicazioni ormai datate,
tratte dal suo scritto “La Commune”. Anche in campo
anarchico la produzione è scarsa, eccezion fatta per
una delle due opere citate, di alcune biografie tradotte dal
francese, e del volume “Louise Michel”, del gruppo
anarchico napoletano a lei intitolato.
L'opera antologica tratta dagli scritti di Louise Michel con
il curioso titolo è che il potere è maledetto
e per questo io sono anarchica (Anna Maria Farabbi, edizioni
Il Ponte, Firenze 2017, pp. 174), curata dalla studiosa e scrittrice
Anna Maria Farabbi, offre conoscenze e sostanziosi spunti a
studiosi e appassionati di storie “controcorrente”,
ed è valido stimolo per nuovi approfondimenti. L'opera
che qui presentiamo concorre in modo importante a colmare lo
sconcertante vuoto.
La curatrice, anche traduttrice, introduce il lavoro spiegandone
caratteristiche e motivazioni, disegnando nei tratti essenziali
la vita e la formazione dell'anarchica. Dall'opera emerge complessa
e completa la personalità della rivoluzionaria; anche
grazie alla mirata scelta dei brani e alla traduzione rispettosa
ed efficace.
Gli scritti, sono tratti dalla corrispondenza (notevole e intensa
quella con Victor Hugo); da documenti di tribunale; dai Memoires;
da La Commune, da Prise de possession; e da altri
scritti. Louise si adopera costantemente per sofferenti ed esclusi,
privandosi sovente del minimo indispensabile. Con la mente e
con il cuore produce azioni concrete, incitando alla rivolta.
“Femminista ante litteram” si batte insieme alle
donne, doppiamente oppresse, per la loro piena affermazione
come persone libere sfidando pregiudizi anche fra i compagni.
Non a caso lotta con le prostitute osteggiate nella loro volontà
di offrire il loro contributo alla lotta per la Comune. Sostiene
i Canachi in Nuova Caledonia, ritenuti selvaggi e antropofagi,
per lei ormai fratelli, nella lotta di liberazione dal dominio
coloniale.
Al ritorno dalla deportazione scende in strada con lavoratori
e disoccupati, affrontando repressione e galera; si reca in
Algeria contro il dominio coloniale. Il “potere maledetto”
e i suoi rappresentanti, sono per lei i maggiori responsabili
delle sofferenze, non solo umane. Si batte con il popolo contro
la violenza statale, sfidando spesso di persona alti esponenti
dell'autorità, dimostrando, come nel tentativo di eliminare
Thiers, di saper perfino uccidere con freddezza per la giusta
causa. Combatte sulle barricate; è fra le “petroleuse”
nel tentativo di fermare le armate di Versailles. Denominata
“vergine rossa, santa laica, la lupa assetata di sangue,
la buona Louise, la grande regina della luce”, è
mossa sempre da compassione, anche quando incita alla ribellione
e alla “presa di possesso” di ciò che è
necessario a dare dignità alla vita.
La rivoluzione per Louise non è solo quella esplosiva,
che tutto travolge; essa si realizza e si prepara giorno dopo
giorno con paziente intelligenza; come nell'attività
di “educatrice libertaria” attenta alle “inclinazioni”
personali e considerando bambine e bambini (insieme, non separati
come nella scuola statale di allora) soggetti attivi al centro
dell'azione educativa. Pone fiducia nella scienza umanizzata,
volta ad alleviare sofferenze, a favorire pari e massime opportunità
a tutti, anche ai cosiddetti malati di mente o ai “criminali”,
formulando lei stessa proposte. Si rivela donna di scienza,
studiosa delle culture indigene e delle forme di vita nella
terra dei Canachi.
È atea. La natura non è realtà esterna
o separata: donne, uomini, ogni particolare ne sono parte integrante.
È contro tutte le guerre. Si schiera in difesa degli
animali anch'essi vittime dell'oppressione. Scopre di essere
anarchica grazie a Nathalie Lemel, discorrendo con lei durante
la navigazione da deportata verso la Nuova Caledonia.
Louise è non solo persona forte nella sua azione, è
anche donna dai sentimenti teneri e profondi verso tutti, eccezion
fatta per gli oppressori. Difende perfino l'uomo che con gesto
folle tenta di ucciderla. Rivolge nelle lettere parole affettuose
ai nonni, ai compagni e alle compagne di lotta, a Victor Hugo,
a Tehophile Ferré e soprattutto alla madre, che torna
sempre nei suoi pensieri anche in momenti estremi.
La rivoluzione anarchica voluta da Louise Michel comprende ogni
aspetto della vita e dell'essere, senza esclusioni.
Il libro offre al lettore pagine interessanti e “istruttive”;
sempre appassionanti e di sorprendente attualità.
Antonio Pedone
Atti di un convegno/
Il prisma dell'anarchismo
 Il
libro L'anarchismo italiano. Storia e storiografia (a
cura di Giampietro Berti e Carlo De Maria, Biblion Edizioni,
Milano 2016, pg. 595, € 35,00) consiste nella messa a punto
storiografica e bibliografica dell'anarchismo italiano degli
ultimi 50 anni. Il libro, che è cronologicamente e metodologicamente
successivo al Seminario pubblico (2013) “La storiografia
dell'anarchismo italiano dal 1945 ad oggi” ed al correlato
Convegno nazionale (2014), ne estende i temi dibattuti in quegli
eventi. Le iniziative, che sono state promosse dall'Archivio
Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia, con il concerto di studiosi che in questi anni
si sono dedicati alla storia dell'anarchismo, hanno costituito
un importante terreno di confronto tra le diverse letture ed
interpretazioni, che in sede storiografica vengono date alla
sua presenza nella società e nel contesto politico. Il
libro L'anarchismo italiano. Storia e storiografia (a
cura di Giampietro Berti e Carlo De Maria, Biblion Edizioni,
Milano 2016, pg. 595, € 35,00) consiste nella messa a punto
storiografica e bibliografica dell'anarchismo italiano degli
ultimi 50 anni. Il libro, che è cronologicamente e metodologicamente
successivo al Seminario pubblico (2013) “La storiografia
dell'anarchismo italiano dal 1945 ad oggi” ed al correlato
Convegno nazionale (2014), ne estende i temi dibattuti in quegli
eventi. Le iniziative, che sono state promosse dall'Archivio
Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia, con il concerto di studiosi che in questi anni
si sono dedicati alla storia dell'anarchismo, hanno costituito
un importante terreno di confronto tra le diverse letture ed
interpretazioni, che in sede storiografica vengono date alla
sua presenza nella società e nel contesto politico.
Sarebbe riduttivo considerare il libro come una macrorecensione
di quasi la totalità di ciò che è stato
pubblicato sull'anarchismo italiano dal 1945 in avanti. I diversi
autori che si sono incaricati di illustrare le sezioni tematiche,
non si sono limitati a redarre delle schede bibliografiche sugli
argomenti di loro competenza, ma hanno approfondito i temi e
le vicende che hanno attraversto le assai numerose pubblicazioni
recuperate dall'oblio delle biblioteche e dagli archivi e dalla
rete editoriale attuale, inquadrandole nelle gradi ripartizioni
che compongono il libro.
Esse sono così articolate: le interpretazioni, le biografie
e le generazioni, gli insediamenti territoriali e l'internazionalizzazione,
l'esilio e le comunità italiane all'estero, l'ecologia
e il neo-anarchismo, l'arte e la letteratura, gli strumenti,
i repertori e le fonti.
Le interpretazioni confrontano tra di loro le storie generali
dell'anarchismo e mettono in evidenza come ciascun autore, che
si è cimentato nel tentativo di racchiudere in una interpretazione
generale fatti e vicende di un movimento complesso e variegato,
sebbene abbia fatto opera pregevole scolpendo i principi che
lo caratterizzano, non sia riuscito a dire una parola definitiva
e conclusiva su una teoria sociale e politica in perenne rinnovamento.
Poiché gli anarchici sono donne ed uomini in carne ed
ossa, il cui destino oltre ad essere determinato dall'idea è
condizionato dal tempo storico nel quale hanno la ventura di
vivere, le biografie sviluppano il tema del vissuto, al fine
di meglio comprendere sia le militanti e i militanti presi in
esame sia il tempo storico con il quale questi si sono confrontati.
In tale parte i biografati sono scansionati secondo le fasi
storico-politiche che il Paese ha attraversato nel secondo Ottocento
ed in età moderna. Da quando la I Internazionale venne
fondata ed, ancora prima, da quando una parte del Risorgimento,
con Carlo Pisacane ed altri seguaci di Mazzini e di Garibaldi,
che sarebbero diventati internazionalisti, pose a base delle
sue tesi l'esigenza della giustizia sociale, fino all'anarchismo
ecologico ed al neoanarchismo.
Se ho trovato alcune biografie intense, altre le ho trovate
meno vicine alle figure studiate, ma nel complesso tutte sono
sostenute da notevole ricerca storica e molte indicano linee
di ulteriore ricerca per la realizzazione storiografica di un
quadro più completo del mondo anarchico. Affinchè
a stagliarsi sul palcoscenico della storia non siano soltanto
le figure di prima grandezza, ma anche compagni di più
modesta levatura, ma di sentire uguale alle predette figure,
come indicato dallo spirito del Dizionario Biografico degli
anarchici italiani. Se le biografie non possono sostituire la
lettura diretta di quanto hanno scritto i biografati, per quanti
vogliono approfondire il loro pensiero, esse sono molto utili
per avere una traccia di lettura, grazie alla quale districarsi
in un panorama editoriale più attento alla vendita che
non alla ricostruzione del pensiero anarchico dei biografati.
Gli insediamenti territoriali e l'internazionalizzazione entrano
nel merito del movimento anarchico come soggetto politico, con
gli altti e bassi che ne hanno caratterizzato le vicende. A
partire dalla predicazione del Bakuninismo in Spagna di Fanelli,
dal cui incontro con Anselmo Lorenzo e con gli altri militanti
sarebbero state poste le basi per la nascita successiva della
CNT, passando attraverso il complicato rapporto con il Giolittismo
e la svolta libertaria promossa soprattutto da Luigi Fabbri
e Pietro Gori, attraversando il fascismo e la Resistenza, per
giungere alle problematiche nuove che la nascita della Repubblica
pose al movimento organizzato.
Se finora gli studi sull'esilio sono stati soprattutto effettuati
sulla diaspora degli anarchici in Francia, durante il periodo
fascista, nella parte dedicata all'esilio ed alle comunità
italiane all'estero, si apprezza un radicale spostamento assiologico
degli studi sull'esilio degli anarchici ed anche del significato
che viene dato all'esilio. Sono descritte le ricerche che nel
mondo anglossasone sono state effettuate e che sono in corso
sugli anarchici emigrati in Inghilterra e negli Stati Uniti,
ossia sul loro ruolo nell Paese di accoglienza, nella formazione
della coscienza di classe e nello sviluppo della cultura dei
lavoratori. All'esilio, pur personalmente doloroso, viene conferito
il significato positivo che gli deriva dalla crescita culturale
e relazionale che produce nel Paese di accoglienza. Spesso Pietro
Gori viene ricordato nell'ambito della sua opera, all'interno
di una rete di solidarietà dell'emigrazione diffusa in
Europa ed in America del Nord e del Sud, che gli storici dedicati
a queste specifiche ricerche stanno tentando di far riemergere
dal passato.
Con la storiografia sulla presenza dell'anarchismo in Brasile
viene confermato che sempre di più la storia degli anarchici
viene scritta da studiosi non necessariamente anarchici.
La parte relativa all'ecologia ed al neo-anarchismo fanno rientrare
il lettore in periodi più vicini all'attualità
quotidiana. È una parte breve che è stata trattata
nell'editoria di movimento ampiamente, ma che nel libro non
è sfortunamente sviluppata.
I molteplici rapporti tra arte, letteratura, attività
politica ed anarchismo sono descritti nella penultima parte
del libro con viva sensibilità. Attraverso una completa
rassegna bibliografica emerge dal passato l'attenzione che il
movimento ha dedicato all'arte.
Attenzione verosimilmente misconosciuta sul piano cosciente
di come si rappresentano gli anarchici a se stessi, come viene
dimostrato da questo libro, prevalentemente impostato sulla
storia e la storiografia politica. Dalla lettura delle diverse
esperienze narrate dagli autori, scaturisce un anarchismo meno
appesantito dalle inevitabili problematiche relazionali proprie
del movimento a confronto con le forze sindacali e politiche.
Questa declinazione dell'anarchismo, che spazia dalla presenza
degli anarchici nel futurismo e negli altri ismi che hanno segnato
la scena artistica del secolo scorso, all'urbanistica ed all'architettura
autogestibile, racconta anche “quindici anni di agitazione
cuturale” attraverso la Rivista ApARTE.
Strumenti, Repertori e Fonti, a chiusura del libro, svolge una
rassegna critica delle monografie che sono state pubblicate
dall'immediato secondo dopoguerra. In questa parte è
sottolineata l'importanza del libro scritto da Pier Carlo Masini
nel 1969 “Storia degi anarchici italiani da Bakunin
a Malatesta”, degli Atti del Convegno promosso dalla
Fondazione Einaudi, sempre nel 1969, “Anarchici ed
anarchia nel mondo contemporaneo”, al quale partecipò
il compianto Gino Cerrito con analisi accurate. Viene anche
affermato che i libri dei primi storici dell'anarchismo, anarchici
militanti degli anni 70 ed il rinnovamento della storiografia
marxista, (fra cui Della Peruta e altri) hanno contribuito a
ridare dignità e spessore storico al movimento anarchico
nella storia d'Italia.
Come si conservano e si valorizzano le fonti per la storia dell'anarchismo
e come la Biblioteca di Nanterre sia stata e sia tuttora fondamentale
per le ricerche della storia dell'anarchismo e dell'esilio degi
anarchici in Francia durante il fascismo, sono gli ulteriori
interventi della parte conclusiva del libro. All'interno di
una riflessione sullo sviluppo davvero notevole che si è
avuto recentemente in campo accademico nella storia dell'anarchismo,
viene formulata la domanda se questo sviluppo sia dovuto alla
scarsa incidenza dell'anarchismo sul piano sociale.
Non vi è dubbio che i libri come il presente, non siano
una lettura di immediata utilità per vivere, dalla prospettiva
ideale che ci è propria, la vita quotidiana; ma li ritengo
essere fondamentali per contribuire alla formazione della coscienza
di sé.
Enrico Calandri
Sì, viaggiare/
C'era una volta l'Eden
Oggi è giornalista e inviato speciale in molte parti
del mondo, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso
Emanuele Giordana era tra quei tanti giovani che sognarono e
misero in atto il “grande viaggio”, quello verso
Oriente, che durava mesi, da cui si tornava smagriti, diversi,
a volte anche profondamente cambiati. La meta era lontana: India,
Nepal, Afghanistan. Era molto lontana perchè si viaggiava
senza aereo, senza carte di credito, i cellulari non esistevano
e nemmeno i bed and breakfast, c'erano uffici del telegrafo
scassati, fermo posta, ostelli, pochi traveller's cheque
in tasca e in agguato malattie gastrointestinali. Qualcuno partiva
con utilitarie poco utili su quei lunghi percorsi, i più
fortunati avevano il pulmino Volkswagen, per tutti c'erano autobus,
treni, autostop e il tempo del viaggio faceva assumere al tempo
un altro ritmo.
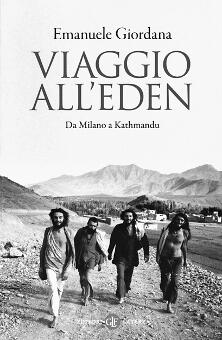 Sembrava
una specie di migrazione giovanile, ma non era in cerca di fortuna.
Per alcuni era un viaggio interiore, individuale e collettivo,
alla ricerca di spiritualità, allargamento della coscienza
e della conoscenza, a cui hashish e altre sostanze contribuivano
non poco. Per quasi tutti era reazione alla famiglia, alla vita
materialistica, competitiva e violenta che si conduceva in Occidente. Sembrava
una specie di migrazione giovanile, ma non era in cerca di fortuna.
Per alcuni era un viaggio interiore, individuale e collettivo,
alla ricerca di spiritualità, allargamento della coscienza
e della conoscenza, a cui hashish e altre sostanze contribuivano
non poco. Per quasi tutti era reazione alla famiglia, alla vita
materialistica, competitiva e violenta che si conduceva in Occidente.
Cosa ci muovesse, allora, alla volta dell'Eden, non saprei
dire: una specie di febbre il cui batterio originario –
covato sottopelle dall'epopea dei grandi viaggiatori –
veniva forse da lontano o era magari appena nato, si sarebbe
detto allora, con i pidocchi che allignavano nelle nostre folte
capigliature. Quella febbre era il sintomo di una malattia che
attraversava tutta l'Europa e l'intero mondo occidentale che,
dagli anni Sessanta in avanti, aveva incominciato a fremere,
scalpitare, ribellarsi. E se ci sembrava giusto ribellarsi (...)
ci sembrava anche giusto liberarci di tutti quegli orpelli (li
chiamavamo allora marxianamente 'sovrastrutture') che potevano
frenare il nostro desiderio rivoluzionario di cambiare il mondo:
famiglia, matrimonio, fabbrica e sacrestia.
Giordana ritrova un diario di quel viaggio fatto da ragazzo,
un quadernino pieno di appunti meticolosi, e parte da lì,
dalla memoria che tutte quelle note evocano; ricorda, racconta,
riflette col senno di poi e dei molti altri viaggi fatti in
seguito negli stessi luoghi. C'è il passato col suo grande
sogno e le sue tragedie, l'attualità coi sogni infranti
e nuove necessità, c'è il tempo, trascorso nel
mezzo, che ha operato trasformazioni e cambiamenti, nei luoghi
e nelle persone.
Sto parlando di Viaggio all'eden – Da Milano a Kathmandu
(Laterza, Bari 2017, pp. 138, € 16,00). Se chi lo leggerà
a quell'epoca viveva a Milano e aveva più o meno vent'anni
come me, anche se quel viaggio non l'ha mai fatto - a partire
poi erano soprattutto i maschi, perchè la cultura di
allora rendeva tutto più difficile a noi femmine, compreso
viaggiare - ritroverà tra le pagine luoghi, atmosfere
e persone conosciute un tempo, in un'ondata di ricordi giovanili.
Per chi ha vent'anni oggi invece può essere interessante
conoscere quel modo di stare nel tempo e vivere i luoghi, quel
modo di intendere i viaggi e le relazioni; non dico per far
lo stesso, che nulla mai si ripete uguale, ma per pensarci,
per pensare al proprio stare nel mondo e scegliere come orientarsi.
Da Milano il viaggio verso l'Eden partiva dalla Stazione centrale
in direzione Trieste per poi attraversare la Jugoslavia, allora
unita e titina. Quindi Salonicco, dove – se a corto di
soldi – si poteva vendere sangue, e Istanbul, la porta
d'Oriente. Dopo c'erano l'Iran dello Scià, con il suo
oppio legalizzato, fino a Mashhad, Afghanistan, e poi Kabul
allora città libera, aperta, con dischi di jazz e cinema
internazionali. Fino a raggiungere l'India, New e Old Delhi,
Benares; per qualcuno la tappa era Goa, altri proseguivano fino
a Kathmandu, capitale del Nepal, con la “Freak Street”
delle fumerie d'oppio legali, all'ombra del favoloso palazzo
reale.
Immagini, ricordi e aneddoti fanno da sottofondo a una riflessione
che, partendo da lì e da allora, guarda all'oggi attraverso
i quarant'anni passati. Non c'è più niente di
uguale e il cambiamento spesso non è stato in meglio,
compreso i viaggiatori che oggi a Kathmandu ci arrivano in poche
ore con tariffe low-cost tutto compreso e a far cosa
non si sa.
Allora erano gli anni a seguito del '68, quelli della “politica”
ma anche di tante altre suggestioni: c'erano le rivolte americane,
i figli dei fiori e naturalmente anche le droghe i cui santoni
spiegavano come fossero una via per allargare la coscienza,
per guardarsi dentro, per liberare il mondo dalle catene non
solo della fabbrica, ma da quelle che ci imprigionavano nella
vita quotidiana. Perchè ognuno potesse risvegliarsi e
finalmente liberarsi dal proprio ego. E non si partiva solo
dall'Italia, sulla strada i ragazzi arrivavano da tutto l'Occidente,
inseguendo un mito probabilmente iniziato con la decolonizzazione
dell'India e i metodi nonviolenti con cui Gandhi ebbe ragione
dell'imperialismo inglese; la suggestione era quella delle filosofie
indiane e alludeva a un percorso di liberazione che richiedeva
di “mettersi in viaggio”.
Arriva un'epoca nella vita nella quale si tirano le fila del
tempo che abbiamo attraversato cercando di legarle al presente
in una maniera che restituisca il senso di una vita vissuta.
Emanuele Giordana dopo quel primo viaggio non ha più
smesso di partire e forse fu proprio quell'inizio a influenzare
così fortemente la sua esistenza. Diventato giornalista
esperto in questioni geopolitiche riguardanti quell'area del
mondo, dal 2016 è presidente di un'associazione per la
ricerca e il sostegno della società civile afgana.
Col suo libro oggi, a noi, restituisce la possibilità
di fare un altro viaggio, quello a ritroso, sospeso tra presente
e passato, consapevolezza e incoscienza, stupore e soprattutto
curiosità. Un viaggio che, mentre leggiamo, invita a
porsi più di una domanda su come sono andate e su come
vanno le cose, ma soprattutto su dove è andato a finire
quel desiderio giovanile di essere migliori e poter modificare
la realtà, quali sono le strade che ha preso.
Silvia Papi
Anarchici/
Tra Pietro Gori e Bob Dylan
Bisogna dialogare con le “Sentinelle perdute”,
con chi ha “il futuro al posto del viso”; bisogna
ricercare la contaminazione per “dilatare il proprio sguardo
sul passato”.  L'imperativo
categorico è: indagare l'uomo nella vita di tutti i giorni.
Nel pantheon dell'autore di questo denso volume c'è Tomas
Tranströmer, premio Nobel della letteratura e poeta del
silenzio. Ma ci sono anche Charles Baudelaire, Pietro Gori,
Robert Zimmerman (alias Bob Dylan) e Patti Smith. E tutti vanno
“a braccetto”. Questo nuovo libro di Maurizio Antonioli
(Un'ardua gioconda utopia. Il «prometeo liberato»,
simboli e miti degli anarchici tra '800 e '900, BFS Edizioni,
Pisa 2017, pp. 158+ ill., € 16,00), che raccoglie in massima
parte contributi pregressi rielaborati e qualcosa di inedito,
si distingue per una particolarità: tutti i saggi che
lo compongono hanno a che vedere con storie di singole persone
ma, ovviamente, non si tratta di biografie stricto sensu.
Nel caso però l'elemento biografico funge da strumento
per ricostruire l'immaginario collettivo. L'imperativo
categorico è: indagare l'uomo nella vita di tutti i giorni.
Nel pantheon dell'autore di questo denso volume c'è Tomas
Tranströmer, premio Nobel della letteratura e poeta del
silenzio. Ma ci sono anche Charles Baudelaire, Pietro Gori,
Robert Zimmerman (alias Bob Dylan) e Patti Smith. E tutti vanno
“a braccetto”. Questo nuovo libro di Maurizio Antonioli
(Un'ardua gioconda utopia. Il «prometeo liberato»,
simboli e miti degli anarchici tra '800 e '900, BFS Edizioni,
Pisa 2017, pp. 158+ ill., € 16,00), che raccoglie in massima
parte contributi pregressi rielaborati e qualcosa di inedito,
si distingue per una particolarità: tutti i saggi che
lo compongono hanno a che vedere con storie di singole persone
ma, ovviamente, non si tratta di biografie stricto sensu.
Nel caso però l'elemento biografico funge da strumento
per ricostruire l'immaginario collettivo.
Sul piano euristico e dell'approccio metodologico Antonioli
prosegue sul filo di un suo antico discorso che, nel tempo,
si è sempre più affinato e sistematicamente palesato
nelle sue opere. L'utopia, il “prometeo liberato”
ed altri miti e simboli connotano l'analisi delle vicende otto-novecentesche
dell'anarchismo e le restituiscono ad una narrazione intensa
e profonda. Sono queste fra l'altro categorie di acquisizione
abbastanza recente nella storiografia sull'età contemporanea,
che ci consentono visuali inaspettate attraverso un'indagine
interdisciplinare, che ci fanno non solo “zoomare”
sulle vite “minuscole” dei senza storia, ma che
ci fanno anche intravedere le mille reti di relazione che vi
sottendono. Insomma non si deve solo descrivere ma anche interpretare
(ma per interpretare occorre prima conoscere). Esegesi sull'universo
libertario così come si è palesato dai gorghi
della modernità, questo non è un “libro
sui libri”, ma la risultante di una lunga personale esperienza
di ricerca, fatta in prima persona e direttamente sulle fonti
(con una particolare attenzione per quelle “imperfette”).
Antonioli, con garbo ma non senza ironia e sarcasmo, si toglie
anche qualche sassolino dalle scarpe. Nella prefazione rivolge
critiche circostanziate a chi scrive di anarchismo “per
infernali e detestabili meccanismi universitari”, a chi
pubblica avulsi medaglioni biografici tipo Selezione del Reader's
Digest, a chi propone storie locali e ignora l'approccio translocale
e transnazionale, a chi si butta sul genere sintesi che sembra
vada tanto di moda.
”...vorrei tuttavia segnalare la caducità di lavori
di sintesi, che non assolvono né una funzione efficacemente
divulgativa, per la quale occorrono un editore importante, doti
di scrittura non comuni e la capacità intuitiva di cogliere
il momento, né utilizzano criteri interpretativi innovativi.
Qualcuno è riuscito a farlo in passato, ma era il 1969,
l'editore era Rizzoli e il nostro amico era una penna fine...”
(p. 13).
Sono otto i saggi che compongono l'insieme della pubblicazione
e c'è un unico fil rouge, che poi è scritto nel
titolo e nel sottotitolo del libro. Nel menu: “Un simbolo
grande e luminoso”. Gli anarchici italiani e l'agitazione
pro Ferrer 1906-1907; Umberto e Bresci. Mito regale e damnatio
del regicida; “Banditi senza tregua / andrem di terra
in terra”. Le vite degli altri: anarchici lombardi ed
emigrazioni tra Otto e Novecento; Alla ricerca dello pseudonimo
perduto; “Libertà dolce sorella”. La nascita
del mito di Pietro Gori; Il teatro sociale di Pietro Gori; Carlo
Della Giacoma e Pietro Gori; Il giudizio di Michels sugli anarchici.
Parlando di Sessantotto – tema che esula dalla specifica
trattazione di questo volume (ma che tuttavia vi si può
connettere attraverso anche il vissuto esperienziale dei lettori
meno giovani) – Jean Maitron, insigne storico francese,
affermava: “La pensée anarchiste traditionnelle
inspire la révolte des jeunes en ce qu'elle a d'essentiel,
son esprit plus que ses thèses...”.
Proprio sul peso e l'entità di questo esprit riferito
ai tempi lunghi della storia anarchica scrive Antonioli: “L'anarchismo
di lingua italiana è stato un movimento politico e sociale
che, con le sue personalità ed esperienze, ha profondamente
caratterizzato l'età classica della storia del movimento
operaio e socialista. Ma come è stato possibile il suo
radicamento in importanti settori del proletariato italiano?
Si può rileggerne la storia non tanto attraverso l'adesione
a un preciso programma politico, ma individuando una molteplicità
di personaggi, simboli e vettori che hanno caratterizzato la
sua immagine collettiva? È possibile dare un'interpretazione
della fortuna e del declino del movimento libertario a partire
dall'analisi di alcuni personaggi ed eventi che hanno sicuramente
alimentato l'immaginario sociale libertario, favorendo quel
processo collettivo di rielaborazione del proprio pensiero e
della propria storia che ha portato all'interpretazione della
realtà in termini mitologici?...” (quarta di copertina)
Ebbene l'autore, interrogando i due secoli dell'anarchismo con
il medesimo piglio e sulla medesima questione posta da Maitron,
ha dato un risposta plausibile in questo libro.
Giorgio Sacchetti
A come Africa/
E come anarchia
Questo testo (Sam Mbah e I.E. Igariwey, Anarchismo in Africa.
Storia, movimenti e prospettive, edizioni Immanenza, Napoli
2017, pp. 240, € 25,00) è interessante sia per la
proposta originale, il testo di Mbah e Igariwey del 1997, sia
per le riflessioni su questo incluse nell'edizione italiana
(la nota dell'editore della prima edizione inglese, la prefazione
all'edizione spagnola, un'intervista di Mbah e la postfazione
di Casciano), offrendo spunti di riflessione polifonici che
aggiungono complessità al testo originario.
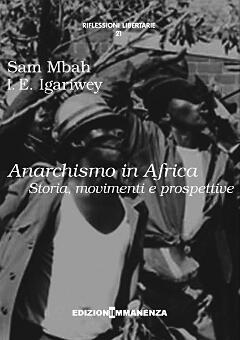 Il
principale merito dell'opera, a mio avviso, è di farci
riflettere sulla genealogia culturalmente specifica delle riflessioni
anarchiche e di farle dialogare con forme di organizzazione
che partono da storie e concezioni distanti da quelle sviluppate
nel Nord-Atlantico e da lì diffuse su scala globale. Il
principale merito dell'opera, a mio avviso, è di farci
riflettere sulla genealogia culturalmente specifica delle riflessioni
anarchiche e di farle dialogare con forme di organizzazione
che partono da storie e concezioni distanti da quelle sviluppate
nel Nord-Atlantico e da lì diffuse su scala globale.
Il testo inizia con un riassunto della storia e delle proposte
anarchiche, non discostandosi troppo dalle ricostruzioni, dalle
citazioni e dagli autori noti alla tradizione europea. La parte
più interessante è l'applicazione degli ideali
anarchici alla realtà africana con un'analisi di lungo
periodo su quello che gli autori chiamano il “comunalismo”
precoloniale africano; l'instaurazione del colonialismo e del
capitalismo; una discussione della proposta dei governi socialisti
africani, con una evidente simpatia per la proposta teorica
di alcuni di questi, sebbene gli autori ne ammettano il fallimento
pratico; le lotte sindacali, soprattutto quelle degli anni Ottanta
e Novanta in cui gli autori individuano strumenti e obiettivi
anarchici, intesi principalmente nella richiesta di sovranità
e autonomia delle comunità.
Gli autori sostengono che le potenzialità di un radicamento
dell'anarchismo in Africa, da scovare in un “comunalismo”
effettivamente praticato e non spazzato via completamente dallo
Stato e dal Capitale, apparentemente non germogliano ma, a loro
avviso, rimangono latenti nella forma di valori culturali diffusi
che potrebbero riproporsi con forza per innescare un cammino
emancipatorio in un contesto di etnicismi violenti, regimi militari,
corruzione, sfruttamento e devastazione ecologica.
La preziosa postfazione di Casciano ridimensiona l'applicabilità
delle proposte di Mbah. Da un lato il tentativo di proiettare
sull'intero continente un'etica anarchica, riproposta in termini
di “comunalismo” è problematica: gli autori
oscillano tra un'applicazione circoscritta del “comunalismo”
ad alcune società acefale ad una sua erronea estensione
indiscriminata, fino a farlo diventare tratto specifico di una
cultura continentale. Dall'altro, la tesi degli autori per cui
“le società comunaliste [africane] erano e sono,
per loro stessa natura, in larga misura autogestite, egualitarie
e repubblicane” (p. 65) è difficilmente sostenibile;
se è vero che erano in buona parte comunità autonome
in termini economici e, in alcuni casi politici, l'autonomia
ha spesso lasciato ampio spazio alla gerarchia (di genere, età,
schiavista) anche nelle società “tradizionali”.
L'Africa, quella sotto il Sahara e a nord del Sud-Africa, è
probabilmente il continente che ha avuto nella storia recente
minori riferimenti espliciti alla genealogia anarchica. Ovvero
sono rare, se non rarissime le forme di attivismo, produzione
intellettuale, strutture organizzative che si rifanno esplicitamente
all'anarchia.
Eppure l'Africa è stato anche un continente che, grazie
ad una estensione tardiva o incompleta dello Stato moderno,
rispetto ad altre regioni, ha mantenuto vive fino ad un passato
non troppo distante pratiche parziali di autogestione comunitaria
in quelli che Graeber definisce “spazi interstiziali”.
Il libro di Mbah e i commenti che lo accompagnano sono un prezioso
inizio per riflettere sulla forza delle pratiche culturali “comunaliste”,
in che contesti si siano diffuse e perché abbiano mantenuto,
in quasi tutti i casi, con l'eccezione delle società
di caccia e raccolta, una combinazione tra autonomia e dipendenza,
tra partecipazione ed esclusione, tra egualitarismo e gerarchia.
Questa dialettica africana può nutrire riflessioni feconde
in grado, tra l'altro, di promuovere la coscienza che l'anarchismo
della genealogia nord-Atlantica è un anarchismo e non
l'Anarchismo e che il dialogo con altre traiettorie politico-culturali
offre sempre ottimi spunti per ripensarsi.
Vedere nella diversità di pratiche e nozioni semplicemente
traiettorie sbagliate, impure, immature e da ripudiare, ci condanna
a accontentarci delle nostre fragili certezze.
Stefano Boni
Agricoltura e alimentazione/
Il pianeta delle aziende-locusta
I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che
sta distruggendo il pianeta, di Stefano Liberti (Minimum
Fax, Milano 2016, pg. 327, € 19,00), è un'inchiesta
globale che indaga e denuncia gli effetti sociali, ambientali
e culturali dell'industrializzazione dell'agricoltura e della
mercificazione del cibo. Seguendo la filiera di quattro delle
principali “materie prime” alimentari (la carne
di maiale, la soia, il tonno, il pomodoro) Liberti ci accompagna
a visitare gli allevamenti e i mattatoi delle principali multinazionali
della carne; le sterminate piantagioni di soia OGM del Mato
Grosso brasiliano; i mega-pescherecci oceanici per la cattura
e la lavorazione del tonno; la Tomatoland cinese dove
- sotto il rigido controllo dell'esercito - viene prodotto un
terzo del concentrato di pomodoro mondiale; le fabbriche dismesse
e i mercati di strada del Ghana; la Puglia delle baraccopoli
e del caporalato.
 Come
il precedente reportage di Liberti, Land Grabbing.
Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimum
Fax, Milano 2011, pg. 248, € 13,00), di cui rappresenta
l'ideale continuazione, anche questo libro è rigoroso,
ben documentato e di facile lettura. L'autore si basa su informazioni
raccolte di prima mano e sulla conoscenza approfondita della
letteratura prodotta su questi temi da università e organizzazioni
non governative di tutto il mondo per mostrarci come “l'inedita
alleanza tra grandi gruppi alimentari e fondi finanziari ha
portato allo sviluppo di quelle che definisco aziende-locusta:
gruppi interessati a produrre su larga scala al minor costo
possibile, che stabiliscono con l'ambiente un rapporto puramente
estrattivo e sfruttano le risorse in modo intensivo, fino al
loro totale dissipamento. Esaurite le capacità di un
luogo, passano oltre, proprio come uno sciame di locuste”.
Tutto questo - ci spiega l'autore - non sarebbe possibile senza
la complicità dei governi locali e delle istituzioni
internazionali (Fondo monetario, Banca mondiale, Organizzazione
mondiale del commercio) che - attraverso i cosiddetti “trattati
di libero scambio” - hanno creato il contesto politico
e normativo in cui le aziende-locusta (Cargill, Monsanto, Shanghui...)
possono agire indisturbate e prosperare. Come
il precedente reportage di Liberti, Land Grabbing.
Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimum
Fax, Milano 2011, pg. 248, € 13,00), di cui rappresenta
l'ideale continuazione, anche questo libro è rigoroso,
ben documentato e di facile lettura. L'autore si basa su informazioni
raccolte di prima mano e sulla conoscenza approfondita della
letteratura prodotta su questi temi da università e organizzazioni
non governative di tutto il mondo per mostrarci come “l'inedita
alleanza tra grandi gruppi alimentari e fondi finanziari ha
portato allo sviluppo di quelle che definisco aziende-locusta:
gruppi interessati a produrre su larga scala al minor costo
possibile, che stabiliscono con l'ambiente un rapporto puramente
estrattivo e sfruttano le risorse in modo intensivo, fino al
loro totale dissipamento. Esaurite le capacità di un
luogo, passano oltre, proprio come uno sciame di locuste”.
Tutto questo - ci spiega l'autore - non sarebbe possibile senza
la complicità dei governi locali e delle istituzioni
internazionali (Fondo monetario, Banca mondiale, Organizzazione
mondiale del commercio) che - attraverso i cosiddetti “trattati
di libero scambio” - hanno creato il contesto politico
e normativo in cui le aziende-locusta (Cargill, Monsanto, Shanghui...)
possono agire indisturbate e prosperare.
Principali vittime di questo colossale processo di espropriazione
e devastazione sono le comunità locali: contadini e pescatori
costretti a lasciare la propria terra e il proprio tradizionale
sistema di vita per trasformarsi in braccianti o operai al servizio
dei “signori del cibo”, ad emigrare verso gli slums
delle megalopoli o a tentare la fortuna (e rischiare la vita)
nel lungo viaggio verso i paesi ricchi del Nord del pianeta.
Ma vittime sono anche i “consumatori poveri” di
tutto il mondo, indotti a nutrirsi di “cibo spazzatura”
sempre più standardizzato, prodotto industrialmente con
l'aggiunta di sostanze chimiche pericolose per la salute.
Questo di Liberti è dunque un eccellente libro-inchiesta,
che ha il merito di suscitare - senza retorica ma con la sola
forza dei fatti - l'indignazione del lettore.
Mi permetto però di segnalarne una lacuna nell'analisi
ed un limite politico. La lacuna è costituita dal fatto
che - curiosamente - Liberti trascura il ruolo che hanno nella
produzione e nel commercio globale del cibo le centrali d'acquisto
delle grandi catene di supermercati e di fast food (Walmart,
Carrefour, Tesco, McDonald's, Burger King...). Come ha raccontato
in modo brillante Christophe Brusset (Siete pazzi a mangiarlo!,
Piemme 2016, pg. 277, € 17,00) esse rappresentano infatti
per le aziende-locusta un alleato imprescindibile nella ossessiva
ricerca del profitto attraverso la compressione dei costi di
produzione a scapito della qualità.
Il limite è invece di carattere politico. Liberti liquida
a mio parere un po' troppo frettolosamente, definendola “una
specie di anacronismo romantico”, l'idea di “sovranità
alimentare basata sull' agricoltura contadina” elaborata
e praticata da La Via Campesina*.
Avrebbe invece dovuto considerare che, per quanto possa sembrare
strano, l'agricoltura contadina - famigliare, di comunità,
cooperativa, prioritariamente orientata alla produzione di cibo
per l'autoconsumo e la vendita diretta nei mercati locali -
nutre ancora oggi circa il 70% della popolazione mondiale, e
quindi non costituisce affatto un fenomeno marginale o residuale.
Come ha riconosciuto Silvia Pérez-Vitoria nel suo appassionato
Manifesto per un XXI secolo contadino (Jaca Book, Milano
2016, pg. 128, € 18,00) il paradigma della sovranità
alimentare ha inoltre rappresentato in questi ultimi venti anni
una “concreta utopia”, saldamente ancorata nel presente
e proiettata nel futuro, capace di aggregare e mobilitare in
tutto il mondo coloro che si oppongono al modello di agricoltura
industriale propugnato dalle multinazionali dell'agrobusiness.
Grazie anche alla forza di questa utopia La Via Campesina
è diventato il più radicato e rispettato movimento
trasnazionale di base, attivamente impegnato a contrastare -
sia sul piano locale che su quello globale - le aziende-locusta
e le loro politiche predatorie. Per questo le sue pratiche e
le sue lotte - che puntano a riportare il controllo della terra,
dell'acqua, delle sementi, dei saperi e dei beni comuni nelle
mani delle comunità locali - avrebbero meritato di essere
presentate in modo più approfondito e con maggiore simpatia.
Ivan Bettini
* La Via Campesina è una
rete internazionale che raggruppa circa 200 milioni di agricoltori,
contadini senza terra, donne rurali, pescatori e comunità
indigene appartenenti a 164 organizzazioni locali di 79 paesi
di Africa, America, Asia e Europa. La sovranità alimentare
è il diritto dei popoli a produrre con metodi ecologicamente
sostenibili (agroecologia) il cibo sano e culturalmente appropriato
di cui hanno bisogno, e quindi il diritto a determinare autonomamente
i propri sistemi agricoli e alimentari (www.viacampesina.org).
Situazionismo/
Il sogno “tecnologico” si è fatto incubo
Per la felicità dei cultori della nanogalassia situazionista,
mai sazi dei contributi di quel manipolo di tenaci miscelatori
che per un paio di decenni provarono a rivitalizzare la tradizione
delle avanguardie artistico-filosofico-rivoluzionarie europee,
questa traduzione rende disponibile alcuni brevi scritti di
Constant Nieuwenhuys che hanno per oggetto la sua creatura prediletta:
New Babylon (New Babylon. La città nomade,
Nautilus, Torino 2017, pp. 60, € 4,00).
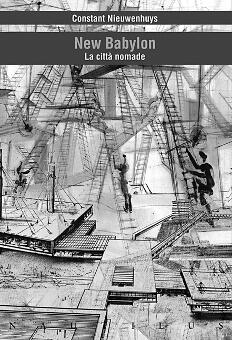 Nieuwenhuys
viene ricordato in particolare per essere stato tra i fondatori
del CoBrA, effimero ma influente gruppo di eclettici
pittori che nel 1948 si era proposto come Internazionale degli
Artisti sperimentali, più che per il suo transito nell'Internazionale
Situazionista di Guy Debord. I suoi interessi nel campo dell'urbanistica
vennero illuminati dalla lettura dell'Homo ludens del
connazionale Johan Huizinga, capace di dare nuova luce all'idea
di futura convivenza nelle libere metropoli che lo sviluppo
tecnologico renderà possibili, una nuova civiltà
basata sulla naturale propensione al gioco e all'imprevisto
propria della specie umana. Nieuwenhuys
viene ricordato in particolare per essere stato tra i fondatori
del CoBrA, effimero ma influente gruppo di eclettici
pittori che nel 1948 si era proposto come Internazionale degli
Artisti sperimentali, più che per il suo transito nell'Internazionale
Situazionista di Guy Debord. I suoi interessi nel campo dell'urbanistica
vennero illuminati dalla lettura dell'Homo ludens del
connazionale Johan Huizinga, capace di dare nuova luce all'idea
di futura convivenza nelle libere metropoli che lo sviluppo
tecnologico renderà possibili, una nuova civiltà
basata sulla naturale propensione al gioco e all'imprevisto
propria della specie umana.
Constant (come viene comunemente chiamato, aggirando l'ostico
cognome) forse ancor più degli altri situazionisti aveva
infatti una fiducia pressoché illimitata nelle potenzialità
che si sarebbero dispiegate con la fine della schiavitù
del lavoro dovuta all'automazione e nelle possibilità
di realizzare architetture instabilmente e meravigliosamente
ludiche. Per oltre un decennio si dedicò instancabilmente
a creare modellini che anticipassero la New Babylon del futuro,
sempre precisando che solo i neobabilonesi saranno i veri creatori
dell'abitare nella società ludica che sostituirà
la società utilitaristica, vale a dire quella basata
sullo sfruttamento della capacità dell'essere umano di
lavorare. È significativo come l'autore definisse utilitaristici
tanto il capitalismo moderno quanto lo Stato socialista (ai
tempi ben saldo con Russia e Cina in cabina di comando), mentre
la sua Nuova Babilonia per realizzarsi avrebbe avuto bisogno
di un mondo senza classi, dove il lavoro produttivo fosse completamente
automatizzato, i mezzi di produzione socializzati e capaci di
procurare a ognuno i beni adeguati. In conseguenza di ciò
la minoranza avrebbe cessato di esercitare il suo potere sulla
maggioranza così da attuare quello che Nieuwenhuys definisce
con parole cristalline “il regno marxista della libertà”.
Oggi queste parole fanno quasi tenerezza, ma in quegli anni
i poveri artisti comunisti, costretti a barcamenarsi tra folle
osannanti a Chrušcev, Brežnev o Mao Zedong, e al tempo
stesso consapevoli che ognuno di quegli avveduti leader avrebbe
mostrato loro “il regno marxista” da una prospettiva
schiettamente siberiana, qualcosa dovevano pur inventarsi. E
Constant si giocò le sue carte senza risparmio d'inventiva.
New Babylon non avrà frontiere e la sua umanità
fluttuerà tra i settori che costituiranno i gangli vitali,
le unità base di una rete modulare, sospesi su pilastri
alti venti metri, con la rete stradale al livello del suolo.
I settori saranno grandi strutture, da 100.000 metri quadrati
in su, incorporanti spazi orizzontali sovrapposti e collegati,
facilmente modificabili perché costituiti da materiali
leggeri, smontabili e riutilizzabili, prevedendo dunque standardizzazione
della produzione e normalizzazione dei moduli (vi assicuro che
non sto recensendo per sbaglio un catalogo dell'Ikea, sono tutte
espressioni dell'autore); la luce del sole sarà di trascurabile
importanza, tutto all'interno del settore verrà illuminato
artificialmente e climatizzato a seconda dei gusti. L'importante
sarà che i neobabilonesi possano cambiare sempre ogni
cosa in un atto creativo ludico e sociale al tempo stesso, visto
che nella dinamica delle interazioni ogni azione perde il suo
carattere individuale, come viene adeguatamente illustrato nella
concisa scrittura del nostro futurbanista.
La lettura di queste pagine è sorprendente in quanto
Nieuwenhuys nel suo sforzo immaginativo anticipa soluzioni che
si dispiegheranno negli anni successivi, solo che invece di
andare a costituire quell'auspicato labirinto dinamico di libertà
creativa, tutto “impermanenza” e trasformazione
giocosa, divengono un moltiplicatore di precaria alienazione.
Dell'utopia post-futurista di Constant resta una specie di ghigno
cariato, il sogno tecnologico sboccia in un concreto incubo
di metropoli modulari che si sfasciano ancor prima che si finisca
di costruirle, in una frenetica costruzione perpetua che di
ludens conserva veramente poco.
Giuseppe Aiello
Cibo/
Quando l'attore principale è la fame
Con una prefazione di Vittorio Sgorbi (gag che Trerè
porta anche nel suo cabaret), il poeta ed attore Andrea Trerè
ci offre questo agile volumetto (Cibi tempestosi. Da Dante
Alighieri ad Aldo Fabrizi, Edizioni Ics Fectori Art, Modigliana
- FC - 2016, pp. 35, € 5,00) che rivisita famosi brani
di prosa e di poesia italiana in chiave gastro-politica. “Mi
sedetti dalla parte del Porto perché tutti gli altri
liquori erano già stati scolati”, la parafrasi
brechtiana sottolinea l'avventura parodistica in un universo
umano in cui la fame è l'attrice principale.

Tante scene teatrali dettate da un allegro stomaco vuoto,
sfrontato e senza colpa, oppure affumicate in ambienti nei quali
l'avidità allupata agisce senza mai saziarsi, come nel
Quinto canto dell'Inferno dantesco. Dante è invece correttamente
citato a fine volume col suo “Poscia più che il
dolor, poté il digiuno” sul conte Ugolino, un finale
che sottolinea l'ingovernabilità della fame.
Abbiamo però, per celebrare la ricchezza del rapporto
col cibo come fondamentale risorsa umana, poesia pura come quella
leopardiana (“...e questa sfoglia, che da tanta parte
dell'ultimo vassoio, lo sguardo esclude...”), rilievi
animalisti (“Verrà l'arrosto, e avrà i tuoi
occhi”), e non manca il “gatto libero magnator”
nella parodia di Trilussa o il dialogo con una contessa trasformata
in cuoca, da Palazzeschi. Termina la maratona culinaria la parodia
di Fabrizi, con una visione di classe estremamente attuale nell'epoca
del cibo spazzatura e delle Chef parade, il poeta ci ricorda
che: “l'italiano, escluso il proletario, mangia tre volte
più del necessario”.
Il libretto, con copertina di Patrizia Diamante, può
essere richiesto ad Andrea Trerè, andreyesfor4@libero.it.
Francesca Palazzi Arduini
Meglio le donne?/
No, il problema è il potere
L'unico modo che abbiamo per verificare un'ipotesi storica
è quella di scrutare il passato e analizzare gli eventi.
Come sono andate le cose? Quale teoria si è rivelata
corretta?
 Per
quanto riguarda la verifica dell'idea – presente già
nella prima ondata di femminismo e mai completamente tramontata
– che le donne al potere possano dimostrarsi figure più
positive rispetto agli uomini, questo metodo non sembra tornarci
molto utile. Certo, negli ultimi due secoli, qualche donna in
posti di potere c'è anche stata (vi ricordate Margaret
Thatcher?), ma il campione statistico risulterebbe troppo limitato
per riuscire a verificare una tesi che riguarda la condotta
di metà della popolazione mondiale. Per
quanto riguarda la verifica dell'idea – presente già
nella prima ondata di femminismo e mai completamente tramontata
– che le donne al potere possano dimostrarsi figure più
positive rispetto agli uomini, questo metodo non sembra tornarci
molto utile. Certo, negli ultimi due secoli, qualche donna in
posti di potere c'è anche stata (vi ricordate Margaret
Thatcher?), ma il campione statistico risulterebbe troppo limitato
per riuscire a verificare una tesi che riguarda la condotta
di metà della popolazione mondiale.
Ma allora, se in questo caso guardare indietro non è
abbastanza, come proseguire? A venirci in aiuto è la
scrittrice Naomi Alderman, che nel suo ultimo libro (Ragazze
elettriche, Nottetempo, Milano 2017, pp. 446, € 20,00)
immagina un futuro in cui le donne – capaci di emanare
scariche di energia elettrica – sono in grado di imporsi
sugli uomini, dapprima fisicamente e poi socialmente. In mancanza
di fatti storici reali, questa distopia ci fornisce un modo
alternativo di testare la nostra ipotesi di partenza. Alderman
offre infatti la possibilità di vedere finalmente all'opera
quella presa di potere delle donne che ancora alcune frange
del femminismo mainstream identificano come obiettivo
principale delle loro lotte. Nel futuro da lei immaginato, la
piramide della gerarchia non vacilla e la struttura rimane invariata.
A cambiare è solo il genere di chi occupa il vertice.
Così, dove prima c'era un uomo, ora c'è una donna.
Dunque cosa ci mostra Alderman? È vero che il potere
declinato al femminile sia meglio di quello maschile? No. E
il motivo è il potere stesso. Le anarchiche e gli anarchici
lo affermano da più di un secolo e mezzo: il problema
sta nel dominio, non in chi lo esercita. Le anarco-femministe,
poi, hanno sempre condotto battaglie contro chi proponeva l'idea
che l'emancipazione femminile fosse una semplice scalata verso
la vetta della società.
La prefigurazione fatta da Alderman potrebbe aiutare a rendere
ancora più chiaro ciò che le femministe anarchiche
affermano da sempre. Le donne non dovrebbero combattere una
battaglia tra i sessi per contendersi le posizioni sociali più
privilegiate. Al contrario, uomini e donne farebbero meglio
ad unire le forze, concentrandosi sulle cause di diseguaglianza
e ingiustizia – fra tutti, la struttura gerarchica della
società – e abbatterle insieme.
Nonostante il messaggio di Alderman sembri chiaro fin dall'inizio,
nei giorni che sono seguiti alla pubblicazione ho letto e ascoltato
diverse interpretazioni. Addirittura, ad una presentazione del
libro cui ho assistito, alcune scrittrici e giornaliste si dicevano
“galvanizzate” (sic!) dalle azioni delle protagoniste.
La forza che dimostravano era la forza di tutte le donne, così
mirabile e ispiratrice in un momento storico come il nostro
fatto di violenza di genere e di abusi. Ma il libro racconta
della crudeltà di una dittatrice di un paese dell'est
Europa, succeduta al marito defunto; dell'assoluta mancanza
di etica e di moralità di una donna a capo di un'organizzazione
criminale, al comando dopo aver scalzato padre e fratelli; del
lavaggio del cervello messo in atto dalla fondatrice di una
nuova religione, incentrata su un dio donna, divenuta presto
fenomeno di massa internazionale. Forse la scelta del titolo
italiano (Ragazze elettriche) diverso dall'originale
(The power) ha contribuito a fare un po' perdere di vista
il cuore del discorso di Alderman: la critica al potere, non
importa se esercitato dalle donne o dagli uomini.
Carlotta Pedrazzini
Chiesa e nazismo/
Amore a prima vista
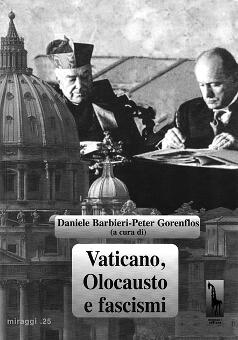 Vaticano
Olocausto e fascismi a cura di Daniele Barbieri e Peter
Gorenflos (Massari Editore, Bolsena – Vt - 2017, pp.208,
€ 20,00) è un proseguimento-ampliamento di un libro
storicamente importante Con Dio e con i fascisti di Karlheinz
Deschner (tradotto in italiano con decenni di ritardo) con materiali
di varia natura: in primo luogo dai contributi scritti per l'omonimo
convegno romano con l'analisi di aspetti psicologici, sociali
e culturali legati al nazifascismo (tre dei quali non riconducibili
all'Olocausto: religione come nevrosi, l'oppressione della donna
e la libertà di propaganda per l'ateismo). Compaiono
poi ricerche specifiche sulle aree geografiche in cui si è
verificata una collaborazione tra Chiesa e nazifascismo, come
il Paese Basco all'epoca di Franco, la Francia di Vichy e un
riferimento a storie più recenti di complicità
vaticana con regimi dittatoriali, come nell'Argentina di Videla
e dei Desaparecidos. Vaticano
Olocausto e fascismi a cura di Daniele Barbieri e Peter
Gorenflos (Massari Editore, Bolsena – Vt - 2017, pp.208,
€ 20,00) è un proseguimento-ampliamento di un libro
storicamente importante Con Dio e con i fascisti di Karlheinz
Deschner (tradotto in italiano con decenni di ritardo) con materiali
di varia natura: in primo luogo dai contributi scritti per l'omonimo
convegno romano con l'analisi di aspetti psicologici, sociali
e culturali legati al nazifascismo (tre dei quali non riconducibili
all'Olocausto: religione come nevrosi, l'oppressione della donna
e la libertà di propaganda per l'ateismo). Compaiono
poi ricerche specifiche sulle aree geografiche in cui si è
verificata una collaborazione tra Chiesa e nazifascismo, come
il Paese Basco all'epoca di Franco, la Francia di Vichy e un
riferimento a storie più recenti di complicità
vaticana con regimi dittatoriali, come nell'Argentina di Videla
e dei Desaparecidos.
Nel trattato Con Dio e con i fascisti, Deschner ricordava
che l'appoggio del papa al fascismo italiano fu già chiaro
nei giorni della marcia su Roma, quando il Vaticano esortò
le proprie gerarchie a non identificarsi con il Partito Cattolico
che all'epoca era avverso ai fascisti. Inoltre Deschner documentava
che anche il successore di Pio XII coprì la politica
collaborazionista di Papa Pacelli verso Hitler, Mussolini e
Francisco Franco.
Dunque sono molte ragioni per diffondere il vecchio testo di
Deschner ma anche per ampliare il discorso come fa Vaticano,
Olocausto e fascismi. Infatti grazie alla massiccia opera
di disinformazione compiuta dai media e da intellettuali compiacenti,
cresce il numero di persone convinte che la Chiesa cattolica
si sarebbe opposta se non al fascismo, almeno al nazismo, cercando
di salvare il maggior numero di ebrei. “È una leggenda
che però va prendendo piede quanto più ci si allontana
da quegli avvenimenti e vengono meno i testimoni diretti delle
responsabilità vaticane”, scrive Daniele Barbieri.
Il Vaticano sostenne Hitler ma dopo il 1945 – mentre in
silenzio favoriva la fuga di molti gerarchi nazisti –
iniziò a sostenere di essersi opposto al nazismo, riappropriandosi
della memoria di quei pochi religiosi che veramente si schierarono
contro Hitler, pagando anche con la vita, e che erano stati
abbandonati dalle gerarchie nazionali e vaticane.
Non è solo necessario ristabilire la verità storica,
ma anche il diritto della Chiesa e di ogni altra religione istituzionalizzata
di avere una sorta di immunità per negare la trasparenza
degli eventi. Ogni tanto il Vaticano sostiene che sta per aprire
tutti i suoi archivi contenenti materiali e documenti sulla
Seconda Guerra Mondiale, ma poi non lo fa. E anche la Chiesa
argentina annuncia che renderà accessibili gli archivi
riguardanti gli anni della dittatura militare, ma per ora non
lo ha fatto.
Intanto lo Ior è sempre complice nel finanziare le guerre
nel mondo. La pedofilia viene tuttora nascosta e difesa. Il
Vaticano continua a difendere e ampliare i suoi privilegi giuridici
e materiali.
Non si vedono fatti concreti che facciano pensare a un reale
pentimento della Chiesa per le complicità del passato
con il nazifascismo e con i tanti regimi dittatoriali. Come
rammenta Peter Gorenflos, l'altro curatore del libro, “Gli
industriali, i banchieri e i grandi proprietari terrieri avevano
paura di una guerra civile e di una presa del potere da parte
della classe operaia, secondo il modello sovietico. Per questa
ragione sostennero Hitler sia finanziariamente che con la stampa
e la propaganda, dal momento che Hitler aveva esplicitamente
dichiarato di essere pronto a eliminare i socialisti, i comunisti
e anche i liberali con l'uso della violenza”.
Laura Tussi
|

