|
le intervistone
Quante storie
intervista a Maurizio Antonioli di Franco Bertolucci
Da oltre mezzo secolo studioso del movimento operaio e socialista, soprattutto in Italia. Fine conoscitore in particolare della storia del sindacalismo rivoluzionario e di tante pagine e figure anarchiche – per esempio, di Pietro Gori. Maurizio Antonioli, a lungo docente all'Università Statale di Milano, ripercorre qui le tappe più significative del proprio impegno professionale, sempre in relazione con le vicende dell'anarchismo e una sensibilità libertaria. E ne parla con il direttore scientifico dell'Archivio Franco Serantini e delle edizioni BFS, nostro collaboratore.
Franco Bertolucci - Come nasce la tua passione per
la storia?
Maurizio Antonioli - Si tratta di una passione tardiva,
sviluppatasi all'Università, durante la preparazione
dell'esame di Storia moderna (non dimentichiamo che la
prima cattedra di Storia contemporanea venne istituita a Firenze
per Giovanni Spadolini soltanto nel 1961) e dopo aver patito
alcune disillusioni in Letteratura francese e in Storia
dell'arte (leggasi: rifiuto dei professori degli argomenti
da me proposti e rifiuto mio di lavorare su quelli proposti
da loro). L'interesse maturato via via per la storia si incontrò
poi con quello che coltivavo fin dagli anni del liceo per Max
Stirner, un interesse tutto intellettuale che poté essere
soddisfatto solo con il rinvenimento su una bancarella di una
vecchia copia de L'Unico (Torino, F.lli Bocca, 2. ed.,
1909), visto che non esistevano allora edizioni correnti. Riuscii
quindi a farmi accettare come tesista presso il nuovo insegnamento
di Storia contemporanea che, inizialmente, praticava
una politica della “porta aperta”, ma fu l'incontro
con Pier Carlo Masini, al Congresso internazionale anarchico
di Carrara (31 agosto-3 settembre 1968), a dare uno sbocco operativo
ai miei confusi progetti. Fu Masini a consigliarmi l'argomento
e a indicarmi una prima sommaria bibliografia. Al congresso
di Torino della Fondazione Einaudi (5-7 dicembre 1969, avevo
già consegnato l'elaborato in segreteria) presenziai
semplicemente come uditore in compagnia di Masini, che tenne
nella circostanza una comunicazione sull'appena costituita Biblioteca
Max Nettlau. Il lavoro di ricerca, durante il quale potei giovarmi
esclusivamente dell'aiuto di Pier Carlo (l'unico a Milano, Bergamo
e dintorni a conoscere l'argomento), mi appassionò a
tal punto che rischiai di non mettere mai la parola fine alla
tesi: mi si aprì insomma un mondo nuovo sul quale non
esisteva praticamente nulla e su cui persistevano tenaci stereotipi
storiografici per lo più sommari e liquidatori. Mi riferisco
in particolare alla storia dell'individualismo anarchico e del
sindacalismo rivoluzionario. Aspetti, momenti e figure che hanno
sempre accompagnato il mio percorso di studi e di ricerche.
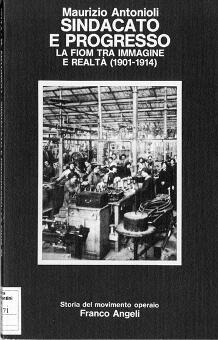
Quali sono state le tue letture giovanili che ti
hanno maggiormente formato?
Come ho accennato prima, a parte il caso di Max Stirner, precocemente
letto e certamente mal digerito a causa di un'ovvia mancanza
di preparazione, la mia formazione è stata sostanzialmente
letteraria, e in subordine artistica (nel senso della storia
dell'arte). Ho insegnato tutta la vita in una Facoltà
di Scienze politiche, ma mi sono sempre sentito abbastanza estraneo
all'iter formativo dei miei studenti. Personalmente non ho mai
studiato diritto, statistica, sociologia, ecc. E naturalmente
tutto questo ha influito sul mio approccio alla storia e, ritengo,
anche sul mio insegnamento. Non so se abbia senso parlare delle
mie letture giovanili, ma per stare al gioco e se la cosa non
annoia, partiamo dal poeta da me prediletto in assoluto, Charles
Baudelaire (da cui non mi separavo mai) e sostanzialmente da
tutta la letteratura francese dell'Ottocento, soprattutto Rimbaud
e Mallarmé da un lato, Stendhal, Flaubert e Proust dall'altro.
A Victor Hugo arrivai un po' più tardi, quando ne intuii
l'importanza per la cultura socialista, e così pure a
Zola e Balzac, a cui allora preferivo Maupassant. E poi, ovviamente,
Tolstoi e i russi, anche più recenti, come Pasternak
e Bulgakov; Thomas Man, Musil e Kafka, nonché Poe, Joyce
ed T. S. Eliot, senza però sottacere l'emozione suscitatami
da Orazio quando dovetti leggerlo tutto per l'esame di Letteratura
Latina e dall'Orlando furioso, preparato per l'esame
di italiano e diventato uno dei miei livres de chevet.
Ma non sarebbe giusto dimenticare ciò che non soltanto
si legge, ma si ascolta.
A parte la mia passione fin da ragazzino per la musica classica,
mi piace ricordare un binomio stravagante: Wagner e Bob Dylan
(come dimenticare: “and Ezra Pound and T. S. Eliot/fighting
in the captain's tower” di Desolation row). Naturalmente
i nomi in tutti i settori erano tantissimi, ma mi sono limitato
a quelli che in quella fase mi sollecitarono di più.
E soprattutto mi interessa chiarire che gli storici, salvo qualche
classico studiato all'Università, non facevano parte
delle mie frequentazioni intellettuali.
Quale è stato il tuo approccio allo studio
del movimento operaio e del mondo degli anarchici?
In parte per il tramite della mediazione stirneriana che certamente
affondava le sue radici nell'atmosfera del momento ma rispondeva
sostanzialmente ad una sollecitazione che aveva a che fare più
con la “mentalità” che non con la realtà
e ben poco con le masse e i movimenti. Infatti il mio primo
progetto di tesi era una sorta di storia dell'individualismo
anarchico. Naturalmente si trattava di una ipotesi velleitaria
e, allora, fuori della mia portata.
Fu merito di Masini suggerirmi la chiave giusta che, senza trascurare
i miei interessi iniziali, li inseriva in un contesto che era
quello del movimento operaio e sindacale alla vigilia della
grande guerra. E allora ho conosciuto, di persona, Leda Rafanelli
e attraverso i loro scritti (nonché i ricordi di Maria
Molaschi) Carlo Molaschi e Giuseppe Monanni, Oberdan Gigli e
Nella Giacomelli e così via. Ma anche Alceste De Ambris
e Filippo Corridoni e di conseguenza l'Unione sindacale Italiana
e la Camera del lavoro confederale di Milano, addentrandomi
nelle pieghe del movimento organizzato dell'età giolittiana.
Un documento tira l'altro: periodici, libri, opuscoli, carte
d'archivio. E non mi sono più fermato.
Gli anni della contestazione studentesca
Esistono nella tua esperienza delle personalità
che possono essere definite i tuoi maestri?
In senso molto eterodosso Masini, ma proprio perché non
voleva esserlo ed era il primo a capire di essere un outsider.
Il suo era in qualche modo un magistero spontaneo, che scaturiva
da una inarrestabile esigenza comunicativa e da una istintiva
generosità nella trasmissione delle proprie conoscenze.
In realtà subito dopo la laurea mi occupai d'altro. All'epoca
non avevo neppure ben chiaro che cosa fosse un professore universitario.
Ma ormai ero contagiato e mi ritrovai a studiare per conto mio
all'Istituto G. G. Feltrinelli, dove ero stato di casa per la
mia tesi. Erano i tempi di Giuseppe Del Bo direttore ed Elio
Sellino bibliotecario. Lì incontrai Alceo Riosa, allora
assistente ordinario a Roma e poi incaricato a Milano di Storia
del movimento sindacale, insegnamento che in seguito fu
di Stefano Merli e, dopo la sua morte, diventò mio. Fu
in realtà Riosa, con cui condividevo molti interessi
e a cui mi legarono una profonda amicizia e una lunga collaborazione,
ad aiutarmi nel 1974 nei miei esordi universitari, grazie anche
all'intervento di Camillo Brezzi, storico del movimento cattolico,
anch'egli di provenienza romana, che mi prese sotto la sua ala
nella Facoltà di Magistero di Arezzo. Ma, pur avendo
debiti di riconoscenza nei confronti di alcune persone, a partire
da quelle citate, non posso parlare di “maestri”
nel senso classico del termine. Un altro storico con cui, all'epoca,
ho avuto una intensa frequentazione e un proficuo scambio culturale,
è stato Idomeneo Barbadoro, che non era un accademico,
ma i cui lavori sulla Cgdl e sulla Federterra sono stati per
me importanti strumenti di riflessione e di stimolo.
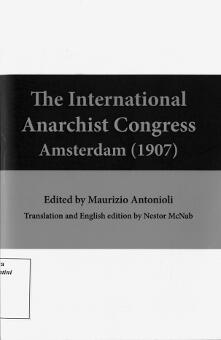
Cosa hanno significato per te gli anni della contestazione
studentesca 1968-69?
Naturalmente hanno significato molto, come credo per tutti.
Non ritengo tuttavia sia interessante parlarne. In certi periodi
ci fu la corsa ad “iscriversi all'albo” dei sessantottini
(come quelli che durante il regime fascista facevano a gara
nel procurarsi un attestato di partecipazione alla Marcia su
Roma), in altri a prenderne le distanze. Ricordo nel '94 una
gentile signora fare propaganda per Berlusconi vantando i suoi
trascorsi sessantotteschi, allora frutto di una sedicente verve
giovanile che aveva necessariamente ceduto il passo alle scelte
dell'età matura. A volte ho l'impressione che molti dei
miei coetanei – me compreso – fossero come Fabrizio
Del Dongo a Waterloo. C'erano ma non riuscirono a vedere nulla
che in qualche modo potesse servire da criterio interpretativo
dei ricordi. Il che è abbastanza normale. Di solito i
testimoni non riescono mai a ricostruire la storia.
Per quanto mi riguarda determinati ricordi fanno parte della
mia vita e non riesco a vederli come un oggetto di studio, come
invece stanno facendo alcuni colleghi. Non studio mai ciò
che ha a che vedere con il mio coté privato. Mi
interessano invece “le vite degli altri”, possibilmente
lontane nel tempo. Certamente gli anni Sessanta, a partire da
precisi eventi politici (crisi di Cuba, Vietnam, Cecoslovacchia)
alle battaglie per i diritti civili, ai fenomeni di costume
(dall'abbigliamento alle capigliature), alla musica, alla cultura
alta e bassa costituirono un condensato straordinario di elementi
di mobilisation spesso spontanea a tutti i livelli. Ma
non amo l'enfasi reducista di alcuni. Forse il '68 è
stato il novello “anno dei portenti” di carducciana
memoria, come lo definiva l'«Espresso» qualche anno
fa. A tale proposito lascio fare ad altri. Que reste-t-il
de ces beaux jours?, canterebbe Charles Trenet. Si vedrà.
Quegli anni di fermenti sono stati però poi
segnati dalla lunga stagione terroristica a partire da Piazza
Fontana e dalla morte di Pinelli. Come hai vissuto da “cittadino”
e da “storico” questi momenti così tragici
per il nostro Paese?
Come “storico” non li ho vissuti, per i motivi ai
quali ho accennato prima. Inoltre ero ancora agli inizi. Però
non è escluso che il dedicarmi a temi sindacali, da un
lato al sindacalismo d'azione diretta poi sfociato nell'Usi,
dall'altro alla nascita della Fiom, il più importante
sindacato industriale italiano prefascista, abbia avuto a che
fare, al di là delle contingenze, con una urgenza personale
di vedere in forme organizzative del movimento operaio reale,
e non in superfetazioni partitiche, i perni di un processo rivendicativo
collettivo, di ritrovare in quelle strutture il senso della
continuità storica, indipendentemente dai dissensi, dalle
frizioni, dalle rotture.
Il mio punto di riferimento era sostanzialmente il modello di
Pelloutier che, tuttavia, ho sempre cercato, e spero di esserci
riuscito, di non usare mai in modo strumentale nei miei lavori.
Non mi piace la storia a tesi precostituite. A differenza degli
anni Sessanta, tuttavia, verso i quali mi concedo qualche nostalgia,
non riesco a pensare al decennio seguente, a partire da piazza
Fontana, come ai “beaux jours”, se non per ragioni
del tutto private. “Lo schianto” della dinamite
può essere “redentore” solo “nel fosco
fin del secolo morente” nei versi di Luigi Molinari (non
a caso poi convertito all'educazionismo e diventato alfiere
della “scuola moderna”) ma non alla fine degli anni
Sessanta. E poi gli “spettri macàbri del momento
estremo” erano altri. Ma non è il mio terreno.
Per usare i versi di un'altra (ben più recente) canzone,
poteva andarmi bene “distruggere la gabbia”. Ma
non il “mitra lucidato”, la “morte della scuola”,
il “rifiuto del lavoro” e così via.
L'importanza dell'opera di Pier Carlo Masini
Una nuova generazione di storici si è formata
a cavallo degli anni Sessanta e Settanta puoi dirmi come si
è distinta rispetto a quella che l'ha preceduta e in
particolare a quella che aveva creato nei decenni Quaranta e
Sessanta un nuovo ciclo di studi storici legati alla storia
del movimento operaio? Una storiografia all'epoca caratterizzata
da un legame molto forte con l'azione dei partiti della sinistra
(comunista e socialista).
A metà degli anni Sessanta, i miei coetanei ed io ci
siano trovati davanti ad una via già tracciata dalla
generazione precedente, quella uscita dalla guerra: riviste,
bibliografie, saggi e volumi, istituzioni, tutto un insieme
di esperienze volte ad esplorare e a valorizzare quello che
veniva definito, con un termine che voleva essere riassuntivo
e globale, il “movimento operaio”, anche se l'espressione
– e lo si vide negli anni Cinquanta – non aveva
lo stesso significato per tutti. Vorrei, a questo punto, per
meglio illustrare la questione, fare riferimento ad un'opera
ormai classica della storiografia, con la quale un po' tutti
allora ci siamo misurati: Il movimento operaio attraverso
i suoi congressi di Gastone Manacorda (Roma, Rinascita,
1953), In questo lavoro, nel quale vengono ripercorse le tappe
istituzionali delle organizzazioni, il movimento operaio viene
visto, all'origine, come un coacervo di tendenze che, attraverso
un serrato confronto di posizioni lungo la seconda metà
dell'Ottocento, si viene, per così dire, depurando fino
a raggiungere, con la fondazione del Partito dei lavoratori
italiani (poi Partito socialista), il suo approdo finale. O
meglio il suo reale punto d'avvio, come se il movimento operaio,
identificato nel nuovo partito, si fosse strutturato attraverso
una sorta di selezione con l'abbandono delle scorie e la recisione
dei rami secchi.
Questa impostazione, accentuata in studi di altri autori non
sempre acuti come Manacorda, ha spesso indotto implicitamente
a considerare l'evoluzione del movimento operaio come il progressivo
passaggio dal meno al più, dall'indistinto al distinto,
in una lunga catena di cicli che, nell'accezione più
scolastica, venivano visti come una successione per gradi, in
una sorta di inarrestabile crescendo: dalle società di
mutuo soccorso alle leghe di resistenza, alle Camere del lavoro,
alla Cgdl, e così via, oppure dalla Prima Internazionale,
al partito di Costa, al Psi, ecc. Indubbiamente c'erano motivi
per farlo. Non ultimo il fatto che questo schema interpretativo
era stato accolto da intere generazioni di militanti che di
quelle vicende erano stati protagonisti.
Tuttavia, continuando per questa strada, non solo si perdevano
di vista i cosiddetti “rami secchi”, che spesso
erano ben più vitali di quanto non si fosse portati a
credere, ma interi “mondi” e “culture”
che non rientravano nel quadro prefissato. E non mi riferisco
soltanto all'universo libertario, certamente minoritario ma
non per questo meno vivo, ma a tutto il movimento operaio di
matrice cattolica, di cui non mi sono mai occupato ma la cui
esistenza non può essere sottaciuta, nonché il
mutualismo laico non socialista. Ed era soprattutto evidente
che il processo non si sarebbe fermato al 1892, cioè
ad un Partito socialista che, nel pluralismo delle tendenze,
avrebbe potuto costituire una sorta di casa comune, magari un
po' rissosa, ma era finalizzato a legittimare l'ultima creazione
politica, il Partito comunista, definitivo interprete del ruolo
politico del proletariato. Emblematica a questo proposito fu
la querelle attorno alla rivista «Movimento operaio»,
che Gianni Bosio aveva fondato nel 1949 e dalla quale venne
estromesso, ad opera di Giangiacomo Feltrinelli, nel 1953.
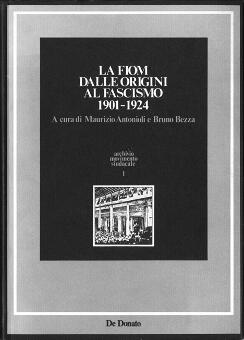 Ma,
sul finire degli anni Sessanta, la situazione era in qualche
modo cambiata: nuove curiosità, nuove sensibilità
ed un esprit nouveau si erano fatti largo. È indicativo
il fatto che il primo volume della Storia degli anarchici
italiani di Masini, uscito da Rizzoli nel 1969, abbia suscitato
un interesse mai riscontrato da tale argomento fino ad allora.
Certo, il merito di Masini fu quello di scrivere un'opera che
aveva un particolare appeal: ben scritta, ben strutturata,
ben documentata. Non la solita sintesi più o meno divulgativa.
Ma un editore come Rizzoli, che aveva il polso del mercato,
doveva essersi mosso per soddisfare precise esigenze dei potenziali
lettori. Ed anche il convegno torinese della Fondazione Einaudi,
Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo, tenutosi
pochi giorni prima dell'esplosione della bomba alla Banca dell'Agricoltura
in Piazza Fontana, dimostrava come lo stesso mondo degli studi
storici, dopo il maggio francese, avesse sentito il bisogno
di interrogarsi sul tema. Ma,
sul finire degli anni Sessanta, la situazione era in qualche
modo cambiata: nuove curiosità, nuove sensibilità
ed un esprit nouveau si erano fatti largo. È indicativo
il fatto che il primo volume della Storia degli anarchici
italiani di Masini, uscito da Rizzoli nel 1969, abbia suscitato
un interesse mai riscontrato da tale argomento fino ad allora.
Certo, il merito di Masini fu quello di scrivere un'opera che
aveva un particolare appeal: ben scritta, ben strutturata,
ben documentata. Non la solita sintesi più o meno divulgativa.
Ma un editore come Rizzoli, che aveva il polso del mercato,
doveva essersi mosso per soddisfare precise esigenze dei potenziali
lettori. Ed anche il convegno torinese della Fondazione Einaudi,
Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo, tenutosi
pochi giorni prima dell'esplosione della bomba alla Banca dell'Agricoltura
in Piazza Fontana, dimostrava come lo stesso mondo degli studi
storici, dopo il maggio francese, avesse sentito il bisogno
di interrogarsi sul tema.
Agli inizi degli anni Settanta, in quella particolare temperie,
cominciai ad approfondire i miei studi sul sindacalismo d'azione
diretta e fui invitato al Convegno di Piombino sul sindacalismo
rivoluzionario (28-30 giugno 1974). Come è noto fino
ad allora i contributi storiografici sul sindacalismo non erano
stati né numerosi né consistenti e avevano sempre
teso a valutare il fenomeno sindacalista in rapporto a qualcosa
d'altro: il Partito socialista per quanto riguardava la fase
iniziale (che venne poi complessivamente analizzata da Riosa
nel suo volume del 1976: Il sindacalismo rivoluzionario in
Italia e la lotta politica nel Partito socialista dell'età
giolittiana, Bari, De Donato), il fascismo per il suo supposto
esito finale. Tutt'al più un certo interesse avevano
suscitato le posizioni interventiste di una parte del gruppo
dirigente dell'Usi, ma l'esperienza dell'organizzazione, sia
durante la fase della sua faticosa gestazione sia nel corso
della sua vicenda vera e propria, era stata decisamente trascurata.
Indipendentemente dalle valutazioni più o meno critiche,
dal riconoscimento o dai giudizi liquidatori, il sindacalismo
d'azione diretta era un'immagine debole, i cui collegamenti
con la realtà del movimento operaio apparivano episodici
(fatta eccezione per il caso di Parma) o comunque frutto di
situazioni particolari quando non della meteorica apparizione
di qualche imbonitore sindacalista. Se maggiore attenzione era
stata dedicata al sindacalismo teorico come variante del revisionismo
(basti pensare al classico studio di Enzo Santarelli, La
revisione del marxismo in Italia: studi di critica storica,
Milano, Feltrinelli, 1964), ben scarso rilievo era stato dato
al sindacalismo pratico degli organizzatori. Parma rimaneva
l'“oasi” sindacalista, una sorta di coltura in vitro,
lo sciopero generale del 1908 il grande esperimento fallito.
Il problema centrale non era comunque semplicemente rovesciare
la prospettiva, rivalutare ciò che veniva prima criticato
o trascurato. Una simile ottica sarebbe stata sempre all'interno
di una visione storiograficamente povera, di parte nell'accezione
deteriore del termine. In primo luogo bisognava andare alle
fonti, numerose e ricche, cosa che quasi nessuno aveva fatto.
C'era chi era riuscito a scrivere di sindacalismo senza aver
mai consultato «L'Internazionale» (1908-1923), per
non parlare di «Guerra di classe» (1915-1922). Secondariamente,
era necessario sprovincializzare il sindacalismo inserendolo
nel quadro internazionale e collegandolo ad esperienze analoghe
di altri paesi, delle quali non si conosceva quasi nulla.
Non a caso in quegli anni si iniziarono a studiare gli Industrial
workers of the world (IWW) statunitensi. Il convegno di Piombino
e quello successivo di Ferrara (2-4 giugno 1977) modificarono
radicalmente la situazione. Si trattò di un mutamento
che non aveva direttamente a che fare con l'identità
politica dei diversi studiosi. La redazione della rivista «Ricerche
storiche», diretta da Ivano Tognarini, che organizzò
il convegno di Piombino, era costituita in larga misura da giovani
studiosi legati al Partito comunista. Questo non impedì
loro di allestire un convegno aperto e, in seguito, di cooptarmi
nella redazione stessa. Così dicasi anche per il convegno
di Ferrara, organizzato da Alessandro Roveri. Ma era cambiato,
e non solo nei giovani, il modo di porsi davanti a certi problemi.
Non era più il tempo dell'Ungheria, quando Di Vittorio
aveva dovuto rimangiarsi il primitivo appoggio agli insorti.
Dopo la primavera di Praga, la situazione non era più
la stessa. Più che dare risposte, ci si ponevano delle
domande. “Una domanda è come un coltello che squarcia
la tela di un fondale dipinto per permetterci di dare un'occhiata
a ciò che si nasconde dietro”, leggiamo, non a
caso, ne L'insostenibile leggerezza dell'essere. È
comunque significativo che Ernesto Ragionieri nella Storia
d'Italia Einaudi (vol. IV, tomo 3°), uscito nel 1976,
si sentisse in dovere di scrivere: “Solo di recente la
storiografia ha cominciato ad approfondire e articolare il giudizio
gramsciano sulla base prevalentemente contadina e meridionale
del sindacalismo rivoluzionario”. E di rilevare, in una
nota, che il convegno di Piombino aveva dato interessanti indicazioni
di ricerca, citando gli interventi di Procacci, Barbadoro e
del sottoscritto. Poca cosa, se vogliamo, e sempre facendo riferimento
a Gramsci, di cui si doveva evidentemente “approfondire
e articolare”, certo non criticare – come mi sembrava
di aver fatto – il giudizio. Un piccolo passo, un piccolo
foro nella diga che andò via via allargandosi.
Nei primi anni Settanta inoltre, nel clima di quello che venne
definito pansindacalismo, videro la luce i primi lavori significativi
sulla Cgdl di Adolfo Pepe e Idomeneo Barbadoro nonché
Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale di
Stefano Merli. Si aprì una stagione che produsse risultati
diversi nella qualità e negli orientamenti ma nella quale
il movimento sindacale diventò senza dubbio uno dei protagonisti
(basti pensare ai numerosi studi su federazioni e camere del
lavoro). Il che attenuò in modo significativo non tanto
un legame con i partiti a livello individuale, ma il peso che
tale legame poteva avere nell'interpretazione storiografica.
Il senso di una “storia militante”
Tu hai dedicato, tra i molteplici studi, molta attenzione
a due filoni della storia politica e sociale italiana ambedue
però compresi nell'arco in particolare dell'età
giolittiana (1900-1914): il primo riguardante la storia sindacale
– nello specifico quella del sindacalismo d'azione diretta
–, in particolare la genesi degli organismi sindacali
(Camere del lavoro, sindacati di categoria etc.); la seconda
quella relativa alla cultura, all'immagine, ai simboli del sovversivismo
e in particolare dell'anarchismo. Puoi dirmi il motivo di tali
interessi?
Gli interessi individuali non sempre sono facilmente spiegabili in modo razionale. Negli ultimi anni di insegnamento, soprattutto quando passai a Mediazione linguistica, mi dedicai molto alla Storia dell'Irlanda e tenevo lezioni costantemente accompagnate da musica politica irlandese. Ma forse un motivo della mia predilezione per la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento sta nel fatto che in quella fase si consuma – questo è un mio parere del tutto personale - tutta la speranza di mutamento possibile, si raggiunge in qualche modo l'apice di un ottimismo foriero di grandi cambiamenti. E lo si vede in tutti i campi: politica, arte, letteratura, musica, scienza. In effetti, i cambiamenti ci furono, epocali: la “grande guerra”, la rivoluzione russa, i fascismi. Ma furono di segno opposto. “Il sonno della ragione genera mostri”.
Detto ciò si può intuire cosa io pensi della rivoluzione russa. Ma è un discorso troppo lungo. Ricordiamoci solo cosa scrisse Malatesta su rivoluzione, “forche e galera”, nel 1925 in «Pensiero e volontà». Quanto alla seconda parte della domanda, sono molto affascinato dalle immagini e dai simboli e dai vari mezzi mediante i quali si può trasmettere un pensiero (un comizio, una canzone, una bandiera, un corteo e così via). Ho cominciato ad occuparmene studiando negli anni Ottanta le origini e lo sviluppo del Primo maggio e, parallelamente, l'immagine di Pietro Gori. E sono anche i lavori a cui sono più affezionato.
Ma la storia non è un succedaneo della fede
Tu sei stato uno storico “accademico”
che non ha rinunciato al confronto anche con i ricercatori indipendenti
e il mondo “militante” del movimento libertario.
Puoi dirmi in due battute come sei riuscito a coniugare un rapporto
che altri hanno risolto in maniera drastica rinunciando all'una
o all'altra?
Ti faccio presente che militanti per così dire “classici”,
seppur molto diversi tra loro, come Gino Cerrito e Nico Berti
ci sono riusciti benissimo. Il problema era semmai avere degli
sponsor forti (Gino ebbe Giorgio Spini) che né Nico né
io abbiamo avuto. Con il passar del tempo tuttavia entrambi
ci siamo procurati degli estimatori. Se ciò che scrivi
viene, non dico condiviso, ma apprezzato sotto il profilo qualitativo
e ne vengono riconosciute le caratteristiche scientifiche, in
una parola vieni accettato nella categoria degli storici professionisti,
molta strada è già fatta. Dipende ovviamente anche
come ci si pone nei confronti dell'istituzione. Se l'obiettivo
dichiarato è quello di distruggere l'università,
è molto probabile che non avrai molte chances.
Per quanto mi riguarda, sono stato direttore di dipartimento,
presidente di corso di laurea e, sempre eletto dai colleghi,
anche consigliere d'amministrazione di un Ateneo grande come
la Statale di Milano e non ho avuto problemi. Certo, non ho
mai detto di volere abolire le tasse universitarie. Il nostro
compito era di cercare di farle pagare a chi poteva permetterselo.
Le università, intese come comunità di studiosi
e non enti burocratico-amministrativi, fin dai loro albori hanno
sempre utilizzato la cooptazione. Non penso che sia facile cambiarle
e, del resto, non credo che esistano criteri oggettivi di valutazione.
In campo storico gli ambiti di studio sono tali e tanti che
è inevitabile che ciascuno di noi ne conosca bene alcuni
e si disinteressi di altri. Anni fa contavano di più
le appartenenze politico-ideologiche, ma c'erano fortunatamente
anche le eccezioni. Ora sembra importante far parte di società
di storici, partecipare alle assemblee e ai convegni, assumersi
qualche incarico, farsi conoscere insomma di persona e non solo
attraverso i propri studi. Quando, alcuni anni or sono, vennero
introdotte le abilitazioni qualcuno pensò che fosse arrivato
il suo momento. Ma poi scoprì che l'abilitazione non
garantiva nulla e che la tanto sospirata chiamata non sarebbe
mai arrivata. Ci sono ottimi associati che non sono diventati
mai ordinari (magari per questioni di età o di bilancio)
e altrettanto validi studiosi “indipendenti” che
per le più svariate (e non sempre nobili) ragioni non
hanno trovato posto in Università. Dimenticavo. Un po'
di fortuna non guasta.
Quanto al “mondo militante”, bisogna capire che
cosa si aspetta da uno storico. Se si aspetta celebrazioni e
conforto per le proprie scelte, sentirsi dire che ha ragione
e che un giorno le sue tesi trionferanno, ha sbagliato indirizzo.
Uno storico agisce sul passato e non può, né dovrebbe,
dare conferme, può però restituire dignità
e senso a determinati percorsi e persone e soprattutto scoprire
quei rivoli di vita, di pensiero, di azione che una lettura
spesso riduttiva e strumentale elimina spietatamente. Mi piace
riportare qualche riga dello sterminato romanzo di Vasilj Grossman.
Vita e destino (ambientato durante la battaglia di Stalingrado):
“Quando si rivolge al passato, la mente umana usa sempre
un setaccio dai fori molto piccoli per filtrare il grumo degli
eventi, e getta sempre via le sofferenze dei soldati, il loro
sconforto, la loro nostalgia”. Ebbene, soldati o meno,
cerchiamo di usare un setaccio dai fori molto grandi e strappare
al tempo, come ha scritto Adriano Prosperi, le sue vittime.
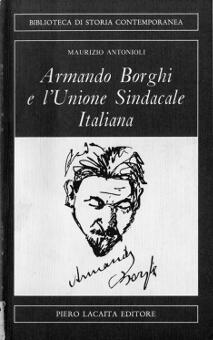
Ma per te ha senso oggi una “storia militante”?
Francamente no. Anch'io quando ero giovane (nel breve periodo
in cui fui nella redazione di «Primo maggio»), ho
avuto qualche velleità del genere. Fortunatamente mi
è passata subito. Il richiamo alla storia militante mi
fa venire in mente quando, nella polemica interna a «Movimento
operaio», qualcuno sostenne che la rivista doveva diventare
uno “strumento della lotta di classe” (1951). Sia
chiaro, non voglio banalizzare nulla né esprimere valutazioni
astraendo dal contesto e sottovalutando l'impegno etico-politico
di molti storici che, all'epoca, erano convinti di marciare
verso il sol dell'avvenire (nel caso specifico ho sempre avuto
molto stima per l'autore di quelle dichiarazioni). Ma se, nella
temperie politico-culturale dell'epoca, è possibile capire
il senso di tali posizioni, pur non condividendole per ragioni
di principio, dopo si sarebbe dovuto evitare lo stesso
errore. Non si tratta di negare allo storico libertà
di scelta e di azione, impegno si diceva quando era di moda
l'intellettuale engagé. Oppure di costruirsi una
identità culturale e sociale, privata e pubblica, anche
attraverso l'elaborazione dei risultati della ricerca. Semplicemente,
di indurlo a sfuggire alla tentazione di relegare la ricerca
storica ad un ruolo ancillare a fini che, per nobili che siano,
non ne sono lo scopo. Il dato interessante è come una
simile questione emerga quasi sempre a proposito della storia
contemporanea, cioè di quel periodo che sembra più
utilizzabile ad obiettivi direttamente politici. Sappiamo benissimo
che tutto può servire ad uso della propria visione del
mondo, soprattutto se totalizzante, perfino i cavalieri teutonici
da un lato o Spartaco dall'altro.
Ma è difficile trovare chi discuta con passione sulle
ragioni di Cesare o su quelle di Bruto e Cassio. Eppure si studia,
questo sì con passione, anche la storia antica e perfino
la preistoria. E si tratta a volte di passioni forti perché
hanno il respiro dei secoli o dei millenni. Poi, magari, alcuni
potrebbero sospettare che si ritorni a scrivere, in questi giorni,
dei “faraoni neri” del Sudan (anche se Meroe
fu dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità già
nel 2011) per motivi non solo culturali, ma sull'onda di problematiche
che nulla hanno a che vedere con la 25a dinastia faraonica.
Divagazioni a parte, l'importante per me sono le domande che
noi poniamo e che devono ampliare e approfondire le nostre conoscenze.
Come poi ciascuno di noi userà tali conoscenze è
un aspetto che attiene alle nostre scelte di vita, non alla
storia. Non ritengo che la storia debba essere un succedaneo
della fede.
Quali sono stati per te i momenti più emozionanti
del tuo lavoro di storico?
Anche se è sempre emozionante trovare qualche inedito,
soprattutto corrispondenza, o documenti che possono dare una
svolta al tuo lavoro, le vere e proprie emozioni sono rare.
Quelle che ricordo con particolare vivezza sono legate alla
figura di Pietro Gori. Ad esempio, quando mi imbattei per caso,
a Gubbio, in una epigrafe a lui dedicata sulla facciata di un
palazzetto già sede di una Società operaia. Oppure,
vent'anni fa, nella piazzetta di S. Ilario, all'Elba, quando
incontrai un vecchio che mi indicò, su mia precisa domanda,
la casa di Gori. In realtà, ad emozionare sempre è
la conoscenza, l'imbattersi in qualcosa che ti porterai dentro
e che contribuirà a dare un senso alla tua vita.
La storia ha un futuro in una società che
ha poca memoria di se stessa come quella attuale?
Penso che la storia avrà sempre un futuro perché
ognuno di noi ha una storia, per piccola che sia, anche le “vite
minuscole” (per riprendere Pierre Michon) per le quali
ho ultimamente molto interesse. Si studia la storia anche di
popoli “senza storia”, così chiamati perché
di essi non possediamo nulla o quasi. Non so poi se la nostra
società sia senza memoria. O meglio, penso che tutte
le società in genere siano senza memoria se con questo
ci riferiamo alla memoria collettiva, espressione molto difficile
da definire, perché invece i singoli ricordano bene le
proprie esperienze. La generazione dei miei genitori è
stata irrimediabilmente segnata dalla guerra (chi l'ha fatta
e chi l'ha subita). Loro e i loro coetanei non dimenticarono
mai quei giorni. Attualmente c'è un'esigenza profonda
di sentirsi ricordati, mista ad uno sfrenato esibizionismo,
se sempre più persone sentono il bisogno di raccontarsi
attraverso i social, di far sapere agli “amici”
che cosa hanno fatto, dove sono stati, che cosa hanno visto,
perfino che cosa hanno mangiato. Anche la televisione porta
sempre più alla luce aspetti della vita quotidiana. Tutto
questo, se suscita spesso in me una spontanea ripulsa, mi induce
tuttavia a pensare che la pubblicizzazione delle vicende personali
darà modo agli storici del futuro di lavorare sul tessuto
sociale – o su una parte di esso – con molti più
mezzi. Produciamo oggi una tale quantità di documenti
(perfino troppi) che ci sarà l'imbarazzo della scelta.
Cambierà – e sta già cambiando – il
mestiere di storico, soprattutto di chi si occupa della stretta
contemporaneità. Quando ho iniziato la mia tesi, cinquant'anni
fa, si studiava praticamente solo nelle biblioteche e negli
archivi visionando carte. La riproducibilità del documento
era quasi nulla, pessime fotocopie, microfilm scadenti e costosi.
E poi i soggetti studiati comunicavano quasi esclusivamente
per lettera, scrivevano sui giornali, dei comizi o dei dibattiti
parlamentari si avevano solo resoconti scritti. Molti non comunicavano
affatto e possiamo saperne qualcosa solo se altri ne hanno scritto
o hanno interessato, per qualche motivo, la polizia. La quantità
di fonti era inferiore, seppur molto dispersa.
Per inseguire certe tracce bisognava girare l'Italia. Oggi,
con un computer si fanno miracoli. Ma le fonti si sono enormemente
moltiplicate e non è facile tenerle sotto controllo.
A parte i personaggi pubblici, la narrazione della quotidianità
oggi è fatta di “vite minuscole”. Il che
non è detto sia negativo.
Come scriveva Saša a Michel, ne Il club degli incorreggibili
ottimisti, “Soltanto la memoria è bella. Il
resto è polvere e vento”.
Franco Bertolucci
 Maurizio
Antonioli (Milano, 1945) è tutt'oggi
uno dei maggiori storici a livello internazionale che
ha dedicato e si dedica con passione alla storia dell'anarchismo
e del movimento operaio. Ha insegnato per oltre tre decadi
Storia contemporanea e Storia del movimento
sindacale presso l'Università Statale di Milano
e diverse migliaia di studenti si sono formati attraverso
i suoi corsi. Ha partecipato a convegni “storici”
importanti come Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo
(Torino 5-7 dicembre 1969) organizzato dalla Fondazione
Luigi Einaudi e cinque anni più tardi fa la sua
prima comparsa a un convegno come relatore: Sindacalismo
rivoluzionario in Italia nel periodo della Seconda internazionale
(Piombino 28-30 giugno 1974). Ha collaborato a progetti
scientifici internazionali e a varie riviste come «Primo
Maggio», «Storia e politica», «Ricerche
storiche», «Economia e lavoro», «Mondo
operaio», ed è stato tra i fondatori e tra
i principali animatori della «Rivista storica dell'anarchismo»
(1994-2004). Maurizio
Antonioli (Milano, 1945) è tutt'oggi
uno dei maggiori storici a livello internazionale che
ha dedicato e si dedica con passione alla storia dell'anarchismo
e del movimento operaio. Ha insegnato per oltre tre decadi
Storia contemporanea e Storia del movimento
sindacale presso l'Università Statale di Milano
e diverse migliaia di studenti si sono formati attraverso
i suoi corsi. Ha partecipato a convegni “storici”
importanti come Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo
(Torino 5-7 dicembre 1969) organizzato dalla Fondazione
Luigi Einaudi e cinque anni più tardi fa la sua
prima comparsa a un convegno come relatore: Sindacalismo
rivoluzionario in Italia nel periodo della Seconda internazionale
(Piombino 28-30 giugno 1974). Ha collaborato a progetti
scientifici internazionali e a varie riviste come «Primo
Maggio», «Storia e politica», «Ricerche
storiche», «Economia e lavoro», «Mondo
operaio», ed è stato tra i fondatori e tra
i principali animatori della «Rivista storica dell'anarchismo»
(1994-2004).
È direttore scientifico della Fondazione Anna Kuliscioff
e membro del comitato scientifico della Fondazione Di
Vittorio, dell'Archivio del lavoro della CGIL di Milano,
oltre che della Biblioteca F. Serantini.
Autore di numerosi libri è stato condirettore del
Dizionario biografico degli anarchici italiani.
Tra i suoi principali lavori ricordiamo alcuni che hanno
segnato il suo percorso di studioso e ricercatore: La
Fiom dalle origini al fascismo, 1901-1924, [con B.
Bezza] (1978); Sindacato e progresso. La Fiom tra immagine
e realtà, (1983); Azione diretta e organizzazione
operaia. Sindacalismo rivoluzionario e anarchismo tra
la fine dell'Ottocento e il fascismo, (1990); Armando
Borghi e l'Unione sindacale italiana (1990); Pietro
Gori. Il cavaliere errante dell'anarchia (1995), Il sindacalismo
italiano dalle origini al fascismo (1997); Il Sol
dell'avvenire. L'anarchismo in Italia dalle origini alla
Prima guerra mondiale [con P.C. Masini, 1999]; Lavoratori
e istituzioni sindacali: alle origini delle rappresentanze
operaie (2002); Riformisti e rivoluzionari. La
Camera del lavoro di Milano dalle origini alla grande
guerra, [con J. Torre Santos], (2006); Sentinelle
perdute. Gli anarchici, la morte, la guerra (2009);
Figli dell'officina. Anarchismo, sindacalismo e movimento
operaio tra Ottocento e Novecento (2012); Per una
storia del sindacato in Europa (2012). È
stato tra i curatori dei volumi Contro la Chiesa. I moti
pro Ferrer del 1909 in Italia (2009) e Nostra patria
è il mondo intero. Pietro Gori nel movimento operaio
italiano e internazionale (2012). L'ultima sua opera
uscita nei mesi scorsi è Un'ardua e gioconda
utopia, simboli e miti degli anarchici tra '800 e '900
(2017).
|
Foto di Roberto Gimmi
|

