
Viaggio
alla fine del dolore
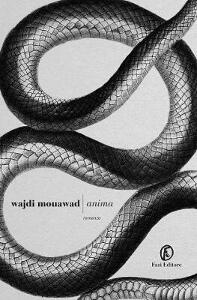 Di
questo libro – pubblicato da Fazi Editore lo scorso mese
di febbraio – hanno scritto in molti e sempre con toni
molto positivi. Ho voluto aggiungermi al coro perché
la sua bellezza si presta a sostenere molto più di un
elogio. Sto parlando di Anima (Fazi Editore, Roma, pp.
496, € 18,50) scritto da Wajdi Mouawad, artista libanese
conosciuto e apprezzato, soprattutto in Francia, come autore
di teatro. Questo è il suo secondo romanzo. Di
questo libro – pubblicato da Fazi Editore lo scorso mese
di febbraio – hanno scritto in molti e sempre con toni
molto positivi. Ho voluto aggiungermi al coro perché
la sua bellezza si presta a sostenere molto più di un
elogio. Sto parlando di Anima (Fazi Editore, Roma, pp.
496, € 18,50) scritto da Wajdi Mouawad, artista libanese
conosciuto e apprezzato, soprattutto in Francia, come autore
di teatro. Questo è il suo secondo romanzo.
Cinquecento pagine scritte nell'arco di dieci anni che hanno
condotto ad un lavoro di rara intensità e pulizia per
un tema così cruciale come quello che si affronta. Il
libro, di primo acchito, si presenta come un noir: un
uomo trova la moglie uccisa barbaramente e decide di partire
alla ricerca dell'assassino, non per vendetta, ma perché
vuole vedere la faccia di chi ha potuto accanirsi in maniera
così brutale sul corpo di una donna incinta e perché
quella morte ha iniziato a far riaffiorare in lui ricordi di
cui non aveva consapevolezza.
Inizia il viaggio e con esso iniziano a dipanarsi le mille sfaccettature
del dolore. È il grande tema e viene affrontato magistralmente
scegliendo di non guardare al dolore solo dal punto di vista
umano ma anche da quello degli animali. C'è il dolore
ontologico, che fa parte del tessuto della vita che uccide la
vita, che di essa si nutre, e c'è quello causato dall'essere
umano sulla sua stessa specie e sulle altre specie viventi.
Niente è peggio o meglio, tutto è sentito e narrato
con eguale partecipazione, asciutta e ricca di pathos.
Unica è l'anima in cui tutto risuona, un'anima universale
che ci comprende insieme alle anime di un universo animale narrante
che costituisce il punto di vista particolare su cui il testo
viene costruito. Infatti ogni capitolo porta il nome scientifico
dell'animale, – felis sylvestris catus, musca domestica,
vespula germanica, equus caballus – che descrive azioni
ed emozioni. Su questa scelta stilistica vorrei soffermarmi
perché ho trovato veramente grande il modo in cui il
dolore umano viene raccontato al pari di quello animale (la
descrizione di una femmina di procione uccisa dal viavai delle
automobili è toccante tanto quanto quella dell'assassinio
della moglie del protagonista e la narrazione della folle disperazione
dei cavalli rinchiusi nel camion che li sta trasportando al
macello non è da meno di quella della peggiore strage
compiuta da esseri umani su altri esseri umani inermi), in un
unico “canto animale” che tutto unisce mentre tutto
lascia scorrere. Unica è l'anima del mondo, quindi uno
è anche il dolore che ci accomuna: questo il messaggio
che nel libro passa con molta chiarezza. Sarebbe bello potessimo
farlo nostro, intimamente.
Ascoltiamo la voce di una scimmia: “Gli umani sono soli.
Malgrado la pioggia, malgrado gli animali, malgrado i fiumi
e gli alberi e il cielo e malgrado il fuoco. Gli umani sono
sempre sulla soglia. Hanno avuto il dono della verticalità,
e tuttavia conducono la loro esistenza curvi sotto un peso invisibile.
C'è qualcosa che li schiaccia. Piove: ecco che corrono.
Sperano nella venuta delle divinità, ma non vedono gli
occhi degli animali che li guardano. Non sentono il nostro silenzio
che li ascolta. Prigionieri della loro ragione, la maggior parte
di loro non faranno mai il grande passo dell'irragionevolezza,
se non al prezzo di un'illuminazione che li lascerà esangui
e folli. Sono assorbiti da ciò che hanno sotto mano e
quando le loro mani sono vuote, se le portano al viso e piangono”.
La solitudine umana è un altro dei temi che si intrecciano,
strada facendo, a comporre la molteplice trama di voci, partendo
da quella del protagonista – Wahhch Debch, libanese di
origini, il cui nome tradotto significherebbe “mostruoso
brutale” – che era bambino in Libano all'epoca della
strage di Sabra e Chatila.
Ci sono i territori delle riserve indiane del Quebec, dove convivono
bassezze orribili insieme alla meraviglia della cosmologia dei
popoli nativi delle zone che Wahhch attraversa per incontrare
l'indiano Mohawk che si sa essere l'assassino di sua moglie.
Sono territori di confine, ma il confine, prima di essere quello
tra uno stato e l'altro, è quello tra il bene e il male,
fra l'identità di un popolo e la sua autodeterminazione,
fra ciò che è umano e quello che è disumano,
tra umano e animale. Ci si muove in continuazione cercando una
spiegazione al male e perciò si sprofonda nelle viscere
di un mondo governato da brutalità e perdizione, si scende
nel lato oscuro della natura umana, il peggiore. Si attraversano
gli stati dell'America alla ricerca della verità sulla
storia del protagonista.
Bellezza e orrore della natura umana ci accompagnano lungo tutto
il viaggiare. Bellezza e brutalità della natura animale
con cui siamo portati a fare paragoni. Il protagonista ha un
rapporto speciale con gli animali, li vede ed è visto,
li rispetta ed è rispettato, li salva ed è salvato
in più di un'occasione, quasi come accade nelle favole
e questo è commovente in un libro che incalza seguendo
il divenire dei fatti tipico della tragedia greca. Si tocca
il fondo dell'obbrobrio per arrivare alla catarsi, a una sorta
di giustizia finale che Wahhch e gli animali compiono.
La storia finisce e la voce narrante del coroner incaricato
delle indagini racconta l'epilogo. Un uomo, una donna e un cane
continueranno il viaggio dirigendosi verso nord: “Cosa
getteranno nel tumulto delle onde? Cosa affideranno agli abissi?
Quale dolore? Quale dispiacere? Nelle profondità marine
esistono pesci mostruosi dotati di parola, custodi di una lingua
antica, dimenticata, parlata ai tempi dei tempi dagli umani
e dalle bestie sulle rive dei paradisi perduti. Chi mai oserà
immergersi per unirsi a loro e imparare a decifrare e parlare
di nuovo quel linguaggio? Quale animale? Quale uomo? Quale donna?
Quale essere? Quell'essere, se risalisse in superficie, porterebbe
nella propria bocca azzurrata dal freddo i frammenti di una
lingua scomparsa di cui tutti noi cerchiamo da sempre, instancabilmente
l'alfabeto. Impareremmo di nuovo a parlare. Inventeremmo parole
nuove. Wahhch ritroverebbe il suo nome. Non tutto sarebbe perduto”.
Silvia Papi
Dietro e dentro
i meccanismi culturali
 È
mio convincimento che una piena, o quantomeno adeguata, comprensione
di qualsivoglia esperienza debba tener conto dell'approccio
con la quale la viviamo. Questa considerazione vale in particolare
quando incontriamo un testo soprattutto se interessante e in
qualche misura illuminante. Nel caso specifico, mi ha indotto
a leggere I Buoni (Chiarelettere, Milano, 2014, pp. 224,
€ 14,00) una conferenza tenutasi in un'austera sala della
Cavallerizza Reale. In quell'occasione si ragionava “della
feroce retorica del Bene e della Cooperazione sociale”
a partiredal libro di Luca Rastello. È
mio convincimento che una piena, o quantomeno adeguata, comprensione
di qualsivoglia esperienza debba tener conto dell'approccio
con la quale la viviamo. Questa considerazione vale in particolare
quando incontriamo un testo soprattutto se interessante e in
qualche misura illuminante. Nel caso specifico, mi ha indotto
a leggere I Buoni (Chiarelettere, Milano, 2014, pp. 224,
€ 14,00) una conferenza tenutasi in un'austera sala della
Cavallerizza Reale. In quell'occasione si ragionava “della
feroce retorica del Bene e della Cooperazione sociale”
a partiredal libro di Luca Rastello.
Ero quindi mosso, come sovente mi capita, in primo luogo da
un interesse pratico-sensibile, dall'esigenza di conoscere meglio
l'universo della cooperazione sociale e del volontariato del
quale mi occupo, di norma, come organizzatore sindacale “irregolare”
e come militante politico.
La conferenza prima e la lettura del libro poi non mi hanno,
da questo punto di vista, certamente deluso, ma è bene
tener conto che si tratta comunque di un romanzo, a rigore di
un romanzo storico che applica puntualmente i canoni che hanno
guidato Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e che sono stati
formalizzati da György Lucaks: le vicende immaginarie di
personaggi immaginari come strumento per una rigorosa disamina
di quadro storico-sociale minuziosamente conosciuto. Non mancano,
quindi, amori, passioni, sofferenze, avventure e vicende che
riguardano il vissuto individuale.
Detto ciò, il libro si caratterizza per la puntuale ricostruzione
della natura umana e sociale e di alcune specifiche culture
politiche di questo universo. Per un verso si descrive il mondo
del volontariato nel suo intreccio con la cooperazione sociale,
un mondo che presenta se stesso appunto come “i buoni”,
coloro che si prendono carico della sofferenza sociale, coloro
che, in una società individualista ed egoista, propongono
uno stile di vita e dei valori antagonisti all'esistente.
Da questo punto di vista si descrivono i meccanismi dello sfruttamento
della forza-lavoro, del ricatto morale con cui questo sfruttamento
è giustificato, della costruzione di un vero e proprio
universo totalitario. A questo universo moralista, cupo, autoflagellantesi
non manca per altro di interlocuzioni forti con imprenditori,
politici, banchieri “amici” secondo l'antico precetto
per il quale omnia munda mundis. Per l'altro verso si analizza
un classico caso di eterogenesi dei fini: l'ibrido prodotto
dell'incrocio fra cattolicesimo radicale e rottami del comunismo
storico novecentesco, sviluppatosi a partire dagli anni Settanta
come tentativo di costruire un altro mondo possibile nella concretezza
del fare, ha prodotto un sottomondo perfettamente funzionale
allo smantellamento del welfare, all'esternalizzazione dei servizi
sociali, al controllo caritatevole della devianza sociale.
Si potrebbe parlare dell'ennesima sconfitta della generazione
del Sessantotto, o quantomeno di quella parte di questa generazione,
e di coloro più giovani che ne hanno seguito le tracce,
che ha tentato di sottrarsi alle ferree leggi dell' economia
di mercato e, contemporaneamente, alla gestione statale e burocratica
dell' esistente.
Uno scacco, se vogliamo, dell'idea che sia possibile costruire,
dentro la società statale e mercantile, un significativo
settore, soprattuto nei servizi, realmente autogestito. Ovviamente
un'analisi approfondita di questo problema richiederebbe uno
spazio che non vi è in questa sede tantopiù se
si considera che questo tema non è centrale nel libro
di Luca Rastello; basta rilevare che, visto che i committenti
sono gli enti locali e comunque lo Stato e che i committenti
definiscono il quadro in cui si svolge la cooperazione sociale
e le risorse che ha a disposizione, sarebbe ben strano che non
tenesse sotto il proprio controllo questo campo di attività.
In realtà Rastello concentra la propria valutazione critica
soprattutto sui meccanismi culturali che sottendono alla vita
di questo mondo ed indubbiamente, se consideriamo che si ragiona
di un lavoro di cura alle persone, il disvelamento della sua
natura profonda è essenziale.
Nei fatti quindi il libro che, oltre ad essere di lettura gradevole
anche se non sempre facile, è uno strumento utile per
la critica dell' attuale struttura di dominio proprio laddove
pretende di celare la sua reale natura.
Cosimo Scarinzi
La pratica della
trasformazione sociale
Una nuova, piccola, casa editrice libertaria. Nella Svizzera
italiana. Si chiama Edizioni Les Milieux Livres e ha appena
pubblicato due volumetti: Manifesto per una alternativa
(Soazza - Svizzera, 2014, pp. 47, € 5,00) di Patric
Mignard e Riflessioni sull'individualismo. Sapere-volere-potere
di Manuel Devaldès. Del primo riproduciamo qui la postfazione
di Stefano Boni.
Per maggiori informazioni:
www.lml-edizioni.org
- lml@lml-edizioni.org
 Mignard
ha una scrittura essenziale, pregevole per la limpidezza e la
capacità di sintesi, libera di citazioni e verbosità
superflue, disinteressata a dibattiti teorici e astratti, sempre
finalizzata a proporre argomentazioni serrate che, piuttosto
che a logiche formali, rispondono alla esperienza quotidiana
dei lettori. Proprio partendo dall'esperienza, l'attenzione
è volta alla questione, su cui chiunque desideri un cambiamento
sistemico si interroga con frequenza, di cosa fare in un contesto
desolante, segnato da decenni di progressiva concentrazione
del potere ed un esproprio generalizzato di sovranità
e diritti, competenze e autonomie dal corpo sociale ai potentati
politici e finanziari. Il tono che assume lo scritto di Mignard,
piuttosto che quello della disquisizione accademica, è
quello quasi profetico, comune ad altri analisti politici contemporanei
come Negri e Holloway. Mignard
ha una scrittura essenziale, pregevole per la limpidezza e la
capacità di sintesi, libera di citazioni e verbosità
superflue, disinteressata a dibattiti teorici e astratti, sempre
finalizzata a proporre argomentazioni serrate che, piuttosto
che a logiche formali, rispondono alla esperienza quotidiana
dei lettori. Proprio partendo dall'esperienza, l'attenzione
è volta alla questione, su cui chiunque desideri un cambiamento
sistemico si interroga con frequenza, di cosa fare in un contesto
desolante, segnato da decenni di progressiva concentrazione
del potere ed un esproprio generalizzato di sovranità
e diritti, competenze e autonomie dal corpo sociale ai potentati
politici e finanziari. Il tono che assume lo scritto di Mignard,
piuttosto che quello della disquisizione accademica, è
quello quasi profetico, comune ad altri analisti politici contemporanei
come Negri e Holloway.
L'opera di Mignard ha due enormi pregi: da un lato il taglio
storico di lungo periodo; dall'altro la proficua autocritica,
coerente e inflessibile. Per uscire dalle nebbie intellettuali
che ci vengono proposte dall'asservita industria dell'informazione,
abbiamo bisogno di trovare un senso in analisi storiche epocali,
riflessioni che aiutino a comprendere, oltre le apparenti urgenze
del momento, dove è indirizzato il modello che ci viene
imposto e la sorte delle resistenze che hanno cercato di opporsi.
Se i media ci propongono solo notizie che evaporano in un presente
frenetico che tende a distrarci da analisi ponderate, abbiamo
bisogno di sguardi eretici e profondi. Mignard stimola proprio
questa ricerca di senso che scardina la cacofonia imperante.
Per individuare le dinamiche che ci hanno portato all'attuale
impotenza politica e sull'orlo del collasso ecologico, si deve
uscire dal chiacchiericcio somministrato dalla retorica della
politica istituzionale e analizzare la storia contemporanea
senza aggrapparsi alle letture e agli alibi ai quali siamo assuefatti,
in grado solo di convincerci ad accettare il prossimo fallimento
o farci compiacere dei contentini ceduti dai potenti, peraltro
di questi tempi sempre più scarsi e tossici. Ci viene
offerta un'analisi senza sconti delle sconfitte nelle lotte,
delle cooptazione di partiti e sindacati rivoluzionari, degli
insuccessi delle mobilitazioni e delle corruzioni dei movimenti
contro il potere di capitale e stato. Se la schiettezza dell'analisi
è estrema, la sua lettura è condivisibile, anzi
irrinunciabile se si vuole immaginarsi un futuro in cui il protagonismo
storico sia diffuso e non concentrato nei palazzi dei potenti.
Mignard, da un lato, dice cose evidenti, dall'altro ciò
che evidente è al contempo sconvolgente. Le “lotte”
dal secondo dopoguerra in poi sono stati un susseguirsi di tentativi
fallimentari, quando in buona fede, e con il passare dei decenni,
si sono trasformati sempre più in forme di mistificazione
e di sostanziale appoggio al mantenimento dell'ordine sistemico,
come ormai reso evidente dal ruolo della maggior parte dei sindacati,
essenziali per svuotare di radicalità ed efficacia le
mobilitazioni dei lavoratori. Perseverare con le tattiche e
le strategie del Novecento è masochismo. Eppure, paradossalmente,
è proprio l'affermazione globale e incontrastata del
neoliberismo (ideologico, produttivo, massmediatico, istituzionale,
neocoloniale) che genera le condizioni non tanto della fine
del capitalismo (che continua ad accumulare profitti, investimenti,
proprietà a scapito del tessuto sociale) ma della sua
messa in crisi in termini di credenza e adesione. Nel momento
in cui la prima arma di affermazione del sistema che ci ha dominato,
il comodo consumismo, comincia a limitare la sua capacità
di diffondere l'agognato agio, si aprono inedite prospettive
per chi da sempre ha sostenuto la perversità sistemica
del dominio criptico della merce e dello stato.
È un'epoca in cui, se da un lato, la prospettiva di una
uscita dal dominio del capitale e del sistema mercantile appare
problematica come non mai, dall'altra parte, se ne stanno creando
le premesse sia per la sua irrinunciabilità (è
oggi in pericolo la nostra stessa esistenza come specie) sia
perché le menzogne che hanno contribuito ad inibire un
conflitto risolutivo appaiono, ad un numero crescente di persone
per quel che sono. Il Potere riesce sempre meno ad egemonizzare
il senso, ad offrire compromessi socialdemocratici, a produrre
merci ammalianti e riassume, quindi, la forma del controllo
e della forza bruta contro qualunque opposizione sociale.
La sfida oggi è di creare un attivismo sociale che non
sia teorico né di testimonianza. Ci sono le premesse
sociali, il disagio e la disillusione per le verità egemoniche,
che rendono le proposte radicali e anarchiche – dopo decenni
di marginalità strutturale – attraenti, sensate.
Come Mignard giustamente nota, non bastano più le manifestazioni.
Le recenti riflessioni anarchiche sul superamento del concetto
di rivoluzione appaiono quanto mai utili. Se la storia insegna
che “prendere il palazzo” rischia di generare nuove
gerarchie, spesso più brutali di quelle che sostituiscono,
allora si tratta di cercare nuove strade per svuotare le istituzioni,
evadere da prassi mercificanti, ignorare i media, interrompere
processi di delega dal tessuto sociale alle istituzioni.
Abbiamo delegato la nostra sovranità politica, ed oggi
appare evidente a molti l'inganno epocale della nozione di democrazia,
nella sua forma rappresentativa. Abbiamo delegato la stesura
delle norme sociali a politicanti senza scrupolo e ci ritroviamo
sovrastati da un sistema legislativo e burocratico sterminato,
incomprensibile, pervasivo, impenetrabile. Abbiamo delegato
la capacità tecnica a multinazionali e ora siamo umanità
priva di competenze tecniche direttamente applicabili, dipendenti
dai loro prodotti e servizi. Abbiamo delegato la salvaguardia
dei nostri territori, con risultati drammatici per fauna, flora
e per la stessa salute umana. Abbiamo delegato la produzione
di alimenti, siamo praticamente costretti al cibo industriale
e malsano dei supermercati. Abbiamo delegato l'educazione dei
nostri figli e delle nostre figlie a istituzioni che più
di formarli si preoccupano di disciplinarli.
La lista delle deleghe potrebbe proseguire: ce ne sono innumerevoli.
Per chi oggi sente le deleghe come una mortificazione della
sua creatività, un'amputazione della sua socialità,
una minaccia per la sua salute, una prevaricazione delle sue
libertà, un'offesa alla sua dignità, l'uscita
dai meccanismi di affidamento alle istituzioni che ci governano
è problematica. L'aspettativa di un processo di riforma
che parta dalle istituzioni stesse appare, oggi più che
mai, illusoria: ormai i potentati costituiscono un blocco omogeneo,
coordinato a livello globale che lascia scarsissimo spazio di
manovra ai singoli governi. La prospettiva di una insurrezione,
oltre che remota, appare con l'attuale configurazione del tessuto
sociale, a forte rischio di derive neo-autoritarie: una sollevazione
popolare oggi assumerebbe verosimilmente toni razzisti e l'esaltazione
di leader carismatici. La strada che appare più plausibile,
in questa fase storica, è una paziente trasformazione
culturale che limiti le deleghe e restituisca protagonismo e
sovranità al tessuto sociale. La distanza tra ciò
che desideriamo e ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi
è grande; è quindi lungo il sentiero da percorrere
per arrivarci. Non ci sono scorciatoie: un cambiamento culturale
non si ottiene vincendo elezioni, conquistando il palazzo militarmente,
fondando un nuovo partito o elaborando una nuova teoria politica.
Si fa insieme e si fa nel quotidiano. Si tratta di innestare
i principi libertari dove ci conducono le nostre esistenze,
seminando processi autogestionari nelle imprevedibili trasformazioni
che segnano le società europee in questa fase prolungata
di stagnazione e recessione.
Mignard arriva al suo Manifesto per una alternativa partendo
dalle sue conoscenze storiche ma l'antropologia indica le medesime
dinamiche: i cambiamenti epocali sono mutazioni culturali; impiegano
più generazioni a concretizzarsi; generano prassi di
vita nel loro insieme innovative; investono ogni ambito del
vissuto. Non si tratta di produrre un Uomo Nuovo ma una nuova
cultura, una nuova organizzazione della vita. Una trasformazione
culturale epocale significa fortificare esistenze che si liberano
dalla delega non come critica teorica ma come prassi quotidiana.
È difficile immaginarsi trasformazioni radicali in grado
di dissolvere le istituzioni se la società si trova a
dipendere da queste per infiniti aspetti, dalla banca al supermercato,
dal telefonino ai combustibili, dal salario alle pensioni, dalla
farmacia alla polizia, dagli alimenti alla scuola. Pare sensato
ritenere che solo una forza sociale che ha riacquistato autonomia,
che si è rimpossessata della gestione di diversi aspetti
della propria pratica quotidiana, possa sviluppare il desiderio
e trovare l'energia per sovvertire l'attuale configurazione
dei poteri. Finché sono attive, come è il caso
ora, dipendenze molteplici che ci vincolano al sistema, siamo
ricattabili. Finché siamo ricattabili, la lotta assumerà
tendenzialmente toni riformisti: non ci si augura il collasso
di un sistema senza il quale crollerebbe l'insieme dei nostri
riferimenti operativi. Una delle ragioni della impotenza delle
lotte contemporanee è proprio la loro fragilità
in termini di indipendenza dalla mega-macchina.
Per minimizzare progressivamente i processi di delega è
quindi importante lavorare sulle nostre esistenze, intese come
tracce, minime ma significative, deboli ma continue, che lasciamo
nella storia, impronte in grado di contribuire, assieme a quelle
di altri, a direzione processi sociali più ampi, a generare
alternative concrete. Ogni nostro voto o assemblea, ogni conformismo
o ribellione, ogni compera o dono, ogni merce o auto-produzione,
sono minuti contributi all'orientamento complessivo che prende
il corpo sociale.
Lavorare sulla prassi ha una serie di vantaggi. Il cambiamento
auspicato è sí più lontano nel tempo, rispetto
ad una prospettiva rivoluzionaria, ma al contempo più
accessibile a tutti e più inclusivo: non a caso l'idea
di un protagonismo diffuso e variegato, costituente della nozione
di rivoluzione sociale, è parte di ideali anarchici consolidati
da più secoli. L'anarchia messa in pratica permette la
sperimentazione, ovvero la verifica dei principi politici e
morali rivendicati, nella loro concretizzazione quotidiana.
La prassi, rispetto alla elaborazione astratta, richiede infiniti
aggiustamenti e ricalibrature, che non sono sconfitte ma costruzioni
di consapevolezza e aggiornamenti indispensabili rispetto al
contesto del tutto peculiare in cui ci muoviamo oggi.
L'uscita dalla delega nella quotidianità, inoltre, contribuisce
a generare ibridazioni, relazioni di affinità e alleanze
nel fare che sono il canale di diffusione più diretto
e coerente della prassi libertaria. La diffusione dell'autogestione,
come specifica Mignard, richiede non solo autonomia gestionale
(anche le aziende capitalistiche sono in un certo senso autogestite)
ma la distribuzione egualitaria del potere decisionale e l'accesso
inclusivo agli strumenti produttivi. La strategia consiste nell'innestare
modalità libertarie in tutte le esperienze che escono
dal connubio ormai sempre più indistinguibile di stato
e capitale, generare quella rete di solidarietà e scambi
indispensabile per il funzionamento dell'autogestione. In Italia,
dopo decenni di lotte difensive, scontri ideologici, faide intestine,
inizia a vedersi un nuovo interesse diffuso per le pratiche
libertarie. È evidente nelle modalità di organizzazione
di molte delle mobilitazioni pubbliche degli ultimi anni ma
anche, forse soprattutto, come ricerca di uscita dalle deleghe
portata avanti da gruppi e singoli che non vengono, per lo più,
da una formazione teorica e intellettuale anarchica. Ogni stretta
antisociale dei poteri allineati di stato e capitale, impegnati
nel taglio ai servizi pubblici e nell'aumento di tasse, norme
e burocrazia, produce risposte autogestite, per ora incipienti
e fragili ma con notevoli prospettive di attrazione di settori
sociali. È il caso di accennare ad un paio di fermenti
che il tessuto sociale italiano ha cominciato ad esprimere in
modo significativo: la filiera alimentare e le proposte in ambito
educativo.
Per quanto riguarda la circolazione di cibo al di fuori della
mercificazione egemonica (industria agroalimentare-supermercato),
a partire dal nuovo millennio si sono moltiplicati esponenzialmente
i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). Sono costituiti da gruppi
di consumatori che entrano in un rapporto con piccoli produttori
e, nelle loro espressioni più coerenti e convincenti,
ri-localizzano la filiera produttori-consumatori, saltando tutti
i mediatori della distribuzione mercificata; intendono la tracciabilità
non come etichetta ma come rapporti di fiducia tra persone che
si conoscono; inventano propri processi di certificazione dei
beni; coniugano il rapporto commerciale con criteri solidali
ed ecologici. In alcuni casi consentono la circolazione di prodotti
di contadini, allevatori, pastori, apicoltori, raccoglitori
di frutta che producono al di fuori delle normative statali
e dei requisiti fiscali, permettendo forme di autogestione rurale
illegale. La forma più coerente e radicale di questo
movimento che salda ruralità solidale e classi medie
urbane è Genuino Clandestino e Terra Bene Comune, movimenti
in rapida espansione.
Federano informalmente gruppi locali che scelgono di sottrarsi
dalle imposizione burocratiche, dalle regolamentazioni insensate,
dal gioco fiscale generando, oltre ad una partecipata rete nazionale,
una autocertificazione che rivendica la clandestinità
dei prodotti, proprio come premessa indispensabile della loro
genuinità. Una conseguenza di questa nuova ondata di
attivismo contadino è il superamento della legislazione
astratta e insensata del biologico, un movimento che era nato
dal tessuto sociale ma ormai completamente legalizzato, istituzionalizzato
e mercificato. Si scegli di insediare mercatini e proporre pranzi
e cene sociali nelle piazze delle metropoli così come
in piccoli paesi. Se alcuni GAS iniziano ad essere cooptati
dalle istituzioni che propongono leggi e facilitazioni, dall'altra
altri non rinunciano a forme integrali di autogestione. Queste
modalità di ripensare il nesso tra produttori rurali
e acquirenti cittadini sono interessanti perché nascono
spontaneamente dal tessuto sociale; perché i gruppi sono
autonomi, privi di una direzione centralizzata; perché
generano relazioni nel rispondere ad esigenze concrete; perché
si fondano sull'idea della responsabilità piuttosto che
della delega; perché funzionano.
L'altro ambito in cui si stanno rafforzando dinamiche interessanti
è l'uscita dalla istituzione scolastica. La qualità
della istruzione pubblica, nonostante l'impegno e la dedizione
di tanti insegnanti, è in caduta libera in seguito al
taglio dei finanziamenti pubblici, a programmi scolastici sempre
più competitivi (fin dalle elementari) e all'aumento
della burocrazia ministeriale (ad esempio, le prove Invalsi).
È stata mortificata l'offerta alimentare (in seguito
alla chiusura di molte mense scolastiche), aumentato sensibilmente
il numero di bambini sotto la responsabilità di una singola
maestra, introdotto un uso (a volte massiccio) della televisione,
minimizzate le ore di gioco all'aperto e le attività
creative. La pervasiva paranoia legale ha raggiunto livelli
tali da impedire di portare torte fatte a casa a scuola per
festeggiare i compleanni. In questo contesto, si sviluppa un'uscita
sempre più cospicua dalla istruzione pubblica (la cui
attrattiva principale per molti utenti non è più
la qualità ma i costi contenuti) verso percorsi formativi
emancipati dai finanziamenti pubblici e quindi anche dalle direttive
e limitazioni statali.
Con diverse ispirazioni (scuola familiare, libertaria, Steineriana,
Montessori) si creano piccole comunità di insegnanti-genitori-alunni
libere di elaborare e sperimentare un proprio percorso formativo
non fondato sulla delega ma sulla partecipazione. In genere
sono esperienze che stabiliscono un rapporto tra docenti e studenti
che permette un'attenzione personalizzata e previene la massificazione.
I programmi sono creativi, variegati e improntati alla sperimentazione
diretta in chiaro contrasto con la rigidità, monotonia
e autoritarismo della didattica pubblica. La formazione prevede,
soprattutto per i più piccoli, numerose ore all'aria
aperta. Si cercano interazioni con le competenze sociali e artistiche
presenti nel territorio circostante. Si valorizza l'irriducibile
singolarità dei bambini. Si torna a cucinare autonomamente,
a volte con alimenti forniti dai genitori. Insomma, tutta un'altra
scuola fondata sul rifiuto della delega e sulla costruzione
dal basso di alternative operative.
La pratica di ciò che si desidera spesso assume carattere
sistemico nel senso che la ricerca di modalità che travalichino
la delega, implicita nell'offerta egemonica che pare ormai unica
opzione possibile, riguarda diversi campi. Questo rifiuto complessivo
del cammino già tracciato per noi, costituisce esistenze
singolari e collettive che effettivamente riescono a evadere,
in parte contenuta ma non irrisoria, processi di delega che
a molti appaiono indispensabili. L'alternativa intesa come prassi,
inoltre, ha la grande potenzialità di essere un canale
di costruzione di affinità politica che non richiede
adesioni ideologiche e quindi rafforza una disponibilità
ad accogliere e includere soggettività variegate che
raramente le iniziative più teoriche raccolgono. È
una politica che non può essere accusata di essere solamente
“contro” il sistema: ciò che rivendica, è
ciò che porta avanti nella prassi quotidiana. L'alternativa
è già presente, efficiente e funzionante e i principi
libertari su cui si basa risultano evidenti nell'azione. È
una modalità di trasformazione sistemica che risulta
accessibile a settori insospettabili del corpo sociale, perché
intesa come impegno a costruire praticamente alternative che
siano portatrici di nuovi principi e, per la loro stessa esistenza,
sabotatrici della modalità egemonica.
L'auspicio di Mignard è che questo testo sia un contributo
ad un processo di trasformazione epocale. Me lo auguro anch'io.
Si tratta di smettere di delegare anche i sogni di trasformazione
ma portarli avanti nella nostra quotidianità. Non c'è
progetto più ambizioso, non c'è progetto più
accessibile di quello che vede il conflitto politico iscritto
nelle nostre stesse esistenze.
Stefano Boni
Uranio impoverito
a teatro
Le storture della guerra si sono spinte, in anni recenti, fino
al nostro sistema linguistico: chiamare bombardamenti, soprusi
e morti con termini quali missioni di pace, missioni internazionali
o missioni umanitarie, oltre a essere un fallace toccasana per
la coscienza, mostra una grande padronanza nell'uso delle figure
retoriche, le quali però, quando non sono usate a fini
letterari o poetici, propongono solo una visione deformata e
pericolosa della realtà.
Miles gloriosus... ovvero: morire d'uranio impoverito
di Antonello Taurino prende spunto proprio dalle “missioni
di pace” degli anni '90 in Kosovo e Bosnia per indagare
un lascito della guerra che torna a casa con i reduci per poi
colpirli, una volta dispersi nello spazio e nel tempo: la morte
per uranio impoverito. Una microstoria lontana dai riflettori
perché orfana dei crismi che servono a un evento per
farsi mediatico e quindi guadagnarsi la ribalta del grande pubblico:
l'immediatezza e la violenza. Ma anche le morti per uranio impoverito
se non fosse stato per Striscia la Notizia, ribattezzata TAR:
Tribunale Antonio Ricci, non avrebbero mai goduto di alcuna
attenzione: uno spaccato che fa riflettere sui modi di condurre
le narrazioni più scomode in Italia e sulle modalità
di ricezione dell'opinione pubblica: pigre e ormai inermi di
fronte a qualsiasi cosa.
In scena, Taurino e Orazio Attanasio, che cura anche le musiche,
sono due giovinastri sospesi tra la necessità di sbarcare
il lunario e la voglia di fare uno spettacolo impegnato e utile.
I nostri, nel destreggiarsi tra un'offerta di lavoro in nero
e il pigliatutto Marco Paolini, che non ha lasciato più
nessun argomento d'inchiesta libero da trattare, ma nei cui
confronti si percepisce un omaggio, menano fendenti verso il
pubblico snocciolando numeri, lettere anonime, documenti e imbarazzi
del governo italiano. I pugni sono ricoperti dal dolce guanto
del sorriso; gli spettatori sembrano poter reggere l'urto, ma
alla fine sono rintronati e con una maggiore consapevolezza
e indignazione rispetto a quando erano entrati in sala.
Se la leggerezza dell'uranio impoverito è insostenibile
perché uccide, la leggerezza di una divulgazione puntuale,
comprensibile e non pedante sostiene la nostra capacità
di discernere e pensare.
Matteo Pedrazzini
Le donne della resistenza
nel Piacentino
È uscito per le edizioni Le Piccole Pagine il libro
di Iara Meloni Memorie resistenti. Le donne raccontano
la resistenza nel piacentino (edizioni Le Piccole Pagine,
Calendasio - Pc, 2014, pp. 235, € 18,00) di cui
pubblichiamo la prefazione di Daniella Gagliani.
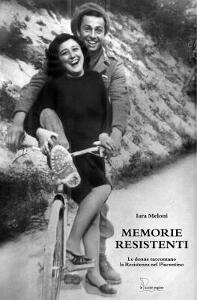 Questo
è un libro che parla della Resistenza, ma è un
libro che parla anche delle resistenze successive al 1945 messe
in campo – si può dire – nello spirito della
Resistenza. Questo
è un libro che parla della Resistenza, ma è un
libro che parla anche delle resistenze successive al 1945 messe
in campo – si può dire – nello spirito della
Resistenza.
La mia osservazione dovrebbe essere conclusiva e, invece, con
essa ho preferito aprire questa nota per evidenziare da subito
l'importanza del lavoro di Iara Meloni.
Centrale è la Resistenza, quella del 1943-1945, contro
il nazifascismo e nel libro se ne parla dalla prospettiva delle
donne, una prospettiva che, non solo ridà corpo e voce
a soggetti per lungo tempo dimenticati o trascurati, quelli
femminili appunto, ma consente anche di rivisitare la Resistenza
– la Resistenza tout court – e di leggerla
come un «evento», insieme normale ed eccezionale,
che ebbe per protagonisti uomini e donne comuni, i quali seppero
opporsi a un potere che praticava ed esaltava l'odio, la discriminazione,
la sopraffazione, la guerra. Perché il fascismo, anche
quello italiano, non dimentichiamolo, aveva fatto dell'odio,
della discriminazione, della sopraffazione, della guerra un
proprio fondamento etico. Opporsi al fascismo significava dunque
opporsi all'odio, alla discriminazione, alla sopraffazione,
alla guerra che, negli anni 1943-1945, si inscrivevano nella
guerra totale e si sostanziavano nella distruzione di uomini
e di cose, e in una crescente brutalizzazione umana. Resistere
significava aprire la strada a un mondo ri-umanizzato di pace
e di ricostruzione solidale e, per molti uomini e donne, anche
di liberi ed eguali.
La prospettiva femminile mostra che la Resistenza fu essenzialmente
un fenomeno politico prima che militare, come Lidia Menapace
e Marisa Ombra hanno da tempo sottolineato. Ridurre la Resistenza
a fenomeno militare ha comportato e comporta una sua sottovalutazione
e, perfino, una mistificazione, perché per la maggior
parte dei resistenti, uomini compresi, la Resistenza fu una
«guerra alla guerra», anche se paradossalmente combattuta
con le armi. Il fascismo era il regno della guerra, non la Resistenza
che gli si opponeva. Non sarebbe altresì comprensibile
l'art. 11 della nostra Costituzione che recita: «L'Italia
ripudia la guerra».
Che per alcuni decenni l'immagine della Resistenza sia stata
identificata con il partigiano in armi deve farci riflettere.
È un fatto che meriterebbe un'analisi particolare, specialmente
per comprendere come un grande fenomeno politico e sociale abbia
potuto essere circoscritto e limitato a un suo aspetto, non
irrilevante, intendiamoci, ma comunque non costitutivo. Le armi
nella Resistenza rappresentarono uno strumento per concludere
al più presto la guerra, non un fine in sé. Al
cuore della Resistenza c'era la volontà di chiudere con
la guerra e con il regno della guerra, emblemi del fascismo.
E in questo consiste il carattere essenzialmente politico della
Resistenza e, insieme, il suo tratto periodizzante nella storia
d'Italia (e, se vogliamo, anche d'Europa).
Giustamente Iara Meloni ha indicato, come centrale per esprimere
la Resistenza delle donne, la «Resistenza civile»,
che, grazie agli studi di Anna Bravo, fa ora parte del nostro
corredo storiografico come categoria di grande spessore. Le
donne di cui Iara Meloni ha raccolto la testimonianza sono,
con specificità diverse, con consapevolezze diverse,
con impegno diverso, tutte inseribili nella Resistenza civile.
E sono tutte resistenti, perché con le forze che avevano
a disposizione hanno dato quanto potevano per chiudere con la
guerra e con il regno della guerra. Senza di loro la Resistenza
sarebbe stata un'altra cosa, forse non ci sarebbe nemmeno stata.
Il loro sguardo su se stesse e sul contesto di quei mesi mette
in luce aspetti che lo sguardo puntato sulle formazioni armate
e le loro azioni non riusciva a mettere in luce. Sono aspetti
che ci introducono a considerare gli eventi in una prospettiva
non eroica, antieroica anzi, in quanto le donne parlano di sé
e anche degli altri come persone normali, non eccezionali. Persone
normali inserite in un contesto eccezionale. Ed è proprio
la «normalità» a consentire di stabilire
un legame con noi oggi, noi di generazioni diverse, ma tutti
«normali», sia che siamo uomini sia che siamo donne,
di sessanta, quaranta, venti e perfino quindici anni.
Lo sguardo femminile, che in epoca di ideologismi poteva essere
giudicato come insignificante (mentre noi sappiamo che non lo
è), non indugia sulle entità astratte, si concentra
sui corpi e riesce pertanto a distinguere le differenze e le
similitudini, sapendo afferrare le peculiarità di ognuno
e rilevarne anche le debolezze, le sofferenze, le paure perché
sono condizioni proprie dell'essere umano. Da qui il loro parlare
di sé e degli altri come esseri umani; da qui la possibilità
di stabilire relazioni con noi, di generazioni diverse, ma sempre
esseri umani. Direi che è la condizione umana a diventare
centrale nel racconto.
Purtroppo, a distanza di settant'anni, molte delle protagoniste
sono morte e alcune non sono più in grado di trasmettere
la loro testimonianza. Non è più possibile scrivere
una storia orale della Resistenza femminile nelle sue più
varie articolazioni. Ma è importante che delle superstiti
si sia voluto raccogliere la testimonianza, perché in
una storia corale quale fu quella della Resistenza è
attraverso le diverse storie di vita – e i tanti episodi
particolari che ognuna può narrare – che possono
emergere la ricchezza, la complessità e anche la semplicità
di quel movimento e, insieme, i suoi momenti di forza e quelli
di debolezza, le difficoltà, anche le tragedie, accanto
al coraggio morale per farvi fronte. Resistere significò
anche capacità di continuare a resistere e, dunque,
richiese tenacia, fermezza, perseveranza al fine di non subire
l'oppressione e di uscire da quel tunnel di morte per vedere
finalmente la luce in un mondo rinnovato.
Prezioso è dunque il lavoro di Iara Meloni, che con grande
sensibilità riesce a restituirci uno spaccato della Resistenza
facendo parlare le protagoniste, inserendole nel contesto di
quei mesi e al contempo ricostruendo un nuovo e più articolato
contesto sia riguardo alla stessa Resistenza sia al periodo
più generale che quelle vite hanno attraversato. Così
si aprono squarci anche sulla società fascista, sul dopoguerra
e sui decenni successivi fino a oggi.
La storia delle donne della Resistenza è una storia di
rimozioni e di silenzi, ma è anche una storia di ripresa
della parola, davanti a una nuova generazione che vuole sapere
e ha capacità di ascolto.
Ero partita con l'osservazione che questo libro parla della
Resistenza del 1943-1945 ma parla anche delle resistenze successive
al 1945. Se a metà degli anni Sessanta si assiste a un
tentativo di valorizzare l'esperienza femminile nella Resistenza,
è solo un decennio dopo che quell'esperienza viene rivendicata
addossando la responsabilità del silenzio sulle donne
ai loro stessi compagni, che le avevano rese irrilevanti ponendo
se stessi sul proscenio. Significativamente si intitolava La
Resistenza taciuta il libro curato da Anna Maria Bruzzone
e Rachele Farina che raccoglieva dodici testimonianze di partigiane
piemontesi (e che uscì nel 1976).
Ora, nel nuovo secolo, le donne della Resistenza non sono più
avvolte dal silenzio, ci dice Iara Meloni. Anche in provincia
di Piacenza, territorio ad «alta densità partigiana»
ma che non aveva conosciuto uno sviluppo di analisi sulla presenza
femminile, sono stati avviati e portati a termine negli anni
Duemila progetti di ricerca, di didattica e di divulgazione
centrati sull'argomento. Un'operazione culturale di grande rilevanza,
che ha consentito il riannodarsi del filo tra le generazioni.
La retorica della Resistenza, da un lato, la delegittimazione
della Resistenza in atto dagli anni Ottanta, dall'altro, stavano
congiurando a rendere trascurabile quel movimento, a espungerlo
dalla nostra storia. Le resistenze dei resistenti e delle resistenti
e soprattutto le resistenze di chi è nato e nata dopo
hanno consentito che il significato della Resistenza non andasse
perduto: fili più esili agli inizi, fili più robusti
successivamente, grazie a quell'«educazione alla memoria»
che congiunge le generazioni, instaura nuovi legami comunitari
e permette una nuova prospettiva sul mondo, mentre risarcisce
le donne della Resistenza sottraendole al silenzio e alla solitudine
che le avevano attorniate per tanti e tanti anni, e rendendole
altresì consapevoli del valore del loro ruolo nel 1943-1945.
Anche di questo parla questo libro, un libro ricco, complesso,
importante che, per di più, costituisce un tassello,
e non piccolo, di quell'educazione alla memoria che si inscrive
nella cultura della Resistenza.
C'è da apprendere, c'è da riflettere. Specialmente
sul domani, quando non ci saranno più i protagonisti
a testimoniare.
Il libro di Iara Meloni offre un contributo anche in questa
direzione.
Daniella Gagliani
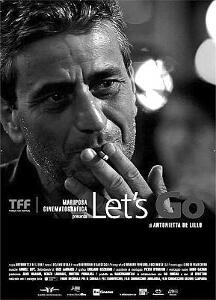 Scivolamento
sociale
verso gli inferiPresentato a Napoli, Let's go (Mariposa Cinematografica,
2014, 55 min.) è, in ordine di tempo, l'ultimo docu-ritratto
della regista Antonietta De Lillo e racconta la caduta agli
inferi di un esodato speciale: il fotografo e regista Luca Musella.
“Se fossi rimasto borghese mi sarei suicidato”.
Le parole del fotoreporter Musella nel docu-ritratto di Antonietta
De Lillo sono quasi il testamento di come una vita possa andare
in rovina e ritrovare (nella stessa rovina) un'ancora di salvataggio.
Musella, attraverso la diretta testimonianza e un suo testo-lettera
(ma la voce è dell'attore Roberto Di Francesco), affronta
un viaggio dalla sua Napoli a Milano, città dove attualmente
vive, narrando come da fotoreporter di successo (ha lavorato
per L'espresso, Agenzia Grazia Neri, Contrasto) e scrittore
e regista stimato (è suo un bel documentario di qualche
anno fa su Giorgio Bocca) sia passato ad una condizione di assoluta
precarietà. La sua è la parabola di un “esodato
professionalmente ed emotivamente” che ha perso tutto,
ma non certamente la dignità e la tenacia per provare
la risalita. Una storia di solitudine e disagio dove Musella
è portavoce di una condizione che non appartiene solo
a lui, ma che affligge tanta umanità di ogni parte del
mondo. Presentato al Cinema Astra di Napoli (dopo l'anteprima
all'ultimo Festival di Torino), Let's go è uno
di quei docu-ritratti con cui Antonietta De Lillo - come dimostrano
anche i suoi due precedenti lavori sulla poetessa Alda Merini
- è diventata una vera esperta del genere: la sua macchina
da presa avvicina una persona e la lascia libera di raccontarsi
senza interferenze anche per scoprire una linea oltre confine.
Infatti, il lavoro della De Lillo nasce sì per narrare
lo scivolamento sociale di Luca Musella, ma pure per mettere
allo scoperto un lato debole della società: l'incapacità
della collettività a sostenere chi si trova a vivere
in uno stato di disagio. Prodotto da Marechiarofilm insieme
a Rai Cinema, musicato da Daniele Sepe e fotografato da Giovanni
Piperno, Let's go è uno sguardo per nulla indiscreto
in un dramma personale che, sorprendendo, lascia sulla sua scia
semi di commovente fiducia.
Mimmo Mastrangelo
Fatta l'Italia,
schediamo gli italiani
 Il
libro di Andrea Dilemmi, Schedare gli italiani. Polizia e
sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963 (Cierre,
Sommacampagna – Vr, 2013, pp. 560, € 24,00) prende
in esame i documenti prodotti dalla polizia per sorvegliare
gli oppositori politici da fine Ottocento ai primi anni Sessanta
del Novecento, e li utilizza come fonte per studiare non gli
oppositori ma gli apparati di controllo. Il Casellario politico
centrale, istituito presso il Ministero degli Interni da Crispi
nel 1894 arriva ai primi anni Sessanta, ma nello stesso arco
di tempo ogni questura italiana ebbe il proprio casellario provinciale:
Dilemmi prende in esame quello di Verona. La serie archivistica
oggetto della ricerca è formata dai fascicoli degli individui
“radiati” (cioè di quelli per cui si disponeva
la fine della sorveglianza), e quindi è il risultato
di uno scarto effettuato verso la fine del funzionamento dello
schedario stesso: tuttavia, con le avvertenze di cui l'autore
è consapevole, è sufficientemente ampio e rappresentativo
per un'analisi della sorveglianza politica esercitata dalla
polizia. Il
libro di Andrea Dilemmi, Schedare gli italiani. Polizia e
sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963 (Cierre,
Sommacampagna – Vr, 2013, pp. 560, € 24,00) prende
in esame i documenti prodotti dalla polizia per sorvegliare
gli oppositori politici da fine Ottocento ai primi anni Sessanta
del Novecento, e li utilizza come fonte per studiare non gli
oppositori ma gli apparati di controllo. Il Casellario politico
centrale, istituito presso il Ministero degli Interni da Crispi
nel 1894 arriva ai primi anni Sessanta, ma nello stesso arco
di tempo ogni questura italiana ebbe il proprio casellario provinciale:
Dilemmi prende in esame quello di Verona. La serie archivistica
oggetto della ricerca è formata dai fascicoli degli individui
“radiati” (cioè di quelli per cui si disponeva
la fine della sorveglianza), e quindi è il risultato
di uno scarto effettuato verso la fine del funzionamento dello
schedario stesso: tuttavia, con le avvertenze di cui l'autore
è consapevole, è sufficientemente ampio e rappresentativo
per un'analisi della sorveglianza politica esercitata dalla
polizia.
La prima figura di poliziotto che viene presentato è
Ernesto Carusi, che a poco meno di trent'anni arrivò
nel 1888 da Salerno a Verona, dove rimase fino a quando diventò
questore, proprio agli inizi del regime fascista. La sua “capacità
di dialogare con gli esponenti socialisti e con i responsabili
del sindacato, di promuovere mediazioni, di prevenire e depotenziare
le tensioni senza dover necessariamente fare uso della forza”
(pp. 109-110) ne fa un modello di “poliziotto giolittiano”,
in sintonia cioè con le direttive del sistema di governo
di allora in tema di gestione dell'ordine pubblico. Il clima
del primo dopoguerra, segnato dalla violenza fascista e da conflitti
sociali molto aspri, mette fuori gioco ogni tentativo di mediazione,
tanto che nell'estate 1922 Carusi chiede un congedo per malattia,
per andare in pensione pochi mesi dopo, quando a Roma si è
instaurato il nuovo governo Mussolini.
La seconda figura è il commissario politico Primo Palazzi,
di Narni, che arriva a Verona nel 1926 all'età di quarantaquattro
anni. Esempio di poliziotto fascista (anche in questo caso,
non tanto per le sue convinzioni personali quanto per il modo
di agire in sintonia con il clima dittatoriale e le direttive
del regime), Palazzi comincia con il dirigere la squadra politica
della Questura, mettendo in piedi una rete di confidenti e fiduciari
e adoperandosi a scoprire associazioni di oppositori politici
(a volte fabbricando prove o esagerando l'importanza delle scoperte).
Esempio di “cacciatore di antifascisti” (p. 186),
dopo la caduta del regime il 25 luglio 1943 Palazzi chiede un
periodo di riposo presentando una prescrizione del suo medico:
una prassi non nuova per i funzionari di polizia, come abbiamo
visto per Carusi, nei periodi di forte instabilità politica.
Grazie all'assenza dalla scena nel periodo della RSI, Palazzi
ritorna in servizio dopo la Liberazione, diventando questore
di prima classe nel 1946 (con la Repubblica), per andare in
pensione l'anno dopo, suscitando il “vivo rincrescimento”
di DC, PSI e PCI per la cessazione dal servizio di un uomo di
“elevato senso del dovere” (p. 212).
A Liberazione avvenuta si forma per un breve periodo, anche
a Verona, un corpo speciale di polizia formato da ex partigiani,
mentre viene costituita una Corte di Assise straordinaria per
individuare e perseguire i fascisti colpevoli di crimini. In
questo periodo, tra il 1945 e il 1947, quasi tutti i nuovi fascicoli
aperti nel casellario politico riguardano fascisti, “caso
unico nella storia del dispositivo” (p. 268). Ma questa
fase si esaurisce già nei primi mesi del 1946, per chiudersi
in seguito all'amnistia concessa da Togliatti, allora ministro,
nel giugno di quell'anno. Nel frattempo il personale di polizia
rimane invariato: “Sciolta la polizia partigiana, viene
riattivata la tradizionale catena di comando e si modificano
nuovamente gli obiettivi della sorveglianza” (p. 270).
Dopo aver ripercorso le vicende in ordine cronologico, il libro
analizza nella seconda parte “il dispositivo della sorveglianza
[...] nei suoi diversi aspetti” (p. 273): uffici, struttura,
organici, attività e competenze della questura di Verona.
Risulta così che i due terzi dei fascicoli vengono aperti
durante il ventennio fascista, con un picco nel 1925, anno “spartiacque
tra una sorveglianza individualizzata ed episodica e una, invece,
sistematica e costante” (p. 310). L'altro picco numerico
di apertura dei fascicoli si registra nel 1945, questa volta
a carico di fascisti, ma, come si è detto, il fenomeno
si esaurisce subito. I fascicoli durano in media ciascuno 25
anni: in pratica seguono l'individuo fino ai 45-50 anni, ma
in alcuni casi di più (pp. 313-314). A iniziare la sorveglianza
sono gli apparati dello Stato: questure, stazioni di carabinieri,
comandi militari, uffici addetti alla censura postale (l'intercettazione
delle lettere durante il fascismo è “uno strumento
quotidiano”, p. 344); durante il fascismo si aggiungono,
oltre alle articolazioni del partito fascista, anche singoli
cittadini, all'opera soprattutto nei luoghi di lavoro e del
tempo libero, quando la delazione, a volte per rancori o vendette
personali, diventa “uno strumento cardine di controllo
sociale” (p. 503). Da una sorveglianza “circoscritta
a un numero relativamente ristretto di soggetti ritenuti e pericolosi”
all'inizio del Novecento, si passa così, con il fascismo,
a una sorveglianza che riguarda “tendenzialmente, l'intera
società” (p. 394). All'interno di queste pratiche
di controllo totale dell'intero corpo sociale, Dilemmi ricorda
che fu il regime fascista, nel 1926, a rendere obbligatoria
la carta d'identità per le persone sospette e pericolose,
e a estendere poi l'obbligo a tutti con il Testo unico di pubblica
sicurezza nel 1931 (p. 357).
La terza parte del libro riguarda i sorvegliati. Sono quasi
tutti uomini: secondo la polizia, “le donne non solo non
si occupano di politica, ma non sono nemmeno in grado di farlo”
(p. 398). Quanto alle idee politiche, fino al 1924 i sorvegliati
sono anarchici e in misura minore socialisti; dal 1925 sono
soprattutto comunisti (”comunista” diventa “quasi
sinonimo di sovversivo”, p. 489), che nei primi decenni
dell'Italia repubblicana costituiscono il gruppo più
sorvegliato.
Merito del libro è di confermare, grazie a un'indagine
minuziosa, la continuità degli apparati statali e delle
pratiche di controllo di polizia in Italia dall'Unità
alla Repubblica. Altra continuità, questa volta di lunga
durata, si può cogliere nel permanere di alcuni caratteri
del profilo del “sovversivo”: la polizia continua
infatti ad andare a caccia del vecchio “untore”,
che però a differenza di quello seicentesco diffonde
nella società non più il germe della peste ma
quello della protesta e della ribellione (p. 533). La polizia
politica inoltre – e questo emerge bene nel libro –
mantiene un residuo del vecchio ruolo di mediazione volto a
disciplinare la società, grazie alla segretezza del suo
comportamento (che i documenti non registrano, al pari della
violenza esercitata, che si può solo intuire). Anche
in un “contesto tendenzialmente totalitario” la
polizia può infatti offrire al sovversivo “una
riconciliazione con lo Stato, a condizione che abbandoni ogni
velleità di dissenso e abbracci, pubblicamente, la causa
fascista” (p. 504), e più in generale, si capisce,
il comportamento di buon cittadino. Tutto questo è riassunto
con efficacia nel titolo del libro Schedare gli italiani,
che suggerisce una nuova versione del celebre detto risorgimentale:
“Fatta l'Italia, bisogna schedare gli italiani”.
Piero Brunello
Non un eroe,
ma un essere umano
 Leggendo
il Libro di Olga Focherini Questo ascensore è vietato
agli ebrei (Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, pp. 144,
€ 12,00) in cui racconta la breve e tragica vita del padre
Odoardo, che si adoperò con tutte le forze per salvare
ebrei nel periodo della repubblica di Salò e dell'occupazione
nazista del nostro paese, ho compreso che Odoardo, che talora
nelle lettere dalla prigionia si firmava Odo, era un uomo normale,
non un eroe, non un eletto, ma un uomo innamorato della moglie
e che adorava i suoi figli. Odoardo trovò normale rischiare
la propria vita e accettare il martirio fino alla morte che
gli derivò dall'impegno, dall'attivismo, testimoniando
che l'urgenza di tendere la mano al più debole, all'oppresso,
in sostanza, al prossimo perseguitato, non insorge da uno stato
di eccezionalità, ma piuttosto da un impulso di insopprimibile
umanità. Leggendo
il Libro di Olga Focherini Questo ascensore è vietato
agli ebrei (Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, pp. 144,
€ 12,00) in cui racconta la breve e tragica vita del padre
Odoardo, che si adoperò con tutte le forze per salvare
ebrei nel periodo della repubblica di Salò e dell'occupazione
nazista del nostro paese, ho compreso che Odoardo, che talora
nelle lettere dalla prigionia si firmava Odo, era un uomo normale,
non un eroe, non un eletto, ma un uomo innamorato della moglie
e che adorava i suoi figli. Odoardo trovò normale rischiare
la propria vita e accettare il martirio fino alla morte che
gli derivò dall'impegno, dall'attivismo, testimoniando
che l'urgenza di tendere la mano al più debole, all'oppresso,
in sostanza, al prossimo perseguitato, non insorge da uno stato
di eccezionalità, ma piuttosto da un impulso di insopprimibile
umanità.
Olga Focherini, figlia di Odo e madre del curatore del testo,
Odoardo Semellini, spinta dalla forza della verità, si
è resa depositaria dell'epistolario del padre, per guidarci
nella vicenda emblematica e nella storia di un uomo come tanti,
non un eroe, non un eletto, ma un giusto che deve trovare un
posto nella memoria di tutti noi. Nel libro si narra la storia
di un uomo arrestato e deportato, con l'unica colpa di aver
posto in salvo oltre un centinaio di perseguitati ebrei. Una
storia con un finale terribile, raccontato per anni dalla figlia
Olga che, vittima e testimone giovanissima, conserva ancora
una memoria vivissima di quel periodo, testimoniando nelle scuole
e ovunque venga richiesta ricostruzione della memoria storica,
superando così una difficoltosa e traumatica elaborazione
del lutto paterno.
Della storia di suo padre, Olga lascia traccia in diversi documenti,
opportunamente trascritti e quindi adattati per il presente
volume, tutti custoditi nell'Archivio della Memoria di Odoardo
Focherini.
Nella trascrizione delle lettere clandestine, Olga scopre che
suo padre è un uomo normale, come tutti, che si lascia
andare, che sta male, che piange, che è combattuto tra
le speranze del ritorno e il timore di non rivedere mai più
i propri cari. Così la figlia Olga recupera l'immagine
vera e reale del padre, come lo ricorda nella sua infanzia:
un uomo giusto, sia per l'aiuto dato agli ebrei perseguitati,
sia per quello che è stato come genitore. Odoardo Focherini,
negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, faceva parte
di una rete clandestina di soccorso in provincia di Modena,
per aiutare gli ebrei perseguitati dal nazifascismo, insieme
ad altri uomini di diversa appartenenza politica e fede religiosa,
che non esitarono a sacrificare la propria vita per salvare
centinaia di persone, altrimenti destinate alla morte nei campi
di concentramento e di sterminio nazifascisti.
Odoardo Focherini (1907-1944) era un giornalista cattolico e
padre di sette figli. Venne arrestato, deportato e trovò
la morte nel campo di lavoro di Hersbruck. Viene raccontato,
in questo libro, dalla figlia primogenita Olga, che dagli anni
'70, ha svolto un'intensa attività di divulgazione nelle
scuole sui temi della deportazione e della Resistenza, dando
così vita all'Archivio della Memoria di Odoardo Focherini.
Nella prefazione al testo, Moni Ovadia ricorda e rievoca la
memoria di padre David Maria Turoldo, sacerdote cattolico, partigiano
e poeta, che custodiva le lettere dei condannati a morte della
Resistenza italiana e europea. Ed è proprio con queste
lettere, testimonianza di resistenza e deportazione, che Moni
Ovadia richiama un importante parallelismo con l'ingente epistolario
di Focherini, un grande patrimonio storico di documenti, scritti,
lettere, che tutti noi dobbiamo tenere presente sempre, nel
corso della vita e in ogni momento che scandisce i nostri giorni
di lotta per la pace, per un mondo più giusto, libero
e vero, nella testimonianza antifascista e nell'impegno sociale
e civile, tramite la forza della verità, per la memoria
storica... per non dimenticare.
Laura Tussi
Zolfatari e contadini/
Due sguardi sulla Sicilia dei primi del '900
 Due
narrazioni molto diverse, una letteraria, l'altra fotografica,
“leggono” con mirabile acume, la medesima realtà:
quella della provincia di Enna della prima metà del secolo
scorso. Nella Sicilia degli anni cinquanta, nel suo ombelico
e centro geografico, nelle terre dell'ennese o meglio nel sottosuolo
profondo e buio delle sue miniere di zolfo, prende corpo la
storia che racconta Davide Orecchio nel suo Stati di grazia
(Il saggiatore, Milano, 2014, pp. 320, €16,00), un romanzo
bello e impegnativo, dal contenuto forte e dalla scrittura incisiva
e originale, perché - si dice bene nel risvolto di copertina
- è “lucida e meravigliata, ipnotica e visionaria,
innervata di continui cambiamenti di ritmo, pause riflessive
e accelerazioni vertiginose”. Unendo sapientemente il
metodo dello storico e del detective, con il talento e la tecnica
del bravo narratore, Orecchio racconta la vita agra di un maestro
elementare di Enna che precipita verso una desolata e amara
cupezza, quando apprende della tragica sorte capitata ad un
suo alunno, costretto dalla miseria e dalla fame a lasciare
lo studio (verso cui è avvezzo) per aiutare il padre
in miniera, dove muore, travolto dalla caduta di un enorme masso.
Il fatto diventa, per il maestro, un'ulteriore e dolorosa occasione
di conoscenza della realtà che lo circonda, di un mondo
del lavoro afflitto e disumano, di cui prende nota nel suo diario:
“ho visto gli uomini scendere nelle tonsille di Sicilia,
a cinquecento metri da quassù, a mille”; “chiestomi
come sia fatto un inferno, di che colore sia e quanti inferni
ci sono. Risposto che l'inferno è il camaleonte, e se
ha un nome si chiama Sicilia”. Sempre più estraneo
ai suoi familiari (moglie e figlia che sente distanti e diverse)
e impotente rispetto ad una realtà che gli appare difficile
e immodificabile, perché collocata in un territorio interno,
remoto, duro e ostile alla presenza umana ( “al tramonto
salito sulla torre del castello di Enna e dalle sue fessure
guardato verso le valli tristi di Caltanissetta una terra che,
si tratti di un aratro o del passo di un uomo, ostacola il cammino”),
il maestro cerca nella miniera Zambulio, ad Assoro, il padre
del suo piccolo alunno morto. A lui consegna un biglietto di
viaggio per l'Argentina, che aveva comprato per sé, quando
il desiderio di cambiare vita s'era fatto in lui irreprimibile
e a tutti aveva detto che sarebbe andato via, per un viaggio
senza ritorno. Due
narrazioni molto diverse, una letteraria, l'altra fotografica,
“leggono” con mirabile acume, la medesima realtà:
quella della provincia di Enna della prima metà del secolo
scorso. Nella Sicilia degli anni cinquanta, nel suo ombelico
e centro geografico, nelle terre dell'ennese o meglio nel sottosuolo
profondo e buio delle sue miniere di zolfo, prende corpo la
storia che racconta Davide Orecchio nel suo Stati di grazia
(Il saggiatore, Milano, 2014, pp. 320, €16,00), un romanzo
bello e impegnativo, dal contenuto forte e dalla scrittura incisiva
e originale, perché - si dice bene nel risvolto di copertina
- è “lucida e meravigliata, ipnotica e visionaria,
innervata di continui cambiamenti di ritmo, pause riflessive
e accelerazioni vertiginose”. Unendo sapientemente il
metodo dello storico e del detective, con il talento e la tecnica
del bravo narratore, Orecchio racconta la vita agra di un maestro
elementare di Enna che precipita verso una desolata e amara
cupezza, quando apprende della tragica sorte capitata ad un
suo alunno, costretto dalla miseria e dalla fame a lasciare
lo studio (verso cui è avvezzo) per aiutare il padre
in miniera, dove muore, travolto dalla caduta di un enorme masso.
Il fatto diventa, per il maestro, un'ulteriore e dolorosa occasione
di conoscenza della realtà che lo circonda, di un mondo
del lavoro afflitto e disumano, di cui prende nota nel suo diario:
“ho visto gli uomini scendere nelle tonsille di Sicilia,
a cinquecento metri da quassù, a mille”; “chiestomi
come sia fatto un inferno, di che colore sia e quanti inferni
ci sono. Risposto che l'inferno è il camaleonte, e se
ha un nome si chiama Sicilia”. Sempre più estraneo
ai suoi familiari (moglie e figlia che sente distanti e diverse)
e impotente rispetto ad una realtà che gli appare difficile
e immodificabile, perché collocata in un territorio interno,
remoto, duro e ostile alla presenza umana ( “al tramonto
salito sulla torre del castello di Enna e dalle sue fessure
guardato verso le valli tristi di Caltanissetta una terra che,
si tratti di un aratro o del passo di un uomo, ostacola il cammino”),
il maestro cerca nella miniera Zambulio, ad Assoro, il padre
del suo piccolo alunno morto. A lui consegna un biglietto di
viaggio per l'Argentina, che aveva comprato per sé, quando
il desiderio di cambiare vita s'era fatto in lui irreprimibile
e a tutti aveva detto che sarebbe andato via, per un viaggio
senza ritorno.
Il padre che ha perso il figlio prende il biglietto e parte:
“A trent'anni saluta i suoi morti, il nero della valle
di Enna, il lezzo dell'antimonio e spreme i ricordi sul labbro
ed è già buio, si getta dal buco dov'è
cresciuto verso il passaggio della vecchia vita che guida alla
nuova col nome nuovo, sente la spinta, il travaglio nasce e
niente più argano, calcherone, fiato della discenderia,
ustioni sul corrimano, punte di trapano, scoppi della dinamite,
nudità sotto terra perché lascia l'isola e raggiunge
Napoli”. Da lì, dopo lungo viaggio, sarà
a Mendoza, in Argentina: lo aspetta ancora lavoro duro e sfruttamento.
Ed è l'inizio di un'altra storia e di altre vicende umane
e politiche, che Davide Orecchio intreccia in una girandola
narrativa, varia e appassionante, di personaggi ed eventi che
si svolgono nel tempo lungo del '900 e sullo sfondo dell'Argentina
dei campi di zucchero e dello sfruttamento degli emigranti,
della dittatura, di Peron e dei desaparecidos, ma anche dell'Italia
e delle lotte sociali e politiche degli anni '70, per concludersi
comunque, il tutto, nuovamente in Sicilia, a Enna, dove nulla
s'è più saputo del maestro, ufficialmente all'estero,
lontano. Tutt'altra, sorprendente e tragica verità, svelerà,
invece, la conclusione del romanzo.
 Romanzo
da leggere magari avendo in mano il bel volume, curato da Arnaldo
Bonzi, che raccoglie le fotografie di Giovanni Pozzi Bellini,
Viaggio in Sicilia (Squilibri edizioni, Roma, 2014, pp.
144, €40,00). L'album d'immagini di Pozzi Bellini mostra
infatti i luoghi siciliani da cui parte la storia di Orecchio:
i paesi, le campagne, le miniere dell'ennese. Romanzo
da leggere magari avendo in mano il bel volume, curato da Arnaldo
Bonzi, che raccoglie le fotografie di Giovanni Pozzi Bellini,
Viaggio in Sicilia (Squilibri edizioni, Roma, 2014, pp.
144, €40,00). L'album d'immagini di Pozzi Bellini mostra
infatti i luoghi siciliani da cui parte la storia di Orecchio:
i paesi, le campagne, le miniere dell'ennese.
Nella Sicilia dei primi anni del '40 Giacomo Pozzi Bellini,
promettente cineasta fiorentino, vi approdò, per girarvi
un film. Aveva ricevuto incarico, da un illuminato e colto direttore
del Ministero dell'Agricoltura, di filmare, con obiettività
e senza pretese propagandistiche, la colonizzazione dei latifondi
siciliani voluta da Mussolini. Il film (il cui soggetto doveva
scrivere lo scrittore ennese Nino Savarese), a seguito di intricate
vicende, non venne mai neanche iniziato: ma durante i viaggi
nell'isola, preparatori alla realizzazione della pellicola,
Bellini realizzò più di centocinquanta immagini
che mostrano i luoghi desolati e arsi della Sicilia interna
- e della campagna ennese in particolate - e i volti, scavati
e duri, dei contadini che la abitano lavorando in terreni quasi
mai floridi e generosi. Sono il ritratto di una Sicilia, antica
e sperduta, fatta, come scriveva in quegli anni Savarese, di
''paesi di sapore classico e rurale, impervi e alla mano, casalinghi
e con quel tanto che basti di moderno; con le loro badie centenarie,
le stradette confidenziali, le famose fiere e le feste agricole
del calendario e l'aria fine; senza pretendere assolutamente
di diventare come le solite città, rumorose, meccaniche
e barocche, pieni di montature e di specchietti”. Nello
scorrere delle foto, stampate tutte in un formato grande e di
sicura presa artistica perché sapiente è la padronanza
tecnica del mezzo che possedeva Pozzi Bellini, prende forma,
in affascinante bianco e nero, la vita dei villaggi, con le
sue presenze umane, il lavoro nei campi (la mietitura del grano,
la trebbiatura), il mondo delle zolfare, la fiera del bestiame
a Enna. A più di settant'anni, le foto di Pozzi Bellini
- che piacquero a Vittorini, a Consolo e ad Enzo Sellerio, che
ebbero modo di vederle ma che solo ora vengono pubblicate in
volume - ci aiutano a capire le contraddizioni della Sicilia
di quegli anni: come scrive nell'introduzione al volume Domenico
Ferraro, l'obiettivo di Pozzi Bellini coglie le ''contrapposizione
tra la semplicità, la saggezza e anche il disincanto
delle popolazioni rurali e la vita artefatta, vuota e spersonalizzante
delle città, mostrando una visione della natura, però,
tutt'altro che consolatoria perché accanto alla sua raffigurazione
come riparo dalle brutture e dai guasti della modernità
c'è anche l'attestazione della sua componente infernale
che, oltre si esprime nei paesaggi ricolmi di fumi e vapori
delle zolfare” e nelle immagini del lavoro, duro e sfruttato,
dei contadini. Inoltre, le foto di Pozzi Bellini che ritraggono
i vicoli, le piazze, gli slarghi, le case di tanti paesi dell'interno,
documentano, certo, le architetture sicuramente povere di un
tempo ma rivelano anche come queste fossero animate, intrise
di umanità e socialità; insomma ci rendono luoghi
che, nella loro diversa e caratterizzata identità locale,
nella loro cultura materiale, contadina e rurale, appaiono oggi
molto lontani dalle caratteristiche attuali che hanno assunto
e che non sempre sono di segno positivo, soprattutto laddove
lo sviluppo non è stato ancorato alla trasformazione
qualitativa dei lavori tradizionali (ma è stato favorito
da un' economia assistita e slegata dalla risorse del territorio)
e dove non si è pensato alla difesa dei centri storici
(che si sono svuotati a seguito di un' espansione edilizia incontrollata
che ha prodotto agglomerati abitativi moderni ma periferici
e anonimi). Le foto di Pozzi Bellini ci permettono quindi di
gettare uno sguardo al recente passato della Sicilia, offrendosi
come stimolo ad una più approfondita valutazione sulla
''modernità” del suo presente o forse sul sogno
di una modernità che ha sacrificato, in nome di un indefinito
'sviluppo', un ritmo antico e lento di produzione e di vita;
un sogno di una Sicilia moderna che oggi, peraltro, s'è
infranto sui crolli e le frane della sua rete autostradale,
simboli ultimi ed eloquenti delle ferite sempre aperte della
sua precarietà.
Silvestro Livolsi
Un comunista
sui generis
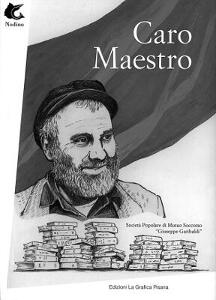 Un
anno fa, il 23 aprile 2014, moriva prematuramente a 63 anni,
nella sua casa di Ponte a Moriano, Francesco Giuntoli da molti
conosciuto come il “maestro”. Molti cittadini comuni
insieme ai parenti, agli amici, ai compagni di partito, ai sindacalisti
e ad alcuni anarchici dettero il 25 aprile, in forma civile,
l'ultimo saluto commosso, solidale e dolente all'uomo, al militante,
all'amico. Un
anno fa, il 23 aprile 2014, moriva prematuramente a 63 anni,
nella sua casa di Ponte a Moriano, Francesco Giuntoli da molti
conosciuto come il “maestro”. Molti cittadini comuni
insieme ai parenti, agli amici, ai compagni di partito, ai sindacalisti
e ad alcuni anarchici dettero il 25 aprile, in forma civile,
l'ultimo saluto commosso, solidale e dolente all'uomo, al militante,
all'amico.
Un anno dopo, gli stessi protagonisti di quell'evento si sono
riuniti al Foro Boario di Lucca in una manifestazione nella
quale hanno voluto rendere omaggio a Francesco, e nell'occasione
è stato presentato il libro Caro Maestro (Edizioni
La Grafica pisana - Società popolare di Mutuo soccorso
G. Garibaldi, 2015, pp. 177, €13,00).
Ma chi era Francesco Settimo Giuntoli? Nasce a Ponte a Moriano
il 28 giugno 1951, da Angela e Giovanni, che gli daranno altri
due fratelli. Dal padre, piccolo commerciante e dirigente sportivo
della squadra di “Saltocchio” e poi della “Lucchese
F.C.”, eredita un pratico buon senso dell'economia quotidiana
e la grande passione per il calcio, mentre dalla madre apprende
l'amore per le radici del mondo contadino e la sua cultura.
Ponte a Moriano è una frazione di Lucca, popolosa e operosa,
dove da sempre vi è un forte insediamento operaio. La
realtà territoriale avrà un forte impatto nella
formazione politica e culturale di Francesco ed è grazie
alla frequentazione con l'ambiente locale e poi in quello studentesco
della fine degli anni Sessanta che egli matura la sua scelta
politica antifascista e comunista. Dopo una prima fase nella
quale frequenta l'ambiente dei gruppi dell'estrema sinistra
lucchese, a metà degli anni Ottanta aderisce a Democrazia
proletaria e quando quest'ultima si scioglie aderirà
al Partito della Rifondazione comunista, assumendo nel 1994
l'incarico di segretario provinciale. Va detto che la sua permanenza
in Rifondazione comunista non sarà continua, uscirà
dal partito quando la direzione guidata da Bertinotti abbraccerà
la scelta politica filo governativa. Rientrerà nel partito
solo nel 2008, con la segreteria Ferrero, a seguito del Congresso
di Chianciano
Nel 2009 costituisce, insieme ad altre compagne e compagni,
soprattutto giovani e immigrati, la Società popolare
di Mutuo soccorso “Giuseppe Garibaldi”, con lo scopo
di riproporre il mutualismo come strumento di lotta, resistenza
e crescita politica contro la grave crisi economica e politica
che investe il nostro paese. Ricoprirà fino alla morte
il ruolo di presidente della “Garibaldi”.
Questo in sintesi l'aspetto politico della figura di Francesco,
ma esiste un altro aspetto, forse meno conosciuto in ambiente
militante, ma che ha fatto dell'uomo una persona amata e stimata
dall'intera comunità del suo territorio, quella del maestro
elementare. Francesco inizia la sua attività di maestro
alla fine degli anni Settanta insegnando in molte scuole della
provincia di Lucca e avviando con i propri alunni un rapporto
profondo che si manterrà anche negli anni seguenti. Francesco
concepisce il ruolo di educatore, come una “figura antica”
depositaria di sensibilità e cultura umanista. Alcune
generazioni di alunni hanno trovato in lui un creativo pronto
a inventarsi percorsi didattici ricchi di stimoli e approcci
culturali volti alla formazione dell'individuo libero da pregiudizi.
Francesco era anche un lettore accanito, un amante della cultura
e della storia, e pur partendo da una formazione comunista non
esprimeva una concezione settaria della politica, tanto che
era sempre pronto a confrontarsi e a ideare iniziative dove
idee e culture politiche della sinistra potessero trovare momenti
di positiva contaminazione comune. In questa dimensione Francesco
incontra gli anarchici di cui era affascinato. Era uno dei pochi
coerenti comunisti che il Primo maggio preferiva andarlo a festeggiare
a Carrara partecipando al corteo degli anarchici, dove secondo
lui maggiormente si sentiva il vero spirito arcaico della festa
dei lavoratori, piuttosto che ad altre iniziative legate al
mondo sindacale e/o politico della sinistra.
Ciò che attraeva maggiormente Francesco verso l'utopia
anarchica era forse l'essenza stessa delle sue contraddizioni:
l'essere un'idea esagerata di libertà che si dipana tra
un istinto antropologico distruttivo dell'ordine esistente e
una spasmodica ricerca della costruzione di una nuova società.
Una contraddizione che Pier Carlo Masini, storico dell'anarchismo,
così raffigura: “Una volta un giudice che gli chiedeva
di definire in poche parole il suo ideale politico, un anarchico
rispose con spirito biblico che per lui l'anarchia era l'arca
di Noè senza Noè. Ma un altro anarchico subito
protestò che quello era riformismo e che semmai l'anarchia
era il diluvio universale senza l'arca. In questo scontro di
battute si fronteggiano le due anime dell'anarchismo, quella
ottimista e razionale e quella romantica e nichilista, le
siècle des lumières e lo Sturm und Drang”.
Masini poi continua: “Errico Malatesta nel primo dopoguerra,
a qualcuno che chiedeva forche per i nemici del popolo sulle
piazze, rispondeva che Åese per vincere dovessi innalzare
delle forche, preferirei perdere'. Tutto il pensiero anarchico
vibra fra questi due poli: l'individualismo e la solidarietà,
l'irrazionale e il richiamo della ragione, l'apocalisse e la
salvezza. Anche i colori nei quali gli anarchici amano riconoscersi
sembrano riflettere questi contrastanti stati d'animo: rosso
speranza e nero disperazione. Lo diceva anche Pietro Gori, salutando
l'anno 1905: Che, i proscritti d'ogni patria ... di questa
idea rossa come l'aurora invincibile, e di questo sudario, nero
come la sciagura umana, sappiano farsi la simbolica bandiera
della liberazione”.
Non a caso sono state richiamate le riflessioni di Pier Carlo
Masini perché lo storico toscano fu uno dei principali
protagonisti della bella serata organizzata nel 1992, proprio
da Francesco e dagli amici del Circolo Utopia e dell'Istituto
storico della Resistenza lucchese, per ricordare Carlo Cafiero
in occasione del centenario della morte. Un'occasione quasi
unica nel panorama di allora della sinistra italiana. L'iniziativa,
dal titolo Carlo Cafiero 1892-1992: pensiero e azione nella
Prima Internazionale, si svolse il 18 dicembre nel bel salone
della Villa Bottini e vide la partecipazione di un folto pubblico
attento e appassionato e, al tavolo degli oratori, oltre a Masini
anche Johannes Agnolli, Adriana Dadà e Italino Rossi.
L'interesse per la storia del movimento operaio affascinava
Francesco, il quale non perdeva occasione per richiamare l'attenzione
dei compagni e degli amici sulla necessità di affrontare
le lotte del futuro e del presente per una società egualitaria,
libera e fraterna, avendo ben chiaro il proprio passato e senza
dimenticare le proprie radici, quelle radici plurali e originali
che avevano caratterizzato fortemente la nascita del primo socialismo
italiano.
Francesco, infine, amava moltissimo un altro personaggio dell'anarchia:
Pietro Gori, che riteneva ingiustamente, anche all'interno dello
stesso movimento libertario, troppo presto dimenticato e accantonato.
Questa passione avvicinò Francesco alla Biblioteca Franco
Serantini con cui ha condiviso e promosso molte iniziative proprio
dedicate al “cavaliere dell'ideale”.
Il libro Caro Maestro, che raccoglie 36 testimonianze
sulla vita di Francesco, ci riconsegna per intero la complessa
e ricca figura di un comunista sui generis che amava
il mondo libertario, la sua storia e la sua cultura.
Per richieste rivolgersi a: Studio Bibliografico Pera, Corte
del Biancone, 5 – 55100 LUCCA. Tel. 0583 955824 email:
libreria@pera.it.
Franco Bertolucci
Medardo Rosso...
e Nero
Spirito anarchico e ribelle, anarchico e pacifista, con aspirazioni
di socialismo umanitario e di anarchismo repubblicano, omaccione
anarchico fin nel midollo: nei commenti alla bella mostra La
luce e la materia che la Galleria d'Arte Moderna di Milano,
in collaborazione con il Museo Rosso di Barzio, ha dedicato
a Medardo Rosso si sprecano le declinazioni del termine “anarchico”
per definire la personalità e l'opera del maestro.
Ma da dove viene la fama di anarchico a Medardo Rosso? Forse
più dalle sue inclinazioni e dalle frequentazioni giovanili
che da una sua reale militanza politica. Nato a Torino, si ribella
sin da giovane alla famiglia che intendeva avviarlo alla carriera
ferroviaria e marina la scuola per frequentare come apprendista
la bottega di un marmista. Trasferitosi a Milano, si iscrive
al'Accademia di Brera dove viene dopo poco tempo espulso per
il suo carattere ribelle e per aver malmenato uno studente che
non voleva firmare un appello di protesta da lui stesso redatto.
Il suo stile ed il suo atteggiamento rivoluzionario vengono
profondamente influenzati dal movimento della Scapigliatura
che in quegli anni a Milano in funzione anti-romantica propugnava
un'arte civilmente impegnata, laica ed anti-clericale che si
scagliava contro l'accademismo e la retorica dell'arte monumentale.
Gli scapigliati, vicini agli ambienti anarchici creavano eventi
di critica corrosiva alle istituzioni artistiche dell'epoca.
In contemporanea alle Esposizioni Nazionali ufficiali, ad esempio,
organizzavano le “Indisposizioni di Belle Arti”
con azioni, esposizioni ed happening che anticipano le
provocazioni futuriste ed i ready made delle avanguardie.
Con questo retroterra di ribellismo rivoluzionario Rosso, trasferitosi
a Parigi influenza lo stesso mostro sacro della scultura francese,
Auguste Rodin, che dapprima suo ammiratore ed amico entra con
lui in contrasto dopo che la critica suggerisce un'influenza
del Rosso sulla sua scultura, soprattutto nella famosa imponente
figura del ritratto di Balzac. La modernità di Rosso
sta anche nell'uso della fotografia e della creazione di esposizioni
in cui si mescolano sculture, fotografie ed assemblaggi di oggetti,
anticipando ciò che oggi definiamo “installazione”.
Il Sacrestano realizzato nel 1883, nel suo periodo milanese,
è la testa di un vecchio ubriaco, probabilmente il sacrestano
della chiesa di San Marco, che ha come piedistallo un'acquasantiera
di marmo rosso e una targhetta con la scritta “Indulgenza
plenaria”. Rosso realizzò diverse versioni, in
bronzo e in gesso della scultura, con diverse basi, una delle
quali un vecchio mappamondo. Non solo realizzò anche
una serie di stampe fotografiche con la testa del Sacrestano
appoggiata su una sorta di altare con alle spalle un santino
di Nostra Signora del Sacro Cuore. Sotto l'acquasantiera una
scritta: se la fuss grapa! E tempo dopo, la riproduzione
della stessa fotografia venne esposta con tracce di usura e
macchie di vino e la dedica scritta dell'autore: “Alla
mia amica Signora Rosa Rosso”, un'operazione concettuale
in cui si mescolano il nome dell'autore, il colore rosso della
rosa, fiore dedicato alla Madonna. Laico ed anticlericale rimase
sempre fedele al suo detto: ci vogliono “meno madonne
e più donne” nell'arte.
 Per
Rosso è importante vincolare l'opera di scultura ad un
punto di vista ben preciso, anche per questo crea installazioni
e costringe l'osservatore ad una posizione definita. Le sue
opere seguono più i dettami della pittura che della scultura
tradizionale attorno alla quale si poteva/doveva girare per
una piena comprensione dell'opera. Rosso dichiara di voler affrancare
la scultura dall'antica dipendenza dall'architettura e rifiuta
il lavoro di bottega, di ascendenza rinascimentale, che prevedeva
numerosi collaboratori, come faceva ad esempio ancora Rodin,
per privilegiare la dimensione artigianale ed il lavoro individuale,
escludendo sin dall'inizio la grande dimensione e la tronfia
retorica della statuaria dell'epoca. La scultura di Rosso è
stata anche definita pittura tridimensionale, per la sua scelta
forzata del punto di vista e per il suo tentativo di dare corpo
materiale alla luce di cui ogni corpo, secondo la sua poetica,
è esclusivamente composto. Per questa sua tecnica fu
considerato scultore impressionista e sicuramente il primo grande
moderno che aprì la strada alle sperimentazioni del '900.
Si dice che Edgar Degas, il grande maestro impressionista, davanti
ad una sua opera esclamasse: “Ma questa è pittura!
È Magnifico!” Per
Rosso è importante vincolare l'opera di scultura ad un
punto di vista ben preciso, anche per questo crea installazioni
e costringe l'osservatore ad una posizione definita. Le sue
opere seguono più i dettami della pittura che della scultura
tradizionale attorno alla quale si poteva/doveva girare per
una piena comprensione dell'opera. Rosso dichiara di voler affrancare
la scultura dall'antica dipendenza dall'architettura e rifiuta
il lavoro di bottega, di ascendenza rinascimentale, che prevedeva
numerosi collaboratori, come faceva ad esempio ancora Rodin,
per privilegiare la dimensione artigianale ed il lavoro individuale,
escludendo sin dall'inizio la grande dimensione e la tronfia
retorica della statuaria dell'epoca. La scultura di Rosso è
stata anche definita pittura tridimensionale, per la sua scelta
forzata del punto di vista e per il suo tentativo di dare corpo
materiale alla luce di cui ogni corpo, secondo la sua poetica,
è esclusivamente composto. Per questa sua tecnica fu
considerato scultore impressionista e sicuramente il primo grande
moderno che aprì la strada alle sperimentazioni del '900.
Si dice che Edgar Degas, il grande maestro impressionista, davanti
ad una sua opera esclamasse: “Ma questa è pittura!
È Magnifico!”
I soggetti di Medardo Rosso non sono mai celebrativi o monumentali,
le sue sculture ritraggono gente del popolo, macchiette come
il Gavroche, sottoproletari, come El Looch o La
Portinaia bambini, il Bambino ebreo, il Bambino
malato e il capolavoro del 1897: Bambino alle cucine
economiche. Soggetti colti in momenti della quotidianità,
come La Rieuse, istantanee fotografiche come il Bookmaker
o l'Uomo che legge.
Alcune sue opere “site specific” sono andate perse
nel turbinare di nuove installazioni e di trasferimenti come
Impressione d'omnibus, di cui resta solo una fotografia,
in cui paga tributo al quadro Interno di un omnibus di
uno dei suoi maestri, Honorè Daumier, come lui cantore
della povera gente, ironico e ribelle. Altri suoi maestri furono
Degas e gli impressionisti che conobbe a Parigi, insieme a Emilé
Zola, Gustave Courbet e tanti altri. Nell'ultima parte della
sua produzione Medardo Rosso fu ponte verso le avanguardie ed
in particolare il Futurismo Italiano. Umberto Boccioni nel suo
Manifesto tecnico della scultura Futurista definisce
Medardo Rosso il “solo grande scultore moderno che abbia
tentato di aprire alla scultura un campo più vasto, di
rendere con la plastica le influenze di un ambiente e i legami
atmosferici che lo avvincono al soggetto”.
Franco Bunc¨uga
L'ultima àncora
prima del vuoto
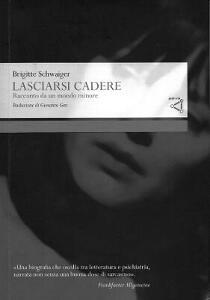 Brigitte
Schwaiger, scrittrice e poetessa austriaca, classe 1949, esordisce
giovanissima, con la sua prima opera Perché il mare
è salato?. Ricompare dopo anni di malattia e cure
psichiatriche con Lasciarsi cadere. Racconto da un mondo
minore (traduzione di Giovanni Giri, Edizioni Gran vía,
Narni – Tr, 2013, pp. 134, € 11,80). Molto più
di un'autobiografia, la scrittura convulsa a tratti liberatoria
di Schwaiger trova spazio nella Collana altrevie, aperta
anche a nonfiction novel, memoir e alle autrici e autori meno
omologati. Brigitte
Schwaiger, scrittrice e poetessa austriaca, classe 1949, esordisce
giovanissima, con la sua prima opera Perché il mare
è salato?. Ricompare dopo anni di malattia e cure
psichiatriche con Lasciarsi cadere. Racconto da un mondo
minore (traduzione di Giovanni Giri, Edizioni Gran vía,
Narni – Tr, 2013, pp. 134, € 11,80). Molto più
di un'autobiografia, la scrittura convulsa a tratti liberatoria
di Schwaiger trova spazio nella Collana altrevie, aperta
anche a nonfiction novel, memoir e alle autrici e autori meno
omologati.
Il racconto da un mondo minore squarcia le ombre che si abbattono
sulla psiche di una donna dalla scorza tenera, fagocitata da
un padre medico, fanatico del lavoro, nazista, molestatore di
bambini. Una nonna sopravvissuta al campo di Theresienstadt
e una madre guardiana della morale, facciata da borghese. Donna
rigida, ostile, chiusa, sempre da assecondare, morirà
suicida a sessant'anni. Intanto, le mortificazioni attanagliano
l'infanzia, un bambino è cattivo se non vuole bene ai
genitori.
In seguito, sensi di colpa per la morte del padre, rimorsi per
avere contratto un matrimonio cattolico non voluto, gli aborti,
un figlio, il divorzio, l'omosessualità repressa confessata
come un delitto. L'indigenza economica e l'umiliazione di una
scrittrice che non riesce più a scrivere, la creatività
trasformata in psicosi. La vergogna di andare per strada sbronza
con il certificato di povertà. E da beneficiario di sussidio
sociale a malato psichiatrico il passo è breve. Nelle
pagine, una critica anche alla società e al sistema sanitario
austriaco: “Come si può vivere in Austria con una
malattia mentale, la burocrazia e la prepotenza dei suoi uffici?”
Ancora: “In Austria, nessuno deve morire di fame, ma la
gente muore di fame psichicamente”.
Poi il ricovero alla clinica Otto Wagner, nel Baumgarten Höle.
A dispetto della bella architettura floreale, immersa in un
parco boschivo con sentieri fin sulla cima della collina, qui
finisce la dignità di ogni essere umano. Sozialschmarotzer,
parassiti sociali, feccia dell'umanità. La malattia mentale
deve essere nascosta.
Si gira con una chiave al collo, e chiusi nei letti gabbia quando
non si prendono le medicine. L'accoglienza è un ferro
freddo sul torace per scuotere i sensi, in attesa di vegetare
nella struttura rifugio-lager dell'istituzione totale. Il risveglio
comincia con il male di vivere. Farmaci producono senso di sicurezza,
suppliscono all'assenza di chi dovrebbe prendersi cura. La malattia
trascorre nel mutismo quotidiano del lavoro a maglia, alla ricerca
spasmodica di una giustificazione per meritarsi il diritto a
vivere, e strapparsi le sopracciglia per mostrare al mondo la
propria ferita. Fino alla convinzione che solo chi è
“normale” ha diritto alla vita.
Un sollievo la lettura, le camminate lente tra i sentieri del
parco. La sopravvivenza nell'ergoterapia, a pelare le patate
il giorno di turno in cucina o distrarsi nelle ore di uscita
per la spesa, sempre con le medicine in borsetta come una carta
d'identità.
Brigitte Schwaiger rimette a fuoco i materiali della sua psiche
in continua lotta con le sovrapposizioni baluginanti di voci
e immagini.
Sferzano come fulmini nella sua scrittura allo stesso tempo
lucida ed eruttiva. Turbinii di pensieri e parole vagolano in
tondo senza posa dentro una mente creativa e visionaria. Il
tormento dell'anima si lenisce: “Scrivere è la
via più lunga”, permette di ritardare l'ora del
“diritto alla dolce morte”, con dignità.
Nel 2010, la forza generatrice e affannata approda al silenzio.
Un'autobiografia del dolore, quindi, e di testimonianza della
scrittura come un'ultima àncora, prima di lasciarsi cadere.
Claudia Piccinelli
|