
Terza laurea fra le sbarre
In prima elementare sono stato bocciato. La stessa cosa accade in seconda elementare. A nove anni per la mia famiglia ero già abbastanza grande per andare a lavorare. Sono entrato in carcere venticinque anni fa con licenza elementare. Durante le atroci esperienze dell'isolamento diurno e notturno nel carcere duro dell'Asinara, sottoposto al regime di tortura del 41 bis, inizio a studiare da autodidatta. Prima l'ho fatto per rimanere umano, dopo per sopravvivere, alla fine per vivere.
Credetemi, studiare mi è costato anni e anni di regimi duri, punitivi e d'isolamento, perché spesso per ritorsione mi impedivano persino di avere libri o una penna per scrivere. E in certi casi mi lasciavano la penna ma mi levavano la carta, perché non c'è cosa peggiore per l'Istituzione carceraria di un prigioniero che studia, pensa, scrive e lotta. Fra mille difficoltà prendo la terza media e mi diplomo. Nel 2005 mi laureo in “Scienze Giuridiche”, nel 2011 in Giurisprudenza e quest'anno in Filosofia con una tesi in “Sociologia della devianza”. Così, il 16 giugno per la terza volta mi sono laureato, stavolta con 110 e lode, da uomo libero grazie a un breve permesso premio giornaliero, nell'Università degli Studi Padova con la relatrice Professoressa Francesca Vianello, discutendo una tesi dal titolo “Biografie devianti”. Ed ho pensato di rendere pubblica questa breve parte personale dal titolo: “Bambino deviante”.
Fin da subito capii che i posti per il paradiso erano pochi, mentre l'inferno era aperto a tutti. Fin da piccolo incominciai a deviare e giurai a me stesso che, nella vita, avrei lottato con tutte le mie forze per salire in paradiso.
E così facendo scesi all'inferno.
Credo di avere incominciato a deviare fin dalla pancia di mia madre, ancora prima di nascere, perché mi raccontarono che calciavo di giorno e di notte. Quando mia madre mi partorì, non volevo venire fuori, forse perché il mondo mi faceva già paura. Alla fine, però, non ebbi scelta e dovetti nascere per forza.
Iniziai da subito a osservare tutto, facendo finta di non guardare nulla per non dare nell'occhio.
Dopo poco tempo, però, fui già abbastanza sveglio per capire che in quello strano mondo dove mi trovavo comandavano i grandi. La cosa non mi piacque molto. Iniziai presto a ribellarmi contro la mia numerosa famiglia. E sperai di non diventare mai come loro. Ricordo che c'erano dei momenti in cui ero felice e disperato allo stesso tempo. Mi piaceva stare dove i grandi non mi potevano vedere. Quando avevo voglia di parlare con qualcuno, discutevo con me stesso. Penso che i grandi non mi abbiano mai visto per quello che ero. Non gliene facevo però una colpa. In fondo, loro erano quelli “normali” e io, invece, ero già il “deviante”. Mi sentivo come un marziano caduto sulla terra.
In casa comandava innanzitutto mio nonno. Lo seguiva mio padre. Poi mio fratello maggiore. E così via. Dovevo fare tutto quello che dicevano loro. A me questo non andava e facevo tutto quello che mi pareva. I grandi non mi piacevano. Mi erano antipatici perché mi volevano comandare. E a me non piaceva ubbidire. E finivo per dire di no anche quando avrei voluto dire di sì.
Esser punito perennemente
Amavo la solitudine. Incominciai a pensare che ero un bambino
diverso dagli altri, perché preferivo stare spesso solo
con me stesso. Così osservavo la mia vita con distacco.
Immaginavo e vivevo una vita tutta mia dentro la mia mente.
Pensandoci bene adesso, debbo ammettere che, come bambino deviante,
ero strano. Un po' anche per dispetto, facevo tutto il contrario
di quello che mi ordinavano di fare i grandi. E iniziai fin
da piccolo a essere punito perennemente. I miei familiari iniziarono
a picchiarmi con le mani. Dopo con i calci. Poi con il mestolo.
E alla fine con il manico della scopa. Io, però, per
non dare soddisfazioni ai grandi, piangevo poco per me stesso.
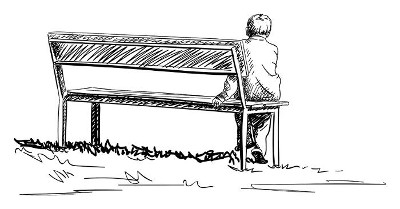 Piangevo
di più quando venivano picchiati i miei fratelli. Quella
che mi picchiava più spesso e più forte di tutti
era mia nonna. Forse perché era la persona della mia
famiglia che mi voleva più bene. E me lo dimostrava tutti
i giorni. A volte, picchiandomi anche due volte al giorno. E
nelle grandi occasioni anche tre volte! Anch'io volevo bene
a mia nonna. Una volta, però, persi la pazienza. E le
ruppi la testa con lo stesso manico di scopa con cui mi picchiava
sempre. Penso che la lezione le fece bene, visto che da quel
giorno non mi mise più le mani addosso. E io, per qualche
tempo, credetti che mia nonna fosse diventata buona perché
mi faceva picchiare solo dai maschi di famiglia. Piangevo
di più quando venivano picchiati i miei fratelli. Quella
che mi picchiava più spesso e più forte di tutti
era mia nonna. Forse perché era la persona della mia
famiglia che mi voleva più bene. E me lo dimostrava tutti
i giorni. A volte, picchiandomi anche due volte al giorno. E
nelle grandi occasioni anche tre volte! Anch'io volevo bene
a mia nonna. Una volta, però, persi la pazienza. E le
ruppi la testa con lo stesso manico di scopa con cui mi picchiava
sempre. Penso che la lezione le fece bene, visto che da quel
giorno non mi mise più le mani addosso. E io, per qualche
tempo, credetti che mia nonna fosse diventata buona perché
mi faceva picchiare solo dai maschi di famiglia.
Fin da bambino ero molto curioso. Iniziai presto a rivolgermi
le prime domande di senso. Solo con il passare degli anni capii
che spesso le risposte erano già contenute nelle domande.
Capii subito, invece, che tutte le persone, prima o poi, dovevano
morire. E mi chiesi per quale ragione si nasce visto che poi
si muore. In primo luogo incominciai a chiedermi perché
ero nato io. Mi domandai pure in quale mondo mi trovassi prima
di nascere. E dove sarei andato dopo morto. Non riuscivo però
a trovare risposte dentro di me. Fui costretto a chiederle ai
grandi. Mi accorsi subito che ne sapevano meno di me. E spesso
mi mandavano a quel paese. Prima con le buone. Poi con le cattive.
E incominciarono a guardarmi in modo strano.
A volte, sentivo i miei familiari bisbigliare fra loro dicendo
che ero un bambino strano, che probabilmente ero pazzo o scemo,
o entrambe le cose. All'inizio ci rimanevo un po' male, ma poi
mi consolavo pensando che forse i pazzi erano loro. Poi accettai
di essere diverso anche perché capii che i bambini si
differenziano dagli adulti per il fatto che conservano in loro
l'innocenza e non sono cattivi ed egoisti come i grandi. Per
difendermi, incominciai a crearmi un mondo mentale parallelo
nel quale leccarmi le ferite che m'infliggeva il resto del mondo.
I grandi mi intimidivano. Li vedevo diversi da com'ero io. Più
insicuri di me. Mi accorsi subito che invece di tentare di fare
del bene, preferivano fare del male. E persino nella mia famiglia
non andavano d'accordo fra loro.
La notte mi piaceva più del giorno perché mi piacevano
le stelle. La sera stavo ore intere con la testa all'insù
a guardare il cielo fin quando non mi girava la testa. Quella
che mi lasciava a bocca aperta era la luna quando era piena.
Sembrava che mi guardasse. E che esistesse solo per me. Poi,
con il tempo, mi accorsi che ero più felice quando dormivo
di quando ero sveglio. E presi l'abitudine di addormentarmi
in qualsiasi posto mi trovassi. Mi piaceva dormire soprattutto
a scuola. Forse anche per questo mi bocciarono in prima e in
seconda elementare.
La maestra aveva una vocina bassa e usava un tono che assomigliava
a una ninnananna. Diceva che due più due faceva quattro.
A me questa cosa non stava bene. E mi domandavo perché
due più due non facesse cinque. Poi, a casa mia, parlavano
in dialetto e la maestra invece parlava in italiano. Io non
capivo perché esistessero due lingue. E pensavo che sarebbe
stato tutto più facile se tutte le persone avessero parlato
un'unica lingua. Non trovavo le risposte. E quella maestra non
riusciva a darmene. Ricordo che mi diceva spesso di fare il
buono. A me la cosa dava fastidio perché pensavo, già
allora, che solo i cattivi hanno bisogno di fare i buoni. Già
a quel tempo credevo che fosse più importante essere
buoni che fare i buoni.
“Dio Padre mi era stato subito antipatico...”
Da bambino mi piaceva portare i capelli lunghi. Una volta però presi i pidocchi. I grandi vollero raparmi la testa a zero. Io però non ero d'accordo. E mi ribellai. Non vollero sentire ragioni. E mi legarono alla seggiola. Piansi molto quando vidi i miei bei capelli per terra. Erano per me come le foglie per un albero, e mi dispiaceva vederli separati dalla mia testa. Il senso di giustizia dei bambini è diverso da quello degli adulti. E a me dispiaceva che i miei pidocchi fossero rimasti senza casa. Già da allora pensavo che tutto dipendeva da quale parte si guardava. E io ero dalla parte dei pidocchi. Loro almeno mi tenevano compagnia. Ogni tanto gli davo una grattatina come fanno i cani. I pidocchi erano contenti. E io ero felice di saperli contenti. Dopo avermi raso i capelli, mi misero sul capo un telo inzuppato di benzina per fare morire le uova dei pidocchi. Lo dovetti tenere per un paio di giorni. Ricordo ancora la puzza di benzina: era tremenda. Alla fine rimasi senza pidocchi. Per un po' di tempo continuai lo stesso a grattarmi la testa perché ne sentivo la mancanza.
In questa strana famiglia dove ero nato si parlava poco di religione. Forse perché non era roba da mangiare. Conobbi Dio, Gesù e lo Spirito Santo in collegio. Non fu un incontro facile. Più che un incontro fu uno scontro. Solo Gesù mi era un po' simpatico perché pensavo che era nato colpevole e sfortunato come me.
Dio Padre, invece, mi era stato subito antipatico perché non capivo per quale ragione giocasse a nascondino senza mai farsi vedere da nessuno. Non gli perdonavo di aver cacciato via dal paradiso terrestre Adamo ed Eva solo per avere mangiato una mela. Pensavo che a me avrebbe fatto di peggio, perché andavo spesso a rubare i fichi, le arance e i limoni dagli alberi dei contadini. E mi convinsi che quel Dio assomigliava terribilmente agli uomini. Soprattutto non gli perdonavo di non aver mosso un dito quando gli uomini avevano messo in croce suo figlio. Non era certo il padre che avrei voluto, anche se il mio non era certo migliore di lui.
Riguardo allo Spirito Santo, non riuscivo a capire che cosa fosse. Provavo ad immaginare una specie di fantasma che c'era perché non c'era, e non c'era perché c'era.
Si può dire qualsiasi cosa dei bambini, ma penso che siano più coraggiosi degli adulti. Io infatti mi arrampicavo sugli alberi più robusti e più alti senza timore di rompermi l'osso del collo. Probabilmente, per dimostrare a me stesso che non avevo paura di morire o forse perché non amavo abbastanza la vita per temere la morte. Adesso però, pensandoci bene, forse ero solo curioso di sapere cosa ci fosse nell'altro mondo.
Il gioco che mi piaceva di più era quello di attraversare la strada di corsa a occhi chiusi rischiando di essere investito da qualche auto. Lo facevo da solo perché nessuno degli altri bambini voleva fare quel gioco. Preferivano battermi le mani tutte le volte che riuscivo ad attraversare la strada senza essere investito. Una volta, però, le cose andarono diversamente e, invece di sentire gli applausi e le urla di gioia dei miei compagni, sentii un grande dolore. Poi sprofondai nel nulla. E mi svegliai in ospedale con un trauma cranico. Seppi che mi aveva investito una motocicletta.
Una volta guarito tornai a casa. Non ricordo che i miei familiari mi abbiano fatto grandi feste nel vedermi di nuovo girare per casa. Forse erano dispiaciuti che ero ritornato a far loro le mie domande.
Carmelo Musumeci
Chi vuole leggere o scaricare integralmente la mie tre tesi di laurea lo può fare nel sito: in home page, in fondo nella parte della Biografia.
|