
California 1967/
50 anni fa i Diggers, tra arte e sovversione
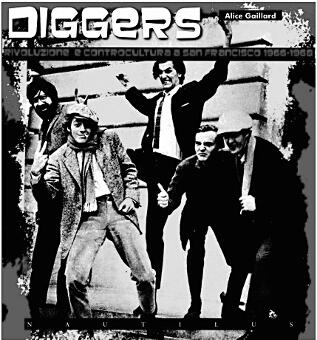 Tra
le ricorrenze del 2017 oltre al macigno del secolo trascorso
dalle due rivoluzioni russe (chissà perché di
quella di marzo non si dice mai niente) e al quarantennale dell'ultima
abortita insurrezione europea (tutta italiana, non sto parlando
dei punk inglesi) ci sono pure i cinquant'anni della Summer
of love, ritenuta a ragione o a torto ipocentro del sisma culturale
che dalla costa occidentale degli Usa propagò nel mondo
intero onde sussultorie di pacifica liberazione individuale
e collettiva - oppure di sfacelo a base di sesso, droga &
r'n'r, a seconda dei gusti. Tra
le ricorrenze del 2017 oltre al macigno del secolo trascorso
dalle due rivoluzioni russe (chissà perché di
quella di marzo non si dice mai niente) e al quarantennale dell'ultima
abortita insurrezione europea (tutta italiana, non sto parlando
dei punk inglesi) ci sono pure i cinquant'anni della Summer
of love, ritenuta a ragione o a torto ipocentro del sisma culturale
che dalla costa occidentale degli Usa propagò nel mondo
intero onde sussultorie di pacifica liberazione individuale
e collettiva - oppure di sfacelo a base di sesso, droga &
r'n'r, a seconda dei gusti.
Il saggio di Alice Gaillard (Diggers: Rivoluzione e controcultura
a San Francisco 1966-1968, Nautilus, Torino 2016, pp. 184,
€ 15,00) corredato di un'ampia documentazione grafica e
di un'esauriente introduzione storica agli eventi del 1966-67
(superflua per gli appassionati di vetuste culture alternative,
necessaria per chi sia a digiuno dei varî Kerouac, Marcuse
e Ginsberg), è focalizzato su un piccolo gruppo di attivisti,
i Diggers, insediato a San Francisco e precisamente nel
quartiere di Haight Ashbury.
Il nome, copiato dagli zappatori espropriatori inglesi del XVII
secolo, non stava a indicare alcun ritorno alla terra, ma simboleggiava
l'urgenza di dare una risposta concreta alle prorompenti esigenze
di una gioventù proiettata verso l'esplorazione di spericolati
sentieri esperienziali. Nati all'interno del Mime Troupe,
collettivo dedito a un teatro-guerriglia di derivazione brechtiana,
si diedero ad espanderne e radicalizzarne le tecniche mettendo
completamente in discussione la separazione tra vita reale e
performance secondo una prospettiva individualista e libertaria.
Mentre il Mime Troupe prima e poi l'ALF (Artist Liberation
Front) si adoperavano per «portare il teatro, la pittura,
la musica verso la gente, in particolare chi abita nei quartieri
non privilegiati», i Diggers si chiedevano: «poiché
la promessa del teatro è sospendere l'incredulità
dello spettatore riguardo a quello che vede e permettergli di
entrare in un quadro in cui gli viene proposta un'altra realtà
per la durata dell'opera, perché non estendere questa
sospensione nella realtà della vita di tutti i giorni
e cancellare i confini tra spazio pubblico e spazio privato,
e recitare in modo che emerga il nuovo mondo che si augurano
di far nascere?»
L'enunciato potrebbe sembrare fumoso e invece questi freaks
estremisti organizzarono in una spontanea collettività
pasti gratuiti, cure mediche, negozi free (nel doppio
senso di “libero” e “gratuito”) in cui
ribaltarono l'idea di merce, e una lunga serie di life-acts,
dove vita, strada e rappresentazione scenica cercavano di fondersi
per entrare in sintonia con quella luminosa e variopinta rivoluzione
psichedelica.
Il contesto che aveva permesso la nascita di questa esplosione
di creatività era formato da una serie di elementi che
ne determinarono l'enorme successo di immagine. Si affacciavano
in simultanea nel paese più ricco del mondo l'esigenza
di una sessualità più libera, l'insofferenza per
una società che discriminava apertamente i suoi componenti
dalla pelle scura, il rifiuto dell'aggressione armata al Vietnam
e, non meno importante, l'affermarsi presso i giovani ribelli
di un prodotto sintetizzato nei laboratori svizzeri della Sandoz
nel 1938 e divenuto celebre come LSD. Oggi sappiamo che parte
delle energie che fecero soffiare un po' ovunque il vento di
Haight Ashbury – qui da noi furono i capelloni
gli apostoli del verbo fricchettone – ne avrebbero presto
decretato il declino.
Durissimo fu l'impatto con l'incontrollabile mostro della spettacolarizzazione,
orde di giornalisti e di turisti in caccia di hippy ruspanti,
mercificazione e prostituzione dilaganti in un'atmosfera tossica
dove a marijuana, LSD e mescalina si aggiunsero oppio ed eroina,
con il conseguente proliferare di spaccio e malavita. Come riportato
nei documenti in appendice, già nell'estate del 1967
i Diggers intuirono come quel grande movimento in piena
espansione cominciasse a barcollare e in che misura il festival
di Monterey, sua massima celebrazione, costituisse in fondo
l'atto conclusivo della sua fase più vitale e l'inizio
di epoche virate in toni cupi. Ma a quel punto i Diggers
erano già diretti altrove.
Giuseppe Aiello

Arte ir-ritata/
Roba da matti
La creatività è una risorsa vitale indispensabile
per noi esseri umani, grazie alla quale, da sempre, siamo riusciti
a re-immaginare e quindi re-inventare noi stessi. In virtù
di questa caratteristica, o predisposizione, abbiamo portato
modifiche e cambiamenti nel mondo intorno a noi fin dalle origini
più remote della nostra presenza come specie animale
umana. Ma è interessante notare che gran parte delle
zone di maggiore interesse per la presenza di arte rupestre
si trova in luoghi dove l'umanità di allora ha trovato
ostacoli ai suoi spostamenti. Sembra che il ritrovarsi a ridosso
di queste soglie – masse oceaniche, catene montuose –
abbia intensificato la produzione simbolica, come se questa
avesse la possibilità di aiutare nel superamento del
limite.
 L'arte
ir-ritata (Sensibili alle foglie, Roma, 2017, pp. 127, €
16,00), curato da Nicola Valentino, parte da questi presupposti
e dedica la sua particolare e documentata attenzione a testimoniare
quel mondo creativo che si manifesta in situazioni estreme di
coercizione – carceri, istituzioni manicomiali, case di
riposo, ecc. – diventando cura di sé, forza per
continuare a vivere, fantasia per sopportare. L'arte
ir-ritata (Sensibili alle foglie, Roma, 2017, pp. 127, €
16,00), curato da Nicola Valentino, parte da questi presupposti
e dedica la sua particolare e documentata attenzione a testimoniare
quel mondo creativo che si manifesta in situazioni estreme di
coercizione – carceri, istituzioni manicomiali, case di
riposo, ecc. – diventando cura di sé, forza per
continuare a vivere, fantasia per sopportare.
Oltre a questi luoghi assurdi anche molti contesti istituzionali
più comuni, quali aule scolastiche, uffici, aziende,
talvolta persino gli ambiti familiari, possono essere vissuti
come angusti e mortificanti. Gesti creativi, forme espressive
ir-ritate – cioè nate da irritazione, come
immediatamente suggerisce la parola, ma anche, approfondendo
etimologicamente il termine, fuori dal rito – sorgono
allora per tras-portare chi le crea, per il tempo che le crea,
in un altrove simbolico che diviene spazio di libertà
e nuova identità. In questo senso sono esemplari i banchi
e/o le porte dei bagni scolastici trasformati in espliciti luoghi
di un altrove evocato che aiuta a tollerare noia e imposizioni.
In maniera affine sono viste le scarabografie, la forma
più comune e spontanea di dissociazione creativa, ovvero
tutti quegli scarabocchi coi quali sovente vengono riempiti
interi fogli di carta, ad esempio, durante poco interessanti
riunioni lavorative.
Un libro di grande ricchezza che in qualche modo si intreccia
con la più conosciuta Art Brut resa nota da Jan Dubuffet
che, già negli anni venti del secolo scorso, ruppe il
collegamento tra le patologie psichiatriche e le opere prodotte
da chi ne soffriva. Dubuffet, artista a sua volta, affermava
che l'arte autentica non sta nei luoghi comodi fabbricati per
lei ma può essere prodotta solo da chi è estraneo
al sistema delle Belle Arti, da chi lavora, in condizioni drammatiche
di solitudine, per “l'incanto del loro solo autore”.
Una grande collezione di “Art Brut” è raccolta
ed esposta a Losanna in un museo a essa dedicato. Allo stesso
modo esiste un archivio di Arte ir-ritata che sta cercando un
posto dove le opere possano essere incontrate stabilmente e
dove si possa scambiare questo sapere sociale. Al momento la
Casa dell'Arte ir-ritata è solo virtuale ma comunque
visitabile ed è nata l'idea di promuovere la costituzione
di una casa diffusa dell'Arte ir-ritata che potrebbe aver spazio
in centri culturali o abitazioni private che vorranno ospitare
una o più opere della raccolta.
Un libro che può avvicinare ciascuno di noi alla propria
capacità espressiva, sfatare il mito del talento innato
necessario a praticare qualsiasi forma di espressione creativa,
e far nascere il desiderio di ritrovare il gusto perduto del
gioco creativo. A questo proposito ci viene incontro il pensiero
di Georges Lapassade, riportato nel testo, il quale vedeva la
condizione di adulto – colui o colei che avrebbe raggiunto
la forma compiuta – come un falso mito sociale che in
realtà non farebbe altro che bloccare e irrigidire la
possibilità continua di trasformazione/nascita che ogni
essere umano, in quanto creatura relazionale, costantemente
ha, grazie ai mondi sociali che attraversa. Irrigidimenti e
blocchi che, come si sa, bene non fanno.
Un libro agile che si fa leggere con interesse, di grande spessore
umano ma soprattutto un libro che mette in allerta riguardo
a ciò che accade in noi quando la vastità interiore
che ciascuno porta in sé viene compressa e avvilita (è
evidente che questo oggi sta accadendo in maniera costante,
subdola e massificata).
Un libro, infine, che invita a comprendere la sofferenza come
“esperienza della mente che perde la sua spaziosità
intrinseca” e a ragionare su tutto questo perché
“forse è proprio quando persone e comunità
si trovano a dover segnare il passo nel loro cammino che possono
creare nuovi modi di significare il mondo, nuovi orizzonti per
l'immaginario personale e sociale”. Forse questa è
l'opportunità che abbiamo.
Silvia Papi
http://artenatura.altervista.org
Storia/
La vicenda dei GAF. Ma gli altri?
Contro la storia. Cinquant'anni d'anarchismo in Italia (1962-2012)
(Biblion edizioni, Milano, 2016, pp. 590, € 35,00), già
rivela nel titolo l'ambizioso progetto, del tutto riuscito,
di Giampietro Berti di realizzare un'opera globale sul periodo
considerato, sopratutto per quanto attiene la nascita e lo sviluppo
del gruppo Materialismo e libertà prima e successivamente
dei Gruppi giovanili anarchici federati (GGAF) e dei Gruppi
anarchici federati (GAF).
 La
sua opera fa venire in mente un altro importante libro della
nostra letteratura, quello di Armando Borghi che, come l'autore,
ha raccontato cinquant'anni di storia dell'anarchismo, dal 1898
al 1945. Meno riuscito il tentativo per quanto attiene la storia
delle vicende della FAI, che, per quanto sia resa in modo circostanziato
e preciso, evidenzia soprattutto i difetti piuttosto che i pregi
di questa organizzazione. La FAI non viene compresa nel suo
importante ruolo organizzatore di energie attive e militanti,
nonché editrice senza soluzione di continuità,
fin dal secondo dopoguerra, del giornale fondato da Errico Malatesta. La
sua opera fa venire in mente un altro importante libro della
nostra letteratura, quello di Armando Borghi che, come l'autore,
ha raccontato cinquant'anni di storia dell'anarchismo, dal 1898
al 1945. Meno riuscito il tentativo per quanto attiene la storia
delle vicende della FAI, che, per quanto sia resa in modo circostanziato
e preciso, evidenzia soprattutto i difetti piuttosto che i pregi
di questa organizzazione. La FAI non viene compresa nel suo
importante ruolo organizzatore di energie attive e militanti,
nonché editrice senza soluzione di continuità,
fin dal secondo dopoguerra, del giornale fondato da Errico Malatesta.
Attraverso pagine chiare e con alti contenuti informativi l'autore
valuta in sede storiografica la scissione del Movimento nel
1965, la sua diaspora in FAI, FAGI, GGAF e successivamente GAF
e GIA, la eterna questione dell'organizzazione e tutto ciò
che ha caratterizzato la storia del Movimento anarchico italiano,
nel tumultuoso contesto storico-politico degli anni '70 e '80
in Italia. Sono pagine dense con prese di posizione recise ed
autentiche, attraverso le quali l'autore esprime con generosità
le sue valutazioni. Come sottolinea in premessa, aspettandosi
inevitabilmente critiche ed osservazioni.
Berti perviene dopo 550 pagine documentatissime e piene di passione
militante, dalla quale, in quanto studioso, con sforzo prende
le distanze, per fornire una narrazione oggettiva quanto più
possibile, ad una serie di domande che attengono al futuro dell'anarchismo,
che è già un presente pressochè immediato.
In sintesi qual è il futuro dell'anarchismo, che appare
all'autore un movimento tendenzialmente autoreferenziale, in
assenza di un soggetto storico al quale fare riferimento, come
era quello operaio e popolare ottocentesco e primonovecentesco,
dal quale e per il quale nacque il pensiero ed il movimento
anarchico? Si tratta di un interrogativo proposto dopo che,
con dettaglio, è stata tracciata dall'autore la storia
delle esperienze ed iniziative dei compagni dei GAF, che dettero
vita alla rivista “A,” a Interrogations, al Centro
studi libertari ed ai suoi Convegni e Seminari di studio e di
approfondimento, alla continuazione e rinnovamento di Volontà,
alla continuazione delle edizioni Antistato ed alla nascita
di Elèuthera ed infine a Libertaria, ciascuna iniziativa
narrata e analizzata nella sua specifica consistenza.
Merito enorme del libro è avere rappresentato a chi non
ha vissuto quelle esperienze ed averlo sottolineato a chi le
ha vissute, la straordinaria complessità innovativa intellettuale
e la assai elevata capacità organizzativa, in quanto
produttori di cultura, degli anzidetti ex militanti dei GAF.
All'interno di questa narrazione l'autore formula opinioni e
punti di vista, taluni bisognevoli di chiarimento. Come ad esempio
l'attribuzione di “anarchismo etico” alla rivista
“A”, che sembrerebbe, a parere di Berti, se non
vado errato, un revisionismo minimalista dell'anarchismo. Mentre
a me sembra l'anarchismo pluralista concreto e attuale ed, in
quanto anarchismo malatestiano, correttamente e giustamente
etico. Altro punto di dissenso è la negazione da parte
dell'autore che vi fosse negli anni '70 un pericolo concreto
di colpo di stato reazionario e di decisa svolta a destra dell'asse
politico del Paese.
Grazie alla ricostruzione di Berti, la militanza degli ex-appartenenti
ai GAF nella ideazione e nella organizzazione del rinnovamento
del pensiero dell'anarchismo, è stata riportata alla
luce ed è stata proposta sia alla rilettura di chi ha
partecipato a questa straordinario percorso di ricerca, che
alla conoscenza di tutti coloro che per ragioni anagrafiche
non lo hanno condiviso.
Enrico Calandri
Psichiatria/
Al servizio del colonialismo (anche italiano)
All'inizio del secolo scorso, le potenze europee che diedero
vita ad un'accanita e competitiva colonizzazione politica ed
economica dei paesi africani e asiatici, ebbero, come strumenti
di conquista di popoli inermi e miseri, gli eserciti e il capitale
finanziario, e al contempo si servirono della 'scienza' per
giustificare la loro missione di civilizzazione della 'razza'
nera, ritenuta arretrata e inferiore rispetto alla razza 'eletta',
bianca ed europea. Un ruolo significativo in tal senso lo ebbero
le scienze mediche, in particolare la psichiatria, come mostra
un interessante volume che raccoglie gli atti di un convegno
(organizzato, nel 2015, dal Centro di storia della psichiatria
di Reggio Emilia) che ha per titolo La psichiatria nelle
colonie (Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 144, € 19,00).
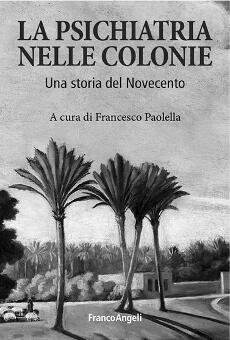 Gli
psichiatri europei, presenti nei territori dell'occupazione
coloniale, nei loro rilievi, effettuati in loco, attestavano
l'inferiorità mentale degli individui di pelle nera,
ritenendoli geneticamente portatori di ereditarie tare organiche
e psichiche e propugnavano l'idea della necessità di
una 'psichiatria razziale' che osservasse, curasse e normalizzasse
gli indigeni colonizzati secondo i parametri di società
e di cultura, di usi e di valori delle nazioni europee: in particolare,
parecchi medici italiani, seguendo perlopiù le teorie
di Lombroso, spiegavano l'eziologia della sofferenza mentale
dei colonizzati con quei criteri antropometrici che secondo
il criminologo torinese distinguevano, in specie il volume del
cranio, la facies del delinquente da quella della persona 'normale';
così come il sistema psicofisico del colonizzato, portatore
di varie e diffuse patologie, da quello, di certo più
sviluppato e sano, del colonizzatore. Gli
psichiatri europei, presenti nei territori dell'occupazione
coloniale, nei loro rilievi, effettuati in loco, attestavano
l'inferiorità mentale degli individui di pelle nera,
ritenendoli geneticamente portatori di ereditarie tare organiche
e psichiche e propugnavano l'idea della necessità di
una 'psichiatria razziale' che osservasse, curasse e normalizzasse
gli indigeni colonizzati secondo i parametri di società
e di cultura, di usi e di valori delle nazioni europee: in particolare,
parecchi medici italiani, seguendo perlopiù le teorie
di Lombroso, spiegavano l'eziologia della sofferenza mentale
dei colonizzati con quei criteri antropometrici che secondo
il criminologo torinese distinguevano, in specie il volume del
cranio, la facies del delinquente da quella della persona 'normale';
così come il sistema psicofisico del colonizzato, portatore
di varie e diffuse patologie, da quello, di certo più
sviluppato e sano, del colonizzatore.
Insomma, come sottolinea nell'introduzione al volume, Francesco
Paolella “la psichiatria è stata arruolata nel
progetto di dominazione coloniale delle diverse nazioni europee.
E pur se in una posizione inevitabilmente defilata, anche la
questione della neutralizzazione e della cura dei comportamenti
scandalosi e pericolosi ha avuto indubbiamente un ruolo nel
più ampio controllo politico e morale delle società
dei paesi colonizzati”. “È quindi legittimo
parlare di una compromissione tra la psichiatria (e la medicina
in generale) e il potere coloniale”, scrive ancora Paolella,
che aggiunge: “queste relazioni pericolose erano senza
dubbio utili all'amministrazione coloniale e funzionali alla
produzione di rapporti di soggezione; l'assistenza psichiatrica
nelle colonie è stata contrassegnata da un rapporto strutturalmente
asimmetrico fra europei e indigeni; un rapporto di subalternità
che tendeva a tradurre, anche se spesso spinto da motivazioni
'alte', filantropiche, in termini medici, alienisti lo status
quo, il contesto di violenza materiale e simbolica”.
I primi due interventi presenti nel volume, di due studiosi
inglesi, Matthews M. Heaton e Waltraud Ernst esaminano il diverso
impatto della psichiatria inglese in Nigeria e in India e il
confronto/scontro tra la Medicina Coloniale e quella tradizionale
nei paesi del Sud Asia. Un terzo intervento, di Marianna Scarfone,
documenta gli articolati nessi tra la presenza italiana nelle
colonie africane e l'istituzione dell'assistenza psichiatrica
per i colonizzati ma anche per gli italiani che, nel loro ruolo
di militari o dipendenti civili dell'ammirazione statale, spesso
incorrevano nella 'follia': incapaci di adattarsi alle diversità
di un territorio e di un popolo straniero, stremati da una guerra
di conquista che percepivano ingiusta e dall'obbedienza ad un
regime (quello mussoliniano) che avvertivano intollerante e
oppressivo, diventavano preda di un isterico, convulso e irrequieto
'furor africano'. Anche loro, per gli psichiatri del tempo,
erano organicamente inetti, inadatti, indegni così come
gli oziosi, ritardati e sporchi neri delle colonie che “o
si piegavano o andavano soppressi”. L'idea della malattia
mentale, decontestualizzata e individuata come effetto di deficienza
fisica e psichica genetica, viene bene fuori dall'intervento
di Luigi Benevelli che presenta ed esamina una relazione del
1935 (riprodotta, a conclusione del volume) condotto dello psichiatra
Eustachio Zara sul caso di un africano residente e ospedalizzato
a Napoli, affetto da paralisi progressiva e a causa di questa
deceduto.
Benevelli denuncia il metodo “ideologico”, perché
“basato sulla biologia e l'anatomia patologica del sistema
nervoso centrale e sulle loro relazioni con le funzioni mentali,
a prescindere da un approccio 'scientifico' alla malattia”,
col quale venne condotta, dal dottor Zara, l'ampia disamina
delle caratteristiche, degli effetti e delle turbe della patologia
psichiatrica dell'africano, insorta probabilmente a causa di
una sifilide non curata e ricondotta quindi ai disordini e alla
costituzione di un individuo di 'razza inferiore'. Ne conclude,
sarcasticamente e amaramente Benevelli: “J. Camel, 'negro'
di ignoti, nato ad Alessandria d'Egitto, dall'età apparente
di 50 anni, arriva nel manicomio di Napoli in condizioni tali
che non era possibile raccogliere da lui i dati anamnestici,
ricostruire le vicende della sua vita. Ma questo non era importante:
bastava il fatto che fosse affetto da paralisi progressiva perché
per lui parlassero i suoi visceri”.
Erano anni di dominio politico, culturale e scientifico delle
élite borghesi e dei dittatori dell'Europa che imposero,
nelle loro colonie, un modello politico e sanitario unico ed
eurocentrico a gente con storie, civiltà e saperi diversi,
altrettanti articolati, efficaci e ricchi di pratiche e conoscenze
di alto valore materiale e spirituale.
Nel volume si indaga anche come si cambiò tendenza, con
l'avviarsi del processo storico della decolonizzazione, nei
decenni che seguirono il secondo dopoguerra, rispetto alla comprensione
e alla cura delle malattie mentali, grazie al lavoro di una
generazione di psichiatri nati nei paesi colonizzati, come Franz
Fanon, che cominciarono a studiare e ad intervenire in modo
'locale' e specifico sulle difficoltà psichiche, rifiutandone
le definizioni e i trattamenti 'occidentali' e globalistici
e dando così vita all'etnopsichiatria: la cui storia
e i cui principi sono di gran attualità, in un mondo
e in società che sempre più vivono la presenza
di 'migranti' e che, quindi, al rispetto delle diversità
e delle libertà di tutti, dovrebbero sempre più
educarsi.
Silvestro Livolsi
Anarchismo, leggi, diritto/
Le riflessioni di Errico Malatesta e altri
”Se respingiamo la legge lo facciamo per raggiungere qualcosa di meglio”
Errico Malatesta, 1925
L'opinione diffusa sulla presunta inconciliabilità tra
anarchismo e diritto è senz'altro frutto di confusione
metodologica oppure di superficialità o critiche tendenziose.
Ma ciò deriva anche dal dato di fatto incontrovertibile
che, storicamente, il diritto ha svolto funzioni di “maschera”
e rappresentazione del potere. C'è inoltre da registrare
l'evidente esistenza di un field ancora troppo ristretto
di questo ambito di ricerca (a parte le meritorie e sporadiche
iniziative del Centro Studi Libertari e dell'università
“Magna Graecia”).
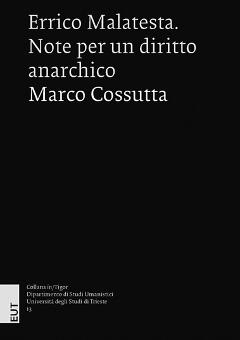 Così
un testo complesso, impegnativo e utile come questo di Marco
Cossutta (Errico Malatesta. Note per un diritto anarchico,
Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste,
2015, pp. 222, € 14,00) ci può aiutare moltissimo.
Approfondimento sugli aspetti giuridici di notevole caratura
presenti nel corpus teorico malatestiano, il volume ricapitola
e incrocia diverse e importanti visuali di lettura: cogliendo
il nesso, prima di tutto, fra diritto e anarchia (su cui esiste
un dibattito interdisciplinare, qualitativamente discreto, che
ha coinvolto nel tempo qualche storico e giurista); approfondendo
quegli aspetti cruciali del pensiero e dell'azione del grande
rivoluzionario campano in genere poco frequentati nei milieu
militanti; proponendo infine alla comunità scientifica
una significativa selezione di questioni e tematiche prettamente
anarchiche. Così
un testo complesso, impegnativo e utile come questo di Marco
Cossutta (Errico Malatesta. Note per un diritto anarchico,
Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste,
2015, pp. 222, € 14,00) ci può aiutare moltissimo.
Approfondimento sugli aspetti giuridici di notevole caratura
presenti nel corpus teorico malatestiano, il volume ricapitola
e incrocia diverse e importanti visuali di lettura: cogliendo
il nesso, prima di tutto, fra diritto e anarchia (su cui esiste
un dibattito interdisciplinare, qualitativamente discreto, che
ha coinvolto nel tempo qualche storico e giurista); approfondendo
quegli aspetti cruciali del pensiero e dell'azione del grande
rivoluzionario campano in genere poco frequentati nei milieu
militanti; proponendo infine alla comunità scientifica
una significativa selezione di questioni e tematiche prettamente
anarchiche.
Filosofo del diritto, l'autore – docente all'università
di Trieste – è tra i pochi specialisti dell'argomento
oggi attivi in Italia (insieme a Massimo La Torre e Alberto
Scerbo); le sue monografie più importanti sono spesso
focalizzate su quei lemmi che la vulgata vorrebbe inconciliabili
(Anarchismo e diritto. Componenti giusnaturalistiche del
pensiero anarchico è ad esempio il titolo del libro
risalente al 1987, edito dalla triestina Coopstudio).
Primo assunto da sottolineare: non confondiamo la legge con
il diritto. Da Proudhon in poi la distinzione è sempre
stata più che netta: da una parte c'è la classica
manifestazione statuale dell'uso monopolistico della forza,
dall'altra si annoverano tutte quelle forme possibili di regolamentazione,
amministrazione, mediazione di rapporti, conflitti e interessi
connessi alle attività umane. A tale proposito Malatesta
conferma in pieno questa impostazione rifiutando qualsiasi esegesi
anti-sociale dell'anarchismo.
Parlare dunque di “diritto anarchico” è non
solo corretto sul piano della storia del pensiero libertario,
ma anche legittimo su quello metodologico delle scienze giuridiche.
Lo snodo di comprensione di tutta questa costruzione teorica
– ribadisce Cossutta – non è tanto la negazione
di qualsiasi “forma di regolamentazione giuridica dei
rapporti sociali” ma, piuttosto, una risoluta intransigente
radicale opposizione verso quelle “forme di regolamentazione
eteronoma che la modernità politica ha prodotto e che
vedono nella compagine statuale il proprio indiscutibile fulcro”.
Quella sorta di ossimoro appare però formulabile solo
attraverso un'autentica prospettiva giuridica anarchica “fluida”
che, basandosi su tre elementi fra loro connessi: regolarità,
autonomia, libero accordo, smentisca di fatto
il luogo comune che presuppone “la natura sregolata dell'essere
umano”.
Il volume (che purtroppo non dispone di indice dei nomi e dei
soggetti notevoli) si articola in tre parti, ciascuna dedicata
a un focus particolare: Per una prospettiva giuridico-politica
anarchica; Per un anarchismo quale moderna declinazione della
classicità giuridico-politica; L'anarchismo fra filosofia
e dogmatismo.
Il noto dissidio tra Malatesta e Francesco Saverio Merlino occupa
uno spazio importante nell'esposizione cossuttiana. Secondo
l'autore, che peraltro non vede all'interno di questa diatriba
la classica contrapposizione tra prospettiva libertaria e democratica,
in essa risiederebbero piuttosto gli elementi di contraddizione
di un anarchismo che, “obbligato ad una perenne critica
dell'esistente”, si ritrova di fatto “operativamente
caduco”.
“Le argomentazioni malatestiane addotte per controbattere
a Merlino, – si legge nelle pagine conclusive del libro
– che dal punto di vista operativo appaiono deboli, acquistano
forza se osservate con spettro teoretico; Malatesta evita di
incorrere in contraddizioni, in quelle contraddizioni in cui
ritiene sia caduto il suo antico compagno di lotta. Ma va anche
evidenziato come i due, sia pur implicitamente, si collochino
su piani diversi; l'uno, Merlino, sul piano operativo dell'efficacia
dell'azione anarchica, l'altro, Malatesta, su quello non operativo
e volto a preservare l'anarchismo da contraddizioni esiziali.
Se sul piano della prassi quotidiana, l'impostazione di Merlino
appare indubbiamente più accattivante, sul versante della
coerenza quella di Malatesta è indubbiamente superiore...”.
Alla base di questo contrasto c'è, con tutta evidenza,
il rigetto totale da parte del rivoluzionario campano dei principi
giuridici e politici fondanti la modernità. In primis
c'è il rifiuto della “rappresentazione della politica
come manifestazione di potere”.
Giorgio Sacchetti
Anni '70/
Gianfranco Manfredi, la memoria critica (e “A”)
Un cantautore “cult” degli anni '70, tra i protagonisti del Festival del proletariato giovanile (Parco Lambro, Milano 1976) e di quegli anni, esce con Ma chi ha detto che non c'è. 1977, l'anno del Big Bang (Milano, 2017, pp. 426, € 18,00), un bel libro di ricordi e analisi critiche del 1977, pubblicato da Agenzia X. Nel capitolo dedicato alla stampa, ricorda Paolo Murialdi, Controinformazione e “A”. Ne pubblichiamo, a seguire, uno stralcio del libro appena uscito.

(...) Il giornalismo, quello dei grandi quotidiani, dal punto di vista del
movimento del 77 mentiva, alterava, stava invariabilmente dalla
parte del regime, che si trattasse di quello politico, giudiziario,
economico, o tutti i poteri insieme in blocco compatto.
 Se
la stampa voleva sopravvivere come contropotere, non poteva
che essere “Controinformazione”, per citare, e non
per caso, una rivista nata a Milano nel 73, che si proponeva
non come organo di un qualche raggruppamento politico, né
intendeva essere, come tante riviste precedenti di sinistra,
parlamentare o extraparlamentare, una sede di elaborazione teorica,
e nemmeno limitarsi all'attualità italiana. Se
la stampa voleva sopravvivere come contropotere, non poteva
che essere “Controinformazione”, per citare, e non
per caso, una rivista nata a Milano nel 73, che si proponeva
non come organo di un qualche raggruppamento politico, né
intendeva essere, come tante riviste precedenti di sinistra,
parlamentare o extraparlamentare, una sede di elaborazione teorica,
e nemmeno limitarsi all'attualità italiana.
Il punto di vista, certo, era dichiaratamente anticapitalistico
e antimperialistico: si esaminavano in concreto le ristrutturazioni
industriali e tecnologiche in corso, la riorganizzazione del
lavoro in fabbrica, le strategie delle multinazionali e quelle
militari in atto sul pianeta, offrendo copiose testimonianze
dal Terzo Mondo. Si studiavano le trasformazioni della magistratura
e dei corpi di polizia, la situazione nelle carceri, le manipolazioni
della stampa scritta e radiotelevisiva. Ampia era la pubblicazione
integrale di documenti. Molta l'attenzione dedicata al sociale
e ai protagonisti delle lotte sul territorio.
Insieme a tutto questo, “Controinformazione” teneva
un profilo alto nella veste grafica. Le copertine a colori erano
opera di un notevolissimo pittore, Paolo Baratella, che aveva
esposto e ricevuto riconoscimenti non soltanto in Italia ma
in tutta Europa, a Mosca, negli Stati Uniti e in Canada. Copertine
tutt'altro che da “realismo socialista”, spesso
cupe ed enigmatiche, sempre di grande forza espressiva. (Sua,
per inciso, la doppia cover del primo lp dell'Ultima Spiaggia,
il già citato Disco dell'angoscia.) Il formato
della rivista era grande, non a quadernetto: un centinaio di
pagine per numero, fotografie, disegni, grafica sempre perfettamente
leggibile. Nel pieno della lotta armata era fatale che la rivista
si ritrovasse in un equilibrio difficile e instabile tra l'antagonismo
radicale e la documentazione pura.
Verrà poi trascinata, a partire dal sequestro Moro, nell'arena
dello scontro politico nelle aule dei tribunali e nelle commissioni
parlamentari, dove si ipotizzeranno collegamenti operativi tra
Toni Negri e le Br attraverso la rivista stessa (o si fanno
riunioni redazionali o si fanno incontri clandestini, l'insurrezione
a tavolino è roba che può venire in mente solo
a magistrati che per mestiere stilano sentenze di pagine e pagine,
la cui lettura corrisponde a un verdetto dalle immediate conseguenze
operative). Comunque, una funzione importante “Controinformazione”
l'ha avuta, anzitutto sul piano della documentazione, che le
normali indagini giornalistiche erano ben lontane dal mettere
a disposizione dei lettori, e poi sul piano che dicevo prima:
raccontare le trasformazioni nei rapporti sociali, nella produzione,
negli assetti del potere, piuttosto che esprimere opinioni tanto
anticonformiste quanto circoscritte a settori specialistici,
e a un dibattito tra intellettuali spesso ostico, se non del
tutto incomprensibile, per gli estranei all'ambiente.
Caso simile eppure diverso quello di “A-Rivista anarchica”,
fondata nel 1971. Grande formato, notevole spazio alla fotografia
e al disegno, ma la fotografia più che al lato estetico
bada all'illustrazione dei momenti di lotta e il disegno si
ricollega alla tradizione della satira di inizio secolo. La
fotografia di tipo documentativo tuttavia non manca di forza
espressiva. Bellissima per esempio la fotografia di copertina
del n. 9 (novembre-dicembre) del 1977 con una fila di ragazzi
addossati a un muro durante una perquisizione di polizia: parla
da sola. E gli obiettivi della satira non sono i capitalisti-maiali
con il cilindro, ma volti ben definiti di leader politici, come
nel numero di giugno, dove sulla copertina compare Breznev che
caca sui lillipuziani che lo sorreggono. Il titolo è:
La nuova Costituzione Sovietica. Il privilegio istituzionalizzato.
Sull'Unione Sovietica la stampa alternativa di quegli anni indaga
poco, di rado, e svogliatamente. Filosovietica non è,
però se si analizza poco quello scenario è perché
si ritiene che il nemico principale sia un altro, sia, alla
fine, uno soltanto: l'imperialismo americano. Per gli anarchici
non è così.
Gli anarchici sono equanimi, non perché mettano sullo
stesso piano, sullo scenario mondiale, le forze dei due blocchi,
ma perché nell'autoritarismo sovietico, da anarchici
e da libertari, non possono in alcun modo riconoscersi. Anche
“A-Rivista anarchica” pubblica molta documentazione
e segue con attenzione le lotte con uno sguardo non limitato
all'Italia, ma al contempo si interroga sugli elementi problematici
interni al movimento, non li scansa. Sul numero già citato
di novembre-dicembre un articolo (di P.F.) centra criticamente
la questione della violenza sfatandone il mito (titolo: Il
mito della violenza). Si legge: “Alcuni settori della
sinistra rivoluzionaria dimostrano una fiducia mitica nella
violenza [...] Negli ultimi mesi, in particolare, vi è
stato un netto aumento del numero e della varietà degli
episodi di lotta armata in Italia: ferimenti di giornalisti,
di capi-reparto, di direttori responsabili del personale, di
dirigenti locali della Democrazia, assalti armati alle sedi
delle forze conservatrici e padronali, uso delle armi contro
le forze repressive dello Stato nel corso di manifestazioni
di piazza ecc.
Nel complesso, quella violenza armata che nel 71 era usata sistematicamente
solo dai primi nuclei delle Brigate Rosse viene oggi praticata
– seppure in forme diversificate – non solo dalle
altre formazioni clandestine (o quasi) che alle Br si sono aggiunte,
ma anche da una parte (non certo clandestina) del 'nuovo movimento'”.
Il punto, riguardo all'uso della violenza, è chiedersi:
Contro chi? Per che cosa?. Un confine netto che va stabilito
è quello della tolleranza. “Impedire sistematicamente
che gli altri, che la pensano diversamente da noi, diffondano
la loro stampa, propugnino le loro idee, parlino in pubblico,
non può far parte della nostra pratica costante. Il diritto
d'espressione degli 'altri' ha per noi lo stesso valore del
nostro diritto a dire la nostra opinione: la libertà
degli altri, in via di principio, arricchisce la nostra, non
la limita.” Era importante, davvero molto importante scrivere
queste cose nel 77, affrontare apertamente la questione del
discrimine alla luce del contro chi? e del per che
cosa?, ribadire l'aspetto e il senso libertario delle lotte
contro l'insensata “logica” militarista.
Gianfranco Manfredi
Contro l'ortodossia/
Marina Abramovic e il suo metodo
Qualche tempo fa è stato pubblicato un testo dal titolo
piuttosto intuitivo “Lo potevo fare anch'io. Perché
l'arte contemporanea è davvero arte”1,
scritto da Francesco Bonami, critico e curatore d'arte fiorentino.
Quella di Bonami è da intendersi quale una provocazione
all'arte contemporanea, soprattutto quando dinanzi a certe opere
tutti noi, abbiamo - almeno una volta - pensato: “Questo
lo potevo fare anch'io”.
Zucche a pois, pianoforti attaccati al soffitto, bicchieri d'acqua
mezzi pieni o mezzi vuoti (a seconda dell'umore dello spettatore)
sono passabili sotto il concetto di “arte”. Ma è
davvero arte? Cosa distingue un grande artista da un uno pessimo
ma soprattutto l'arte per essere provocatoria deve essere necessariamente
“incomprensibile”? La rassicurazione viene da una
sfilza di critici che ci dice che dietro l'opera vige un concetto
ed è quello che fa vincere l'atto figurativo e ne elegge
lo statuto.
A tenere aperta questa questione è Marina Abramovic,
artista contemporanea di origini serbe che si è autodefinita
“nonna della performance art”. Nata a Belgrado nel
1946, figlia di due genitori partigiani, si forma presso l'Accademia
di Belle Arti della sua città per poi trasferirsi nel
1976 ad Amsterdam dove rimane per molti anni legata al suo compagno
di vita e d'arte Ulay, con il quale - per sancire la separazione
dopo dodici anni - percorre a piedi, per circa tre mesi, l'intera
muraglia cinese, sfidando stanchezza e solitudine.
 Stabilitasi
in seguito a New York, l'artista ha lì fondato il suo
istituto dedicandosi all'insegnamento e alla pratica del suo
metodo - il metodo Abramovic, appunto. Stabilitasi
in seguito a New York, l'artista ha lì fondato il suo
istituto dedicandosi all'insegnamento e alla pratica del suo
metodo - il metodo Abramovic, appunto.
Ciò che colpisce di Abramovic, del modo di stare nell'arte,
è la rivoluzione del limite e l'utilizzo del corpo nel
processo creativo, un corpo che si espone ad un allargamento
di visione che diventa a tratti violenta. Oltre a essersi fustigata,
aver urlato fino a perdere la voce, essersi fatta prendere a
schiaffi, aver fatto strisciare su di sé serpenti affamati,
Abramovic ha corso anche profondi rischi nel corso delle sue
performance come quando nell'opera Rythm 5, stava soffocando
in un incendio distesa dentro una stella unta di petrolio o
come quando nella Rythm 0, stava per essere sparata da una persona
che aveva afferrato una pistola armata (messa a disposizione
dall'installazione).
“Se io sono riuscita a sopravvivere a tutto questo, allora
anche voi potete farcela” - afferma Abramovic in piena
sovversione dell'effigie idealizzata dell'artista. Lo spettatore
può fare ciò che l'artista fa, ovvero creare un
“prodotto” che è ben lontano dall'esperienza
teatrale. La stessa Abramovic sottolinea come, se nel teatro
è tutto finto, nella performance è tutto vero,
anche il sangue. Laddove la funzione del teatro è espressione
di un copione- spesso già dato - che risponde a una vicinanza
con la platea - la funzione della performance art è la
rappresentazione di un limite che viene ad essere sabotato sia
dallo spettatore che dall'artista. È proprio attraverso
questo dispositivo che avviene lo scandalo, la meraviglia, lo
stupore e anche l'orrore.
C'è qualcosa di insondabile in questo personaggio, qualcosa
di anarchico, come una strenua rivolta contro l'ortodossia che
si estende fino all'esasperazione e questo si legge bene nelle
pagine dell'autobiografia (Attraversare i muri. Un'autobiografia,
Marina Abramovic, J. Kaplan, Bompiani, Milano, 2017, pp. 416,
€ 19,00) che Abramovic ha scritto con l'aiuto di James
Kaplan. Ciò che colpisce nella lettura della vita di
questa artista è l'eredità delle sue origini balcaniche
ruvide come i monti dell'ex Jugoslavia. Il racconto crudo del
regime repressivo di Tito fa spesso la sua digressione in quello
familiare, tra la violenza di una madre coriacea incapace di
donare carezze e l'assenza di un padre fedifrago poco attento
alle sue esigenze. L'espressione “attraversare i muri”
non pare scelta a caso, anzi è come se si declinasse
dall'arte alla vita nel suo significato più ampio. Attraversare
un muro, spiega Abramovic, implica il superamento non solo dei
vincoli reali ma anche dei vincoli più intimi, quelli
affettivi che sono immagine e simbolo delle apnee, delle mancanze
e delle paure che l'esistenza impone.
È come se - in termini psicoanalitici - stessimo dicendo
che solo attraversando la propria ombra, il proprio fantasma,
ci si possa individuare, soggettivare, sapere dove si è
rispetto a se stessi. E di solito è un percorso doloroso
ma liberatorio e Abramovic lo traduce nella violazione della
sacralità del corpo: “Avevo sperimentato la libertà
assoluta, avevo percepito il mio corpo senza limiti, senza confini.
Avevo provato che quel dolore non aveva importanza, che niente
aveva importanza”.
Una lettura molto acuta è stata offerta da Georges Didi-Huberman2,
storico dell'arte e filosofo francese. Nel suo esporre la dimensione
figurativa del corpo - dice Didi-Huberman - Abramovic è
come se ricorresse alla fotografia medica delle psicopatologie
della seconda metà dell'Ottocento come quella della Salpêtrière,
famosa clinica psichiatrica dove esercitò per anni il
neurologo Charcot e dove accorse anche Freud per imparare. Quelle
fotografie, in bianco e nero, di spettro manicomiale, raffigurano
donne isteriche nel pieno dei loro sintomi con tanto di didascalie,
un'iconografia che non è certamente definibile sotto
il termine di “arte” ma che rappresenta un tentativo
di inquadramento dell'isteria con tutti i suoi parossismi. Non
va dimenticato infatti, che all'epoca di Charcot, l'isteria
rappresentava il fascino (e il terrore) verso la psiche femminile.
In un lavoro di “antropologia dell'immagine” Abramovic
presenterebbe così il suo debito con queste foto e con
lo stesso Charcot, nella relazione, cioè, tra immagine
e discorso sul sapere.
La costellazione dell'estasi rintracciabile nelle opere di Abramovic
ed intesa nella sua fenomenologia accessoria, quale catalessia,
patetismo, erotismo e violenza si riallaccerebbe al mondo isterico
così profondamente indagato dalla psichiatria e dalla
psicoanalisi, ripensando il rapporto fra mondo fisico e quello
psichico, fra corpo e mente. E chissà, forse proprio
per questo, l'opera di Abramovic risulta, nel suo enigma, così
seduttiva.
Daniela Mallardi
- Lo potevo fare anch'io. Perché
l'arte contemporanea è davvero arte, F. Bonami,
Mondadori, Milano, 2009.
- L'invenzione dell'isteria. Charcot e l'iconografia fotografica
della Salpêtrière, G. Didi-Huberman, Marietti,
Torino.
Spunti di riflessione/
Memoria involontaria ed eredità sommerse
“Perché il dovere di non dimenticare il passato
sempre presente?” Motivo conduttore della scrittura di
Stajano (Corrado Stajano, Eredità, Il Saggiatore,
Milano, 2017, pp. 165, € 18.00), la memoria, in un dialogo
continuo con l'attualità. “È difficile,
forse inutile, si sa, cercare di evocare il passato, gli sforzi
della memoria, dell'intelligenza e anche dell'immaginazione
risultano vani. Talvolta una fuggevole sensazione, un antico
gesto, lo scorcio di un paesaggio, un suono riescono misteriosamente
a farlo ritrovare”. La memoria involontaria riporta così
alla luce eredità sommerse.
 La
prospettiva dal basso della narrazione: “Ero anch'io un
figlio della Lupa” conferisce al racconto un sentore di
straordinaria inconsapevolezza della guerra incombente. La
prospettiva dal basso della narrazione: “Ero anch'io un
figlio della Lupa” conferisce al racconto un sentore di
straordinaria inconsapevolezza della guerra incombente.
Il Figlio della Lupa - un padre soldato e una madre che, da
ragazzina, nel '15-'18 non ha dimenticato la tragedia della
guerra, con Caporetto, i profughi del Friuli - conosce dal “Corriere
dei Piccoli” le vicende straniate di un mondo fiabesco
illustrate dal signor Bonaventura. Ma come spinto da una forza
segreta, si schiererà sempre dalla parte dei perdenti.
Quando la guerra comincerà ad incendiare l'Europa, dopo
gli attacchi dei sottomarini tedeschi contro la portaerei inglese
“Courageous” nella Manica, l'affondamento della
corazzata Royal Oak, e anche quando il 30 novembre l'Unione
Sovietica aggredirà la Finlandia, il Figlio della Lupa
farà il tifo per i soldati con le tute bianche del maresciallo
Carl Mannerheim. Vede al cinema, nei cinegiornali dell'Istituto
Luce, gli esperti sciatori combattere sulla neve contro il gigante
russo.
La storia individuale e personale si apre alla storia del Novecento,
narrata dallo scrittore attraverso l'eredità - testimonianza
dei luoghi, intervallata da frammenti di diari, saggi, lettere
di chi ha vissuto le persecuzioni, l'internamento, la guerra.
Documenti ufficiali restituiscono nomi sconosciuti di sovversivi,
non più giovani, colpevoli di scambiarsi due chiacchiere
all'osteria, spiati dagli informatori. Sui registri neri nella
Casa del Fascio di Terragni, verranno schedati per motivi politici:
essere un socialista praticante, un esponente del Partito Popolare,
proclamarsi “di idee rosse”, essere “malcontento
e insofferente della libertà fascista”, oppure
bollato perché “contraddice tutto quanto sa di
fascismo”.
Spunti di riflessione emergono da figure enigmatiche e inquiete.
Come quella di Margherita Sarfatti, ebrea, la consigliera del
duce. Con la biografia “Dux” lascerà la sua
scomoda eredità. Dirà Mussolini a Claretta Petacci:
“Il mio errore, il più grande errore della mia
vita: averle permesso di scrivere un libro su di me è
al di là di ogni comprensione, non so come abbia potuto
legare per sempre il nome di quella donna al mio. Nella storia
passerà come la mia biografia”.
Farinacci, fascista di piazza San Sepolcro, nominato segretario
del Pnf, avvocato per meriti massonici di provincia, difensore
in tribunale dei sicari di Giacomo Matteotti, sarà il
primo denigratore di Margherita Sarfatti. Sulla donna incomberanno
i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”,
poi convertiti in legge. Sarà costretta a lasciare l'Italia
e raggiungerà Parigi passando per la Svizzera.
Altra l'eredità di padre David Maria Turoldo, il gigante
dai capelli rossi, il frate servita, uomo della Resistenza.
Tra i fondatori del “Fronte della gioventù per
l'indipendenza nazionale e per la libertà”, le
sue prediche faranno tremare i muri e risveglieranno le coscienze.
Volitivo, tenace resisterà anche alle accuse di “frate
rosso” mosse dai perbenisti, per il suo rifiuto della
chiesa-potere, l'appoggio alle minoranze intellettuali e politiche,
ai popoli più deboli e oppressi.
Il racconto prende forma tra le mura di una scuola, con il severo
maestro in orbace. Distribuisce ad ogni scolaro una bandierina
tricolore e una germanica con la croce uncinata, in attesa del
grande evento ormai imminente: l'incontro tra Galeazzo Ciano
e Joachim von Ribbentrop, i ministri degli Esteri “collaboratori
fedeli del duce e di Adolfo Hitler”, come la scolaresca
apprenderà da “La Provincia di Como”, 8 maggio
1939.
E mentre in controluce la vita quotidiana sembra scorrere come
su una pellicola in bianco e nero, il 22 maggio nei saloni della
Cancelleria del Reich a Berlino sarà firmato il protocollo
segreto: “Le due nazioni unite nell'intimo delle loro
ideologie (...) sono decise a marciare fianco a fianco, unendo
le loro forze per assicurarsi uno spazio vitale”.
Tra gite domenicali con il battello per Bellagio, Menaggio,
Ossuccio, un tè danzante, balli di gala, cena a mezzanotte
e campionati di golf a villa d'Este, i giovani non sembrano
mostrare trepidazione per il loro futuro. Propaganda e irreggimentazione
avevano già maturato i loro frutti.
Il bambino cresciuto in fretta, ora ragazzo, dopo i bombardamenti
nell'agosto del '43 su Milano, rivede la città distrutta,
interi quartieri, palazzi, il castello, il duomo, le chiese.
E la fabbrica dell'orrore in via Santa Margherita 16, all'albergo
Regina, sede del servizio di informazioni e di spionaggio politico
e militare della Germania nazionalsocialista. All'ultimo piano
nelle celle di sicurezza vengono interrogati uomini della Resistenza,
ebrei, cittadini e cittadine innocenti. La narrazione è
filtrata dal vissuto del ragazzo che ora si sente un Pinocchio
e non indosserà più la divisa nera, e dalle voci
corali della popolazione che assiste inerme, come immersa in
uno stupore apocalittico, senso di dissacrazione e profanazione
dei luoghi, paura, sospetto.
Il padre tornato dal lager, dopo una notte di racconti, non
parlerà mai più dei campi di concentramento e
di sterminio. “Dopo lo sfogo, il silenzio, non sereno,
sordo, sarebbe stato giusto far domande? Chiedere? Pungere la
memoria riluttante?” Ancora: “Lo impedì nel
ragazzo anche la soggezione delle vecchie generazioni nei confronti
del padre”.
Un'eredità pesante, quindi, sulla quale il presente è
chiamato a riparare rimanendo con l'attenzione sempre vigile
sul risveglio dei germi di nuovi fascismi e guerre nuove. Ma
anche un'eredità impegnativa, un patrimonio ideale di
valori incarnati nella Resistenza: la faticosa e mai conclusa
conquista della Giustizia e della Libertà.
Ancora una volta, come in altre opere dello scrittore particolarmente
riuscite - così “La stanza dei fantasmi: Una vita
del Novecento”- la storia del “Secolo breve”,
dalla penna di Corrado Stajano, si fa racconto di un vissuto
individuale e collettivo, capace di commuovere e smuovere le
coscienze.
Claudia Piccinelli
|