
Antifascismo, Resistenza, nonviolenza/
Sulle orme di Aldo Capitini
 Il
libro di Alfonso Navarra e Laura Tussi Antifascismo e nonviolenza
(Mimesis, Milano, 2017, prefazione di Adelmo Cervi, contributi
di Fabrizio Cracolici e Alessandro Marescotti, pp. 82, €
7,00) rilancia il binomio antifascismo e nonviolenza, un filone
al centro del dibattito politico e culturale del Novecento in
varie parti dell'Europa. Il
libro di Alfonso Navarra e Laura Tussi Antifascismo e nonviolenza
(Mimesis, Milano, 2017, prefazione di Adelmo Cervi, contributi
di Fabrizio Cracolici e Alessandro Marescotti, pp. 82, €
7,00) rilancia il binomio antifascismo e nonviolenza, un filone
al centro del dibattito politico e culturale del Novecento in
varie parti dell'Europa.
In Italia il personaggio chiave di questo pensiero è
certamente Aldo Capitini, fondatore con Guido Calogero del liberalsocialismo,
perseguitato dal regime fascista, arrestato e incarcerato nel
1942 e 1943, a Firenze e Perugia. “Parlare della Resistenza
italiana - scrive Capitini nell'inedito “La Resistenza
italiana” del 1955 - non sarebbe completo né esatto,
se non si estendesse il termine a comprendere non soltanto la
Resistenza armata dall'8 settembre '43 al 25 aprile '45, ma
anche la resistenza politica, morale, ideologica, che fu dal
3 gennaio 1925”.
Sempre nel 1955, nello scritto autobiografico, “Sull'antifascismo
dal '31 al '43”, Aldo Capitini rafforza ulteriormente
il progetto di una Resistenza non violenta. “Il periodo
della Resistenza armata - osserva Capitini - non esaurisce la
Resistenza, in quanto essa è stata qualche cosa di più
complesso di un'azione armata, anche qualche cosa di più
durevole della fine pura e semplice di quel regime”. E
in un altro scritto del 1967, “Aspetti dell'opposizione
etico-culturale al fascismo”, Capitini osserva che “l'opposizione
non è che la lunga premessa morale, culturale e politica
di quella che poi è stata detta «Resistenza»
e che ne è l'esecuzione, per così dire, armata”.
In sostanza, Capitini non rinuncia alla lotta contro il fascismo,
non si sottrae allo scontro, anche durissimo, ma sceglie una
seconda via: l'antifascismo della nonviolenza. Si tratta di
un pensiero scomodo nell'Italia dall'8 settembre 1943 al 25
aprile 1945, un periodo in cui le posizioni in campo sono due:
la brutalità del regime fascista e la contrapposizione
dell'opposizione armata.
“Non volevo né criticare ciò che altri avevano
fatto con tanto coraggio ed eroismo, né perdere quella
doverosa affermazione che mi toccava, di un metodo diverso,
del sogno che gli italiani si liberassero da sé dal fascismo
con un'eroica non collaborazione e disobbedienza civile”.
In “Note di antifascismo nazionale e perugino”,
Capitini cita il metodo gandhiano della non violenza.
“I miei amici sanno che il mio pensiero e il mio sogno
era che in Italia sorgesse una non collaborazione generale,
coraggiosa, tenace, secondo il metodo di Gandhi, negando ogni
appoggio al fascismo e ogni mezzo, ma senza torcere un capello
a nessuno; e in poche settimane il regime avrebbe finito di
funzionare, e non sarebbero venuti gli immensi disastri di poi”.
Quella di Capitini non è una teoria isolata, bensì
un sogno interrotto, una utopia non realizzata, una buona pratica
mal interpretata. In molti l'hanno fatta propria prima, durante,
dopo il fascismo: padre Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani,
Danilo Dolci, Riccardo Tenerini, Alex Langer, fino a Stéphane
Hessel, a cui si ispira il lavoro di Navarra e Tussi. “La
nonviolenza è il cammino che dobbiamo imparare a percorrere”.
L'indicazione di Hessel resta attuale, ancora oggi, negli anni
in cui il fascismo sembra imperversare lungo le vie d'Europa.
Daniele Biacchessi
Antispecismo/
Una questione di passione?
 Si
potrebbe definire l'ultimo libro di Massimo Filippi, Questioni
di specie (Elèuthera, Milano, 2017, pp. 120, €
13.00), un libro sulla passione. La passione degli animali,
innanzitutto: il dolore immane e l'orrore inimmaginabile delle
moltitudini animali sterminate e oppresse dalla violenza istituzionalizzata
del loro sfruttamento e messa a morte. Ma anche la passione,
vitale, dell'antispecismo che ascoltando e amplificando il gioioso
grido libertario del movimento animale indica una nuova politica
della comunità a venire. Si
potrebbe definire l'ultimo libro di Massimo Filippi, Questioni
di specie (Elèuthera, Milano, 2017, pp. 120, €
13.00), un libro sulla passione. La passione degli animali,
innanzitutto: il dolore immane e l'orrore inimmaginabile delle
moltitudini animali sterminate e oppresse dalla violenza istituzionalizzata
del loro sfruttamento e messa a morte. Ma anche la passione,
vitale, dell'antispecismo che ascoltando e amplificando il gioioso
grido libertario del movimento animale indica una nuova politica
della comunità a venire.
Il testo di Filippi mira, con profondità e chiarezza
d'analisi e mediante un percorso graduale - che passa attraverso
la preliminare definizione di che cosa siano la questione animale
e lo specismo - proprio alla caratterizzazione di questo antispecismo.
E cioè di «un movimento politico di critica radicale
dell'esistente» (p. 15) che sia in grado di resistere
e di arrestare le contrazioni digestive di quell'eccezionale
«apparato digerente» (p. 16) che è
il capitalismo contemporaneo e di sviluppare, finalmente, altre
specie di prassi e di pensiero chiedendo, né più
né meno, la liberazione animale. Il capitalismo ha mostrato,
infatti, una straordinaria capacità di resilienza di
fronte alle diverse istanze antagoniste che nel corso del tempo
ne hanno perturbato l'ordine: femminismi, movimenti Lgbt, ecologismo,
movimenti per la libertà di migrazione... Non solo
ha resistito e continua a resistere al loro urto, ma ha anche
la forza di neutralizzarne la carica sovversiva e, grazie all'attuale
neoliberalismo imperante, di trasformarle in innocui stili di
vita o, meglio – scrive Filippi –, in redditizi
«stil[i] di consumo» (p. 17). Meccanismi fagocitanti
di questo tipo sono già all'opera anche nel caso del
movimento per la liberazione animale: basta pensare alla crescente
fetta di mercato vegan o al proliferare del concetto
di benessere animale la cui ipocrisia strategica è funzionale
al permanere dello sfruttamento e dell'uccisione dei corpi animali.
Questioni di specie assume allora un'importante valenza
militante – oltreché teorica – configurandosi
come punto di riferimento, e di partenza, per un pensiero che
aspiri alla resistenza e sovversione dell'ideologia e delle
pratiche di dominio, tanto dell'uomo sull'animale quanto dell'uomo
sull'uomo. La tesi del saggio, sostenuta con fermezza da Filippi,
è infatti che «il sistema di smembramento di tutti
i corpi (umani inclusi) continuerà a funzionare a pieno
regime finché le bestie saranno trattate come sono trattate»
(p. 18). Da ciò segue la necessità stringente
di un antispecismo intersezionale, capace di contaminarsi, a
livello analitico e di lotta, con altri movimenti politici di
liberazione ed emancipazione di più lunga esperienza.
Ma anche la necessità che questi stessi movimenti inizino
a prendere sul serio le questioni di specie, smettendo di considerarle
faccende di secondo piano per poche anime belle e rivedendo,
criticamente, il loro antropocentrismo.
Il libro di Filippi non è soltanto un libro su
questo antispecismo a venire, ma è già un libro
intersezionalmente antispecista che fin dal titolo si ibrida
con il pensiero femminista-queer, rinviando al suo testo inaugurante,
opera della filosofa americana Judith Butler, Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity, tradotto in italiano
come Questione di genere. Il femminismo e la sovversione
dell'identità. Non si tratta di un collegamento puramente
nominale, ma di una continua interlocuzione che, grazie a un'approfondita
conoscenza, può provocare gli strumenti concettuali elaborati
in questo ambito per spingerli oltre le soglie dell'umano.
Così Filippi può lavorare alla decostruzione della
dicotomia gerarchica di uomo/animale, mostrando che anche il
sostantivo “uomo”, come i suoi attributi di maschio,
bianco, eterosessuale... già decostruiti dalle rispettive
teorie critiche, ha ben poco a che fare con la biologia e molto
con la politica. Anche il dualismo uomo/animale, che legittima
ideologicamente lo smembramento dei corpi, e i dispositivi che
effettuano tale smembramento sono costituiti in modo analogo
a quanto succede nel caso del binarismo di genere con la norma
eterosessuale, ossia sono prodotti da, ed entro, una cornice
normativa: la norma sacrificale.
L'autore, inoltre, non esita a intersecare ulteriormente il
riferimento alla riflessione femminista e queer con i “suoi”
filosofi (Adorno, Agamben, Nietzsche, Deleuze, Foucault... per
non citarne che alcuni), al fine di sviluppare questo nuovo
antispecismo, che prende il nome di antispecismo del comune.
Dopo i cosiddetti antispecismo dell'identità –
volto all'estensione del riconoscimento morale a certi animali
in quanto dotati di caratteristiche (quasi) propriamente umane
– e antispecismo della differenza – volto alla moltiplicazione
delle linee di differenza tra l'uomo e l'animale – prende
forma un pensiero che non traccia più alcuna linea, rifiuta
l'esistenza stessa di un “proprio” dell'uomo e spicca
il volo verso l'impropria relazionalità del comune. «Il
comune – scrive Filippi – è lo spazio in
perenne mutamento dove la vulnerabilità e finitudine
dei differenti corpi sensuali incontrano la capacità
tutta “animale” di gioire, di giocare,
di rendersi inoperosi, ossia di muoversi e sentire senza
un fine prestabilito, sottraendosi in tal modo agli imperativi
categorici della produttività e della riproduzione»
(p. 76).
Chiara Stefanoni
1. Che cosa sia il fenomeno del dominio, nel suo diversificarsi da quello del potere e dalla violenza, è precisato dall'autore in una pagina tanto agile quanto concettualmente fondamentale. «Il dominio si realizza nell'assoggettamento annichilente, nel controllo sistematico, assoluto, totale, capillare e completo sulla vita di chi, più che oppresso, è già-morto. [...] In ambito intraumano il nonluogo dove il dominio si manifesta compiutamente è il campo di sterminio, dove impossibilità di resistenza e invisibilità sociale raggiungono il loro acme» (p. 35).
Sacco e Vanzetti/
La loro storia, i funerali, le ceneri
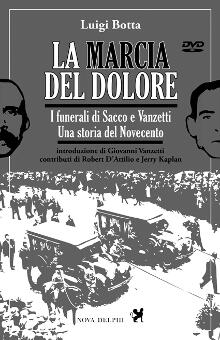 Novant'anni
fa due lavoratori anarchici - innocenti - vengono uccisi sulla
sedia elettrica nel carcere di Charlestown, Boston Massachusetts,
pochi minuti dopo la mezzanotte tra il 22 e il 23 agosto 1927,
a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Novant'anni
fa due lavoratori anarchici - innocenti - vengono uccisi sulla
sedia elettrica nel carcere di Charlestown, Boston Massachusetts,
pochi minuti dopo la mezzanotte tra il 22 e il 23 agosto 1927,
a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.
I loro nomi e la loro storia sono noti in tutto il mondo. Sono
il calzolaio pugliese Nicola Sacco (Torremaggiore, Fg, 1881)
e il pescivendolo piemontese Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto,
Cn, 1888), emigrati negli Stati Uniti e attivi politicamente
nei circoli e nei giornali anarchici, lettori e collaboratori
del settimanale «Cronaca Sovversiva». La notte del
3 maggio 1920 il tipografo anarchico Andrea Salsedo «vola»
dal 14° piano del palazzo della polizia di New York sfracellandosi
sul marciapiede. La sera del 5 maggio, in compagnia di Nicola
Sacco, su un tram, Vanzetti - che si era già occupato
dell'arresto segreto di Salsedo - è arrestato e gli trovano
in tasca un volantino per un comizio di protesta per l'illecita
detenzione e per la tragica morte del tipografo siciliano. Li
incolpano di una rapina a mano armata e della morte di due persone.
Sulla base dei pregiudizi politici e razziali sono condannati
alla pena capitale. Al processo il Procuratore Generale Fedrerik
Katzmann era stato chiaro: «Se anche non fossero colpevoli
di rapina e di omicidio, sono colpevoli di essere anarchici
ed italiani». In tutto il mondo si susseguono manifestazioni
per strapparli alla sedia elettrica. All'inizio il quotidiano
anarchico «Umanità Nova» e altre testate
registrano in Italia oltre seicento manifestazioni a loro favore.
Poi il fascismo mette tutto a tacere. Solo qualche giorno prima
dell'esecuzione, mentre il re tace, Mussolini - che ha riempito
le prigioni e il confino di anarchici - senza alcuna convinzione,
fa un superficiale intervento a loro favore.
Vanzetti esprime il desiderio di vedere una delle sorelle ed
è raggiunto da Luigina. Sacco vorrebbe essere sepolto
al suo paese. Dopo l'esecuzione e il funerale del 28 agosto
i loro corpi vengono cremati e una metà delle ceneri
destinate in Italia. In carcere respingono coerentemente più
volte l'offerta dei conforti religiosi. Sacco muore da solo,
senza aver visto nessuno dei suoi familiari, che non si sono
spostati e Rosa Zambelli, la moglie, nei sette anni di galera
del marito, non ha quasi mai avuto rapporti con Torremaggiore.
Al funerale, otto miglia sotto la pioggia, partecipa una folla
di oltre mezzo milione: uomini e donne sfilano con un feltro
rosso - distribuito dagli anarchici - al braccio con la scritta
nera in inglese: «Remember. Justice Crucified August 23,
1927». «Ricordate! La Giustizia è stata
crocefissa il 23 agosto 1927!». Eleganti, composti
e tristi, in giacca e cravatta o con il papillon, gli operai,
i minatori, i calzolai, i contadini anarchici. La polizia, che
vieta bandiere e cartelloni, carica i partecipanti. Il Defense
Committee «Sacco and Vanzetti» di Boston, consapevole
dell'importanza dell'evento funebre, incarica alcuni cineoperatori
di riprendere di nascosto e clandestinamente il funerale con
cineprese collocate lungo il percorso, per documentarlo ai posteri.
Lo stesso giorno il governo ordina tassativamente la distruzione
dei filmati, ma la preziosa pellicola di 4'30'' viene sottratta
alla distruzione, finendo in mani anonime e solo nel 2014 è
stata restaurata e resa pubblica.
|
| Luglio 1921. Dal carcere al tribunale di Dedham il percorso è breve:
Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, ammanettati, vengono
accompagnati a piedi, tra due ali di folla, dagli ispettori di polizia |
Dopo la cremazione, viene deciso che una porzione delle ceneri
di Sacco verrà mandata in Italia e una delle ceneri di
Vanzetti rimarrà negli Stati Uniti e saranno entrambe
custodite da Rosa Zambelli. Luigina accompagna nel viaggio per
l'Italia le ceneri di entrambi, che sono custodite in due urne
separate e distinte collocate in una cassetta. All'arrivo in
Francia la polizia le sequestra per consegnarle alla polizia
italiana che le porterà a Villafalletto, dove - senza
tener conto del rifiuto ai conforti religiosi opposto in carcere
- sono benedette dal parroco. Il 14 ottobre le ceneri di Vanzetti
vengono seppellite, quelle di Sacco proseguono per Torremaggiore
e sono seppellite il giorno dopo. Temendo manifestazioni sovversive
il paese è presidiato dai carabinieri. Ciò nonostante
al loculo - sul quale le autorità vietano di scrivere
il nome - appesa ad un chiodo, viene trovata una corona di fiori
rossi. Il colore fa infuriare le autorità, che fermano
il fioraio Gino Moffa, ma è rilasciato poco dopo. Per
paura di altre manifestazioni, la tomba è sorvegliata
anche di notte! E il due novembre, il giorno dei morti, è
guardata a vista per impedire capannelli e depositi di fiori.
|
| Dall'interno della gabbia dove sono collocati, in una pausa durante
processo, i due italiani riescono anche a dialogare con la moglie di Nicola
Sacco, «Rosina», ovvero Marianna Teresa Rosa Zambelli, nata a
Lonato sul Garda (Brescia) il 13 giugno 1895 |
|
| Due cartoline su Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti
(Archivio Galzerano Editore) |
Intanto in America le ceneri sono custodite da Rosa Zambelli
nel giardino di casa, a Millis dove si è trasferita.
Luigina vorrebbe quelle del fratello a Villafalletto e nel 1930
vengono recuperate dall'anarchico Emilio Coda, che le affida
alla famiglia di Alfonsina e Vincenzo Brini, con i quali Vanzetti
ha vissuto a lungo. Nel 1949, in occasione del suo primo viaggio
in Italia, Alfonsina pensa di consegnarle a Luigina, ma Aldino
Felicani, giornalista anarchico, responsabile del Comitato,
amico dei due anarchici, è contrario e - spiega in una
lettera a Luigina - vorrebbe custodirle in un monumento da costruire
a Boston per perpetuare la memoria di Sacco e Vanzetti. Rimangono
ancora nelle mani di Alfonsina Brini che nel 1966 le consegna
ad Aldino Felicani, che scompare l'anno dopo. Il 26 ottobre
1979 i figli Anteo e Arthur Felicani donano l'urna con le ceneri
di Vanzetti e tutto il prezioso materiale del padre (lettere,
foto, giornali, libri, ecc.) alla Boston Public Library, che
lo custodisce e ha digitalizzato il fondo Felicani. Le ceneri
di Nicola Sacco invece sono andate disperse.
|
| Il 7 agosto 1927, durante il viaggio verso gli Stati Uniti, Luigina Vanzetti
partecipa ad una grandiosa manifestazione di protesta a Parigi |
|
| A Boston, il 28 agosto 1927, il funerale di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,
la «Marcia del dolore», prende l'avvio da Hanover Street, dove ha sede l'impresa di pompe
funebri di Joseph Langone, e raggiunge il cimitero di Forest Hills, dov'è
il «crematorium». Si snoda per un percorso di 13 km |
Alla vicenda del funerale e delle ceneri è dedicato l'appassionante
volume con la ricerca di Luigi Botta La marcia del dolore.
I funerali di Sacco e Vanzetti, una storia del novecento
(Nova Delphi Editrice, Roma, 2017, pp. 190, € 18,00) che
ricostruisce e documenta nei minimi dettagli tutti i passaggi.
È un argomento insolito, inedito e sconosciuto, il funerale
e le ceneri. Analizzando e ordinando cronologicamente i vari
documenti, Botta segue i fatti con meticolosa precisione e con
una straordinaria partecipazione umana, culturale e politica,
chiarendo - con linguaggio toccante e penetrante - i passaggi
oscuri. Narra in maniera avvincente, passo dopo passo, particolari
inediti e di grande interesse e, documenti alla mano, smentisce
la diceria delle ceneri mescolate e sepolte insieme. Nel bel
libro - al quale è allegato il dvd di Fabiana Antonioli
della Filmika di Torino, con il prezioso filmato del funerale,
The March of Sorrow, e un'intervista all'autore - Luigi
Botta, che da anni raccoglie in tutto il mondo materiale sulla
vicenda, troviamo la cronaca puntuale e in presa diretta di
quei drammatici e ancora oggi coinvolgenti e indelebili eventi,
che da novant'anni fanno parte della storia del movimento anarchico,
operaio e rivoluzionario.
Giuseppe Galzerano
Rivoluzione russa/
La disillusione di Emma Goldman
È uscito da poco Un sogno infranto. Russia 1917 (Zero in Condotta, Milano, 2017, pp. 120, € 10,00), antologia di scritti di Emma Goldman, inediti in italiano, a cura della nostra redattrice Carlotta Pedrazzini e con postfazione di Daniele Ratti. Ne pubblichiamo qui l'introduzione della curatrice.

Ad un secolo esatto dalla rivoluzione russa, il mito bolscevico non è
ancora stato sfatato, così come la credenza che rivoluzione
e bolscevismo siano sinonimi.
È questo che rende gli scritti sulla rivoluzione russa
di Emma Goldman (1869-1940) così ostinatamente attuali,
nonostante i decenni trascorsi. E tali resteranno fino a che
la verità su quegli anni non confuterà le analisi
falsate che hanno influenzato il mondo fin dai primi mesi che
seguirono la rivoluzione.
 Quando,
il 21 dicembre 1919, il governo degli Stati Uniti imbarcò
forzosamente Emma Goldman sulla nave Buford diretta in Russia
– insieme ad Alexander Berkman e ad altri 247 immigrati
colpevoli di avere opinioni politiche non gradite – l'anarchica
“più pericolosa d'America” era sinceramente
convinta che i bolscevichi fossero i portatori delle istanze
libertarie espresse dal popolo russo durante le sollevazioni
del febbraio e dell'ottobre 1917. Quando,
il 21 dicembre 1919, il governo degli Stati Uniti imbarcò
forzosamente Emma Goldman sulla nave Buford diretta in Russia
– insieme ad Alexander Berkman e ad altri 247 immigrati
colpevoli di avere opinioni politiche non gradite – l'anarchica
“più pericolosa d'America” era sinceramente
convinta che i bolscevichi fossero i portatori delle istanze
libertarie espresse dal popolo russo durante le sollevazioni
del febbraio e dell'ottobre 1917.
Goldman, una delle esponenti più influenti del movimento
anarchico statunitense, si schierò inizialmente dalla
parte dei bolscevichi, seppur marxisti, difendendoli dagli attacchi
che la stampa e le forze politiche statunitensi avevano rivolto
ai rivoluzionari russi. Tra il 1917 e il 1918 scrisse articoli
in loro sostegno e tenne conferenze in diversi stati americani
per far conoscere quella che, in quel momento, riteneva fosse
la verità sui bolscevichi.
Una volta messo piede sul suolo russo, però, la scoperta
della dittatura instaurata dal partito comunista trasformò
il sogno di essere approdata nella terra della rivoluzione sociale
in un orribile incubo. Alla sua entrata in Russia, nel gennaio
del 1920, il regime dittatoriale era già nel pieno delle
sue forze. Persecuzioni, uccisioni sommarie, incarcerazioni,
privilegi, militarizzazione del lavoro, povertà, carestie,
requisizioni forzate dei raccolti, violenze, prevaricazioni,
tutto questo e molto altro accadeva nella Russia post-rivoluzionaria.
Di ciò per cui la popolazione aveva lottato tra il febbraio
e l'ottobre del 1917 – ossia uguaglianza, giustizia sociale,
autodeterminazione, libertà, un sistema di soviet autonomi
– non c'era traccia. Se non nella propaganda del governo
bolscevico.
Il popolo russo si era battuto per la rivoluzione sociale, ma
il processo di emancipazione che aveva messo in moto si era
scontrato con la sete di potere dei bolscevichi, arrestandosi
definitivamente. Con il pretesto della guerra civile, del blocco
da parte dei paesi occidentali e della controrivoluzione, Lenin
e il suo partito avevano messo da parte le richieste della popolazione,
chiedendo di attendere tempi migliori per la loro realizzazione.
Ma quel futuro, come sappiamo, non arrivò mai.
Quando giunse in Russia, la cinquantenne Emma Goldman aveva
alle spalle tre decenni di lotta per l'emancipazione sociale
spesi tra le file del movimento anarchico statunitense. La convinzione
che in Russia si fosse realizzato ciò per cui aveva sempre
combattuto ostacolò la presa di distanza dai bolscevichi,
anche quando i segnali di una deriva negativa erano evidenti.
A quel tempo (gennaio 1920-dicembre 1921, tanto durò
la sua permanenza in Russia) molti anarchici in tutto il mondo
avevano già espresso critiche e perplessità nei
confronti del governo comunista e della cosiddetta “dittatura
del proletariato” instaurata nel paese. Eppure Goldman
faticava ad ammettere il fallimento.
Solo dopo quindici mesi di attente osservazioni e analisi della
situazione sociale, politica ed economica, Goldman riuscì
a riconoscere che la rivoluzione sociale era stata definitivamente
sconfitta. Non dai controrivoluzionari, ma dai bolscevichi.
Gli stessi per i quali in passato aveva speso parole entusiastiche.
Una sola possibilità: andare
all'estero e...
Mentre tutto volgeva al peggio, mentre la Ceka imprigionava
e giustiziava arbitrariamente anarchici e oppositori e la carestia
uccideva la popolazione, mentre il governo disponeva la militarizzazione
del lavoro e le requisizioni, accanendosi su operai e contadini,
Goldman non era rimasta a guardare. Aveva incontrato diversi
leader comunisti per esporre le sue perplessità e tentare
di far valere le istanze degli oppressi; aveva persino incontrato
Lenin per avere chiarimenti, nella speranza di riuscire in qualche
modo ad influenzare il terribile corso degli eventi. Fu nel
marzo 1921, dopo la rivolta dei marinai di Kronstadt repressa
nel sangue, che Goldman capì di non aver alcun margine
di azione. Nello Stato comunista russo non c'era spazio per
quei rivoluzionari che, come i marinai di Kronstadt, chiedevano
che venissero rispettate le richieste di libertà, uguaglianza
e autodeterminazione avanzate dal popolo nel 1917.
Goldman realizzò così di avere un'unica possibilità:
recarsi all'estero per raccontare al mondo cosa stesse effettivamente
succedendo in Russia, nella speranza di innescare un movimento
di solidarietà internazionale con i prigionieri politici.
Insieme agli anarchici Alexander Berkman e Alexander Shapiro,
l'1 dicembre 1921, ventitré mesi dopo il suo arrivo,
Emma Goldman lasciò definitivamente la Russia per non
farvi mai più ritorno.
A partire dal 1922, redasse diversi articoli a denuncia della
situazione politica e socio-economica russa, alcuni dei quali
sono raccolti in questo libro. Il senso di pubblicarli oggi,
a un secolo di distanza dalla loro stesura, è dato dal
principio “didattico” con il quale furono scritti
e dall'amore per la verità che, a suo tempo, li ispirò.
I testi di Emma Goldman sulla rivoluzione e sul seguente regime
comunista possono essere considerati un manuale di interpretazione
e di riferimento per tutti i movimenti sociali, non solo per
quello anarchico. Le riflessioni che Goldman concepì
sulla rivoluzione hanno travalicato lo spazio e il tempo di
quegli accadimenti e si sono spinte a toccare le più
generali questioni dell'autoritarismo, del significato delle
rivoluzioni, del potere, della dittatura, della violenza. Considerazioni
importanti, straordinariamente valide, con le quali tutti gli
esponenti dei movimenti socialisti e alternativi del mondo dovrebbero
fare i conti. Inoltre, riportare le testimonianze dirette –
e per lungo tempo ignorate – di un'esponente del movimento
rivoluzionario, riguardanti un evento così significativo
come la rivoluzione russa, è un essenziale esercizio
di verità storica. Reso ancora più importante
dalla completa dissonanza rispetto alle versioni ufficiali di
regime.
Sarebbe positivo se la stessa credibilità che quasi unanimemente
è riconosciuta a Emma Goldman nel campo dell'emancipazione
femminile si estendesse anche alle sue analisi sulla rivoluzione
russa. Si tratta di riflessioni che certamente si inseriscono
in una più vasta concezione anarchica, ma che –
proprio per la ricerca della verità che le ha ispirate
– non sono affatto il frutto dell'ideologia. Lo dimostra
il drastico cambiamento di valutazione sull'operato dei bolscevichi
avuto da Goldman tra il 1917 e il 1921.
Profonda e indiscutibile onestà
Proprio questo cambio di rotta le procurò, e le procura
tuttora, critiche da alcuni aderenti al movimento anarchico
che non le perdonano il ritardo con cui arrivò a prendere
le distanze dai comunisti al potere. In realtà, quella
che alcuni considerano una sbavatura o una debolezza di pensiero
è ciò che, ancor di più, conferisce valore
alle sue valutazioni, unicamente frutto di un'incontrovertibile
realtà che le si pose di fronte e con cui dovette fare
i conti.
Sebbene fosse una donna con solidi riferimenti ideologici, Emma
Goldman non lasciò mai che la rigidità teorica
offuscasse il suo sguardo scientifico e sincero sul mondo. Probabilmente
una visione più dogmatica degli eventi russi le avrebbe
impedito di esprimersi inizialmente a favore del regime bolscevico,
risparmiandole quella che fu per lei una delle più drammatiche
disillusioni politiche e personali. Di certo, però, le
sue considerazioni non avrebbero avuto lo stesso valore. D'altra
parte, la riconosciuta rilevanza di Goldman non deriva dalla
sua infallibilità, ma dall'aver prodotto delle analisi
sul mondo, sull'emancipazione sociale e sull'anarchismo tanto
valide quanto sofferte. Sempre pervase da una profonda e indiscutibile
onestà. [...]
Carlotta Pedrazzini
Pedagogia/
Buoni e cattivi maestri
 I
cattivi maestri, quelli, veri, sono altrettanto rari e preziosi
dei buoni maestri, particolarmente in un'epoca di uniformizzazione
e conformismo nascosti sotto la coltre delle immagini scintillanti
dello spettacolo. Entrambi, lontani dall'accademia e dal mainstream,
rischiano strade poco frequentate in prima persona, senza titoli,
paraventi, inclassificabili e irrecuperabili. Entrambi ci insegnano
a pensare con loro e contro di loro. Forse mentre i buoni maestri
ci spingono a trovare le nostre strade scavando in profondità,
i cattivi maestri aprono vie di fuga inaspettate, I
cattivi maestri, quelli, veri, sono altrettanto rari e preziosi
dei buoni maestri, particolarmente in un'epoca di uniformizzazione
e conformismo nascosti sotto la coltre delle immagini scintillanti
dello spettacolo. Entrambi, lontani dall'accademia e dal mainstream,
rischiano strade poco frequentate in prima persona, senza titoli,
paraventi, inclassificabili e irrecuperabili. Entrambi ci insegnano
a pensare con loro e contro di loro. Forse mentre i buoni maestri
ci spingono a trovare le nostre strade scavando in profondità,
i cattivi maestri aprono vie di fuga inaspettate,
Di questi ultimi si occupa il libro di Paolo Mottana, Cattivi
maestri. La controeducazione di René Schérer,
Raoul Vaneigem e Hakim Bey (Castelvecchi, Roma, 2014, pp.
128, € 14,50). Insegna filosofia dell'educazione in Bicocca
a Milano, è autore tra l'altro di Antipedagogie del
piacere. Sade Fourier e altri erotismi (Angeli 2008), Piccolo
manuale di controeducazione (Mimesis 2012) e tiene da anni
un blog dal titolo Controeducazione (contreducazione.blogspot.it),
in cui insegue pensieri controvento e in cui si può leggere:
“La controeducazione, contrapposta alla triste scienza
dell'ortopedia e dell'ingessatura, della mummificazione del
cucciolo d'uomo e delle sue ulteriori figure sull'altare del
conformismo e della passivizzazione, dell'ascetismo e della
rinuncia, dell'immolazione al sacrificio, alla fatica, alla
crocifissione, all'inginocchiamento, reali o metaforici, contrappone
l'esaltazione affermativa dell'immaginazione, delle emozioni,
del corpo e del piacere”. Bello no?
È emozionante trovare in qualcuno che non si conosce
direttamente, frequentazioni e passioni verso autori amati,
in particolare, almeno per me, Vaneigem, che continuo a leggere
dai tempi del bellissimo Trattato di saper vivere a uso delle
giovani generazioni, testo che ha mezzo secolo, ma a rileggerlo
oggi è di una freschezza e di un'attualità sorprendenti,
cosa che raramente accade ai testi “militanti” che
a volte oltre che triti diventato tristi.
Uno dei fili comuni che legano il pensiero di questi autori
diversi è il tema del desiderio e delle passioni che
si riallaccia alla grande esplosione del Sessantotto (e forse
ancor di più per l'Italia del Settantasette), o per dir
meglio della liberazione dei desideri, dal principio di produzione
e prestazione e dalla mercificazione dominante.
Il primo, Schérer (nato nel 1922), filosofo, autore di
alcuni testi fondamentali e purtroppo (non a caso) dimenticati
(e occultati) come Emilio pervertito (1974 della benemerita
Emme edizioni, reperibile sul sito educareallaliberta.org) e
Co-ire. Album sistematico dell'infanzia (Feltrinelli
1979), ha cercato di restituire al bambino quella passionalità
e quel desiderio anche erotico che, se non sono stati negati,
sono stati deviati e inquadrati dentro le maglie dei regimi
pedagogico, familiare, psicologico. Sono bambini in fuga quelli
di Schérer (e di Deligny1),
come quelli di Truffaut, in fuga dalla scuola, dalla famiglia,
dall'infantilizzazione che li priva di passioni e desideri esorbitanti
e improduttivi, gioiosi ma talvolta selvaggi, che ci guidano
in una sorta di wilderness poco frequentata dagli educatori2.
Ma, e qui è un punto centrale, e critico, l'uscita dal
“campo pedagogico”, comunque qualificato, porta
a vedere il bambino e l'infanzia liberati come cifre essenziale
della liberazione totale. La sua apparente incompletezza e imperfezione
su cui si accaniscono le orto-pedagogie è in realtà
tensione continua verso l'alterità, vitalità ingovernabile,
sovrabbondanza d'essere, apertura verso altri regni, oltre-umani.
I riferimenti essenziali di questa traversata oltre l'umanismo
(che fa del bambino un uomo in divenire), sono senz'altro Gilles
Deleuze e Charles Fourier a cui Schérer ha dedicato diversi
studi, autore di una utopia al cui centro stanno le passioni,
le loro composizioni e scomposizioni per la realizzazione di
una nuova armonia sociale.
Altro appassionato di Fourier è un altro cattivo maestro
del libro di Mottana, Hakim Bey, pseudonimo di Peter Lamborn
Wilson (nato nel 1945), noto in Italia soprattutto per il suo
scritto sulle TAZ. Zone temporaneamente autonome, (Shake
edizioni 1993, disponibile online). Inclassificabile rivoluzionario
(o forse meglio dire insorgente), sufi, mistico, sciamano, cyberpunk,
luddista e primitivista, poeta e visionario. Molto contestato
e chiacchierato anche nel mondo anarchico per le sue tendenze
mistiche, accomunato ai primitivisti come Zerzan, Hakim Bey
ha continuato il suo percorso solitario per fortuna senza ingessarsi,
né lesinare in autocritiche e cambiamenti di rotta. Come
scrive all'inizio della prefazione alla sua ultima raccolta
di scritti Anarchist Ephemera “questa raccolta
di pezzi effimeri e fuggiaschi degli ultimi vent'anni più
o meno (dal 1990 al 2013) dev'essere incorniciata da una prefazione
in cui io possa dissentire da me stesso”3.
L'insistenza di Hakim Bey sulla liberazione ora (il suo immediatismo)
deriva dalla delusione e la totale mancanza di fiducia verso
progetti messianici ed escatologici che, come dice scherzosamente
citando l'Alice di Lewis Carroll, parlano di “marmellata
ieri o marmellata domani, ma mai marmellata oggi”4,
in fondo figli di una cultura del sacrificio.
Nell'immediatismo di Hakim Bey, dice Mottana, si cerca di eliminare
ogni strumento che riduca l'impatto fisico e sensuale della
creazione e che soprattutto renda più facile la sua recuperazione
da parte dei sistemi di mediazione egemonizzati dal Capitale”5.
Ecco allora l'irruzione delle TAZ, zone autonome temporanee,
atti di creazione effimera che attraverso la liberazione del
desiderio letteralmente creano un nuovo spazio-tempo che è
un tempo di festa, lo spazio di un'utopia realizzata, instabile
e repentina. “la TAZ è “utopica” nel
senso che prevede un'intensificazione della vita quotidiana
o come avrebbero potuto dire i surrealisti, la penetrazione
della Vita da parte del Meraviglioso”6.
Sono piccole isole le TAZ che esistono anche in esperienze storicamente
lontane: nelle comunità di pirati, nelle azioni luddiste,
nelle comuni di Parigi e Marsiglia, ma che continuamente si
creano e scompaiono come onde nell'Oceano del caos.
La grande suggestione del pensiero di Hakim Bey sta nella sua
capacità straordinaria di montare nel suoi costrutti
teorici materiali del tutto eterogenei, appunto come si diceva
dal sufismo e sciamanesimo a Stirner e Nietzsche, senza tema
di contraddizione. Come scrive Mottana, si tratta di quello
che Bey definisce terrorismo poetico, “pratica
attiva di sabotaggio e destabilizzazione ironica e arguta, autentica
messa in pratica di quell'”anarchismo ontologico”
esso stesso generato dalla inarrestabile facoltà di invenzione
ossimorica di Bey, di autentica prassi contraddittoriale del
pensiero”7.
È una pratica creativa che affonda chiaramente le sue
radici nell'estetica dell'avanguardia, in particolare dadaismo
e surrealismo, avanguardie a cui è legato attraverso
il situazionismo anche l'ultimo maestro di cui si occupa il
libro, Raoul Vaneigem (nato nel 1934). Dopo il successo del
Trattato del 1967 già citato, ha continuato a
lavorare in disparte a ricerche sulle eresie e senza lasciare
mai il punto di una contestazione sociale radicale.
Ha scritto tra gli altri8 un
bel libro contro la scuola, La scuola è vostra,
recensito qui anni fa9. Anche
lui fourierista, mette al centro della sua riflessione il desiderio
e le passioni, prosciugate dal potere mortifero della società
mediatica e mercantile e in via di sparizione. In questo modo
la vita diventa sopravvivenza, un banchetto di avvoltoi sopra
un mondo in rovina. “Non c'è niente che uccida
con maggiore certezza che l'accontentarsi di sopravvivere”10.
E ci sono pochi testi, almeno per me, che abbiano come quelli
di Vaneigem il potere di scuotermi dal torpore della sopravvivenza,
di riaccendere le passioni, di spingermi alla rivolta contro
la rassegnazione con un linguaggio poetico straordinario. La
creatività non è qualcosa destinata a poeti, grafici
e stilisti: ci appartiene, a noi tutti, ed è in grado
di fare quella rivoluzione della vita quotidiana di cui abbiamo
sempre e comunque bisogno per vivere e non sopravvivere. E il
cattivo maestro Vaneigem non può che proporci la sua
visione della scuola trasmutata: “Occupate dunque gli
edifici scolastici invece di lasciarvi contagiare dalla rovina
programmata. Abbelliteli a vostro piacimento, la bellezza infatti
incita alla creazione e all'amore, mentre la bruttezza attira
l'odio e l'annientamento. Trasformateli in laboratori creativi,
centri d'incontro, in parchi d'intelligenza attrattiva. Che
le scuole siano i frutteti di un gaio sapere, alla maniera degli
orti che i disoccupati e i bisognosi non hanno ancora avuto
l'immaginazione di impiantare nelle grandi città, sfondando
l'asfalto e il cemento”11.
Dobbiamo ringraziare Paolo Mottana che, con la sua vendemmia,
ci ricorda che vino inebriante stilla dai cattivi maestri e
quanto, al contrario, è insipida l'acquetta in cui è
immerso il chiacchiericcio pedagogico corrente. A noi, come
bravi sommelier, la sfida di abituare il palato a gusti e combinazioni
sempre nuove e sorprendenti. Un buon bicchiere di vino al giorno,
toglie il pedagogico di torno.
Filippo Trasatti
- Mottana riprende da Schérer una citazione di Deligny
particolarmente significativa: “Il paradosso è
che guardando Summerhill (che per molti rimane un modello
del suo genere), ritrovate Makarenko (l'educatore stalinista
nel suo massimo splendore), l'assemblea generale, il diritto
di parola; i ragazzi, la gente, tutti presi nella responsabilità
dell'assemblea generale. Dappertutto direttori, è la
parola che dirige. Le funzioni distribuite [...] fino alla
parola obbligatoria. In alternativa al diritto di parola,
io metto il diritto di tenere la bocca chiusa” (p. 21).
- Non è il caso qui di riprendere la cronaca del processo
che ha visto coinvolto il filosofo (scagionato anni dopo),
accusato insieme ad altri educatori di abusi sessuali su minori
e che Mottana riferisce in modo puntuale e con una nota critica
pienamente condivisibile (pp. 23 e seguenti) ma è ovvio
che si tratta di un terreno estremamente scivoloso, scabroso,
quasi al limite del dicibile, soprattutto oggi, su cui Schérer
tra i pochissimi ci invita a pensare. Per provare a capire
come è cambiato il clima sulla questione della “pedofilia”
e dell'eros dei bambini, vi invito a leggere un libro a cura
di Egle Becchi, L'amore dei bambini, (Feltrinelli 1981)
che contiene diversi interventi tra cui quelli dello stesse
Schérer e di Foucault. Oggi sarebbe impensabile, credo.
- Peter Lamborn Wilson, Anarchist Ephemera, Ardent
Press 2016, p. I.
- Cit. in Mottana, p.89.
- Id., 89.
- Id., 89.
- Id., p. 92.
- Voglio ricordare almeno il bellissimo, Noi che desideriamo
senza fine, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1999.
- L'allevamento intensivo degli studenti, A rivista,
n. 229, 1996.
- Raoul Vaneigem, Trattato di saper vivere, Vallecchi,
Firenze 1973, p. 44.
- cit. in Mottana, p. 61.
L'antifascismo a Livorno/
Proletario, popolare, con tante donne
Siamo ormai al secondo volume di una serie che si annuncia
editorialmente fortunata e che, ci auguriamo, possa proseguire
sul medesimo filone d'indagine magari con altre pubblicazioni
in sequenza. Il soggetto storiografico focalizzato da Marco
Rossi (Livorno clandestina. Un ventennio di opposizione antifascista
(1923-1943), BFS Edizioni, Pisa, 2017, pp. 130 + ill., €
14,00) è una comunità con caratteristiche antropologiche
e sociali assai peculiari, città portuale “all'ombra
dei Quattro Mori” marcata da una cultura cosmopolita,
da un pronunciato protagonismo proletario.
 Dopo
la Livorno “ribelle e sovversiva” degli Arditi del
popolo, ecco ora – stesso autore e stesso editore –
quella “clandestina” dedicata al periodo tra le
due guerre e all'antifascismo militante e popolare. In questo
nuovo lavoro Rossi, con il consueto stile narrativo asciutto
ma intenso, ci disvela un mondo in gran parte misconosciuto
dal grande pubblico e che spesso è stato ignorato dalla
tradizionale storiografia sul movimento operaio e socialista.
Come si legge in premessa “Nessuna ricerca storica sarebbe
possibile senza l'apporto di altri studi, memorie e condivisioni...”;
così il saggio si basa su una solida conoscenza della
letteratura sull'argomento, sia a carattere locale che nazionale,
delle opere classiche come di quelle più recenti e innovative.
Le fonti, compulsate con scrupolo e metodo, spaziano moltissimo;
una consistente bibliografia si incrocia con carte da archivi
pubblici e privati, con testimonianze orali e articoli tratti
dalla stampa coeva. Dopo
la Livorno “ribelle e sovversiva” degli Arditi del
popolo, ecco ora – stesso autore e stesso editore –
quella “clandestina” dedicata al periodo tra le
due guerre e all'antifascismo militante e popolare. In questo
nuovo lavoro Rossi, con il consueto stile narrativo asciutto
ma intenso, ci disvela un mondo in gran parte misconosciuto
dal grande pubblico e che spesso è stato ignorato dalla
tradizionale storiografia sul movimento operaio e socialista.
Come si legge in premessa “Nessuna ricerca storica sarebbe
possibile senza l'apporto di altri studi, memorie e condivisioni...”;
così il saggio si basa su una solida conoscenza della
letteratura sull'argomento, sia a carattere locale che nazionale,
delle opere classiche come di quelle più recenti e innovative.
Le fonti, compulsate con scrupolo e metodo, spaziano moltissimo;
una consistente bibliografia si incrocia con carte da archivi
pubblici e privati, con testimonianze orali e articoli tratti
dalla stampa coeva.
Affresco efficace e narrazione brillante, questa ricerca, lungi
dall'essere relegata nella dimensione angusta di mera storia
locale, deve essere piuttosto inquadrata nella specie dei case-studies.
Il punto di partenza è un interrogativo che, sebbene
rimandi a diatribe politiche e storiografiche tardo novecentesche,
di fatto si presenta ancora oggi in tutta la sua brutalità:
ossia la natura del rapporto tra masse e capi. In specifico
si tratterebbe di valutare, indirettamente – in un ambito
territoriale predeterminato e dai connotati molto speciali –
i due parametri classici: la consistenza effettiva del “consenso”
di massa al fascismo; l'indefinita cosiddetta “zona grigia”
(intesa come tacito dissenso o anche come adesione obtorto
collo). Su quest'ultimo punto, assai delicato e controverso,
l'autore enuncia un metodo interpretativo che ci pare convincente
nella sua semplicità:
”...In altre parole, nella ricerca storica è necessario
tenere presente come il silenzio non coincida con l'assenso:
infatti chi tace, in primo luogo sta zitto. Inoltre, sovente,
l'adesione passiva o l'estraneità silenziosa costituirono
la premessa per successive scelte di resistenza attiva...”
(p. 10).
L'adesione al PNF “tutt'altro che entusiasmante”
registrata a Livorno, in pratica fino agli albori degli anni
Trenta, certifica del resto le difficoltà di relazione
con il “proprio” popolo da parte di un regime totalitario
che pure si era dichiarato fautore di una demagogica rivoluzione
dall'alto. Su questi aspetti, volendo, si potrebbero aggiungere
anche altri dati quantitativi convergenti che riguardano la
Toscana o altre zone a vocazione refrattaria. Ad esempio, da
alcune ricerche si evince che intere federazioni sindacali fasciste
stentino a raccogliere un minimo di aderenti.
È così che emerge, di contro, un'opposizione diffusa
e latente con tutte le sue opzioni possibili e immaginabili:
antifascismo esistenziale ed etico prima di tutto, ma anche
cospirativo, libertario e d'organizzazione, di semplice contro-propaganda
e di azioni armate in epoca parecchio precedente alla Resistenza.
E le donne – “riottose e intemperanti”, sfuggenti
al disciplinamento sessista – sono sempre in prima fila.
Ecco la Livorno illegale e clandestina di cui ci parlano queste
pagine, solidale e fraterna con chi sta consumando i suoi giorni
nelle sofferenze dell'esilio, del carcere e del confino, risoluta
nell'avversione al regime mussoliniano.
Rossi analizza bene la figura, peraltro assai ingombrante e
di grande rilievo in ambito nazionale, del gerarca Costanzo
Ciano (consuocero del Duce), definito “primo imprenditore
politico della livornesità” (p. 11). Nonostante
l'agiografia e gli sforzi propagandistici di accreditarne l'immagine
pubblica, di accrescerne la reputazione e il prestigio –
come ci raccontano le stesse carte di polizia – il personaggio
rimarrà ancorato nella memoria popolare al significativo
soprannome di Ganascia, alle sue pose tronfie da macchietta
fatte oggetto di continui sberleffi, alle ruberie di famiglia
di cui tutti parlano.
Il racconto, riprendendo da dove era rimasto nella precedente
pubblicazione, si snoda avvincente con titoli di paragrafi che
sono una vera guida di lettura: Livornesi contro: una memoria
conflittuale - Tra squadrismo e repressione statale - «Eia
eia... baccalà»: il sovversivismo popolare - «Riottose
e intemperanti» - L'attività anarchica - La rete
comunista - Socialisti e repubblicani - Resistenza di classe
- Marzo 1933: un funerale esplosivo - La propaganda delle armi
- Le armi della propaganda - Contro lo stato di guerra.
Nell'interessante apparato fotografico che costella queste pagine
si nota l'immagine, curiosa, del famosissimo, prestigioso musicista
e compositore livornese Pietro Mascagni, ritratto in una posa
inconsueta e davvero poco professionale (lo vedranno i lettori).
Per finire una ricca appendice documentaria, comprendente una
mirata selezione di preziose carte di polizia, riporta anche
una esilarante rassegna di scritte sui muri di Livorno, riferite
al periodo 1929-1943, con epiteti poco gentili rivolti ai fascisti
“bui rotti”.
Giorgio Sacchetti
Architettura e controllo sociale/
Ma l'anarchia?
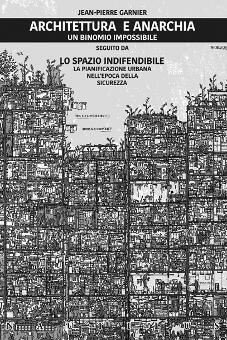 Anche
se con un po' di ritardo (ma per fortuna non tutti i libri irrancidiscono
con il passar dei mesi) è opportuno segnalare il volumetto
pubblicato dalle autoproduzioni editoriali Nautilus nell'ambito
di una serie di brevi contributi riguardanti i processi di sviluppo
dell'urbanizzazione, che raccoglie due lunghi articoli del sociologo-urbanista
Jean-Pierre Garnier sotto un titolo accattivante al punto da
risultare lievemente ingannatore. Architettura e anarchia
– Un binomio impossibile, di Jean-Pierre Garnier,
Nautilus, Torino, 2015, pp. 61, € 4,00) infatti parla assai
poco delle realizzazioni o delle potenzialità del libero
edificare e quando lo fa azzarda bizzarre menzioni come quella
di Léon Krier, misteriosamente definito da Garnier “più
libertario che anarchico”: anche se è evidente
quanto Poundbury sia più bella di Quarto Oggiaro o di
Scampia ciò non basta ad attribuire una tale onorificenza
al tradito progettista di Novoli. Ancora più curioso
il cedere dell'autore a liriche sviolinate (“Come non
sentirsi vibrare di fronte a questi villaggi appollaiati sul
bordo delle falesie che ci danno l'impressione che la neve sia
caduta in piena estate...”) degne dei depliant di una
mediocre agenzia turistica mediterranea, come scivolosissima
appare pure l'apologia del bel tempo che fu, quando la “quarantina
di professioni che compongono l'artigianato del costruire”
non erano state ancora soppiantate dall'edilizia industriale
volta a mortificare ogni creatività del costruire. Anche
se con un po' di ritardo (ma per fortuna non tutti i libri irrancidiscono
con il passar dei mesi) è opportuno segnalare il volumetto
pubblicato dalle autoproduzioni editoriali Nautilus nell'ambito
di una serie di brevi contributi riguardanti i processi di sviluppo
dell'urbanizzazione, che raccoglie due lunghi articoli del sociologo-urbanista
Jean-Pierre Garnier sotto un titolo accattivante al punto da
risultare lievemente ingannatore. Architettura e anarchia
– Un binomio impossibile, di Jean-Pierre Garnier,
Nautilus, Torino, 2015, pp. 61, € 4,00) infatti parla assai
poco delle realizzazioni o delle potenzialità del libero
edificare e quando lo fa azzarda bizzarre menzioni come quella
di Léon Krier, misteriosamente definito da Garnier “più
libertario che anarchico”: anche se è evidente
quanto Poundbury sia più bella di Quarto Oggiaro o di
Scampia ciò non basta ad attribuire una tale onorificenza
al tradito progettista di Novoli. Ancora più curioso
il cedere dell'autore a liriche sviolinate (“Come non
sentirsi vibrare di fronte a questi villaggi appollaiati sul
bordo delle falesie che ci danno l'impressione che la neve sia
caduta in piena estate...”) degne dei depliant di una
mediocre agenzia turistica mediterranea, come scivolosissima
appare pure l'apologia del bel tempo che fu, quando la “quarantina
di professioni che compongono l'artigianato del costruire”
non erano state ancora soppiantate dall'edilizia industriale
volta a mortificare ogni creatività del costruire.
Assai più incisiva è invece l'analisi della “pianificazione
urbana nell'epoca della sicurezza”, trattata soprattutto
nel secondo contributo, anche perché affronta la questione
della funzione repressiva dell'urbanistica in una prospettiva
che non è immediatamente applicabile alle città
italiane, ma potrebbe appartenere - mutatis mutandis
- al nostro futuro. Le rabbiose rivolte acefale e scarsamente
orientate che, sempre sottaciute o sminuite dai media, coinvolgono
da decenni con imprevedibile ripetitività buona parte
delle periferie francesi, sono una delle conseguenze della storia
politico-militare di una nazione capace di scaricare le proprie
contraddizioni interne su popolazioni, in particolar modo africane,
soggette a una feroce colonizzazione, palese o di basso profilo
a seconda delle fasi.
Questa gente, alla quale i pallidi invasori distrussero e continuano
a distruggere territorio, forme produttive e cultura, è
stata costretta a collocarsi al gradino più basso della
struttura sociale in terra straniera, faticando tenacemente
nella speranza di un miglioramento economico e culturale per
i propri figli. Speranza che si è dimostrata del tutto
mal riposta, vista la ghettizzazione a ogni livello alla quale
le nuove generazioni sono state sottoposte secondo un processo
poco paragonabile con la nostrana emarginazione dei terroni
in nord Italia. È da loro, innanzitutto, che gli urbanisti
cercano di difendere la metropoli, la società e il suo
spazio perpetuamente minacciato, dalle risonanze tra criminalità
e ribellione ormai totalmente compenetrate in quel sistema di
sviluppo. Quindi non solo telecamere, recinzioni, sorveglianza
privata, realizzazione di fortini residenziali per benestanti
in territorio nemico (tutte realtà ben conosciute anche
da noi) ma proprio una formalizzazione dell'esigenza del dominio
di poter favorire l'intervento della forza pubblica, ridurre
le zone scarsamente visibili e ogni possibilità di assembramento
indesiderato.
Dopo l'espulsione della plebe dai centri storici, le parole
d'ordine per gli urbanisti sono quelle di parcellizzare il territorio,
privatizzarlo in modo da invitare i cittadini a sentirsi custodi
della pace sociale, eliminare gli spazi di libera condivisione,
modificare la struttura dei quartieri dove la polizia ha difficoltà
di intervento e di controllo con abbattimenti mirati e aumento
della viabilità. L'obiettivo più o meno dichiarato
del potere è quello di una strategia progettuale in cui
l'urbanista divenga al tempo stesso creatore di condizioni controllate
e tutore dell'ordine.
L'acuta descrizione di Garnier lascia poche speranze sulla riformabilità
di tali processi, facendo risuonare ancora una volta attuali
le acri parole che Vaneigem scrisse oltre mezzo secolo fa: “se
i nazisti avessero conosciuto gli urbanisti di oggi, avrebbero
trasformato i campi di concentramento in progetti di edilizia
residenziale”.
Giuseppe Aiello
Africa (e non solo)/
La grande finanza alla ricerca di baby-calciatori
È diventata una vera e propria “tratta”,
quella dei bambini che dal Sudamerica e dall'Africa, principalmente,
vengono condotti in Europa ad inseguire il sogno di una carriera
calcistica che pensano sarà fatta di grandi successi
e quindi di fama e di soldi.
 Negli
ultimi decenni s'è intensificato sempre più il
mercato dei giovani e giovanissimi extracomunitari che, avvicinati
nei loro paesi natii (il Camerun, il Senegal, l'Argentina,il
Brasile) da osservatori ufficiali delle squadre europee di calcio,
o da “agenti” che operano in modo del tutto personale
e indipendente, vengono convinti a sbarcare in Europa a far
prova delle loro abilità calcistiche, dietro un compenso
che dovrebbe servire a lanciarli in squadre che potranno assicurare
loro ingaggi e compensi, mentre in realtà, il più
delle volte serve solo a far guadagnare millantatori o venditori
di speranze. Negli
ultimi decenni s'è intensificato sempre più il
mercato dei giovani e giovanissimi extracomunitari che, avvicinati
nei loro paesi natii (il Camerun, il Senegal, l'Argentina,il
Brasile) da osservatori ufficiali delle squadre europee di calcio,
o da “agenti” che operano in modo del tutto personale
e indipendente, vengono convinti a sbarcare in Europa a far
prova delle loro abilità calcistiche, dietro un compenso
che dovrebbe servire a lanciarli in squadre che potranno assicurare
loro ingaggi e compensi, mentre in realtà, il più
delle volte serve solo a far guadagnare millantatori o venditori
di speranze.
Le cause, le caratteristiche e le rotte di questo “trasferimento”,
ormai planetario, di baby-calciatori, sono ben indagate in un
volume d'analisi e di denuncia di Stefano Scacchi (Materie
prime, Edizioni dell'Asino, Roma, 2017, pp. 168, €
12,00) che informa sui numeri (impressionanti) del fenomeno
e fa nomi e cognomi dei numerosi intermediari (singole persone,
accademia del calcio, società sportive) protagonisti
di questo commercio di giovani uomini che avviene molto spesso
al di fuori di ogni normale e regolare legalità.
Cercando di diventare i nuovi Messi o Ronaldo, ai quali il calcio
europeo ha cambiato la vita, liberandoli dalla miseria e da
un futuro incerto, migliaia di ragazzini dei paesi poveri del
mondo non esitano a mettersi nelle mani di osservatori e procuratori,
ai quali consegnano cifre che vanno dai 500 ai 2000 dollari,
affinchè li portino in un club calcistico europeo a far
mostra della loro bravura, affidando all'affermazione nello
sport il proprio desiderio di riscatto economico e umano: tanto
pesantemente avvertono la subalternità, la discriminazione
e la marginalità geografica rispetto ad un mondo che
pensano prospero e luccicante, ma di cui si può facilmente
far parte, solo se si riesce, con quattro calci ad un pallone,
a entrare in una squadra che militi in gironi professionistici,
dove i tifosi applaudono, le tv riprendono, gli sponsor investono
e i presidenti pagano e i soldi girano: anche con le scommesse,
quelle in chiaro e quelle clandestine e con le rutilanti compravendite
del calcio-mercato.
Scacchi, con una mole notevole di riferimenti a casi concreti,
si dedica ad esaminare la situazione italiana, da profondo conoscitore
di vicende e uomini dello sport più popolare della nazione,
quello che catalizza aspettative e illusioni di tanti ragazzi,
quello che è diventato sempre più “professionistico”,
dalle grandi città ai piccoli centri, dove proliferano
le scuole-calcio, dove si viene pagati anche per giocare in
serie “basse” (in Promozione, Eccellenza) e molto
lontane dalla serie A.
Anche in Italia, dunque, come ampiamente documenta Scacchi,
la “tratta” di calciatori stranieri ha assunto dimensioni
vastissime, con tutte le connotazioni negative che la tratteggiano:
dall'Argentina, soprattutto negli anni in cui la crisi economica
imperversava e dai paesi africani, da dove più forte
viene il flusso migratorio, sono arrivati in Italia, spontaneamente
o pilotati ad hoc, centinaia di giovani calciatori, moltissimi
minorenni, che sono caduti nella rete di direttori sportivi,
tutori, assistenti di comunità e quant'altro di una giungla
di faccendieri e speculatori che anima il mondo del calcio:
qualcuno di questi aspiranti campioni, promettente e talentuoso,
è riuscito ad arrivare nelle serie più alte del
calcio italiano, altri sono rimasti a vivacchiare nei club di
serie minori ma pur sempre professionistiche e i tantissimi,
invece, sono stati costretti ad abbandonare la loro aspirazione
sportiva, a ripiegare in altri e precari lavori, a sopravvivere
tra i permessi di soggiorno sempre più difficili da ottenere,
trovando riparo e assistenza nelle case religiose di accoglienza.
Di tutto questo mondo sommerso e contraddittorio, perché
è anche vero che il calcio ha offerto una possibilità
reale di miglioramento della vita di tanti extracomunitari ed
è una palestra di vera integrazione in tante realtà
grandi e piccole dell'Italia, il libro di Scacchi racconta tanto,
con dovizia di particolari, seguendo numerose storie reali,
paradigmatiche di un fenomeno oramai mondiale, dai risvolti
veramente gravi, se si pensa, come si legge nel libro, che nel
Laos una scuola di addestramento calcistico riservata ai minori
s'è trasformata in un vero e proprio lager, da cui è
stato difficile liberare i minori-calciatori catturati da avida
gente che voleva “amministrarli” secondo una disumana
logica del profitto: perché i bambini sono diventati
la “materia prima” del calcio mondiale che può
assicurare fortune economiche a chi ne scopre il talento, a
chi riesce a venderli al miglior prezzo e quindi al miglior
club.
Di questo potenziale mercato milionario s'è accorta finanche
la grande finanza: scrive, amaramente allarmato, Scacchi: “le
grandi banche d'affari internazionali hanno iniziato ad assoldare
esperti di calcio in grado di individuare i giovani più
promettenti sui quali investire acquistando il cartellino oppure
finanziandone l'acquisto prestando soldi ai club meno ricchi.
Vengono creati veri e propri prodotti finanziari basati sul
calcio. Girano brochure nelle quali i calciatori sono diventati
“derivati” umani. D'altronde, dati alla mano, in
questo momento di stallo dell'economia mondiale, pochi prodotti
tirano come il calcio. Nessun altro bene garantisce un ricarico
come un calciatore promettente di 16 anni scoperto in Sud America
o in Africa e rivenduto a 19 anni ad un grande club europeo.
I calciatori sono diventati una merce sulla quale investire
i patrimoni dei miliardari”.
Silvestro Livolsi
|