
Autogestione/
Fare dell'anarchia una realtà del presente
Sotto un titolo lievemente fuorviante (La pratica dell'autogestione,
Elèuthera, Milano 2017, pp. 223, € 16,00) il volume
di Guido Candela (economista) e Antonio Senta (storico) non
è, come ci si potrebbe attendere, un'analisi delle realtà
autogestionarie, delle loro caratteristiche, funzionamento e
differenze, quanto piuttosto un'articolata argomentazione sul
senso, le prospettive e soprattutto sull'efficacia dell'agire
in prima persona nelle dinamiche produttive e sociali. Testo
forse destinato a polarizzare i lettori, visto che coloro i
quali sono interessati alle tematiche libertarie ma allergici
a ogni forma di linguaggio specialistico incontreranno nei capitoli
dedicati al tentativo di conciliazione tra efficienza economica
e solidarismo qualche passaggio di non immediata digeribilità.
D'altra parte chi ritiene necessario combinare le idee di trasformazione
radicale con l'utilizzo di una terminologia e di concetti specifici
troverà pane per i propri denti.
 L'idea
di base è quella di comprendere se l'autogestione nelle
sue diverse modalità possa essere oggetto di una valutazione
che consideri con criteri standardizzati la convenienza di un'organizzazione
basata sulla condivisione consapevole e non su dinamiche gerarchiche.
Che si parli di egoismo-altruismo oppure di Homo oeconomicus
vs. Homo reciprocans il nodo da sciogliere resta pur
sempre quello che indusse Kropotkin a scrivere Il mutuo appoggio,
ma questa volta discusso in base a una serie di test specifici
(esperimenti-giochi) rivolti ai meccanismi che inducono a specifiche
opzioni nella ripartizione delle risorse disponibili. Non è
certamente questo lo spazio per mettere in dubbio o addirittura
discutere la correttezza metodologica dei “giochi”
ideati, che, come ogni esperimento di laboratorio, possono essere
messi in atto solo grazie a una drastica semplificazione delle
variabili in campo: se la riduzione degli elementi influisca
sulla validità del test sarà giudizio di chi legge. L'idea
di base è quella di comprendere se l'autogestione nelle
sue diverse modalità possa essere oggetto di una valutazione
che consideri con criteri standardizzati la convenienza di un'organizzazione
basata sulla condivisione consapevole e non su dinamiche gerarchiche.
Che si parli di egoismo-altruismo oppure di Homo oeconomicus
vs. Homo reciprocans il nodo da sciogliere resta pur
sempre quello che indusse Kropotkin a scrivere Il mutuo appoggio,
ma questa volta discusso in base a una serie di test specifici
(esperimenti-giochi) rivolti ai meccanismi che inducono a specifiche
opzioni nella ripartizione delle risorse disponibili. Non è
certamente questo lo spazio per mettere in dubbio o addirittura
discutere la correttezza metodologica dei “giochi”
ideati, che, come ogni esperimento di laboratorio, possono essere
messi in atto solo grazie a una drastica semplificazione delle
variabili in campo: se la riduzione degli elementi influisca
sulla validità del test sarà giudizio di chi legge.
Ritengo viceversa doveroso sottolineare che il merito maggiore
del saggio non sta nelle risposte, che pure vengono avanzate
senza timori, quanto negli interrogativi che esplicitamente
o implicitamente solleva. In primo luogo ci si potrebbe chiedere
se sia veramente necessario chiamare ripetutamente in causa
categorie etiche, che per certi versi contraddicono la stessa
tesi fondamentale. Ovvero: se davvero conviene praticare
l'autogestione anarchica, perché dovremmo invitare gli
altri all'etica solidale? La cosa più sensata sarebbe
quella di dire “fate come vi pare, disinteressatevi della
morale, ma abbiate la bontà di osservare come noi, che
viviamo con modalità di libera condivisione, campiamo
assai meglio di chi fa scelte opposte”.
Qui i ripetuti richiami alla morale rendono il testo, a mio
modestissimo avviso, poco efficace. Ma queste potrebbero essere
idiosincrasie da vecchio stirneriano anticonfuciano, e come
tali del tutto irrilevanti. Viceversa, sorvolando su molte altre
interessantissime questioni aperte (apribili), voglio sottolineare
come un condivisibilissimo e fondamentale messaggio sia trasmesso
con modalità insidiosamente parziali. Si tratta del tema,
che pervade quasi l'intero libro, della necessità di
fare dell'anarchia una realtà del presente, quotidiana,
della quale l'autogestione costituisca la colonna portante.
L'idea del non attendere la rivoluzione che ci condurrà
al sol dell'avvenire si va, per fortuna, lentamente radicando,
e con essa la consapevolezza che ci sono interessi concreti
a neutralizzare le realizzazioni ottenute.
Scrivono gli autori: “...nella pratica il capitalismo
reale e il mercato reale sono difesi da coloro, che, nei rapporti
dell'uno contro l'altro, esercitano di fatto il dominio, il
quale si esplica nell'ostacolare e nel nascondere l'affermarsi
dell'autogestione fino a impedirla”. Ora, tali parole
possono essere ampiamente sottoscritte, ma sono anche largamente
insufficienti.
Infatti, ovunque l'organizzazione orizzontale superi il livello
di tolleranza che il dominio ha deciso di praticare, il problema
non è affatto che il potere “ostacoli e nasconda”
l'autogestione, ma che si dedichi a combatterla con i suoi strumenti:
paramilitari associati a polizia e narcos in Messico, squadroni
della morte in Sudamerica, carrarmati di produzione tedesca
e statunitense che il governo turco scaglia contro le comunità
del Rojava, in questo preciso momento, domani altri poliziotti,
altri carabinieri, altri militari - chissà dove. Questo
tassello, non so se centrale ma certamente ineludibile, credo
meriti una giusta considerazione in qualsiasi discorso sulla
libertà in via di costruzione.
Giuseppe Aiello
Arte/
Un messaggio profetico
“Forse l'arte è proprio questo,
un luogo dove il mondo può mettere la sua confusione.”
(C. Bollen, Orient)
Per anni, direi decenni, mi sono illusa, continuando a frequentare
esposizioni d'arte, di poter vedere qualcosa che non fosse sempre
il solito gioco delle tre tavolette spostate di qui per essere
messe di là. Ne ho ricavato quasi sempre la sensazione
di essere stata presa in giro da curatori che, incrociando in
vario modo i soliti nomi di artisti, organizzano eventi commerciali
camuffati d'aura culturale per raggiungere l'obiettivo degli
incassi senza preoccupazione alcuna di fornire strumenti per
ampliare conoscenze, affinare sensibilità e mettere in
movimento cervelli. Personalmente son davvero rare le volte
che ci casco ancora buttando al vento i miei denari, ma non
è sempre stato così; è l'ultimo ventennio
che, anche in questo ambito, ci ha regalato il trionfo della
banalità.
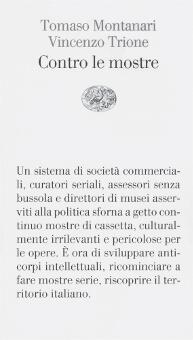 Ho
avuto la fortuna di vedere esposizioni bellissime e, avendo
provato cosa significhi essere coinvolti intimamente da una
mostra ben fatta, quanto piacere e senso di gratitudine se ne
possa trarre e come ci si senta arricchiti, il fatto che questo
accada in percentuale così piccola da essere quasi invisibile,
porta con sé la triste constatazione della povertà
di spirito della nostra società. Ho
avuto la fortuna di vedere esposizioni bellissime e, avendo
provato cosa significhi essere coinvolti intimamente da una
mostra ben fatta, quanto piacere e senso di gratitudine se ne
possa trarre e come ci si senta arricchiti, il fatto che questo
accada in percentuale così piccola da essere quasi invisibile,
porta con sé la triste constatazione della povertà
di spirito della nostra società.
Detto questo è ovvio che un libro come quello di Tomaso
Montanari e Vincenzo Trione, pubblicato lo scorso anno con l'esplicito
titolo Contro le mostre (Einaudi 2017, pp. 184, €
12,00) con me abbia trovato porte spalancate: finalmente qualcuno
che in maniera competente e approfondita, arrivando ad analizzare
caso per caso, denuncia il disastro in cui versa questo settore
della cultura italiana. Non sono io ad avere le traveggole!
Centocinquanta paginette per raccontare come un marasma di gente
collusa con la peggior politica, curatori seriali e assessori
senza bussola gestiscano il nostro patrimonio artistico in maniera
arrogante e ignorante, impegnandosi a ricavare soldi dal puro
intrattenimento di bassa qualità. Dalle Biennali di Venezia
passando per Roma, Milano, Napoli, Firenze ecc. il libro è
un elenco di “male-fatte”, di squallidi esempi documentati
con precisione, fornendo date e nomi, nonché un accorato
appello affinchè l'immenso patrimonio del nostro paese
possa essere gestito con saggezza e acume da gente competente
non asservita al politico di turno.
L'obiettivo sembra essere univoco: non permettere all'arte di
svolgere il suo compito che è comunicare, interrogare,
spiazzare, creare dubbi, porre interrogativi e in questo modo
educare. Infinite visioni del mondo si raccontano attraverso
di essa, ma bisognerebbe saper accompagnare passo passo alla
comprensione di un linguaggio, ci vorrebbero ricchezza di materiali,
dedizione, sensibilità organizzativa, bisognerebbe aver
nel cuore il fatto che le opere d'arte tutto sono tranne che
merce da businnes e invece... viviamo un'epoca dove “una
sorta di autoipnosi collettiva, indotta dall'alto, punta a dimostrare
che la cultura è una merce come tutte le altre. Basta
pagare il biglietto di un museo per acquistarla”. E questo,
si badi bene, non ha niente a che fare con la democratizzazione
della cultura, anzi è l'esatto contrario, è lo
svuotamento di tutte quelle funzioni che a tutti potrebbero
permettere di conoscere la storia del passato e vedere l'attualità
alla luce di quella storia.
Un libro soprattutto di denuncia ma non soltanto e gli esempi
di buona gestione – sempre in località minori e
un po' depistate, guarda caso – sono raccontati con altrettanta
appassionata meticolosità. Un libro che riflette sul
senso del passato artistico in relazione alla contemporaneità
e dedica le conclusioni a quanto di più attuale si possa
vedere in giro per le strade, street art.
Voglio dilungarmi sull'esempio che segue perché è
davvero emblematico del come vanno le cose. Nel 2016 a Bologna
decisero di organizzare (riporto da una citazione del sito ufficiale)
“la prima grande retrospettiva dedicata alla storia della
Street Art” preoccupati “sulle modalità di
salvaguardia, conservazione e musealizzazione di queste esperienze
urbane”. Titolo: “Street Art. Banksy & Co.”
Se normalmente non ci sono grandi reazioni rispetto alla maggioranza
delle mostre, per questa invece ce ne furono eccome, e un post
del collettivo Wu Ming andò diritto al sodo denunciando
“l'arroganza paciona di curatori, restauratori e addetti
alla cultura, che con il pretesto dell'amore per l'arte di strada
trovano un'occasione di carriera, mettendo a profitto l'opera
altrui. (...) Questa mostra sdogana e imbelletta l'accaparramento
dei disegni degli street artist, con grande gioia dei collezionisti
senza scrupoli e dei commercianti di opere rubate alle strade.
(...) Dopo aver denunciato e stigmatizzato graffiti e disegni
come vandalismo, dopo avere oppresso le culture giovanili che
li hanno prodotti, dopo avere sgomberato i luoghi che sono stati
laboratorio per quegli artisti, ora i poteri forti della città
vogliono diventare i salvatori della Street Art. Tutto questo
meritava una risposta”.
La risposta fu la cancellazione da parte di Blu, uno degli artisti
messi suo malgrado in cartellone, aiutato dai ragazzi di due
centri sociali occupati, dei pezzi da lui dipinti a Bologna
in quasi vent'anni. E questo gesto è compiuto –
cito ancora Wu Ming – “da coloro che non accettano
l'ennesima sottrazione di un bene collettivo allo spazio pubblico,
l'ennesima recinzione e un biglietto da pagare. Lo compiono
coloro che non sono disposti a cedere il proprio lavoro ai potenti
di sempre in cambio di un posto nel salotto buono della città.
Lo compiono coloro che hanno chiara la differenza tra chi detiene
denaro, cariche e potere, e chi mette in campo creatività
e ingegno. Lo compiono coloro che ancora sanno distinguere la
via giusta da quella facile”.
È stato un caso eclatante che ha messo in evidenza –
ci ricordano gli autori del libro – tutte le opposizioni
che entrano in gioco nel mondo dell'arte, in primis quella tra
il potere/denaro e la vera ricerca, a seguire il rapporto tra
curatori e artisti, tra intrattenimento e conoscenza, tra cattività
e libertà.
Che ci piaccia o meno, di fatto l'arte di strada mostra un modo
di fare e condividere cultura ricco di futuro e totalmente in
opposizione all'industria delle mostre; spesso è espressione
collettiva, anonima o celata dietro pseudonimi, niente a che
vedere con il culto della personalità tipico del moderno,
poiché la sua ricerca è altrove. Un'arte senza
nomi che in occidente rimanda a un'epoca della storia prerinascimentale,
quando l'individualità degli artisti si confondeva in
una sorta di configurazione collettiva dando origine a opere
che ancora andiamo a rimirare; un esempio per tutti, le cattedrali
gotiche dell'Ile-de-France, capolavori anonimi voluti e costruiti
da comunità civili.
Ma ad altre latitudini l'arte tribale – che siano aborigeni
australiani o i Dogon del Mali – è tuttora sempre
più o meno anonima, un'arte che nega il nesso arte-mercato
e riporta al concetto di arte-comunità. Un messaggio
profetico, si dice in chiusura del libro, all'interno del quale
è probabilmente racchiusa la traccia da seguire per dare
futuro all'arte. Auguriamocelo.
Silvia Papi
Antropologia dell'anarchismo/
Società senza Stato? Per esempio...
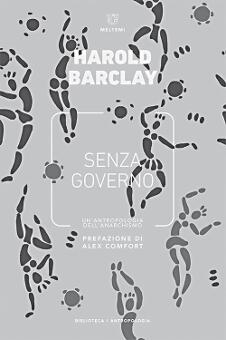 Che
cosa accomuna la storia di popoli come gli inuit dell'Artico
nordamericano, i san dell'Africa meridionale, gli yurok californiani
o i land dayak del Borneo – solo per citarne alcuni –
tra loro e con i protagonisti della rivoluzione spagnola del
1936 o con i collettivi dell'Ucraina di Machno? Che
cosa accomuna la storia di popoli come gli inuit dell'Artico
nordamericano, i san dell'Africa meridionale, gli yurok californiani
o i land dayak del Borneo – solo per citarne alcuni –
tra loro e con i protagonisti della rivoluzione spagnola del
1936 o con i collettivi dell'Ucraina di Machno?
L'anarchia, intesa come assenza di governo, che non è
né caos né un sogno utopico impossibile. Si tratta
piuttosto, secondo l'autore, di una forma di organizzazione
politica molto comune, che ha caratterizzato buona parte della
storia umana sia su piccola scala, come in gruppi di cacciatori,
raccoglitori e coltivatori, ma anche in alcune grandi popolazioni
con relazioni sociali complesse, nel passato come nel presente.
“Diecimila anni fa, tutti erano anarchici” sostiene
Harold Barclay nel suo saggio (Senza Governo. Un'antropologia
dell'anarchismo. Meltemi, Milano 2018, pp. 238, € 16,00)
il cui titolo originale People without government suggerisce
un'indagine accademica sui popoli di tutto il mondo che non
hanno avuto o non hanno governo. O meglio, che hanno attivato
forme di autogoverno diverse per regolamentare la propria società,
normandola attraverso sanzioni sociali che non si avvalessero
di autorità imposte dall'alto, ma che prediligessero
una distribuzione diffusa e orizzontale del potere decisionale.
Attraverso una panoramica diacronica e plurale, descritta con
un “presente etnografico”, sullo sviluppo delle
strutture politiche anarchiche che attraversano differenti tipologie
di società, si cerca di dimostrare cosa sia la pratica
dell'anarchismo. Barclay infatti fornisce numerosi esempi di
realtà, che si sono avvalse di forme altre di governo,
anarchiche, per mantenersi in vita. Interessante è la
similitudine fra il federalismo anarchico e il sistema di lignaggio
segmentario, caratteristico di molte politiche anarchiche, soprattutto
in Africa, dove l'autorità più efficace sta nella
più piccola unità, diminuendo direttamente quando
si passa a livelli più ampi di integrazione, affinché
al vertice la federazione finale abbia poca o nessuna influenza.
Emerge quindi l'esigenza di disquisire sulla natura dell'anarchia,
titolo del primo capitolo, dedicato al definire la differenza
tra anarchia e anarchismo; laddove per anarchia si intende quella
condizione della società all'interno della quale non
esiste sovrano, spesso anche associata a quelle società
definite “arcaiche” e “primitive”, mentre
per anarchismo quella teoria politica sociale, sviluppatasi
nel diciannovesimo secolo in Europa, che incorpora l'idea dell'anarchia
come parte e risultato di un più ampio sistema di valori
consapevoli, che ritiene essenziali la libertà dell'uomo
e l'elogio dell'individualità.
Nel farlo, bisogna considerare i diversi modi in cui, all'interno
di un ambito anarchico, sia mantenuto l'ordine. E questo è
a sua volta legato al problema più generale delle dinamiche
che intercorrono tra libertà e autorità che caratterizza
la società umana, in tutte le sue evoluzioni. Si possono
distinguere infatti, tra i vari esempi di politiche anarchiche,
quelle che sono “involontarie” e quelle che invece
sono “intenzionali”. Queste ultime si potrebbero
definire come tentativi deliberati e pianificati da parte di
alcuni individui, al fine di avviare un ordine sociale in accordo
con un programma predeterminato. Per utilizzare un aggettivo
descrittivo, essi sono esperimenti “utopici”, sulla
scia delle idee anarchiche.
La maggior parte dei campioni analizzati nel testo è
“involontario”, vale a dire quei tipi di società
che, come quasi tutti quelli dell'avventura umana, sono cresciuti
nella totale assenza di un piano consapevole generale, mentre
gli ultimi capitoli si concentrano su alcune esperienze moderne,
care alla tradizione del pensiero libertario, nelle quali una
collettività cosciente sperimenta relazioni non gerarchiche,
almeno in apparenza, sulla base delle quali portare avanti una
società di liberi ed uguali.
Barclay dedica la parte conclusiva del libro all'analisi delle
motivazioni che hanno portato le comunità intenzionali
al collasso, alla graduale scomparsa o alla tendenza a degenerare
poi in governi normalizzanti, delineando alcuni fattori ricorrenti
come cause-effetto di epiloghi spesso tragici, altri come punti
di forza comuni che fungono da collante, oltre ovviamente a
considerare la varietà dei fattori esterni che influenzano
inesorabilmente le sorti di queste concrete utopie. E da queste
considerazioni si interroga sulle possibilità future
dell'anarchismo e sugli insegnamenti che da esso si possono
trarre: “l'anarchia semplicemente richiede lavoro, responsabilità
e una grossa scommessa”.
Per determinare se l'anarchia abbia un avvenire pragmatico,
occorre inoltre considerare se sia possibile fare a meno dello
Stato, che oggi domina ovunque. Come scrisse Gustav Landauer:
“Lo Stato non è qualcosa che si può distruggere
con una rivoluzione, ma è piuttosto una condizione, un
certo tipo di relazione tra gli esseri umani, un modo di comportarsi.
Possiamo distruggerlo intrattenendo un altro tipo di rapporti,
comportandoci diversamente.”
Gaia Raimondi
Donne anarchiche/
Che fatica uscire dall'angolo!
Il 27 febbraio 2016 si è svolta a Carrara, nella sala
Leo Gestri della Biblioteca civica Lodovici, una Giornata di
studi sulle donne nel movimento anarchico italiano promossa
dall'Associazione Amici dell'Archivio Famiglia Berneri –
Aurelio Chessa.
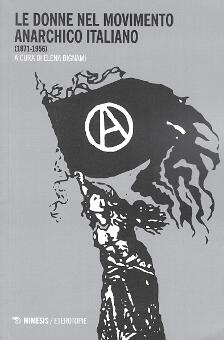 L'Associazione
nasce nel 2014 con l'intento di organizzare eventi culturali
in linea di continuità con il patrimonio storiografico
conservato dall'archivio reggiano. L'Associazione
nasce nel 2014 con l'intento di organizzare eventi culturali
in linea di continuità con il patrimonio storiografico
conservato dall'archivio reggiano.
All'interno dell'assemblea, che coordina tali iniziative, è
nata l'esigenza di approfondire le peculiarità dell'impegno
militante delle donne nel movimento libertario, tanto da far
maturare la proposta di dar vita ad un Centro di documentazione
specifico.
La raccolta di materiale e lo studio delle istanze ideali, sociali
ed etiche di tante donne che hanno dato il loro contributo al
movimento anarchico non si vuole limitare alle figure più
note, ma si pone come obiettivo di far emergere anche le esperienze
meno conosciute.
Recentemente sono stati pubblicati gli atti della Giornata di
studi di Carrara (Le donne nel movimento anarchico italiano
(1871-1956), a cura di Elena Bignami, ed. Mimesis, Milano,
pp. 185, € 18,00) che testimoniano, quindi, non un punto
di arrivo, bensì uno stimolo concreto per “riflettere
sulle complessità di questo tema, per cercare di mettere
a fuoco ciò che a proposito è stato fatto e ciò
che ancora occorre fare”, come sottolinea la curatrice
Bignami.
Il libro raccoglie le interessanti relazioni presentandole con
criterio cronologico. La continuità degli interventi
è rappresentata dal rigore storiografico, dall'ampia
bibliografia, dalla precisione dei riferimenti documentativi
e dalla volontà di colmare la trascuratezza dei testi
antologici che, per troppo tempo, hanno limitato tante protagoniste
al ruolo di comprimarie citandole per essere figlie, sorelle,
mogli o compagne di militanti maschi, mentre avrebbero meritato
un interesse puntuale. Queste pagine, oltre al valore dei contenuti
che trasmettono, lasciano la sensazione di una partecipazione
corale ed appassionata ad un tema che necessita di un'analisi
appropriata.
Attraverso linguaggi e intonazioni differenti, in tutti i contributi
affiora la difficoltà di una ricerca condotta su materiali
incompleti e sulla scarsità di testimonianze: un coro
di voci, una sorta di rapsodia che sprona a sviscerare sensibilità
anticipatrici di istanze che, nelle loro specificità,
oggi appaiono urgenti e attuali, ad esempio sulla coerenza di
un ideale vissuto anche in ogni aspetto della quotidianità
o sulla possibile convivenza fra la militanza dettata da fatti
contingenti e i progetti più graduali.
Antonio Senta si è occupato dell'impegno apportato dalle
donne del movimento anarchico, nel contesto della fine del secolo
XIX, quando l'Associazione internazionale dei lavoratori rappresentò
il fulcro delle lotte emancipatrici. Dal suo studio meticoloso
dei documenti si evince quanto, soltanto a partire dalla Comune
di Parigi del 1871 e alla conseguente formazione di sezioni
operaie femminili, fosse emersa l'esigenza di affiancare, ai
temi dell'emancipazione di classe, una critica alla discriminazione
sessista nella società e ai ruoli di asservimento all'interno
della famiglia patriarcale: analisi e lotte entro le quali si
distinsero molte anarchiche “in un'ottica in cui la sfera
politica e personale si sovrappongono e in cui esse possano
essere finalmente «libere e felici»”.
La seconda relazione è curata da Mirella Scriboni, alla
quale è doverosamente dedicata questa pubblicazione,
vista la sua recente scomparsa. Il periodo storico preso in
considerazione è quello giolittiano dell'inizio del secolo
XX e ad essere oggetto di approfondimento è l'impegno
antimilitarista, soprattutto in seguito al tragico interventismo
nella guerra mondiale. Soltanto “riscattando dall'oblio
anche le figure che hanno avuto minore visibilità”,
emergerebbe il pensiero determinante di molte donne anarchiche
e rivoluzionarie impegnate nella sensibilizzazione nei confronti
delle politiche governative causa di lutti, restrizioni economiche,
sofferenze fisiche e traumi psicologici; non casualmente, si
registrarono anche molte diserzioni all'interno dell'esercito
per lo più represse con internamenti nelle istituzioni
totali carcerarie e manicomiali.
Edda Fonda inserisce in questo contesto il suo racconto di una
fra le personalità più discusse, nonché
rivalutate, del movimento anarchico grazie all'immenso ed eterogeneo
lascito di scritti politici e letterari: Leda Rafanelli. Espresse
il suo contributo su temi contingenti alle lotte più
rilevanti e condivise l'analisi di altre anarchiche, come Emma
Goldman, che videro nel suffragio universale, o negli incarichi
di potere, una falsa emancipazione per le donne.
Leda seppe personalizzare sia lo stile che i contenuti di un'utopia
vissuta e sofferta in prima persona anticipando, in alcuni casi,
riflessioni e dando alle analisi un taglio soggettivo, tanto
che l'autrice di questo intervento suggerisce uno studio della
sua vita romanzesca e delle sue opere, alla ricerca degli aspetti
inediti e anticipatori perché quando “si naviga
al buio e (...) si mira lontano, si va incontro a onde avverse,
a scogli non segnati sulle carte, capita anche di scegliere
rotte audaci”.
Lorenzo Pezzica, esprimendo l'esigenza di superare una “iconografia
stereotipata presente anche in molta memorialistica anarchica”,
traccia profili di donne che hanno vissuto il periodo fra le
due guerre mondiali soffermandosi su Maria Luisa Berneri e Lucia
Sánchez Saornil nel delineare i differenti percorsi di
esistenze caratterizzate dall'esilio: “un vivere a metà
(...) al di fuori della normalità e della sicurezza,
dove si impone uno sguardo attento e sempre in guardia”;
un esilio divenuto anche la cifra di percezioni interiori che,
grazie alla volontà, seppero tramutare il contesto oppressivo
in opportunità.
La seconda fu una delle fondatrici delle Mujeres Libres
e seppe, non soltanto denunciare, ma anche vivere in prima persona
contro lo stereotipo della donna madre, sposa ed eterosessuale
rivendicando scelte personali rischiosamente anticonformiste
e impegnandosi nella solidarietà alle classi più
sfruttate e nella militanza per la rivoluzione sociale. Nei
suoi scritti sono già presenti molti dei temi che diverranno
il fulcro del femminismo attuale.
Su M. L. Berneri, nata e cresciuta respirando climi libertari,
offre un ulteriore approfondimento anche Giorgio Sacchetti:
emerge così una personalità distintasi per le
scelte militanti, i sodalizi ideali e l'attività editoriale.
Già a sedici anni segnalata dal Casellario Politico Centrale,
nel suo soggiorno londinese ricevette la stima delle migliori
menti progressiste dell'epoca, nonché la loro solidarietà
quando la Freedom Press subì attacchi repressivi
e processi penali.
Fu tra le prime ad ampliare l'analisi sulle molteplici sfaccettature
dei condizionamenti di una cultura che esige la riproduzione
di modelli autoritari: la sua critica al dispotismo comunista
e alle subdole democrazie si arricchì di riflessioni
su “i modelli di pensiero precostituito, siano essi afferenti
la dimensione politica, economica, etica, oppure religiosa,
finanche sessuale”. La morte la colpì prematuramente
e molti dei suoi scritti rimasero incompiuti.
Giuseppe Galzerano ci parla di Virgilia D'Andrea, della sua
difficile infanzia, della sensibilità antimilitarista
e poetica. Impegnata nell'Unione Sindacale Italiana, scrisse
su «Guerra di classe» e su «Umanità
Nova». Subì accuse per vilipendio e istigazione
all'odio di classe, persecuzione e carcere. Fu un'instancabile
e stimata conferenziera, attività che svolse anche all'estero:
il suo messaggio “supera il suo tempo (...) anche oggi
può destare sentimenti di umanità e libertà:
nelle sue parole (...) avvertiamo il bisogno irrinunciabile
di lottare per reclamare (...) più spazi di libertà”.
L'aggravamento della malattia di cui soffriva la sorprese mentre
era negli USA, fu sepolta a New York. Tormento, una sua
raccolta di poesie, fu pubblicata con la prefazione di Errico
Malatesta.
Francesco Codello dedica la sua attenzione a Giovanna Caleffi
che, dopo gli anni difficili del ventennio fascista accanto
al compagno Camillo Berneri e alle figlie Giliana e Maria Luisa,
focalizzò il proprio impegno in esperienze significative
e nella redazione di «Volontà», privilegiando
i temi della disobbedienza civile e della prospettiva educazionista,
riuscendo a conciliare il pluralismo culturale e il pragmatismo
metodologico con battaglie civili, mirando all'emancipazione
del pensiero e al superamento del bisogno indotto dei ruoli
di potere e di comando. “La sua visione strategica è
profondamente anarchica e dunque inevitabilmente rivoluzionaria,
seppur decisamente gradualista”. Nei suoi scritti e nella
sua esperienza emerge l'esigenza di perseguire una costante
verifica sulla coerenza fra mezzi e fini.
La chiusura di Elena Bignami si colloca ai primi anni dell'Italia
repubblicana quando il movimento libertario risentì,
inevitabilmente, della sconfitta della rivoluzione catalana,
dei contraddittori strascichi del fascismo e della “sofferta
e controversia partecipazione alla Resistenza”. É
“una storia affascinante e complicata” sulla quale
molti studi hanno finora omesso, o sminuito, l'impegno di tante
anarchiche. I documenti a disposizione fanno risaltare, o quanto
meno intuire, un vivo e vivace panorama che richiama la necessità
di ricerca, nel tentativo di giungere ad una conoscenza più
completa che possa anche abbracciare l'arco di tempo a noi più
vicino.
Nel tracciare alcuni esempi significativi delle esperienze di
quegli anni, l'autrice delinea un percorso metodologico soffermandosi
sull'importanza delle fonti orali, le sole capaci ad integrare
pubblicazioni o epistolari con la viva voce delle testimonianze:
“lo strumento di indagine più idoneo a recepire
i modi e le forme attraverso cui la donna vive e ripensa la
propria memoria, registrando soprattutto i temi del privato
e del quotidiano”.
Chiara Gazzola
Architettura/
Per un rispetto di fondo delle esigenze dei singoli e delle comunità
Due sono i temi che Adriano Paolella tratta fondamentalmente
in questo saggio sulla partecipazione in architettura (Partecipare
l'architettura. Ovvero come progettare nella comunità,
Cosenza 2017, Pellegrini, pp. 167, € 15,00) e tra loro
strettamente collegati: il ruolo dell'architetto in un libero
processo di sviluppo – non solo formale – della
comunità e la qualità architettonica del costruito
in una società egalitaria.
 Lo
scopo dell'attività di Paolella in quanto architetto
è sempre stato chiaro, “contribuire a migliorare
le condizioni ambientali e sociali del Pianeta e delle comunità
insediate” per “capire, interpretare, sostenere
interessi comuni piuttosto che (...) produrre manufatti”
e approfondire la dimensione “culturale e sociale (...)
di un mestiere unico e indispensabile”, come precisa sin
dalle prime righe. Una visione ben distante da quella spacciata
dai media del progettista come archistar, figura così
amata dai rotocalchi, dal mercato e dalle grandi compagnie immobiliari. Lo
scopo dell'attività di Paolella in quanto architetto
è sempre stato chiaro, “contribuire a migliorare
le condizioni ambientali e sociali del Pianeta e delle comunità
insediate” per “capire, interpretare, sostenere
interessi comuni piuttosto che (...) produrre manufatti”
e approfondire la dimensione “culturale e sociale (...)
di un mestiere unico e indispensabile”, come precisa sin
dalle prime righe. Una visione ben distante da quella spacciata
dai media del progettista come archistar, figura così
amata dai rotocalchi, dal mercato e dalle grandi compagnie immobiliari.
Il testo analizza nei suoi vari aspetti i vari modi e tentativi
di superare “la dicotomia molto profonda tra linguaggio
disciplinare e necessità e desideri degli abitanti”
e di riallacciare quel legame tra progettista e comunità
che in alcuni momenti felici della storia e particolari contesti
contemporanei esiste ed è sempre esistito. In questo
Partecipare l'Architettura è una miniera di esempi
e di citazioni di architetti che hanno operato in modo libertario
e con strumenti partecipativi nei più diversi ambiti
territoriali: dagli interventi di John Turner nelle favelas
sudamericane negli anni '60 all'attuale quinta Monory del gruppo
Elemental di Julio Aravena, dall'architettura partecipata di
Lucien Kroll e Ralph Erskine agli interventi sociali e di autocostruzione
di Colin Ward e di Giancarlo De Carlo, alle teorie di Ivan Ilich,
Walter Segal, Bernard Rudofsky, il geniale autore nel '64 di
Architecture Without Architects e all'opera di tanti
altri architetti e teorici di impronta libertaria. Un manuale
prezioso.
Se la figura dell'architetto che Paolella preconizza, in tutte
le varianti partecipative e tipologie professionali ampiamente
descritte nel quarto capitolo L'architetto e gli abitanti,
risulta chiara e ben delineata, altrettanto chiaro è
il modello architettonico e insediativo che l'autore auspica:
quello 'vernacolare' di una comunità che contribuisce
a realizzare in modo autonomo i propri spazi abitativi.
“Quali sono le necessità di un abitante? (...)
una casa solida (...) una città non inquinata (...) Tendenzialmente
tra le necessità dell'abitante non vi è un grattacielo,
né una stazione ferroviaria grande quanto un paese,”
– l'autore pensa al gigantismo inutile della stazione
Tiburtina di Roma che cita nel testo – “né
edifici pubblici monumentali, né assi stradali haussmaniani.
Di questi ci si può stupire, nel caso esserne orgogliosi,
ma è difficile usarli per soddisfare le richieste di
benessere degli abitanti.”
Piccola scala dunque e attenzione alle esigenze abitative, anche
minori che vengono dal basso, come esigenze di piccoli spazi
accessori, personalizzazione dell'ambiente, possibilità
di intervenire sugli spazi e le funzioni. Non l'imposizione
di stili o modelli da parte di un progettista illuminato, allineato
alle esigenze del mercato, ma accoglienza della complessità
dei gusti e delle esigenze dei singoli nella definizione dei
propri spazi: l'architettura senza architetti descritta da Rudofsky
che inevitabilmente assume una conformazione 'vernacolare'.
Cosa che può essere possibile solo in una comunità
compatta che usa consapevolmente gli strumenti della partecipazione
e con il coordinamento e l'aiuto dell'architetto che non deve
“organizzare progetti 'per' e nemmeno 'con', ma 'dei'
cittadini.” “I progettisti hanno un compito imponente:
capire cosa vogliono i cittadini, estrarre i desideri da quanto
di commercialmente e culturalmente indotto, e aiutarli a concretizzarli”.
Altrove Paolella afferma: “Ecco, gli architetti sono degli
artigiani, dei sarti e le case le fanno su misura per gli abitanti,
come i vestiti.”
Purtroppo oggi la gran parte di noi usa abiti confezionati anonimi
e per di più, per comodità e per motivi economici,
li ordina in rete...
Il vestito su misura è un lusso che possiamo ancora permetterci?
Farei rispondere a William Morris, che l'autore cita in queste
pagine, ricordando quanto il suo messaggio sia stato frainteso,
a partire dai suoi contemporanei. Morris sosteneva che fosse
necessario recuperare le capacità artigianali nella realizzazione
del proprio ambiente abitativo, conoscenze e tecniche che stavano
sparendo alla fine del XIX secolo lasciando il posto alla produzione
industriale in serie che poteva ridurre i costi e aumentare
l'efficienza e la velocità di realizzazione.
I conti con una popolazione di 7 miliardi
Il suo messaggio fu scambiato dai suoi critici, soprattutto
di area marxista, per una forma di conservatorismo piccolo-borghese,
questi sottolineavano come i costi dei prodotti industriali
fossero incomparabilmente più contenuti e adatti dunque
anche alle fasce più indigenti della popolazione. Si
trascurò l'aspetto fondamentale della proposta di Morris,
che proponeva la diffusione delle competenze artigianali all'interno
della comunità e teorizzava l'autocostruzione del proprio
alloggio e la creazione di comunità autogestite in gran
parte autosufficienti, anche nella produzione di manufatti e
prodotti artistici. La proposta di Morris voleva essere innanzitutto
il tentativo di cambiare il modello centralizzato capitalista
di produzione di beni e recuperare gli elementi di mutuo appoggio
comunitario che erano ancora vivi alla fine del XIX secolo.
Per Paolella la scelta è chiara: “o si opera per
la diffusione di una cultura che favorisca la partecipazione
attiva degli abitanti alla composizione dei loro spazi o si
opera ordinando e quindi imponendo ai cittadini le soluzioni
elaborate (nel chiuso del suo studio) dall'architetto.
Tra le due ipotesi vi è la stessa differenza esistente
tra un bosco e un giardinetto: il primo può contare su
centinaia di specie vegetali e animali, il secondo su meno di
una decina di specie; il primo ha la capacità di sostenersi
autonomamente, di rigenerarsi, mentre la nostra aiuola ha bisogno
di manutenzione continuativa. Il primo è un sistema disordinato
ma anche molto più complesso; il secondo un sistema semplificato,
artificializzato, ordinato”. Nella produzione edilizia
contemporanea “l'edificio tende a divenire un prodotto
alienato, così come quello della catena di montaggio,
e contribuisce alla perdita delle capacità tecniche proprie
delle comunità locali.” “L'immagine proposta
da Morris (...) rimanda ad un'organizzazione del lavoro, ad
una comunanza di cultura, al perseguimento di un benessere comune
ottenuto con l'attività consapevole della comunità
e delinea l'architettura in forma di prodotto della cultura
collettiva.”
Così, se dovesse cambiare il modo di produzione, 'il
vestito su misura' potrebbe tornare ad essere la scelta più
economica ed efficace.
Nella tradizione urbanistica libertaria, da Morris a Kropotkin,
passando per Patrick Geddes, Lewis Mumford, sino ad arrivare
a John Turner, Colin Ward e Giancarlo de Carlo, si è
sempre auspicato l'insediamento sul territorio di piccole comunità
autogestite e di conseguenza alla realizzazione di edifici e
manufatti di dimensioni contenute; i monumenti, i grattacieli,
le megastrutture che caratterizzano le metropoli attuali sono
sempre state considerate come nient'altro che la forma visibile
del potere economico, del controllo e dello sfruttamento. Vero.
Ma è con questo mondo di sette miliardi di abitanti che
dobbiamo fare i conti oggi, e con conurbazioni mostruose di
dimensioni inter-regionali. Problema che Murray Bookchin si
era posto con il suo I limiti della città del
1973 (tradotto nel 1975 da Feltrinelli), alla fine proponendo
di dividere città come New York in tanti municipi o comuni
tra loro liberamente federati. Il problema della grande dimensione
deve essere ancora affrontato in materia seria nell'ambito delle
riflessioni libertarie.
In un passo del saggio Paolella dichiara la sua perplessità
anche nei confronti dell'architettura in verticale, dei grattacieli,
dubitando che ne possano esistere di ecologici prendendo
in analisi un esempio nostrano di grande successo: “Non
è semplice capire se un edificio è efficiente,
sostenibile, ecologico. Si prenda ad esempio l'edificio chiamato
'bosco verticale' di Stefano Boeri a Milano. È un edificio
ecologico? Tendenzialmente no. (...) La soluzione non interpreta
una condizione naturale ma pone elementi naturali in condizioni
di elevata artificialità impegnando energia e materiali
(dalla conformazione dell'edificio ai fitofarmaci e concimi).”
Non un bosco, quindi, per Paolella, ma quello che sopra ha definito
“un sistema semplificato, artificializzato, ordinato”
che “ha bisogno di manutenzione continuativa”, insomma
un giardinetto o una semplice aiuola.
Tutto il saggio è una dichiarazione di fiducia nelle
capacità creative spontanee degli abitanti e un incitamento
al recupero della dimensione comunitaria del costruire che ancor
resiste in nicchie importanti sul pianeta, alla rivalutazione
di uno 'stile' vernacolare, all'azione del progettista che dovrebbe
“invece di imporre agli abitanti soluzioni insediative
astratte, cercare una continuità con la cultura vernacolare,
innovandola, interloquendo e limandone gli eventuali fattori
negativi.”
Franco Bunčuga
Il ritorno di “Sacco e Vanzetti” (in blu-ray e doppio Dvd)/
Gridatelo dai tetti
A inizio Novecento lasciarono l'Italia per trovare lavoro.
Si conobbero in America. Erano anarchici. Furono arrestati ingiustamente
per rapina e omicidio, che non avevano commesso.
 Negli
Stati Uniti dell'epoca, da Chicago a San Francisco, ma anche
in Inghilterra, a Londra, si mobilitarono migliaia di persone
per l'evidente ingiustizia in corso, al grido di «Sacco
and Vanzetti Must Not Die!». Nell'Italia del regime
fascista non fu silenzio, ma quasi. Mussolini però definì
il tribunale statunitense «pregiudizialmente prevenuto»
e tentò di salvare Nicola e Bartolomeo tramite i funzionari
del Ministero degli Esteri, l'ambasciatore italiano a Washington
e il Console italiano a Boston. Negli
Stati Uniti dell'epoca, da Chicago a San Francisco, ma anche
in Inghilterra, a Londra, si mobilitarono migliaia di persone
per l'evidente ingiustizia in corso, al grido di «Sacco
and Vanzetti Must Not Die!». Nell'Italia del regime
fascista non fu silenzio, ma quasi. Mussolini però definì
il tribunale statunitense «pregiudizialmente prevenuto»
e tentò di salvare Nicola e Bartolomeo tramite i funzionari
del Ministero degli Esteri, l'ambasciatore italiano a Washington
e il Console italiano a Boston.
Nick e Bart furono condannati alla sedia elettrica su cui morirono
il 23 agosto 1927.
La storia di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è limpida,
quanto atroce, nella sua tragedia. Icona-simbolo chiaro della
violenza a cui può spingersi il potere, caricatura di
se stesso, che – nei corsi e ricorsi storici – condanna
a morte due poveri cristi innocenti, “colpevoli”
di essere “sovversivi”, “radicali” e
per di più immigrati «venuti nel paese di Bengodi
per arricchire...». Roosevelt lo definì «il
più atroce delitto commesso in questo secolo dalla giustizia
umana».
Il 23 agosto del 1977, nel cinquantesimo anniversario dell'assassinio
di Nick e Bart, il Governatore del Massachussetts, Michael Dukakis,
riabilitò – non senza retorica americana –
le figure dei due compagni italiani, indicendo il 23 agosto
“giorno commemorativo”.
A oltre novant'anni dai fatti narrati esce nuovamente in blu-ray
e Dvd (ed. Ripley's) il film che Giuliano Montaldo realizzò
nel 1971 per raccontare l'atroce verità su Nick e Bart*.
Come le due canzoni Ballata di Sacco e Vanzetti e Here's
To You, Nicola and Bart di Joan Baez (ed Ennio Morricone),
che aprono e chiudono il film, Sacco e Vanzetti procede
in un crescendo melodrammatico accorato, politico e sentito.
La prima e l'ultima sequenza sono in bianco e nero, come il
materiale di repertorio che contrappunta il film. Il resto è
a colori, come a dare un “presente” alle parole
e alla sofferenza di Nick e Bart. Il bianco e nero della lunga
sequenza finale pare invece marcare una connotazione di allucinata
“atemporalità”, un “per sempre”
iconicizzato, da non dimenticare, traccia tangibile e fotografica
di qualcosa che è davvero esistito, benché ricreato
ad arte dal Cinema.
Sacco e Vanzetti è un film “militante”
e “partigiano”, perché non si può
non essere dalla parte degli innocenti e degli sfruttati, dunque,
fin dalla prima sequenza dell'aggressione delle forze dell'ordine
al Circolo Lavoratori Italiani, Montaldo prende un punto di
vista chiaro e parziale, però mai didascalico.
Opera di contrasti, in particolare fra i due caratteri opposti
dei protagonisti: il parlare fluido e antipotere di “Tumlin”
Vanzetti – «Ho combattuto per eliminare il delitto...
primo fra tutti lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo!»
– e il silenzio di Sacco che parla con lo sguardo, il
volto segnato dal dolore, salvo poi fargli ritrovare parole
magnifiche nella bellissima lettera al figlio: «Possono
bruciare i nostri corpi, oggi, non possono distruggere le nostre
idee, esse rimangono per i giovani del futuro, per i giovani
come te. Ricorda, figlio mio, la felicità dei giochi,
non tenerla per te... cerca di comprendere con umiltà
il prossimo, aiuta il debole, aiuta quelli che piangono, aiuta
il perseguitato, l'oppresso... loro sono i tuoi migliori amici.»
Pare quasi di sentire Tom Joad in Furore di Steinbeck
e nella ballata che ne ha tratto Springsteen (The Ghost of
Tom Joad).
Nel finale sulla sedia elettrica il nostro sguardo coincide
a lungo – in soggettiva – con quello di Nicola Sacco,
come a dire che la sua storia è/può essere la
nostra, anarchici e non, vittime dell'ingiustizia più
nera. E proprio nel nero, sulla luce che si spegne mentre Vanzetti
è sulla sedia elettrica, si chiude il film.
Storia complessa quella del film Sacco e Vanzetti: tre
anni per trovare un produttore, Arrigo Colombo, ebreo fuggito
in America, che aveva imparato l'inglese leggendo proprio le
lettere che Bartolomeo Vanzetti aveva scritto ai membri del
Comitato di difesa.
Un primo potenziale produttore chiese, senza alcuna ironia,
a Montaldo se Sacco e Vanzetti fossero una ditta di import-export
(cfr. la prefazione del regista al libro autobiografico di Vanzetti
Gridatelo dai tetti, a cura di Alberto Gedda, ed. Fusta).
Quando, tempo fa, era uscita la prima edizione dvd del film,
finalmente, sembrava essere stata fatta un po' di giustizia
alla versione originale cinematografica, dopo che le versioni
circolate in VHS o visibili in tv sulla Rai censuravano ancora
la battuta finale di Vanzetti-Volonté che si siede sulla
sedia elettrica al motto (sempre ammutolito-censurato in tv)
di: «Viva l'anarchia!».
|
| Riccardo Cucciolla (Nicola Sacco) e Gian Maria Volonté (Bartolomeo Vanzetti) |
Per tantissimi anni il film è poi rimasto fuori catalogo
e si doveva ricorrere all'edizione francese. Dopo una prima
edizione blu-ray del 2012 nuovamente non completa (la battuta
finale della versione inglese tramutata in «I am innocent!»),
oggi, grazie a Ripley's Film, è uscito finalmente in
versione blu-ray e dvd a doppio disco nella sua integrità.
Osservò, tempo fa, quel genio libertario di Kurt Vonnegut
(cfr. Un pezzo da galera, ed. Feltrinelli): «Quand'ero
giovane, ero convinto che la storia di Sacco e Vanzetti sarebbe
stata raccontata tanto spesso quanto la storia di Gesù
Cristo, suscitando altrettanta commozione. Non avevano forse
diritto, i moderni – pensavo – a una Passione moderna
come quella di Sacco e Vanzetti, che si concludeva sulla sedia
elettrica? Quanto agli ultimi giorni di Sacco e Vanzetti e al
finale della loro Passione: come già sul Golgota, erano
tre i condannati a morte dal potere statale. Stavolta, non uno
su tre era innocente. Innocenti erano due, su tre...».
Purtroppo la storia di Nick e Bart, poveri cristi uccisi sulla
croce-sedia elettrica, almeno in Italia, sembra ancora dimenticata
o mai abbastanza ricordata.
Scrisse Bart Vanzetti con la potenza di un poeta (cfr. Gridatelo
dai tetti): «La mia vita non può assurgere
a valore di autobiografia comunque considerata. Anonimo nella
folla anonima, essa trae luce dal pensiero, dall'ideale che
sospinge l'umanità verso migliori destini. E questo ideale
io riassumo come balena nel mio pensiero...».
Luca Barnabé
* Sacco e Vanzetti (Box
blu-ray e DVD Sacco e Vanzetti, ed. Ripley's Home Video).
La nuova edizione in blu-ray e Dvd di Sacco e Vanzetti contiene
diversi extra speciali: booklet C'erano una volta Nick e
Bart, un'intervista a Giuliano Montaldo, il provino di
Rosanna Fratello che interpreta Rosa, la moglie di Sacco, Trailer,
Cronache degli Anni Venti e un documento sul Comitato di riabilitazione
del 1976.
Pedagogia libertaria/
A scuola con Colin
Francesco Codello ha curato per Elèuthera un libro di pedagogia scritto dall'architetto e militante anarchico inglese Colin Ward (1924 – 2010): L'educazione incidentale (Milano 2018, pp. 256, € 17,00). Ne riproduciamo qui la prefazione.
Famiglia e scuola sono sempre stati considerati i luoghi per eccellenza dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze, acquisiscono un'educazione. Colin Ward decide invece di esplorare un particolare aspetto dell'educazione che prescinde da queste istituzioni: l'incidentalità. Ecco allora che le strade urbane, i prati, i boschi, gli spazi destinati al gioco, gli scuolabus, i bagni scolastici, i negozi e le botteghe artigiane si trasformano in luoghi vitali capaci di offrire opportunità educative straordinarie.
Questa istruzione informale, volta alla creatività e all'intraprendenza, rappresenta pertanto una concreta alternativa a un apprendimento strutturato e programmato che risponde più alle esigenze dell'istituzione e del docente che alle necessità del cosiddetto discente. Si configura così un approccio al tempo stesso nuovo e antico alla trasmissione delle conoscenze in grado di fornire un'efficace risposta a quella curiosità, a quel naturale e spontaneo bisogno di apprendere, che sono alla base di un'educazione autenticamente libertaria.

Nel 1975, durante una conferenza tenuta al Garden Cities/ New
Town Forum di Welwyn Garden City, in cui criticava gli esponenti
di una certa cultura marxista rivoluzionaria, Colin Ward (1924-2010)
sosteneva che questi ultimi sono simili «a quanti pensano
che sia meglio lasciar morire di fame i poveri negli slum
perché così il giorno della rivoluzione arriverà
più in fretta. A parte la nostra antipatia morale per
questo modo di pensare, le cose non funzionano così».
Tutti i suoi scritti, tutta la sua vita di studioso militante,
di architetto ed educatore, di giornalista e insegnante, di
sociologo e urbanista, di economista e osservatore delle abitudini
e dei comportamenti umani, è improntata a questa convinzione.
Perché una «società anarchica, una società
che si organizza senza autorità», ha scritto nel
suo libro forse più noto, Anarchia come organizzazione,
«esiste da sempre, come un seme sotto la neve, sepolta
sotto il peso dello Stato e della burocrazia, del capitalismo
e dei suoi sprechi, del privilegio [...] del nazionalismo [...]
delle religioni».
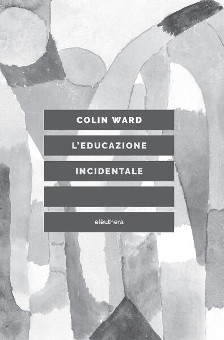 Si
potrebbe dire che l'anarchismo di Colin Ward e il suo approccio
all'educazione si fonda, principalmente, su due convinzioni.
La prima è stata espressa da Paul Goodman: «Una
società libera non può essere l'imposizione di
un 'ordine nuovo' al posto di quello vecchio: essa è
invece l'ampliamento degli ambiti di azione autonoma fino a
che questi non occupino gran parte del sociale». La seconda
da Gustav Landauer: «Lo Stato non è qualcosa che
può essere distrutto attraverso una rivoluzione, ma è
una condizione, un certo tipo di rapporto tra gli esseri umani,
un tipo di comportamento; lo possiamo distruggere creando altri
rapporti, comportandoci in modo diverso». Da queste premesse
consegue il suo inevitabile interesse per l'educazione e l'importanza
che essa assume nel suo disegno di trasformazione sociale. Si
potrebbe dire che l'anarchismo di Colin Ward e il suo approccio
all'educazione si fonda, principalmente, su due convinzioni.
La prima è stata espressa da Paul Goodman: «Una
società libera non può essere l'imposizione di
un 'ordine nuovo' al posto di quello vecchio: essa è
invece l'ampliamento degli ambiti di azione autonoma fino a
che questi non occupino gran parte del sociale». La seconda
da Gustav Landauer: «Lo Stato non è qualcosa che
può essere distrutto attraverso una rivoluzione, ma è
una condizione, un certo tipo di rapporto tra gli esseri umani,
un tipo di comportamento; lo possiamo distruggere creando altri
rapporti, comportandoci in modo diverso». Da queste premesse
consegue il suo inevitabile interesse per l'educazione e l'importanza
che essa assume nel suo disegno di trasformazione sociale.
La scrittura di Ward è semplice, essenziale, immediata,
parte da un fatto, da una serie di esempi concreti, da osservazioni
dirette, per cercare di rinvenirvi degli insegnamenti, mai però
esaltati, sempre proposti come spunti di riflessione critica
e autocritica. Anarchico senza dogmi, intellettuale concreto
poco interessato a rivolgersi a un'accolita di iniziati o a
una setta, Ward non è il tipo di anarchico che scrive
in codice, e non si perde mai nella polemica astiosa o nel culto
devoto della tradizione. L'anarchismo, secondo la sua rivoluzionaria
interpretazione, non è un «programma di cambiamenti
politici ma un atto di autodeterminazione sociale». Lo
«sguardo» di Ward esplora molte dimensioni della
nostra vita sociale e quotidiana, a partire dalla premessa che
non c'è circostanza della nostra esistenza e della vita
pubblica che non presenti un grado latente di libertà
e non consenta una scelta tra soluzioni «autoritarie»
e «libertarie», cioè radicalmente diverse
da quelle burocratiche e autoritarie dello Stato.
Questo libro non solo testimonia in maniera esemplare come si
possa scrivere osservando in modo disincantato e critico ciò
che ci accade intorno, ma ci stimola a riflettere suggerendo
un metodo di indagine che supera le contestualizzazioni spazio-temporali
da cui muove e che restituisce un senso profondo al nostro rapporto
tra lo spazio e l'ambiente, spiattellandoci davanti, senza dirlo,
l'orrore della pianificazione e dell'urbanizzazione delle società
industriali e post-industriali. Il suo approccio, anche in questi
ambiti, è globale, ricco, diversificato, interdisciplinare.
Non fornisce prescrizioni tassative, ma racconta esempi che
possono suggerire nuove pratiche, per un uso non formale e inconsueto
del nostro ambiente e dello spazio corretto e rispettoso che
noi possiamo trovare all'interno di esso.
Nei vari capitoli che costituiscono questa antologia, dedicati
al tema dell'educazione e della scuola, Ward ci mette davanti
una quantità di esempi concreti di come l'educazione
passi attraverso un uso creativo dell'ambiente e di come la
Scuola sia, di fatto, una gabbia troppo recintata che impedisce
un profondo arricchimento culturale, perché estranea
sempre più alla vita sociale delle giovani generazioni.
Il suo interesse per l'educazione è vivo fin dall'inizio
della sua attività di pubblicista. Figlio di un maestro
elementare, poi divenuto direttore di scuola primaria, Ward
non è un alunno modello, abbandona presto gli studi per
lavorare in diversi ambiti. Tra il 1971 e il 1979 si impiega
come responsabile all'istruzione nella Town and Country Planning
Association, dove cura la pubblicazione del «Bulletin
of Environmental Education», per poi dedicarsi principalmente
all'attività di saggista. Fedele al monito di Alexander
Herzen (più volte citato nei suoi scritti), secondo cui
«un obiettivo che sia infinitamente distante non è
un obiettivo, è un inganno», si prodiga per portare
alla luce, in vari testi sugli argomenti più disparati,
quei «semi sotto la neve» che testimoniano come
l'anarchia sia principalmente una teoria e una pratica di organizzazione
sociale. Il suo punto di riferimento principale, in un ipotetico
«pantheon» anarchico, è sempre stato quel
Pëtr Kropotkin che aveva scritto Il mutuo appoggio
e Campi, fabbriche, officine, cioè quella tradizione
libertaria (molto anglosassone e socialista) che si è
dedicata principalmente a realizzare e a sperimentare soluzioni
antiautoritarie nelle varie situazioni della vita concreta.
In un libro pubblicato nel 1991, Influences. Voices of Creative
Dissent, Ward ci presenta dieci pensatori che, in diversi
ambiti di interesse, hanno influenzato la sua ricerca, offrendogli
lo spunto per sviluppare il suo percorso di pratiche e di riflessioni.
Alla voce Education egli annovera il filosofo inglese
William Godwin e l'antesignana del femminismo Mary Wollstonecraft.
Ambedue vengono rivalutati per le loro idee in ambito educativo
e in particolare per uno stile di scrittura che sprigiona empatia
verso i bambini (Wollstonecraft) e per un approccio pionieristico
all'educazione libertaria (Godwin). Nella critica radicale che
il filosofo inglese muove all'organizzazione statale dell'istruzione,
Ward intravede le potenziali argomentazioni che pensatori moderni
come Paul Goodman, Ivan Illich ed Everett Reimer hanno mosso
nei confronti dei sistemi scolastici contemporanei. Una concezione
completamente diversa della scuola, ci ricorda il nostro autore,
è stata prefigurata proprio da Godwin già nel
1797, anno in cui sostiene la necessità di spazzare via
l'intero apparato che si è fin lì assunto quel
compito: «Per la precisione, sulla scena non compariranno
più personaggi come il precettore o il discepolo. Il
ragazzo, al pari dell'adulto, studierà perché
ne ha voglia. E seguirà un programma ideato da lui personalmente,
o comunque fatto suo per libera scelta». Questa idea radicale
di organizzazione dell'istruzione viene collegata da Ward sia
a scuole come la Summerhill di Alexander Neill o ad altre esperienze
alternative simili, sia a qualche esperienza minoritaria e isolata
dentro il sistema scolastico ufficiale, come la Prestolee School
di Edward O'Neil nel Lancashire, attiva nel periodo successivo
alla prima guerra mondiale.
In particolare egli fa sua l'idea formulata da Paul Goodman
di «educazione incidentale», secondo cui sarebbe
più semplice, più economico e più equo
smantellare tutto il sistema scolastico e dare a ogni studente
la parte che gli spetta del denaro stanziato per l'istruzione:
Il programma di Goodman è spaventosamente semplice. Prevede
per i più piccoli «un ambiente protettivo e stimolante,
creato decentralizzando la scuola in piccole unità che
comprendono da venti a cinquanta bambini, dislocate in negozi
o sedi di associazioni utilizzabili a questo scopo, con l'abolizione
dell'obbligo di frequenza, collegando la scuola a piccole fattorie
in cui i bambini delle città possano trascorrere uno
o due mesi all'anno».
Questo programma è esattamente l'opposto delle riforme
scolastiche che i vari governi hanno messo in atto nei vari
Stati con i risultati che tutti noi possiamo vedere. Per Ward
ogni angolo della città è un'aula scolastica,
ogni strada uno spazio di incontro e di sperimentazione di relazioni
vitali, ogni contesto urbano o rurale è un luogo di apprendimento,
ogni occasione è propizia a stimolare l'autonomia e la
partecipazione diretta alla vita sociale. Come testimoniano
i suoi scritti, è indispensabile riappropriarsi dell'ambiente
in cui viviamo, ricondurlo a dimensione di bambino e bambina,
trasformandone ogni contesto organizzato in una sorta di aula
scolastica.
Nella prospettiva di Ward, l'educazione è pertanto necessariamente
«educazione ambientale», nel senso duplice che questa
idea introduce, ovvero sia l'uso dell'ambiente (contesto), in
luogo dell'aula scolastica, come mezzo educativo, sia l'educazione
che riguarda l'ambiente naturale. Ma egli sottolinea anche la
necessità che l'educazione ambientale «venga intesa
come qualcosa che riguarda le città dove la stragrande
maggioranza dei bambini europei vive e va a scuola». Questa
educazione dovrebbe avere lo scopo di «rendere i ragazzi
padroni del loro ambiente: altrimenti non si vede a cosa possa
servire». L'approccio che occorre avere nei confronti
dell'ambiente è quello di indagare il contesto sociale
a partire dai problemi specifici e quindi diviene inevitabilmente
educazione alla partecipazione. Questo implica che «l'interpretazione
dell'ambiente avviene per contatto diretto con la cosa stessa,
e non attraverso una sua proiezione bidimensionale nel chiuso
di un'aula. La ricerca dei ragazzi sull'ambiente urbano deve
avvenire nella città stessa, attraverso quello che i
geografi chiamano 'lavoro sul campo' e che, nel contesto urbano,
potremmo chiamare 'lavoro di strada'. Tutte le conoscenze e
le esperienze che la strada (metafora del contesto sociale)
può direttamente offrire al processo di apprendimento
sono di fatto scomparse dalla vita quotidiana dei nostri ragazzi;
anzi, scriveva Ward, 'gli sforzi della nostra società
sono tutti rivolti a tenerli lontani dalla strada'. Il
risultato è che 'nessuna città è gestibile
se non fa crescere cittadini che la sentano propria'.
Per questo 'occorre portare avanti l'idea che la scuola deve
diventare una scuola di ricerca: un'istituzione privilegiata,
autorizzata a investigare e criticare in nome della prossima
generazione'». Questa nuova scuola non si caratterizzerebbe
più per la quantità di denaro e di investimenti
richiesti, ma si configurerebbe come una scuola più «povera»,
cioè meno dotata di mezzi costosi, che utilizzerebbe
l'ambiente locale a favore dell'istruzione dei ragazzi, mettendoli
veramente al centro del processo di apprendimento. Infatti:
gran parte delle nostre spese sugli insegnanti e sulle strutture
è sprecata se si cerca di insegnare ai bambini ciò
che non vogliono imparare in una situazione in cui non vorrebbero
neanche essere [...]. La scuola è diventata uno degli
strumenti con cui gli adolescenti vengono esclusi dalle responsabilità
e dalle attività reali nella vita come nella società.
Ward insiste su questa visione di «povertà»,
non consueta rispetto alla centralità giustificativa
che spesso gli stessi insegnanti reclamano a favore di sempre
maggiori investimenti. Come Paul Goodman, anch'egli sottolinea
sempre una visione pluralistica dell'educazione, la necessità
di decentrare le istituzioni scolastiche, il ruolo strategico
che devono assumere la partecipazione e il coinvolgimento dei
ragazzi e di tutti coloro che a vario titolo operano nelle realtà
educative. Perché, soprattutto per l'istruzione, «l'autogoverno
è più importante di un buon governo». Occorre,
a suo giudizio, puntare «tanto sulla disponibilità
dell'eccellenza accademica quanto sull'approccio decisamente
non accademico», quindi sulla flessibilità e sulla
malleabilità di ogni organizzazione scolastica in modo
da favorire le diverse sensibilità e i diversi talenti.
L'obiettivo dell'azione educativa che i sinceri libertari devono
perseguire è quello di organizzare una società
a misura di bambino, perché in questo modo sarà
una società più felice: «I bambini non possono
scegliere i propri genitori, le proprie condizioni economiche
o il proprio luogo di residenza. Aiutiamoli quindi a trarre
il meglio da ciò che possiedono». Tutto questo
nella convinzione che «l'approccio anarchico al problema
dell'istruzione si basa non sul disprezzo per lo studio ma sul
rispetto dell'allievo».
In questa antologia Colin Ward esplora quel particolare aspetto
dell'educazione, l'incidentalità, che viene opportunamente
valorizzato nei diversi contributi raccolti. Ecco che le strade
della città, i prati e i boschi della campagna, gli spazi
deputati al gioco (più o meno strutturato), gli scuolabus
e i bagni delle scuole, i negozi e le botteghe artigiane, non
solo offrono opportunità straordinarie per un'educazione
informale, ma sono luoghi vivi che si rivelano vitali per imparare.
Questa incidentalità rappresenta pertanto una vera alternativa
all'apprendimento strutturato e programmato, costituendo un'autentica
risposta a quella curiosità, a quella ricerca spontanea,
a quel naturale e istintivo bisogno di apprendere, che sono
alla base di una profonda e coerente educazione libertaria.
Francesco Codello
Fonti orali/
Gli atti di un convegno sulla militanza anarchica
Mentre assistevo al convegno su La militanza anarchica e
libertaria in Italia nel secondo Novecento. Le fonti orali:
questioni metodologiche promosso dall'Archivio Berneri-Chessa
e dalla Biblioteca Panizzi nel novembre 2016 a Reggio Emilia,
non riuscivo a non riflettere preoccupato sulla mia memoria
da pesce rosso. Per fortuna, mi consolavo, dubito che qualcuno
in futuro mi verrà a intervistare, ritenendomi una fonte
orale in qualche modo significativa. Rileggendo gli atti pubblicati
nel volume Parlare d'anarchia. Le fonti orali per lo studio
della militanza libertaria in Italia nel secondo Novecento
(a cura di Enrico Acciai, Luigi Balsamini e Carlo De Maria,
Biblion edizioni, Milano 2017, pp. 219, € 22,00), mi sono
reso conto che le cose non sono affatto così semplici
e che dietro alle fonti orali c'è qualcosa di ben più
'ciccioso' rispetto alle mie preoccupazioni circa un troppo
vigoroso sfrondamento celebrale.
 Mi
spiego. Solitamente (e semplificando un lavoro ben più
complesso) chi si occupa di storia del movimento anarchico sceglie
in primo luogo l'argomento che vuole trattare (i motivi dietro
a tale scelta rappresentano un'altra questione che lascerei
da parte), legge ciò che è stato scritto sul tema,
si immerge nel reperimento e nella consultazione delle fonti,
che generalmente sono scritte: si annaspa quindi tra rapporti
di polizia, si naviga nella pubblicistica, si perde la bussola
tra volantini, manifesti, relazioni, bozze e comunicati. I più
temerari affrontano anche i carteggi con il proposito di andare
a vedere, per esempio, cosa sta dietro a particolari riflessioni
oppure le ricadute sulla vita personale di determinate scelte.
In questo percorso difficile, ricco di domande esistenziali
e di insulti verso il mondo (parlo per me), i luoghi della ricerca
non sono solo gli archivi per così dire istituzionali
e le biblioteche, ma anche i centri di studio e di documentazione
legati oppure più o meno affini al movimento anarchico,
sulla cui realtà si può dare uno sguardo attraverso
l'ottimo libro Fragili carte di Luigi Balsamini. Mi
spiego. Solitamente (e semplificando un lavoro ben più
complesso) chi si occupa di storia del movimento anarchico sceglie
in primo luogo l'argomento che vuole trattare (i motivi dietro
a tale scelta rappresentano un'altra questione che lascerei
da parte), legge ciò che è stato scritto sul tema,
si immerge nel reperimento e nella consultazione delle fonti,
che generalmente sono scritte: si annaspa quindi tra rapporti
di polizia, si naviga nella pubblicistica, si perde la bussola
tra volantini, manifesti, relazioni, bozze e comunicati. I più
temerari affrontano anche i carteggi con il proposito di andare
a vedere, per esempio, cosa sta dietro a particolari riflessioni
oppure le ricadute sulla vita personale di determinate scelte.
In questo percorso difficile, ricco di domande esistenziali
e di insulti verso il mondo (parlo per me), i luoghi della ricerca
non sono solo gli archivi per così dire istituzionali
e le biblioteche, ma anche i centri di studio e di documentazione
legati oppure più o meno affini al movimento anarchico,
sulla cui realtà si può dare uno sguardo attraverso
l'ottimo libro Fragili carte di Luigi Balsamini.
Questo 'schema', questo modo di procedere generale può
però avere, nel caso del Novecento e soprattutto della
seconda metà del secolo, un ulteriore innesto: le fonti
orali, cioè le interviste, le testimonianze e i racconti
di chi ha vissuto, di chi è stato in qualche modo protagonista
di quello che il ricercatore vuole studiare. A differenza delle
fonti scritte, quelle orali sono costruite a posteriori, con
il contributo determinante e non imparziale del ricercatore
stesso. Le fonti orali devono inoltre fare i conti con i filtri
soggettivi e con i meccanismi di rimozione e di distorsione
tipici della memoria, con le inevitabili 'aggiunte' e abbellimenti
a posteriori. «La memoria», si legge in Parlare
d'anarchia, esercita «un'azione di rielaborazione
continua operando dei meccanismi di costruzione che intrecciano
il passato con il presente: sul ricordo incidono non solo gli
eventi e come sono stati vissuti nell'attimo stesso in cui sono
accaduti, ma anche tutta la storia successiva della persona,
che in base alle proprie esperienze quei ricordi rielabora,
anche inconsciamente, finendo per riscrivere continuamente la
propria memoria» (p. 189). In parole povere, questa tipologia
di fonte pone dei problemi metodologici essenziali. Ciononostante,
le fonti orali rappresentano un patrimonio significativo per
lo studioso delle vicende del movimento anarchico e libertario,
specie per la fase storica presa in considerazione dal volume
in questione. Il periodo di tempo tra gli anni Cinquanta e Ottanta
del Novecento rappresentano infatti, scrivono i curatori nella
loro nota iniziale, uno snodo fondamentale che «ha segnato
una profonda trasformazione del movimento anarchico –
sempre che di movimento, al singolare, possa essere lecito parlare
– sia per quanto riguarda le sue teorie di liberazione
sociale, sia per la sua pratica militante, sia per il modo di
concepire se stesso dentro, contro e fuori la dialettica politica
contemporanea» (p. 9).
La prima parte del volume ricostruisce pertanto il contesto
e le coordinate storiografiche su cui si inserisce la seconda
sezione, dedicata invece alle questioni più prettamente
metodologiche relative alle fonti orali. Esaminando la «storia
di storie» (p. 13) dell'anarchismo italiano, Antonio Senta
individua i tre piani sui quali si muove (sociale, politico
ed etico) e li interseca con una periodizzazione che trova il
suo spartiacque nel biennio '68-'69, specialmente in Piazza
Fontana e nelle sue conseguenze. Dopo questa panoramica, Elena
Bignami si concentra sulla militanza femminile anarchica, un
tema che mostra già il suo potenziale «perché
va a integrare non solo la realtà del movimento anarchico
del secondo dopoguerra, che resta un capitolo ancora molto sfuggente,
incompleto oltre che decisamente controverso, ma soprattutto
la storia delle donne e del femminismo, che in Italia è
deficitaria di qualsiasi riferimento alla cultura anarchica»
(p. 48). Segue l'intervento di Emanuela Minuto e di Alessandro
Breccia sulle attività in campo educativo di una «minoranza
libertaria», il gruppo Milano 1, ricostruite attraverso
«narrazioni 'in soggettiva'» che si rivelano spesso
come «biografie collettive» (pp. 64-65). Questa
prima sezione si chiude con il saggio di Pasquale Iuso, il quale
insiste sulla necessità di inserire il movimento anarchico
e libertario del secondo dopoguerra nei «molteplici fenomeni
che attraversano l'Italia repubblicana» (p. 81).
La seconda parte si apre con un utile intervento di Luigi Balsamini
dedicato a una prima ricognizione di ciò che già
c'è (e di dove si trova) in tema di fonti orali. Se Piero
Brunello delinea bene il rapporto nonni-nipoti, con tutte le
sue sfaccettature e conseguenze, che sembra caratterizzare il
movimento anarchico della seconda metà del secolo scorso,
Alessandro Casellato presenta l'insieme delle problematicità
ruotanti intorno a una testimonianza orale prendendo come caso
di studio un'intervista nata... da un libro di ricette! Può
sembrare uno scherzo, ma il saggio è davvero stimolante.
Segue l'intervento di Giovanni Contini sulla memoria di Pietro
Gori presso gli abitanti dell'Isola d'Elba (ho riso al convegno
e sono tornato a ridere leggendo il suo contributo). A questo
proposito, Contini precisa che talvolta gli aneddoti sono «più
utili a capire chi racconta (chi raccontava) che a comprendere
gli eventi e le persone ricordate» (p. 160). Infine, questa
seconda sezione si chiude con il contributo di Marco Masulli,
il quale restituisce attraverso la biografia di Placido La Torre
uno spaccato dell'anarchismo siciliano. Parlare d'anarchia
si conclude con la trascrizione riveduta dell'intervista a Gianni
Carrozza, Paolo Finzi, Claudia e Silvia Pinelli, una fonte orale
presa in diretta al convegno (la registrazione originale è
custodita dall'Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa di Reggio
Emilia).
Per ragioni indipendenti dalla volontà dei curatori del
volume, manca purtroppo l'interessante intervento di Lorenzo
Pezzica. Cosa diceva di preciso? Non me lo ricordo ovviamente,
però potrei raccontare del perché ero a quel convegno
e del percorso umano e politico che mi ci ha portato ecc. ecc.
(anche se, come accennavo all'inizio, non credo che a qualcuno
interessi). Questo per dire, un po' scherzando ma la faccenda
va presa sul serio, che le fonti orali presentano sfide e potenzialità
da non sottovalutare per la ricerca storica che possono portare
lontano, al di là di facili battute sulla memoria, illuminando
questioni inaspettate. Fanno perciò bene i curatori del
volume a lanciare un appello «per la registrazione di
testimonianze orali sulla militanza anarchica e libertaria del
secondo Novecento» (p. 10).
David Bernardini
Giordana
Garavini e Misato Toda
Due
belle figure di anarchiche ci hanno lasciato in questi
ultimi tempi: Giordana Garavini e Misato Toda.
Le ricorderemo
con due specifici “dossier”, curati rispettivamente
da Gianpiero Landi (che riferirà anche
di altri
familiari di Giordana, a partire dai genitori Emma Neri
e Nello Garavini) e da Paolo Finzi. |
|