
I troll Mumin,
una famiglia allargata in piccola comunità
 Lo
spunto per parlare dei Mumin (Moomin) me lo offre l'edizione
2012 della festa dei libri per bambini e ragazzi “La tribù
dei lettori”, che si è tenuta a Roma, al Maxxi
(Museo nazionale delle arti del XXI secolo) in via Guido Reni,
dal 28 maggio al 2 giugno 2012. La Tribù li ha infatti
premiati come i migliori, nelle edizioni Black velvet. Io invece
li conosco da diversi anni nella mitica collana Gl'Istrici,
diretta per Salani da Donatella Ziliotto. Lo
spunto per parlare dei Mumin (Moomin) me lo offre l'edizione
2012 della festa dei libri per bambini e ragazzi “La tribù
dei lettori”, che si è tenuta a Roma, al Maxxi
(Museo nazionale delle arti del XXI secolo) in via Guido Reni,
dal 28 maggio al 2 giugno 2012. La Tribù li ha infatti
premiati come i migliori, nelle edizioni Black velvet. Io invece
li conosco da diversi anni nella mitica collana Gl'Istrici,
diretta per Salani da Donatella Ziliotto.
I Mumin sono quanto di più anticonformista e libertario
– autenticamente libertario – mi sia capitato di
incontrare nel vastissimo panorama dei libri per bambini e ragazzi.
La loro comunità è nata nel 1946, in Finlandia,
dall'immaginazione e dall'intelligenza di una raffinatissima
disegnatrice e scrittrice appartenente alla minoranza di lingua
svedese: Tove Jansson (Helsinki, 1914 - 2001). Dapprima le sue
storie dei troll Mumin furono raccontate attraverso albi illustrati,
poi divennero strisce a fumetti, infine veri e propri libri
tradotti in più di trenta paesi. Lettura culto per generazioni
di ragazzini in tutto il mondo ma soprattutto nordeuropei, che
li hanno celebrati e li celebrano tuttora in numerosissimi fans
club, i Mumin hanno guadagnato alla Jansson decine di riconoscimenti
internazionali, tra cui nel 1966 la Medaglia H.C. Andersen (il
Nobel della letteratura per bambini).
Tralascio tutti gli annessi e connessi di carattere commerciale
(tv, merchandising ecc.) che hanno accompagnato nel corso del
tempo il “fenomeno Mumin”, per dire piuttosto dell'incanto,
perché di incanto si tratta, che questi esseri suscitano
in egual misura in piccoli e grandi.
Prendiamo, per esempio, Il Cappello del Gran Bau (Adriano
Salani Editore, Firenze 1990, pp. 157), un libro che Tove Jansson
diede alle stampe nel 1968 e che, insieme con Magia di mezza
estate, fu il primo della serie a essere pubblicato in Italia
da Salani nel 1990. Non ne racconterò la trama. Ma in
questo strampalato susseguirsi di avventure, il piacere dell'eleganza
della scrittura (tradotta da Annuska Palme Sanavio e dalla stessa
Ziliotto) e delle illustrazioni originali dell'autrice si accompagna
a un altro piacere, senz'altro per me più sottile e stupefacente:
quello della rappresentazione poetica e giocosa della coesistenza
pacifica e non gerarchica di un gruppo di individui.
Nel breve prologo, sempre lo stesso, che accompagna tutti i
suoi testi editi da Salani, Tove Jansson spiega che, a differenza
dei troll comuni delle saghe nordiche, “che sbucano solo
di notte”, questi troll Mumin “sono molto più
civili e istruiti” e “hanno un grandissimo amore
per il sole”. “D'estate naturalmente sono felici”
afferma la scrittrice, che ci tiene anche a partecipare ai lettori
come proprio la mezza estate, il 21 giugno, sia la loro festa
più grande.
Dal mio punto di vista è proprio il sole la chiave di
lettura per comprendere la visione del mondo e delle relazioni
sociali che sta alla base di questa cosmogonia creata dalla
Jansson.
I troll Mumin – "famiglia allargata in piccola comunità,
che vive nell'omonima valle" – non sono esenti da
invidie, gelosie o rabbia. Il loro universo non è affatto
un eden. Anzi, se c'è un tratto nel quale ci si può
riconoscere completamente è la verità di un quotidiano
raccontato senza ipocrisie. La loro sostanziale solarità
li spinge tuttavia ad adottare quasi sempre atteggiamenti aperti
e tolleranti, spesso addirittura amorevoli nei confronti dei
propri simili. E dettati da una grandissima gioia di vivere.
Una joie de vivre esplosiva e liberatoria, che non conosce
sensi di colpa.
È lo stesso Papà Mumin a esemplificare con una
metafora la saggia filosofia che regola la vita nella Valle:
considerando la fugacità dell'estate nordica, bisogna
cercare di divertirsi il più possibile finché
si è in tempo, dichiara nel Cappello del Gran Bau
davanti a figli e amici riuniti.
Ma come sono risolti i conflitti qui, in questa specifica storia
e anche nelle altre della saga? Accettando di partecipare tutti,
troll piccini compresi, a un confronto aperto e leale, che non
esclude la messa a nudo dei propri sentimenti, per quanto deplorevoli.
Sembra molto banale, vero? Non lo è!
“Bisogna tenere consiglio. Tutti si trovino al cespuglio
di lillà alle tre per discutere la questione”,
stabilisce Grugnino, dovendo affrontare uno spinoso problema,
qual è quello del “furto” di un “rubino
grande come la testa di una pantera, incandescente come un tramonto,
vivo come il fuoco e come lo scintillio dell'acqua”. (Che
però non è stato rubato per il suo valore economico,
bensì per la bellezza che promana). Nessuno nella comunità
pensa di sottrarsi all'appello.
La scena del tribunale è spassosissima, giocata com'è
sul filo della parodia dei tribunali veri. Ma è notevole
soprattutto per l'epilogo. Un epilogo che sfocia nella mediazione,
l'unica via realmente percorribile dopo aver riconosciuto le
ragioni di tutti i contendenti. In tal modo il verdetto non
potrà che essere equo, e questo grazie anche alla partecipazione
attiva di ciascun membro del gruppo.
Qualche volta, leggendo, capita di commuoversi. A me è
successo spesso di ridere e di sentirmi al contempo profondamente
colpita dall'acutezza psicologica, delicata e leggera, con la
quale la Jansson tratteggia i suoi personaggi.
Nel Cappello del Gran Bau è la descrizione dell'amicizia
tra Tabacco e il troll Mumin a farmi un grandissimo effetto.
Si tratta di un legame prezioso, fondato sul rispetto della
diversità e delle esigenze reciproche. Quando infatti
Tabacco, sentendo il richiamo di luoghi remoti dove “ha
bisogno di andare da solo”, parte, il troll Mumin è
così generoso da accettare la felicità dell'amico
pur soffrendo moltissimo il distacco.
“Brindo a Tabacco, che stanotte vaga verso sud, solitario,
ma certo felice quanto noi! Auguriamogli un posto tranquillo
per la sua tenda e per il suo cuore!” afferma davanti
alla comunità in festa questo piccolo grandissimo troll
nascondendo le lacrime.
Il microcosmo dei Mumin è un esperimento di libertà
che possiamo proporre ai nostri bambini e che possiamo condividere
con loro in un percorso di crescita comune. Saremo sorpresi
dalla franchezza con cui l'autrice parla... di noi. E anche
dall'ironia, spesso sferzante, con cui lo fa.
Per quanto riguarda il piccolo troll Mumin, così triste
per la partenza di Tabacco, vien quasi voglia di abbracciarlo,
di averlo anche noi per amico tra quelli che possiamo contare
sulle dita di una mano.
Emanuela Scuccato
Il ritorno di
Cristiano De André
Penso che si provi sempre un forte brivido ascoltare Le
vent nous portera dei Noir Désir, avvertire come
una ebbrezza la voce vellutata del leader ribelle (e maledetto)
della rock band francese (scioltasi nel 2010), Bertrand Cantat,
che intona “... mentre aumenta la marea/ognuno fa i propri
conti/ io mi ritrovo in fondo alla mia ombra/polvere di te/il
vento ti porterà/ ma il vento ci guiderà... ”.
Un capolavoro assoluto di poesia e struggente malinconia dell'ultimo
decennio (uscito nello stesso giorno dell'attentato alle Torri
gemelle di New York), Cristiano De André ne ha rifatto
una splendida versione tutta in italiano e l'ha inserita in
Come in cielo così in guerra (Nuvole production),
album comparso sugli scaffali a dodici anni di distanza dall'ultimo
Scaramante.

|
| Cristiano De André |
Per realizzarlo De André è volato in California
e si avvalso dell'aiuto di Corrado Rustici, che ne ha curato
gli arrangiamenti, e della partecipazione di artisti sempre
più richiesti a livello internazionale, come il bassista
e compositore Kaveh Rastegar e il batterista Michael Urbano
(che lavora da un po' di anni anche con Ligabue). Dieci tracce
che si tengono insieme senza stridore anche se De André
(che, oltre a cantare, suona violino, bouzouki e chitarra acustica)
ha cercato di mischiare le carte del rock con l'etno, l'elettronica
con la word music (qui i sentori di Peter Gabriel si avvertono,
eccome). Un album curatissimo nei minimi dettagli con De André
che si racconta senza nascondersi e lascia pulsare dentro le
sue canzoni gli ideali, l'amore, il legame spesso conflittuale
tra genitori e figli, l'affanno dell'affrontare la vita che
è poi il disagio del vivere di tutti. Ci ha messo in
questo lavoro il cuore e, soprattutto, la poesia che permette
di osservare, abbracciare più in profondità le
cose e la vita.
Dai dieci pezzi sicuramente viene fuori un Cristiano De André
fortemente ispirato, che si veste da demone e angelo, da viandante
con le sue certezze e insicurezze. Oltre alla cover dei Noir
Désir che, tra l'altro, ha un testo tanto in sintonia
col pensiero più deandreiano (nel senso che è
affine tanto al padre Fabrizio che al figlio Cristiano) del
sentirsi sulla terra profughi infiniti, si può provare
una certa emozione nell'ascoltare altri brani ricchi di candore
e delicate sfumature come Non è una favola, Disegni
nel vento e Sangue del mio sangue, ma sono altrettanto
da scoprire Ingenuo e romantico e Vivere, le cui
sonorità più si ascoltano e più entrano
dentro. Una nota a parte meritano Le bambole della discarica,
testo scritto insieme al poeta pavese Oliviero Malaspina dove
le donne (le bambole) di cui si parla sono le puttane di oggi
che si vendono non per soddisfare il bisogno primario del pane,
ma per arrampicarsi sullo specchio di un benessere illusorio,
e sicuramente Credici, un pezzo indiscutibilmente politico
in cui si può specchiare lo stato di un paese malridotto,
“svenduto al peggior dei medioevi”, dove viene richiamata
alle sue responsabilità anche la “Santa Madre Chiesa”
che ha voltato le spalle a Cristo per inchinarsi allo Ior e
all'Opus Dei.
In questa stagione mancava nel panorama della musica italiana
un album così ricercato e ponderato su un ben definito
stilema di generi, e ora è arrivato da Cristiano De André,
come fosse un delicato fiore (dono) di primavera.
Mimmo Mastrangelo
L'insurrezione che viene.
Due letture
Provando a commentare –
in un precedente numero di “A” (n.378) –
il recente libro di Negri e Hardt, Questo non è un
manifesto, si evidenziavano alcuni limiti interpretativi
del volume riguardo agli attuali movimenti in corso d'opera,
auspicando, come opzioni, necessarie rotture di piani affinché
emergessero aperture di orizzonti più inclusive e di
maggiore respiro, in grado di coniugare le proteste dei vari
movimenti metropolitani contro la crisi economico-finanziaria
con le conseguenze provocate dal disastro ambientale, nella
considerazione che una sola è la crisi che dilaga, che
ci attraversa e di cui si parla.
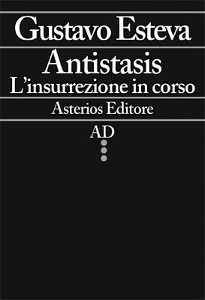
Produzione di verità e pratiche
politiche
Il recente volumetto di Gustavo Esteva, Antistasis. L'insurrezione
in corso (Asterios, Trieste, 2012, pp. 96, € 9,00),
pur nella sua brevità, adempie meritoriamente a questa
prospettiva inclusiva. Riprendendo Foucault (autore che taglia
trasversalmente e sotterraneamente l'intero testo), la questione
per Esteva non sta nel modificare le idee della gente, ma si
tratta di lavorare sui dispositivi (politici, economici, istituzionali,
ecc.) di produzione della verità, ovvero l'insieme di
enunciati in base ai quali governiamo (o veniamo governati):
noi stessi e gli altri, i corpi e le menti. Non a caso il libro
si apre con l'affermazione che l'insurrezione inizia dal linguaggio.
La sostituzione del sostantivo con il verbo – denominatore
comune di molte delle attuali iniziative sociali e politiche
– dichiara il passaggio dall'idea all'azione, all'utopia
concreta: in questione è il mangiare degli uomini e delle
donne, così come l'abitare, l'apprendere, il curarsi
e via dicendo.
Fondatore nella città messicana di Oaxaca della Universidad
de la Tierra (luogo in cui non vi sono insegnanti né
esami o programmi da rispettare: lì, i ragazzi non sono
consumatori dell'istruzione come merce, né rivendicano
il diritto allo studio, ma esercitano in maniera conviviale
la libertà di conoscere), Esteva – assai vicino,
come si può intuire, alle posizioni di Ivan Illich –
si definisce “attivista sociale e intellettuale pubblico
deprofessionalizzato”.
“Stiamo vivendo una catastrofe di civiltà che mette
a rischio la sopravvivenza della vita umana”: questo è
il punto d'avvio del saggio e da qui l'autore prova a sondare
i segnali di inversione, le vie di fuga e di rottura che si
possono intravedere.
Un'insurrezione sta attraversando il mondo, dice Esteva, e alcune
sue espressioni sono sotto gli occhi di tutti: la primavera
araba, gli indignados spagnoli, le manifestazioni greche,
il movimento Occupy statunitense, ma anche il dramma e la lotta
dei popoli migranti, o il raggruppamento internazionale di via
Campesina impegnato nella difesa della biodiversità,
per la sovranità alimentare e per politiche in campo
agro-alimentare più legittime e sostenibili.
A partire da ciò Esteva rielabora alcune domande, per
così dire classiche, individuando al contempo possibili
direzioni di percorso. In breve: ciò che sta accadendo
(e l'attenzione del libro è rivolta in primis,
anche se in modo non esclusivo, a quanto succede nel continente
latinoamericano) ha la portata di un'insurrezione? Qual è
la sua fisionomia? Quali rischi e quali potenzialità
esprime? Possiede tratti realmente anticapitalistici o rischia
di essere funzionale al regime dominante, un ulteriore tassello
che, sebbene involontariamente, ne alimenta la sopravvivenza?
L'alternativa comunitaria
La sola alternativa, secondo Esteva, è quella comunitaria.
Né individualismo capitalista né statalismo socialista,
con le derive autoritarie verso cui entrambi degenerano (criminalizzazione
dell'avversario, stato di eccezione), ma recupero pieno del
valore della collettività, la quale può assumersi
in prima persona compiti e responsabilità, senza accentramenti,
deleghe o surrogati di sorta (vi sono qui interessanti riferimenti
al pluralismo radicale di Raimon Panikkar). Non vi è
ed è bene che non vi sia un centro-guida che articoli
un unico movimento di resistenza e di protesta mondiale; ad
esso è preferibile l'idea di una rete plurale, interconnessa
e dinamica, che si muove ed entra in azione quando un nodo della
rete agisce o viene aggredito. Così come va abbandonata
l'ossessione della presa del potere (attraverso le tornate elettorali
o con la lotta armata), concentrandosi invece verso una progressiva
erosione dei meccanismi statali e dei suoi apparati (istituzioni,
esperti, ecc.), per la creazione di una normatività “dal
basso”, una democrazia davvero radicale. Il riferimento
esplicito dell'autore va all'esperienza zapatista (di cui fu
consigliere nel corso dei negoziati dell'Ezln con il governo
messicano), al loro mandar obedeciendo (“comandare
obbedendo”) e ben espresso dalle parole dello stesso Marcos:
“Il nostro vantaggio è per l'appunto di non avere
un centro-guida, né un piano preconcetto nel tentativo
di omogeneizzare le parti di questa rete”. E ancora: “La
maggiore scommessa dello zapatismo è nel proclamare la
possibilità di fare politica senza prospettare la presa
del potere”.

|
| Gustavo Esteva |
Il buen vivir
L'approdo e la forma stessa di questo percorso è il buen
vivir, di cui si parla molto in America latina e pochissimo
in Europa (quando non lo si confonde con le varie forme di benessere
narcisistico: vedi il new age). Buen vivir è
un'espressione spagnola che riprende a sua volta un termine
di origine quechua e che può essere sintetizzato come
la ricerca di armonia e benessere collettivo con la natura intesa
come terra mater, come madre natura (Pacha Mama),
laddove la concezione occidentale dominante della terra è
quella di una mera estensione, passiva, res nullius da
predare e colonizzare.
Su questo tema segnaliamo anche il volume di Carlo Sini, Del
viver bene (Jaca Book, Milano, 2011), per molti versi
differente da quello di Esteva ma non per questo distante, in
cui viene compiuta una quanto mai articolata ricognizione genealogica
– con gli strumenti della semiotica filosofica –
riguardo l'economia dell'attuale mercato globalizzato, a cominciare
dall'analisi delle strutture del sacrificio, del dono e dello
scambio, fino a far affiorare le sottili relazioni intercorrenti
tra scrittura, sapere e denaro con la conseguente mercificazione
dei rapporti umani. Per giungere a riconoscere (in particolare
nell'ampia appendice finale del saggio) nel buen vivir
degli indios le tracce di possibili economie politiche alternative,
fondate sul rispetto della biodiversità e del pluralismo
culturale.
Federico Battistutta
Un passaggio
tra gli scheletri
 Homo
sapiens che, con le loro fughe di morte, raccontano un'epica
quanto tragica rincorsa verso un'irraggiungibile immortalità,
ma anche quella di “qualcun altro” che, esibito
pornograficamente o consumato quotidianamente, sta lì
– immortalato – a suggerirci di incarnare finalmente
un quid comune che ci ri-guarda. Homo
sapiens che, con le loro fughe di morte, raccontano un'epica
quanto tragica rincorsa verso un'irraggiungibile immortalità,
ma anche quella di “qualcun altro” che, esibito
pornograficamente o consumato quotidianamente, sta lì
– immortalato – a suggerirci di incarnare finalmente
un quid comune che ci ri-guarda.
Una storia in-naturale, insomma, che è poi quanto prefigura
Massimo Filippi in questo piccolo libro (Natura infranta.
Dalla domesticazione alla liberazione animale, Ortica Editrice,
2013), organizzato in 18 tesi – che dalla preistoria arrivano
fino ai nostri giorni – e arricchito da quattro tavole
in bianco e nero dell'artista Luigia Marturano; libro in cui
l'autore si fa interprete di emozioni vitali che indagano (lasciandosi
indagare) l'indeterminatezza del senso, dei sensi e del sentire.
Uno dei protagonisti di questa storia altra è
un cadavere. Un feto di maiale, “l'animale addomesticato
e oppresso per eccellenza, con una sola testa e due corpi”.
Il risultato di due violenze: quella incosciente della natura
e quella istituzionalizzata dal devastante impulso di supremazia
dell'umano che, sistematicamente e con “successo”,
si è adoperato e si adopera in una guerra di presunta
liberazione, ma che in realtà è una guerra fratricida
che si concretizza nel millenario atto di autoaffermazione identitaria
diretto contro la sua componente animale.
Questo feto di maiale è mostruoso, è il risultato
di malformazioni moltiplicate oltre ogni misura dal contesto
forzato, per quanto onnipresente, dell'allevamento. Un mostro
che, però, è in grado di emettere un urlo muto
capace di rievocare l'impotenza della creazione e l'insalvabilità
che la percorre. Un'eco straziante che indica con insistenza
assordante (nella fragorosa indifferenza sociale) che quella
bocca, spalancata più che aperta, è una porta
annidata dentro le porte normalmente chiuse dell'umano, una
via di fuga dall'ignominia del presente. Apertura incancellabile
che continuamente evoca la necessità di una rivoluzione
immanente del “chi” – piuttosto che dell'eternamente
procrastinabile “cosa” –, una rivoluzione
che travalichi le barriere di un sistema che ci ha ridotti,
insieme agli altri animali, a strumenti funzionali ad un presunto
ordine naturale e che contemporaneamente sorvoli oltre i labirinti
delle prospettive ideologiche oggettivanti. Apertura che ci
permette di intravvedere un sentiero che non segue né
le vecchie orme conformi alla prima legge né le
fatidiche promesse normative di un irrealizzabile superamento
della condizione di sfruttamento generalizzato in cui viviamo.
Un percorso che, abbandonando i disegni deliranti di liberarci
dalla natura o di liberazione della natura, si
incammina verso una liberazione alla natura ancora tutta
da pensare. Un piccolo passaggio che ci fa intravvedere la possibilità
“di costituirci come esseri naturali in quanto culturalmente
coscienti della [nostra] finitudine”.
In questo libro, che senza dubbio rappresenta un contributo
lungimirante al dibattito antispecista, l'autore svincola la
questione animale dai recinti concettuali imposti sia dall'ecologia
profonda che dalle varie culture di stampo umanista, proponendoci
un excursus di natura politica e filosofica che giunge a conclusioni
del tutto inedite e rispondenti all'esigenza da parte del variegato
movimento di liberazione animale – in crescente sforzo
di autonomia e di autodeterminazione – di contestualizzare
storicamente e socialmente il proprio messaggio.
Davide Majocchi
Cantami
di questo vento
Girotondi di vaste solitudini si muovono tra le linee melodiche
disegnate da un giovane cantautore del nostro tempo. Sguardo
che sfila e cuce, come sospinto da un buon vento, i richiami
di un sentire profondamente umano. Ogni espressione, traccia
di un'opera letteraria o slancio d'inventiva poetica, avanza
scandita da un cantato avvolgente e accende il tempo dell'ascolto
per queste Storie in forma di canzone di Nicola Pisu.
Raccolta di immagini narranti che cercano lo spazio per raccontarsi
e riposano su paesaggi sonori abitati da movimenti strumentali
in armonica mescolanza. Il mare, con il suo moto oscillante
che culla e trasporta, diventa spazio prediletto che accoglie
le lacerazioni del dolore. Nel mare si conserva un amore senza
via di scampo e scivola il pianto di Maria Maddalena,
amante e madre che guarda la vita da una feritoia. Sulla
pianura di sale vive il pescatore con la sua pelle bruciata
e imbevuta di solitudine, il cui destino si consuma nel sentiero
suggerito da una pallida luna. Acqua che scorre e rovescia le
vele gonfie di algebre del vittorioso Colombo, eroe perdente
tra il massacro dei nativi. Mare che si infrange sulla riva
di altri mondi emarginati, quelli da cui proviene la voce di
un professore che si appella alla vita mascherandosi d'euforia.
Anche nel discreto passare della protagonista della prima
storia tuona il delirio della solitudine, risolto invocando
la salvezza nel richiamo di un amore di figlia.
E ancora si riflette sulla fatalità del destino umano
nel nucleo dedicato alla Sardegna, dove si muovono comparse
carnevalesche dai presagi funesti. Resta sospesa, tra le storie,
la voce di un ideale smisurato: emerge dai frantumi della
sua vita invisibile, l'incantevole ritratto del giovane Franco
Serantini il cui grido libertario annegò sul Lungarno
come un sogno impossibile. Girotondi segnati dalla carica
vitale di una folla umana che si muove tra smarrimenti e speranze
nel tracciato dell'esistere. Nella scrittura in musica di Nicola
Pisu, autore e compositore delle tredici canzoni che compongono
l'album, la forte propulsione narrativa si dissemina in un lungo
percorso che non tradisce la cifra stilistica prescelta ma si
carica di esperienza e sperimentazioni intrise di buon vento.
Laura Medda
L'album è disponibile presso i principali negozi
di musica online. è possibile ascoltare un'anteprima
delle canzoni su nicolapisu.zimbalam.com
Il pugile zingaro
che sfidò il Terzo Reich
Buttati giù, zingaro di Roger Repplinger (edizioni
Upre Roma, Milano, 2013, pp. 292, € 12,00) si presenta
come uno straordinario affresco sulla solitudine dell'uomo oppresso,
forte anche dinnanzi alla consapevolezza della propria fine;
una vicenda emblematica del coraggio di accettare l'esistenza
comunque essa sia, anche quando condannata alla sofferenza e
all'ingiustizia.
La penna di Repplinger, con grande profondità e lucidità,
ritrae il percorso dall'infanzia all'età adulta del protagonista,
il sinto tedesco Johann “Rukeli” Trollman, regalandoci
un racconto molto intenso sul piano emotivo. La ricerca sui
personaggi è approfondita (soprattutto su Trollmann).
Lo stile è ricercato ma senza troppi stancanti virtuosismi:
è un'opera piacevole, che può essere apprezzata
soprattutto da chi si sente in un certo senso speciale e reietto
nei confronti della società e degli altri. È un
lavoro estremamente maturo per la compiutezza del contenuto
e per l'alta tensione emotiva sviluppata: un crescendo di sensazioni
che avviluppa l'anima del lettore, tra momenti di allegria,
di tenerezza, di tristezza, di speranza e di morte.
Il libro trasuda umanità, prestando la voce a coloro
che gridano aiuto e facendo entrare il lettore accorto nel mondo
buio della diversità. Quella narrata da Repplinger non
è una storia sconclusionata e surreale, ma è l'altra
faccia della vita: quella meno fortunata, meno sorridente, meno
scanzonata da una parte, e quella incanalata in un sistema totalitario
dall'altra.
 |
| Johann Trollmann
(nome sinto Rukeli) |
Questo è un libro che si legge in apnea e che in apnea
ti lascia quando lo hai finito; sarà anche questo un
indicatore che ci dice che è una buona opera destinata
a rimanere nel tempo.
Johann Trollmann (nome sinto Rukeli) è nato il 27 dicembre
1907 a Wilsche e ha iniziato a tirare di boxe per caso a 8 anni,
dopo essere capitato in una palestra dove un amico si allenava
già da due settimane, al 10 di Schaufelderstrasse.
Campione della circoscrizione sud per ben quattro volte –
la prima nel 1925, nei pesi medi, e campione dei dilettanti
di Hannover dal 1925 al 1928, inizia a vincere spesso, in un
periodo in cui il pugilato stava prendendo sempre più
piede. Rukeli è agile come un gatto, molto veloce e così
mobile sul tronco che non viene quasi mai colpito. Diventa una
celebrità locale, piace alle donne, ha qualche soldo
in tasca, diventa campione dei pesi medi della Germania nord-occidentale
nel 1928 senza aver combattuto – l'avversario non si è
presentato a causa di una malattia –. Il suo ultimo match
da dilettante si svolge il 5 ottobre 1928 e vince ai punti.
È proprio in quel periodo che Trollmann inizia a farsi
conoscere per la sua boxe provocatoria e sopra le righe a cui
si aggiunge un carisma che lo porta ad avere una reale presa
sul pubblico. In effetti il suo modo di essere, spavaldo fino
ad arrivare alla spacconeria, era una novità “spettacolare”
per quei tempi ed esercitava un fascino immediato sul pubblico,
sempre più assetato di sue notizie.
Venerdi 9 giugno 1933, Berlino. Trollmann è rapido sul
ring, l'avversario Witt tenta di colpire, Trollmann sfugge,
agile e leggero, l'arbitro ammonisce i pugili: “combattere
con più agonismo”.Trollmann domina il ring, Witt
non ha chance, dopo dodici riprese l'arbitro, Otto Griese, sale
al centro ring, verdetto: non c'è un vincitore. Witt
è stupito, il pubblico rumoreggia, si arriva alle mani.
Trollmann piange: ha vinto ma non gli assegnano il titolo. Si
riunisce la commissione sportiva: visti i cartellini, Trollmann
viene ufficialmente dichiarato il vincitore. Nuovo campione
tedesco dei mediomassimi. Ma un campione zingaro nella Germania
nazista è inconcepibile. Il lunedi seguente si riunisce
la Bbd, autorità tedesca per il pugilato: il titolo viene
sospeso, la commissione annuncerà il prossimo incontro
per il titolo dei mediomassimi. È la fine della carriera
di Trollmann e si sta edificando una “nuova Germania”.
24 luglio 1933, Trollmann contro Eder. Le direttive per Rukeli
sono chiare: deve perdere con dignità. Lui però
è orgoglioso e reagisce: sfida gli ariani e nell'incontro
si tinge i riccioli neri di biondo e si cosparge il corpo di
borotalco. Accetta di stare al centro ring senza muoversi, alla
tedesca, come vuole il regime, fermo, senza fare un passo indietro.
Si fa picchiare, massacrare, finchè sfinito cade in una
nube di bianco borotalco. Rukeli è fuori gioco e per
lui inizia la paura, non degli avversari sul ring, ma di quelli
fuori dal ring, che gli urlano: “Trollmann, buttati giù,
altrimenti ti veniamo a prendere” e “Porco zingaro,
vattene in Valacchia”.
Nel '34, mentre Rukeli prende parte ad alcuni incontri di pugilato
nel luna park, si intensifica la persecuzione dei sinti. Dopo
essersi nascosto nella foresta di Teutoburgo, aver divorziato
dalla moglie per preteggerla dalla deportazione e dopo aver
combattuto sul fronte russo per la Wehrmacht (ed esser stato
ferito), nel '42 Rukeli viene arrestato e trasferito nel lager
di Neuengamme. È qui che la sua storia si intreccia con
quella di un altro comapione dello sport: Otto “Tull”
Harder, “ariano”, membro del comando delle SS del
lager ed ex stella del calcio, che dopo la guerra sarà
condannato a 15 anni di detenzione, ma che per il natale del
'51 sarà già un uomo libero.
Diverso è invece il destino di Johann, che nel 1944 muore
assassinato dal triangolo verde Emil Cornelius, che Trollmann
aveva umiliato, battendolo in combattimento. Cornelius, sconfitto,
aveva minacciato: “gliela farò vedere io allo zingaro”
e infatti Trollmann, sfinito dal lavoro, viene ucciso a randellate
da Cornelius che occulta l'assasinio e ne denuncia la morte
come incidente. Solo nel 2003 agli eredi di Trollmann viene
consegnata la sua cintura da campione, in una mesta e disertata
cerimonia. Gustav Eder, che aveva abbattuto l'inerme Rukeli
in una nube di bianco borotalco, morì anziano nel 1993.
Trollmann finì la sua vita assassinato a Wittenberge
da un criminale comune per aver vinto un incontro di boxe.
Giorgio Bezzecchi
vice presidente nazionale Federazione rom e sinti insieme
Rom, questione
di sguardi
 Briciole
è il nome dato al trimestrale del Cesvot (Centro volontariato
Toscana) che raccoglie gli atti dei percorsi formativi svolti
dalle associazioni di volontariato attive in Toscana. Il numero
32 (aprile 2012), dal titolo RomAntica cultura, è
dedicato alla questione dell'“invisibilità ed esclusione
del popolo rom” ed è curato da Valentina Montecchiari,
Martina Guerrini e Valeria Venturini. Briciole
è il nome dato al trimestrale del Cesvot (Centro volontariato
Toscana) che raccoglie gli atti dei percorsi formativi svolti
dalle associazioni di volontariato attive in Toscana. Il numero
32 (aprile 2012), dal titolo RomAntica cultura, è
dedicato alla questione dell'“invisibilità ed esclusione
del popolo rom” ed è curato da Valentina Montecchiari,
Martina Guerrini e Valeria Venturini.
Gli interessanti contributi raccolti nella pubblicazione sono
il frutto di un lavoro collettivo che indaga esperienze e tematiche
di notevole rilevanza e attualità. Offrono uno sguardo
plurale e articolato che pone interrogativi, suscita dubbi,
e allo stesso tempo rappresentano un'opportunità di approfondimento
per una formazione interculturale.
Merita un'attenzione particolare il saggio di Martina Guerrini
Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista
contro le donne romni in una prospettiva anticolonialista.
L'autrice propone un rovesciamento di prospettiva dello sguardo
rivolto alla donne romni, attingendo a una metodologia comparativa
antropologica – già applicata allo studio delle
donne migranti – che impone di ri-guardare con occhi più
critici anche la nostra società.
Qual è lo sguardo con il quale la nostra società
considera quella rom? Caratteristiche patriarcali e sessiste
esistono solo nella tradizione rom oppure, in qualche misura,
persistono anche nella nostra società, che si considera
“più emancipata”? O anche quest'ultimo non
è forse uno stereotipo? La nostra società italiana
sembrerebbe abilissima nel costruire “immaginari”
a proprio uso e consumo. Quale rappresentazione ne dà
delle identità delle donne romni? Zingara cartomante
e un po' strega. Girovaga e felice per il mondo. Allo stesso
tempo, povera vittima di un arcaico mondo patriarcale violento
e misogino.
Il nostro immaginario cristallizza in forme rigide, semplifica
e schematizza laddove la complessità, il non definito
caratterizzano la quotidianità. Quanto sfugge alle maglie
del conosciuto viene ricompattato secondo un'ottica che predilige
il controllo dall'alto. Con la presunzione di conoscere la cultura,
il popolo rom quando invece ciò che si conosce è
la nostra rappresentazione mentale del loro mondo. Ed è
ancora più vero per le donne romni, delle quali si crede
di conoscere i problemi, i bisogni, le aspirazioni. Ma l'ottica
è deformata. Quindi, prevale la visione unidirezionale
delle istituzioni e non la realtà variegata, multiforme,
sfaccettata e mai definita una volta per tutte del popolo rom
e delle romni in particolare. Siamo noi ad aver bisogno di dare
loro un'identità circoscritta da assimilare o differenziare
a seconda del momento, delle necessità. Così,
prima imponiamo la nostra idea della loro identità, ci
convinciamo di rispondere alle loro reali necessità,
e infine siamo disposti ad assimilarli, a condizione che dimostrino
di essere bravi ad accettare le nostre regole di convivenza.
Ancora – si chiede Guerrini – non è il nostro
sguardo sessista a prevalere negli elementi discriminatori verso
le donne romni? Le donne sono le uniche alle quali le istituzioni
chiedono conto dell'educazione dei figli, e le si condanna se
li portano con loro quando vanno a chiedere l'elemosina, perché
ritenute responsabili di coinvolgerli in attività degradanti.
Forse la nostra società sta mostrando interesse per la
crescente sofferenza di minori in situazioni di disagio nelle
nostre famiglie, e troppo spesso sottoposti a violenza? Oppure,
le istituzioni stanno facendo abbastanza per contrastare la
persistenza di stereotipi sessisti nell'ambito dell'educazione
scolastica? Solo le donne romni sono vittime di violenza domestica
e dell'accettazione sociale di tale violenza? Quali conclusioni
si possono trarre riguardo alle nostre donne italiane appartenenti
alla società cosiddetta emancipata? Sono magari più
fortunate, con i massacri quotidiani perpetrati a loro danno
dai loro stessi mariti, compagni, conviventi? Sono solo alcuni
interrogativi sollevati da Martina Guerrini. L'invito è
quello di uscire dai panni delle “emancipatrici delle
altre”, ri-orientare lo sguardo giudicante in un'ottica
che osservi il mondo rom senza occhi da gagè e, soprattutto,
includa e consideri “la voce delle altre e degli altri”
e ne accetti posizioni antagoniste. Un esempio? Accettare il
rifiuto, da parte del popolo rom, di prender parte alla guerra
gagè delle identità. Allora, oltre allo sguardo
bisognerà riorientare anche l'itinerario del viaggio.
La provocazione di Marcello Palagi espressa nel titolo del suo
saggio Volete un progetto? Non fate progetti! sembra
calzare a pennello. Se i gagè, le istituzioni, i tribunali,
le forze dell'ordine, l'assistenza sociale, le fondazioni, il
volontariato insistono nel decidere al posto loro, significa
che rom e sinti sono presi in considerazione solo come oggetto
di provvedimento, rivolto a chi è giudicato come un “caso
da risolvere”, un problema di ordine pubblico che riguarda
un'umanità da contenere. Sì, perché rom
e sinti sono considerati fermi allo stadio infantile e inetto,
incapaci di decidere in modo autonomo. Una volta relegati a
una condizione di genetica inferiorità è più
facile instaurare rapporti di potere. Così si decide
a tavolino una soluzione abitativa, senza averli interpellati
in base alle loro reali esigenze. Si impongono modelli di vita
gagè. Vengono sottratti i figli ai loro genitori in nome
della presunta tutela dei diritti dei minori, senza contemplare
il diritto dei minori di rimanere con i propri genitori.
Si stipulano patti di legalità legittimando una legalità
diversa, cucita su misura. E poi ci si indigna se rom e sinti
continuano a vivere come se il patto non esistesse. Ma è
un patto non patteggiato, piovuto dall'alto, declamato dai rappresentanti
delle istituzioni, che dettano regole, magari nemmeno capite
dagli interessati. Prevalgono l'imposizione, la repressione.
Confronto alla pari, mediazione, dialogo sono i grandi assenti.
Eppure rom e sinti hanno una funzione politica importante: tengono
allarmata l'opinione pubblica, che poi si coalizza per sostenere
programmi politici antidemocratici. Non ci sono, infatti, controindicazioni
a perseguitare i rom. E oggi il razzismo mostra la sua duplice
faccia. La propaganda che fa leva sull'immagine dello straniero
percepito come pericoloso, deviante, criminale influenza e autoalimenta
sia il razzismo popolare, sia quello istituzionale. A sua volta,
si verifica una ricaduta nelle modalità di intervento
dell'assistenza sociale, delle amministrazioni pubbliche e si
condizionano altresì le valutazioni dei giudici, con
grande amplificazione anche da parte dei mass media. Allora,
cosa rimane da fare, secondo Marcello Palagi? Niente! Se si
vuole fare qualcosa di buono, non si facciano progetti. Nessun
progetto per rom e sinti, quindi, ma difesa del loro diritto
a decidere da soli di se stessi, a scegliere per se stessi.
Un valido progetto? Essere solidali e rispettosi dei loro diritti
fondamentali. A partire dal rispetto del loro diritto a una
visione minoritaria, originale del mondo. Visione, in un certo
senso, profetica e critica del presente.
Lo stesso giornalismo cova dentro di sé il germe del
razzismo e della discriminazione. Lo sottolinea Lorenzo Guadagnucci
in Giornalisti contro il razzismo. Come distruggere lo stereotipo
negativo dei rom e degli immigrati. La questione immigrazione
nelle varie redazioni – è risaputo – viene
affidata ai cronisti di nera, ma i dati Istat confermano che
non c'è correlazione tra i fatti reali, la criminalità
in atto e il rilievo attribuito. L'enfasi sulla cronaca nera,
il linguaggio usato negli articoli, le fonti considerate hanno
portato alla falsa emergenza sicurezza. L'angolo visuale dei
media è distorto. La discriminazione parte dall'uso del
linguaggio. Al riguardo, nel 2008 il gruppo dei Giornalisti
contro il razzismo ha messo in campo una proposta di autoregolamentazione.
Al bando le parole tossiche. Clandestino. Perché evoca
sospetto e la condizione di fuorilegge. Nomade. Si riferisce
a un inesistente nomadismo, in quanto i rom e i sinti che vivono
in Italia sono quasi tutti stanziali. Il termine serve però
a giustificare la segregazione di gruppi familiari nei cosiddetti
“campi nomadi”. Zingaro. Ha assunto nel tempo un'accezione
dispregiativa ed è rifiutato dallo stesso popolo rom.
Extracomunitario. Ha perso la sua originaria connotazione di
extra rispetto alla Comunità europea e ora indica persone
“extra” rispetto alla comunità maggioritaria,
nel senso di “altre”, “escluse” per
il colore della pelle o per la condizione di povertà.
Ma il termine “extracomunitario” viene forse usato
per indicare un cittadino statunitense o svizzero? Oppure per
designare altre persone di pelle nera, ma famose nell'ambito
del calcio, della moda o dello spettacolo? La Carta di Roma
è un documento professionale importante per un uso del
linguaggio rispettoso e non discriminatorio, pertanto tenuto
a essere rispettato da tutti i giornalisti iscritti all'albo.
Ma non basta. Guadagnucci sottolinea che anche ognuno di noi
può dare un contributo rilevante. In che modo? Accogliendo
l'invito a depurare l'immaginario comune dal lessico velenoso.
Estirpare non solo nei discorsi pubblici, ma anche nell'uso
quotidiano tutti quei termini impregnati di stereotipi mistificanti.
Non solo. Serve una partecipazione ancor più diretta
dei cittadini. Lettere al direttore, esposti all'ordine dei
giornalisti, fino alla denuncia alla magistratura dei casi più
gravi di violazione della deontologia professionale. Sono prese
di posizione volte a contrastare queste forme di discriminazione,
proprio a partire da un uso pubblico non stereotipato e stigmatizzante
del linguaggio.
Claudia Piccinelli
Il volume è gratuito. Se si vuole scaricarlo in
pdf (gratuitamente), si può farlo sul sito del Cesvot
(cesvot.it).
Se invece si desidera il libro cartaceo (per malati della
carta stampata e delle grandi librerie), si può richiedere
a questo indirizzo, pagando le sole spese di spedizione:
altra_info@yahoo.it.

Donne, con equilibrio
e tenacia
Ascoltare la rabbia di una donna è ascoltare l'urlo di
tutti gli oppressi. E se avete timore di ascoltare la voce di
chi lotta contro il proprio padrone, Dio o marito che sia, allora
Funambole di Isabel Farah (Marco del Bucchia Editore,
€ 11,50) non è libro che fa per voi. Se al contrario
avete il desiderio di aprire questo immenso vaso di Pandora,
allora fatelo con tutta l'attenzione e la cura necessaria, proprio
come fanno le funambole quando camminano sul filo sottile che
le sorregge.
Sedici donne, sedici voci che raccontano storie
lontane nel tempo ma tremendamente vicine al nostro presente;
il mito greco e la sua storia ufficiale tutta al maschile per
una volta sono ribaltati e denudati dalle maschere di ipocrisia
che lasciano sentire dietro il “profumo di giustizia,
la puzza di legge”.
La narrazione si tinge allora di rosso, come il sangue dell'oppressore
ucciso, e di nero, come la rivolta “dinanzi al progetto
della [propria] esistenza scritto da terzi”; la donna
può finalmente gettare quegli abiti portati da anni per
volontà altrui, scegliere di non vestire nessuna maschera
e di non “interiorizzare nessun dogma” come gli
uomini hanno invece fatto fino a perderne coscienza.
La sua rabbia si intreccia stretta con la voce di tutte le altre
donne, il suo progetto di rivalsa a quello di tutte le compagne
di cammino, proprio come il filo sottile, e al tempo stesso
forte, che lega tutte le oppressioni ma anche tutte le ribellioni,
un filo su cui le donne hanno imparato a camminare con equilibrio
e tenacia, proprio come le funambole.
Laura Gargiulo
Per ordinare il libro:
isabelfarah@gmail.com
- delbucchia.it
- ordini@delbucchia.it
|