
L'arte/
Il ruolo nell'educazione libertaria
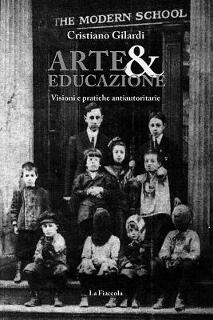 Pubblichiamo
l'introduzione al libro di Cristiano Gilardi Arte &
educazione - Visioni e pratiche antiautoritarie (La Fiaccola,
Ragusa, 2016, pp. 128, € 13,00). Per richieste:
Giovanni Giunta, via Tommaso Fazello 133 - 96017 Noto (SR).
CCP n. 78699766. Pubblichiamo
l'introduzione al libro di Cristiano Gilardi Arte &
educazione - Visioni e pratiche antiautoritarie (La Fiaccola,
Ragusa, 2016, pp. 128, € 13,00). Per richieste:
Giovanni Giunta, via Tommaso Fazello 133 - 96017 Noto (SR).
CCP n. 78699766.
Se ci limitiamo ad osservare il panorama dell'establishment
culturale occidentale, ci rendiamo conto che l'ultimo scorcio
del XIX secolo origina, da una parte un intricato circuito di
valore (senza valori?) che Hans Magnus Enzensberger definisce
«industria della coscienza» (gallerie, musei, luoghi
espositivi per il mercato dell'arte...); dall'altra, un'istituzione
scuola, nella configurazione che va ad assumere, così
come arriva fino ai nostri giorni. Due sistemi che maturano
a partire dall'ideologia utilitarista e materialista della borghesia
industriale, con elementi in comune, ma di matrimonio difficile,
perché la scuola mal accetta ancora oggi di applicare
un concetto ampio di creatività che va oltre le ore destinate
alla cosiddetta educazione artistica, tranne in rari
casi, che confermano la regola, o altri in cui le logiche competitive
concordano con le strategie formative.
Questo è l'esempio del Goldsmiths College di Londra,
che adotta una filosofia atta a preparare i propri studenti
alle strategie del mercato dell'arte e all'ideologia del successo,
o della Central Saint Martins (sempre di Londra), che rappresenta
la più grande scuola sforna talenti dell'arte
e del design del Regno Unito. Istituti che, nonostante superino
la formula della bottega artistica, continuata invece dalle
accademie di belle arti, avviano un determinismo storico, sotto
forma di accaparramento al visibile, di antica data se si pensa
che la storia dell'arte è piena di scuole specialistiche
che ricercano la tendenza o che duellano fra loro per contendersi
il primato dell'educazione più innovativa dal punto di
vista della creatività.
Ma perché la scuola generalista rinuncia alla ricchezza
che può offrirle l'arte? Secondo Raoul Vaneigem –
ma anche Ivan Illich, Denis de Rougemont, Neil Postman (per
citare alcuni contemporanei) – la scuola moderna, riflettendo
appieno la società di produzione e consumo, avvia
un processo di sublimazione compensatorio, sostituendo gioco,
creatività ed eros – abbecedario
dei bisogni espressi dall'educando al suo debutto a scuola –,
con bisogni altri che alimentano in lui il passaggio
da «produttore/creatore» a neo «consumatore».
Difatti, se il mercato (soprattutto anglo-americano) assorbe
una parte di queste esperienze – se non altro perché
si accorge dell'importanza di una formazione attraverso una
materia capace di fornire due qualità fondamentali alla
new Economy: la inventiva e la reinventiva, cioè
la capacità di rimettersi in gioco, acquisendo quella
flessibilità tanto cara ai sostenitori del lavoro precario
– i governi, dal canto loro, non hanno nessun interesse
a legittimare una professione non censibile (quella di futuro
artista, attore, musicista... nel caso di istituti specialistici),
che inflazionerebbe il numero di lavoratori non convenzionali,
poco fruttuosi cioè alle casse istituzionali, o di incrementare
il numero di persone «creative» (nel caso di una
riforma che investirebbe l'intero apparato scolastico), per
i problemi che queste possono apportare a un sistema basato
sulla dissipazione di vitalità.
Tuttavia, oltre alla scarsa presenza dell'arte nella maggior
parte delle scuole pubbliche e questi sodalizi tra mondo dell'azienda
e mondo scolastico, esiste una terza categoria di luoghi in
cui arte ed educazione si legano assieme. Ed è proprio
su questa terza via che intendo far luce. Più esattamente,
voglio ricostruire il filone libertario dell'Art Education,
con le sue scuole, le colonie di artisti, le piattaforme pedagogiche,
le opere partecipate.
Un'indagine, la mia, prevalentemente storico-sociologica, che
prende in disamina tutti gli aspetti del legame significante:
dalle esperienze che da anni si susseguono in maniera critica
contro le fissità formali-metodologiche, alle posizioni,
militanti e non, di coloro che si pongono, anche solo spiritualmente,
all'interno di visioni e pratiche antiautoritarie.
Apologia di un incontro
Forse non è un caso che la fenomenologia estetico-didattico-oppositiva
risiede, in parte nell'affermazione stessa di arte educativa
contro il modello di sapere elaborato da Boezio che riduce l'arte
a mero intrattenimento; in parte all'estetica, che al suo apparire,
grazie a Baumgardner, si mostra già come «conoscenza
attraverso i sensi»; e in parte alla nascita delle corporazioni
di Arti e Mestieri che, al pari delle universitates sorte in
età volgare (XII sec.), con la loro intimità ambientale,
riescono ad avviare quel rapporto docente/discente di complice
trasmissione del sapere e di esplicito rimando all'èsoteros
greco.
Praxis visibilis a partire dall'éducation nouvelle,
ma che, rarità di esempi a parte, trova ostacolo anche
nella sola pianificazione dell'atto, che per natura si compone
di soggetto-attivo (catalizzatore), mezzo e fine,
che cambiano secondo le varianti tipologiche. Nel caso dell'artista-insegnante
è lui a condurre il gioco e a utilizzare la didattica
per iniziare all'arte o insegnare con l'arte per
stimolare i processi cognitivi senza veicolare necessariamente
le sorti professionali dei propri discenti. Stessa dinamica
accade quando è l'intera scuola a farsi «soggetto-attivo».
Qui gli insegnanti (che non devono essere necessariamente degli
artisti) hanno un vantaggio in più rispetto al singolo
artista chiamato a insegnare in una struttura che non favorisce
l'applicazione di metodi non convenzionali.
Pur non volendo ridurre l'incontro di arte ed educazione alla
sola didattica, dobbiamo affermare che essa occupa un posto
notevole nel nostro percorso. un posto in cui la più
alta percentuale di praticanti sono artisti e, nel nostro caso:
artisti spiritualmente o ideologicamente vicini al movimento
libertario. Sono loro, infatti, i primi a saper leggere nel
movimento libertario uno spirito epifanico, e a intravedere
la relazione tra creazione plastica e creazione sociale. E non
è strano quindi che le prime scuole artistiche, poetiche
e politico-dissidenti (in quanto circoli di informazione e di
formazione) siano i Cenacoli e i Caffè Letterari.
Ma in cosa si differenzia quest'educazione libertaria di indirizzo
estetico dal resto della pedagogia della creatività?
Prima di rispondere, va aggiunto e sottolineato che la pedagogia
estetico-libertaria è scivolata su un terreno in cui
le differenze sostanziali nei confronti delle altre pedagogie
progressiste non sono facilmente riconoscibili. Tuttavia, benché
si tratti di una corrente che spesso utilizza il medesimo gergo,
ha finalità e sostanza differenti, e oggi, gli autori
che ne fanno parte, spesso, non riescono neppure a emergere
a sufficienza e, dunque, a partecipare al gran dibattito culturale
o, se lo fanno, devono entrare in un sistema altamente competitivo,
che dà loro voce in capitolo attraverso il conseguenziale
successo.
La più generale Pedagogia della creatività, nel
corso della sua storia, sembra ridursi a due poli estremi: da
una parte, il conservatorismo dai rigidi insegnamenti, che promuove
programmi di purismo esecutivo spesso paralleli a un sistema
premio-punitivo; dall'altra, chi fa lievitare le idee dalla
pancia stessa dei propri discenti, ponendosi in un'ottica vichiana
o comunque romantica. È tra questi ultimi da ricercare
la nostra posizione? La risposta non può che essere duplice:
in parte sì (genericamente) e in parte no (peculiarmente).
Essa, ponendosi all'interno del più generale pensiero
libertario, muove le sue teorie a partire da precisi contesti
di critica e proposizione entro parametri sperimentativi di
libertà, con concezioni molto elastiche che vanno dall'educazione
«armonistica» di Charles Fourier alla Libera università
Internazionale di Joseph Beuys. Più esattamente, muove
le sue teorie perseguendo tre fasi esplicative: presa di
coscienza, teorizzazione e limitazione della metodologia applicata
nei ristretti ambiti di necessità.
Come quest'ultimo fattore può e deve essere applicato
coerentemente non è facile dirlo. Vi sono diverse teorie
che, pur muovendo su un terreno di base comune, prendono le
distanze nei processi applicativi. E, se alcuni autori investono
nella costruzione di un nuovo tipo umano (nell'uomo nuovo,
per intenderci), altri scelgono di invitare l'iniziato a percorrere
un sentiero che non conduce a nessuna via maestra; con
la consapevolezza che solo un sentiero non previsto da nessuna
mappa topologica può mettere l'iniziato in condizione
di fare certe esperienze, di cercare altre vie o, come Kerouac,
di trovare nella strada stessa il suo luogo-altro, la
madre-scuola che alleva/educa i propri figli randagi, togliendoli
dal predefinito strutturale: dal lusso medio alto dei banchi
di fronte alle cattedre dell'«io so».
Il libro presenta la creatività come arte nelle
sue varie specificità (non solo visiva), e può
essere riassunto in:
– enti educativi tra autoritarismo e libertà;
– istruzione come sostentamento economico atto a preservare
la libera attività del versante creativo;
– antiaccademismo;
– arte come mezzo di liberazione sociale;
– autoeducazione attraverso l'arte;
– appropriazione di metodi e linguaggi pedagogici per
fini estetici o utilizzazione dell'arte come mezzo per giungere
alla conoscenza di problematiche sociali legate a fattori educativi.
Sei punti che fanno propri linguaggio e principali
istanze caratterizzanti la più generale Pedagogia
libertaria: lotta all'autoritarismo, istruzione integrale o
olistica, coeducazione dei sessi (valida anche per gli istituti
artistici), apprendimento cooperativo, messa in atto di una
maieutica socratica, cura per l'ambiente...; uniti a un vocabolario
terminologico specifico che il mondo dell'arte cerca ormai da
anni di introdurre nel sistema scolastico generale: osservazione
degli oggetti da più angolazioni, uso del «bildhafte
denken» («pensiero per immagini»), «decontestualizzazione»,
consapevolezza del carattere dei materiali, eccetera.
Cristiano Gilardi
Pedagogia interculturale/
Per fermare le guerre
 Il
Dialogo per la Pace (L. Tussi - F. Cracolici, Mimesis Edizioni,
Milano, 2014, pp. 107, € 12,00) è un libro utile,
il cui architrave è offerto dalla “pedagogia interculturale”.
Se la “pedagogia della pace”, come spiega Fabrizio
Cracolici, «apre a tutte le tradizioni e le religioni,
al fine di raggiungere un'unità di senso e di significato,
un comune orizzonte di idee, in un alto momento di incontro,
pluralista e democratico, basato sulla dignità delle
differenze che costituiscono il vero motore, attivo e libertario,
dei popoli», allora la “pedagogia interculturale”
ne rappresenta una premessa ed una declinazione. Da una parte,
la pedagogia interculturale come antefatto del “lavoro
di pace” dal momento che, come spiega Laura Tussi, «ognuno
di noi presenta una propria specificità e differisce
da ogni altro nelle personali prerogative identitarie; la considerazione
ed il riconoscimento dell'“altro da sé” permettono
il reciproco confronto e la gestione educativa del conflitto»
(p. 25). Dall'altra, la pedagogia interculturale come articolazione
del lavoro di pace, dal momento che «educare significa
scegliere sempre la persona, per agire a favore del più
debole, interagire in contesti di pluralismo culturale, in cui
la natura del soggetto consiste nell'affermare la propria differenza
e singolarità e appropriarsi di valori e di ricchezze,
comuni all'umanità» (p. 54). Se è vero che
questi termini non esauriscono l'impegno dei costruttori di
pace, è almeno altrettanto vero che essi finiscono per
istituire una mappa concettuale importante intorno a tre questioni:
pace, memoria e inter-cultura. In primo luogo, resta implicita
una connotazione del lavoro di pace, vale a dire l'esercizio,
costante e consapevole, del decentramento emotivo e cognitivo
quale presupposto della dislocazione in medias res: si
tratta, cioè, di porsi a confronto nella relazione e
a contatto nella diversità, maturando la consapevolezza
necessaria a comprendere la specificità del contesto
sociale e l'irriducibilità dei paradigmi cui si riferiscono
persone, popoli e comunità. In secondo luogo, la pedagogia
interculturale è una parte della pedagogia per la pace
e può costituire uno strumento prezioso per innervare
di senso le modalità del “dialogo di pace”
che, in contesti di violenza, conflitto e post-conflitto, si
intende instaurare. In questi casi, il lavoro di pace si estrinseca
spesso in termini di ricomposizione di ciò che la guerra
ha scomposto, di ritessitura di ciò che la violenza ha
lacerato e di rigenerazione di ciò che il dolore ha sfigurato.
Non si tratta né del lavoro del pompiere né dell'azione
di tutoraggio: il costruttore di pace non è colui che
“mette la toppa” o “detta le regole”,
bensì colui che si mette a disposizione, abitando il
conflitto dal lato di chi ne ha maggiormente subito l'ingiustizia,
di un processo di trasformazione sociale che punti ad estinguere
i bacini della violenza, a dissodare il terreno delle legittime
esigenze di “pace con giustizia” e a contribuire
a riorganizzare il tessuto delle relazioni sociali. Come ricorda
Alessandro Marescotti, «una pedagogia della vita quotidiana
che ami la bellezza, l'arte e la cultura; che educhi alla complessità
e alla pazienza, al dubbio e alla saggezza [...] è impegno
contro la guerra come espressione di barbarie». L'impegno
per la pace rappresenta così «un modo per mettersi
in gioco, per assumersi delle responsabilità e per indicare
la strada concreta della nonviolenza». Ovvero, «la
pace come umanità che si deve riconoscere una, plurale
e solidale, concretamente esistente nei singoli esseri umani,
tutti uguali per diritti e dignità, tutti differenti
per caratteri, propensioni ed opinioni, nell'umana convivenza
[...] di cui ogni persona è promotrice» (p. 105).
È, se vogliamo, la sfida stessa della “pace positiva”,
tra le più esigenti per il lavoro costruttivo di “pace
con giustizia”, che resta come “sotto-testo”
di questa narrazione. Il
Dialogo per la Pace (L. Tussi - F. Cracolici, Mimesis Edizioni,
Milano, 2014, pp. 107, € 12,00) è un libro utile,
il cui architrave è offerto dalla “pedagogia interculturale”.
Se la “pedagogia della pace”, come spiega Fabrizio
Cracolici, «apre a tutte le tradizioni e le religioni,
al fine di raggiungere un'unità di senso e di significato,
un comune orizzonte di idee, in un alto momento di incontro,
pluralista e democratico, basato sulla dignità delle
differenze che costituiscono il vero motore, attivo e libertario,
dei popoli», allora la “pedagogia interculturale”
ne rappresenta una premessa ed una declinazione. Da una parte,
la pedagogia interculturale come antefatto del “lavoro
di pace” dal momento che, come spiega Laura Tussi, «ognuno
di noi presenta una propria specificità e differisce
da ogni altro nelle personali prerogative identitarie; la considerazione
ed il riconoscimento dell'“altro da sé” permettono
il reciproco confronto e la gestione educativa del conflitto»
(p. 25). Dall'altra, la pedagogia interculturale come articolazione
del lavoro di pace, dal momento che «educare significa
scegliere sempre la persona, per agire a favore del più
debole, interagire in contesti di pluralismo culturale, in cui
la natura del soggetto consiste nell'affermare la propria differenza
e singolarità e appropriarsi di valori e di ricchezze,
comuni all'umanità» (p. 54). Se è vero che
questi termini non esauriscono l'impegno dei costruttori di
pace, è almeno altrettanto vero che essi finiscono per
istituire una mappa concettuale importante intorno a tre questioni:
pace, memoria e inter-cultura. In primo luogo, resta implicita
una connotazione del lavoro di pace, vale a dire l'esercizio,
costante e consapevole, del decentramento emotivo e cognitivo
quale presupposto della dislocazione in medias res: si
tratta, cioè, di porsi a confronto nella relazione e
a contatto nella diversità, maturando la consapevolezza
necessaria a comprendere la specificità del contesto
sociale e l'irriducibilità dei paradigmi cui si riferiscono
persone, popoli e comunità. In secondo luogo, la pedagogia
interculturale è una parte della pedagogia per la pace
e può costituire uno strumento prezioso per innervare
di senso le modalità del “dialogo di pace”
che, in contesti di violenza, conflitto e post-conflitto, si
intende instaurare. In questi casi, il lavoro di pace si estrinseca
spesso in termini di ricomposizione di ciò che la guerra
ha scomposto, di ritessitura di ciò che la violenza ha
lacerato e di rigenerazione di ciò che il dolore ha sfigurato.
Non si tratta né del lavoro del pompiere né dell'azione
di tutoraggio: il costruttore di pace non è colui che
“mette la toppa” o “detta le regole”,
bensì colui che si mette a disposizione, abitando il
conflitto dal lato di chi ne ha maggiormente subito l'ingiustizia,
di un processo di trasformazione sociale che punti ad estinguere
i bacini della violenza, a dissodare il terreno delle legittime
esigenze di “pace con giustizia” e a contribuire
a riorganizzare il tessuto delle relazioni sociali. Come ricorda
Alessandro Marescotti, «una pedagogia della vita quotidiana
che ami la bellezza, l'arte e la cultura; che educhi alla complessità
e alla pazienza, al dubbio e alla saggezza [...] è impegno
contro la guerra come espressione di barbarie». L'impegno
per la pace rappresenta così «un modo per mettersi
in gioco, per assumersi delle responsabilità e per indicare
la strada concreta della nonviolenza». Ovvero, «la
pace come umanità che si deve riconoscere una, plurale
e solidale, concretamente esistente nei singoli esseri umani,
tutti uguali per diritti e dignità, tutti differenti
per caratteri, propensioni ed opinioni, nell'umana convivenza
[...] di cui ogni persona è promotrice» (p. 105).
È, se vogliamo, la sfida stessa della “pace positiva”,
tra le più esigenti per il lavoro costruttivo di “pace
con giustizia”, che resta come “sotto-testo”
di questa narrazione.
Gianmarco Pisa
L'Internazionale Situazionista/
Un dialogo tra Gérard Berréby e Raoul Vaneigem
Raoul Vaneigem (1934) è un autore belga e un critico
radicale della società. Dopo aver frequentato il liceo,
all'età di diciassette anni iniziò a studiare
letteratura all'Université Libre di Brussels. Una volta
laureato, insegnò per alcuni anni in diversi istituti
scolastici. Era il periodo dei lunghi scioperi in Belgio a cui
Vaneigem prese parte (anni 1960-61). È stato poi un membro,
per quasi dieci anni, del movimento conosciuto come Internazionale
Situazionista (I.S.).
Vaneigem non rilascia mai interviste. Ma nel caso dell'autore
francese Gérard Berréby (1950), molto interessato
al Movimento Situazionista e anche editore, è stato diverso.
Berréby era estremamente preparato al dialogo. Lui e
Vaneigem iniziarono a discutere sul luogo di provenienze di
quest'ultimo, prima di iniziare a parlare degli anni passati
nell'Internazionale Situazionista. E naturalmente anche di ciò
che è venuto dopo.
 Il
risultato è un libro in cui il dialogo è continuo,
riempito di note informative, molte immagini e altri materiali,
sotto-interviste fatte da Berréby a persone dell'ambiente
culturale di Vaneigem e sovrastampe (brevi articoli) o altri
testi per maggiori informazioni. Tutto questo in una vivace
e varia elaborazione di layout. In breve, Rien n'est fini,
tout commence (Niente ha una fine, tutto inizia,
Editions Allia, Paris, 2014, pp. 400, € 25,00) è
diventato un libro affascinante. Il
risultato è un libro in cui il dialogo è continuo,
riempito di note informative, molte immagini e altri materiali,
sotto-interviste fatte da Berréby a persone dell'ambiente
culturale di Vaneigem e sovrastampe (brevi articoli) o altri
testi per maggiori informazioni. Tutto questo in una vivace
e varia elaborazione di layout. In breve, Rien n'est fini,
tout commence (Niente ha una fine, tutto inizia,
Editions Allia, Paris, 2014, pp. 400, € 25,00) è
diventato un libro affascinante.
La maggior parte del dialogo è dedicata agli sviluppi
del Movimento Situazionista, a cui Vaneigem prese parte nel
1961. Questi sviluppi riguardano un'Internazionale Situazionista
in trasformazione (anno di svolta 1963), l'esperienza del picco
(Maggio '68) e poi il suo declino. Raoul non ha avuto esperienza
dello scioglimento del 1972 poiché aveva già rassegnato
le dimissioni nel 1970.
Una domanda pressante è quella su come un giovane talentuoso
come Raoul inizi ad essere coinvolto in un movimento radicale
come l'Internazionale Situazionista. La risposta va ricercata
nella prima parte del dialogo.
Vaneigem è nato in una famiglia proletaria nel villaggio
belga di Lessines, situato nel distretto minerario di Borinage.
Suo padre lavorava per le ferrovie ed era un sindacalista. All'interno
di quella regione e di quell'ambiente, Raoul diventa sensibile
a quello che succede nel mondo: lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
Le condizioni lavorative facevano aumentare il numero di incidenti
(mortali) in quella regione. “Questo genere di eventi,
a cui eravamo vicini, alimentava la mia rabbia contro i padroni”
dice. “A tredici, quattordici anni avevo assorbito l'intera
atmosfera dell'ambiente lavorativo”. Quell'atmosfera e
quella rabbia non l'hanno mai più lasciato.
I suoi studi sulla letteratura e l'interesse nei confronti del
poeta francese Lautrémont, lo ispirarono nella scrittura
del saggio “Poésie et Révolution”
(Poesia e rivoluzione). Curioso di avere un'opinione sullo scritto,
lo inoltrò al sociologo francese neo-marxista e critico
sociale Henry Lefebvre (1901-1991). Di suo Raoul aveva già
letto “Critica della vita quotidiana” (1947). Con
suo immenso piacere, Lefebvre reagì. Si rivolse ad un
amico, consigliandogli di contattarlo. Questo amico era Guy
Debord. Così, agli inizi del 1961, Debord e Vaneigem
cominciarono ad avere contatti personali.
“Quando io [Raoul] li incontrai [Guy Debord e sua moglie
Michèle Bernstein] a casa a Parigi per la prima volta,
Guy aprì una credenza e disse “Voilà, y
a da quoi faire!” (Guarda, abbiamo qualcosa da digerire!):
15 bottiglie di vino. In pratica, era tutto cibo, bevande e
discussioni”. È subito scattato qualcosa tra loro
tre. Debord e Vanaigem si capirono immediatamente. “Noi
[l'Internazionale Situazionista] siamo stati catalizzatori di
confusione, con l'intento di rovesciare le basi esistenti a
beneficio di una società radicalmente nuova” dice
Raoul. E Michèle Bernstein condivide con loro tutto questo.
Lei è tante cose insieme, fa notare Raoul: “Molto
conviviale quando si tratta di cibo e bevande, molto precisa
quando si tratta del linguaggio; prende parte ai dibattiti e
non vive in alcun modo all'ombra di Guy.” [...]
La transizione verso la critica politica ha rinnovato l'Internazionale
Situazionista completamente e ha reso manifesta la rottura con
l'idea di avanguardia. “Noi non volevamo essere un'avanguardia.
Sì, volevamo essere individui che seminano il radicalismo,
ma senza essere “alla guida del proletariato” come
gli stalinisti continuavano a ripetere”. L'Internazionale
Situazionista era entrata in una seconda fase.
Raoul si riconosce presto in questa situazione. “Debord
e io fummo presto d'accordo nel lasciare la critica dell'arte.
Dopotutto un oggetto artistico è meno importante delle
critiche al sistema di mercato. La critica dell'arte può
essere sorpassata dalla critica politica”. [...]
Con questo atteggiamento l'Internazionale Situazionista ha partecipato
al Maggio '68. Si è comportata da “avamposto”.
Raoul: “All'improvviso abbiamo visto moltissimi dei principi
che difendevamo ottenere visibilità”. Comunque,
fa anche notare, “il risultato andò oltre le aspettative.
La nostra idea di costruire un “avamposto” si trasmise
da persona a persona avendo cura di non lasciare che il nemico
riuscisse a penetrarci. Poi si formò una nuova “autorità”,
gli “Enragés” (gli arrabbiati) con, tra gli
altri, Cohn-Bendit”.
Insieme a Berréby, Vaneigem esamina cosa successe al
movimento di rivolta (Maggio '68). Alla fine è bene non
ignorare questa osservazione: il riconoscimento internazionale
dell'I.S. e la sua vittoria hanno annunciano allo stesso tempo
il suo declino. La cosa verso cui Vaneigem ha molte obiezioni
è la sbavatura stalinista, come si evince dalle espulsioni
fatte da Debord. Berréby e Vaneigem ne discutono a fondo.
Ciò che mi sembra importante ripetere qui è ciò
che solennemente piace a Raoul, perché ha importanza
nel presente. Raoul: “Quello che ci è sempre stato
chiaro è il radicalismo. Siamo d'accordo con ciò
che diceva Lefebvre circa l'importanza della vita quotidiana.
E questo è tornato nei dibattiti di oggi. Prendiamo la
discussione sul velo per le donne musulmane. Quella è
ideologia. Comunque ciò che è importante è:
la condizione della donna! La discussione sull'accettare o proibire
il velo, quello non è affar nostro. Per contro: che le
donne siano soggette al dominio maschile di un patriarcato arcaico
nei regimi tradizionali del mondo arabo o da qualche altra parte,
questo è il vero problema. Il punto è constatare
che i diritti delle donne non sono gli stessi degli uomini e
questa è la vera battaglia”. [...] Così
di nuovo si ripete durante il dialogo: c'è sempre una
critica alla vita di tutti i giorni che genera sovversione nel
rifiuto di una vita preconfezionata, programmata dal capitalismo.
Il declino dell'Internazionale Situazionista segue all'abbandono
di Debord nel 1972. Prima di lui, Vaneigem si era allontanato
nel 1970. Nostalgico? No. E il libro sui loro carteggi che è
stato pubblicato? Non gli interessa. L'idea di una costante
evoluzione è l'unica cosa che gli interessa e “stimo
ancora i pensieri teorici dell'I.S., ma per il resto...”.
Il dialogo Rien n'est fini, tout commence (Niente ha
una fine, tutto inizia) non ha introduzione o conclusione, persino
il sommario è assente. Tutto ciò che può
essere citato, come le note, le immagini, gli allegati sono
stati pubblicati tra i dialoghi. Il dialogo si apre con una
risposta, che - come potete immaginare - è preceduta
da una domanda: “Nel 1961, quando ero professore al Pedagogical
Academy di Nivelles...”. In questo modo viene presentato
Raoul. Quasi 400 pagine più avanti, Berréby gli
pone l'ultima domanda. Per farvi capire quanto il vecchio Vaneigem
sia ancora il giovane Vaneigem, riporto qui alcuni paragrafi
delle ultime due pagine (pp. 392-393).
Raoul: “La distruzione della vita e delle risorse naturali,
causate oggi dalla mafia finanziaria e dal dispotismo della
moneta, è inarrestabile e si diffonde come una malattia
contagiosa. Siamo di fronte ad un sistema assurdo che dà
ordini perentori agli stati, impoverisce le popolazioni, sperpera
i beni pubblici, avvelena il cibo, fa diventare brulla la terra
e la vita di tutti i giorni, accresce la disperazione e la noia
e tutto questo per continuare dritto sulla strada della guerra
di tutti contro tutti.
Gli stati giocano il ruolo dei servi in questo assurdo sistema.
La loro ultima ragione di esistere si conferma l'esercizio della
funzione repressiva. Il gioco è chiaro. O si persevera
nella logica suicida per acconsentire a morire nelle camere
a gas dei banchieri... o si prende coscienza che non c'è
nessuno pronto ad aiutarci tranne noi stessi.
Noi buttiamo giù le fondamenta di quella società.
E lo sappiamo bene: non abbiamo bisogno di ideologie per mettere
in funzione scuole, ospedali, trasporti, case, imprese socialmente
utili (metallo, energie rinnovabili, tessuti, cibi naturali),
per recuperare i beni pubblici [...].
Guardiamo la Grecia, la Spagna, il Portogallo dove dinamiche
autogestionarie sono apparse nei settori dell'educazione, della
sanità e nella produzione del cibo di qualità.
Sono solo esperimenti, ma nel futuro l'auto-governo della vita
quotidiana inizierà a delinearsi. È l'unico modo
per dare una chance alla vita”.
Thom Holterman
traduzione di Carlotta Pedrazzini
Padre anarchico
di una figlia speciale
È uscito da poco il volumetto Baby Block,
scritto da Dino Taddei e pubblicato da Zero in Condotta (Milano,
2015, pp. 86, € 10,00). Una vicenda umana e politica intensa,
vissuta con una bella dose di salvifica ironia (o meglio, auto-ironia).
Ne pubblichiamo qui un capitoletto, relativo ai primi tempi
del suo impegno politico in un quartiere popolare della periferia
milanese. Prima che nascesse la figlia di Anna e sua. E che
la musica (per tanti aspetti) cambiasse.
A seguire, pubblichiamo anche la recensione di Gianfranco
Marelli.

Un estratto dal libro
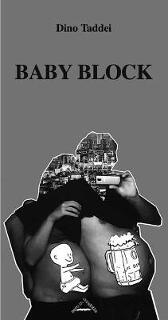 La
svolta avvenne improvvisa e insperata poco tempo dopo. Eugenio
aveva iniziato a frequentare in via degli Appennini la locale
sezione di Lotta Comunista (delle fighette democratiche se confrontati
ai filo-albanesi). Loro peculiarità era quella dell'Analisi
(di qualunque cosa: dagli scritti giovanili della Luxemburg,
alla produzione casearia in Burkina Faso), quest'impostazione
necessitava di monumentali studi preparatori e chiavi interpretative,
diciamo che non si poteva giudicare il pecorino del Burkina
Faso senza gli scritti giovanili della Luxemburg. La
svolta avvenne improvvisa e insperata poco tempo dopo. Eugenio
aveva iniziato a frequentare in via degli Appennini la locale
sezione di Lotta Comunista (delle fighette democratiche se confrontati
ai filo-albanesi). Loro peculiarità era quella dell'Analisi
(di qualunque cosa: dagli scritti giovanili della Luxemburg,
alla produzione casearia in Burkina Faso), quest'impostazione
necessitava di monumentali studi preparatori e chiavi interpretative,
diciamo che non si poteva giudicare il pecorino del Burkina
Faso senza gli scritti giovanili della Luxemburg.
Eugenio gongolava, gli pareva di aver finalmente trovato pane
per i suoi denti: milioni di nozioni a sua completa disposizione.
Tutto il mondo aspettava solo di essere svelato nel suo necrotico
meccanicismo.
Nella sua foga da neofita, ci sottoponeva a martellanti trattazioni,
usava noi scout come pubblico nella sala di studi anatomici.
Tutto fluiva chiaro sotto le ferree leggi delle scienze sociali.
Era veramente ridicolo vedere questi quattro ragazzi sfigatoni
e foruncolosi intenti a costruire cucine da campo, tende sopraelevate,
che discutevano sulla scelta astensionista di Lotta Comunista.
E fu proprio in questa circostanza che Eugenio ebbe un tremito
nella sua stentorea esposizione: una piccola incertezza che
mi fece rizzare le orecchie.
Si dà il caso che, in una di quelle simpaticissime lezioni
frontali, capitò all'insegnante di dover ammettere che
l'astensionismo elettorale era una pratica condivisa dal Partito
con gli anarchici, lumpenproletariat-immaturo-e-residuale
che si rifaceva ad un certo Bacunino; un nobilastro russo piantagrane,
così pieno di alterigia da voler far baruffa addirittura
con Marx.
«Addirittura con Marx?!»
«Già, sembra incredibile. Questo Michele Bacunino
se l'è spassata tutta la vita con i soldi di quattro
minchioni che gli stavano dietro, pure a Marx ha fregato la
fresca, e tutto per spregio verso le masse lavoratrici».
Basta: ero definitivamente consacrato all'Anarchia e a Michele
Bacunino.
Scoprii velocemente che questo Michele Bacunino era una pietosa
italianizzazione di Michail Bakunin. Del resto anche Marx faceva
di nome Carlo (sicuramente qualche matto avrà anche provato
a scrivere Marcs). In fondo un modo bonario di mettere sulla
tavola della cucina la storia. Molto meglio soffiare sul caffellatte
con il Carletto, il Michelone e perché no anche con il
Bepi (Stalino): tutto si umanizza. Tutto diventa alla portata
di osteria, tra smargiassate e lazzi. Un modo di mettere al
centro del nostro circoscritto universo le idee e gli uomini
foresti.
«In fondo anche il Papa si scaccola il naso come te!»
mi insegnò un giorno un compagno, intendendo dire che
i mostri in natura non esistono (semmai lo diventano poi).
I mostri forse no ma sicuramente i supereroi sì e Bakunin
era tra questi. Di lui si dicevano cose mirabolanti, alcune
vere altre meno, altre così bugiarde da diventare credibili,
ma per noi apprendisti stregoni (escluso Eugenio che faceva
il noiosetto precisino) tutte verissime. Avevamo trovato la
saga e non intendevamo mollare l'osso. Bakunin come Maciste.
Bakunin che da un albergo praghese vede maltrattare un gaglioffo,
prende le pistole e spara dalla finestra contro i birri, scatenando
la rivoluzione. Bakunin che ai ceppi nella prigione di San Pietro
e Paolo in Russia, riesce a fumare trecento sigari uno dietro
l'altro, bevendo solo caffè. Bakunin che chiede scusa
allo zar e poi scappa attraversando la Siberia, il Giappone,
l'America per arrivare a Napoli (!) pronto ad accendere la scintilla
rivoluzionaria. Bakunin che litiga con Fichte sul carattere
nazionalista della rivoluzione berlinese ma poi, vedendo le
barricate, non resiste e si mette anche lui a tirare rivoltellate.
Bakunin che ha distrutto innumerevoli patrimoni altrui e comunque
è morto povero, come un vero nobile.
E della vita di Marx cosa ci doveva entusiasmare? Un topo di
biblioteca arido e vendicativo.
«Però un colosso di sapienza, mentre Bakunin non
è mai riuscito a scrivere un'opera organica» tentava
Eugenio di calare qualche asso, nella speranza di riprenderci.
Noi non sapevamo bene cosa contrapporgli e ci zittivamo. In
realtà le sue parole sortivano esattamente l'effetto
opposto: quel Sole disordinato, fantasioso e vitale ci dava
la misura di quanto noi non c'entrassimo nulla con il Terzo
Libro del Capitale.
Comunque iniziammo la lettura delle opere 'non organiche' di
Bakunin, scoprendo l'essenza di tutto l'anarchismo: la lotta
senza quartiere verso ogni forma di autorità. Finalmente
avevamo trovato il bandolo della matassa: il principio di autorità
(qualunque autorità, anche quella del portinaio), si
fonda sulla costrizione, sullo sfruttamento, sulla distruzione.
Di autorità si muore, di certo l'autorità non
porta amore e vita ovvero due degli atomi costituenti la Libertà.
Forse non l'ha detto proprio Bakunin ma poco importa, oggi penso
che Eugenio fosse nel giusto affermando che il gigante russo
non avesse mai scritto un'opera organica ma fosse nello sbagliato
non credendolo un colosso di sapienza. Penso addirittura che
a Bakunin interessasse indicare solamente una mulattiera sconnessa
e imprevedibile come è la Libertà, non costruire
una autobahn con le uscite segnalate come Marx. Nulla
di più slavo contro nulla di più teutonico. Nulla
di più dionisiaco contro nulla di più carcerario.
Un richiamo all'ardore/ardire individuale che ben si attagliava
alla nostra voglia di sfida. Eugenio si trovò in minoranza
ma la faccenda durò poco, perché ad un Primo Maggio
fu cacciato dal corteo di Lotta Comunista avendo osato presentarsi
con l'orecchino... «Cosa fai tu, con quella roba all'orecchio?
Credi di essere al circo Medrano? Ti prendi forse gioco del
Partito di Classe?» questo gli dissero allontanandolo
quasi fosse Franti e questo gli bastò per dire definitivamente
addio al Partito di Classe e tornare a fare il Garrone con noialtri.
La nostra nuova tendenza anarcoide (perché di più
non si poteva dire) non passò inosservata negli ambienti
scout, il vento stava cambiando anche lì e avanzavano
le forze restauratrici e bigotte. Ancora ancora si poteva accettare
un qualche sentimento che rientrasse nell'alveo della Repubblica
di Dio ma sobbarcarsi un gruppo di diciassettenni atei anarchici
era effettivamente troppo.
Comunque dapprincipio la risposta dei capi fu quella di cercare
di sviarci nel sociale spinto, basta marce in alta montagna
e invece massima attenzione verso il volontariato sociale. Volevano
ubriacarci di carrozzelle, carceri minorili e deviati di ogni
risma.
Pensavano di indirizzarci verso il modello del bravo scout che
aiuta la vecchietta ad attraversare con il semaforo verde. Non
si rendevano conto che ci stavano dando gli strumenti per sabotare
il semaforo.
Ci spingevano verso l'umanitarismo e noi imparavamo la dignità
umana, verso il sociale che per noi diventava socialismo, verso
il volontariato che per noi significava delegittimare lo stato.
Quando se ne accorsero era troppo tardi: non restava che la
purga.
Tengo a sottolineare il ruolo formativo che ebbe comunque questo
ambito, in mezzo a un deserto. A mala pena rammento di essere
stato un 'ragazzo dell'ottantacinque', una patetica mobilitazione
nazionale degli studenti medi durata mesi contro la ministra
dell'Educazione Falcucci. Un inutile scimmiottamento (senza
averne la cattiveria necessaria) delle esperienze dei fratelli
maggiori: un mare di occupazioni, un oceano di manifestazioni,
qualche lecca sul groppone ma poi finì tutto lì.
D'altronde quello che più premeva alla gran parte degli
studenti era andare al parco a fumarsi qualche cilum di charas.
Non dimentichiamoci che a parte qualche avanzo di 'china' (dicasi
ciaìna), vi era un'egemonia culturale dei 'paninari',
chi poteva permetterselo e chi aspirava ad esserlo. Avere le
Timberland, mangiare da Burghy, ascoltare i Duran
Duran, guardare Drive-in ridendo in modo sincopato
come il finto pubblico nei telefilm americani. Oppure nella
versione aspiranti: rubare le Timberland, fare a cartelle
sulla 57 per andare da Zia Maria, ascoltare il Leone
di Lernia e guardare il porno di venerdì a mezzanotte
su Telereporter.
Ditemi voi dove si poteva andare...
Dino Taddei
La recensione
Baby Block di Dino Taddei è una storia intima,
minimalista, della vita di un militante anarchico divenuto padre
di una bimba – Anita – alla quale confessa il suo
smisurato amore. È il racconto di una vita semplice,
comune e senza preoccupazioni, fino a quando la conclamata patologia
di Anita [una malattia genetica, la Crigler Najjar, che colpisce
un bambino su un milione] non conduce il padre a ripensare se
stesso, offrendosi nudo allo sguardo inconsapevole della figlia.
Pertanto il racconto non assume né accelerazioni improvvise,
né interruzioni tragiche, ma si snoda sulla normalità
di un'esistenza tranquilla, paciosa, godereccia.
Dopotutto chi l'ha mai detto che la vita di un militante deve
essere una vita da milite? Ma se non è così, perché
raccontarla, scriverla e addirittura tramandarla? Perché
non siamo eroi, tantomeno santi; come tutti viviamo le emozioni
che la vita ci offre, accettandole alcune di buon grado, desiderandole
altre con smisurata passione, evitandole poche quando ciò
è possibile.
Ma si sa, la vita per essere vissuta bisogna non tanto accettarla
per come viene, piuttosto arrangiarla per come si può.
Per questo, nel raccontarla agli amici, più che cercare
di “farsi belli”, si vuole belle, particolari, le
avventure che si affrontano. Dopotutto, avventurieri lo siamo
un po' tutti, poiché avventuriero è colui che
va incontro all'avventura della vita quotidiana, e non tanto
chi, per bramosia di vivere la “bella morte”, la
cerca.
Certo, nella “Milano da bere” di fine anni '80,
ben poche erano le occasioni per non essere travolto dall'indifferenza
di una vita trascorsa nella bulimia pubblicitaria, soprattutto
da parte di chi non voleva consumarla in discoteche o in spettacoli
televisivi degni di Drive-in. Così al babbo [ancora in
erba] Dino sono bastate le uscite all'aria aperta con i boy-scout,
o le riunioni in locali tristi e scuri organizzate da propagandistiche
associazioni Italia-Albania, per far sì che i suoi anni
di formazione del carattere e delle poche idee ma ben confuse
fossero propedeutici ad un futuro spirito anarchico e ribelle.
Tanto basta poco, perché il più viene con lo studio,
l'esperienza e la convinzione che se è così che
funziona il mondo, vuol dire che il mondo funziona proprio male.
Di chi è la colpa? Non certo di un Dio sadico e baro,
troppo distante dalle cose terrene che anche ad invocarlo con
sonore bestemmie gli si attribuirebbe una notorietà non
meritata. E poi basta l'umanità, quella servile, pronta
a sottomettersi scegliendo essa stessa i propri padroni. Dal
che spontaneo sorge l'appello a non essere né schiavi,
né padroni, cercando di praticare in ogni dove la libertà
dall'autorità preposta o desiderata, fedeli al principio
di La Boétie: “siate risoluti a non voler servire,
ed eccovi liberi”.
Facile, no? Ma spiegalo a tua figlia di due anni, alle sue necessità
come ai suoi capricci, e soprattutto alla sua perentorietà
di Baby Block. E allora le domande poste da Dino nel suo libro
- «Si può essere anarchici e padri nello stesso
tempo? Come si riesce a salvare delle virtù collettiviste
libertarie dall'assalto di una figlia appena nata e già
individualista? Riuscirò a trasformare la perentorietà
del “mio!”, nella ragionevolezza del “nostro”?»
- non appaiono domande peregrine. Sono il sale dell'anarchia
sparso sulle vive ferite della quotidianità.
Gianfranco Marelli
Arte/
La rivoluzione siamo Noi
 Nel
mitico '77, giovanissimo, ho avuto occasione di incontrare Joseph
Beuys, libertario e uno dei più grandi artisti del secolo
scorso, alla Documenta.6 di Kassel, una delle più importanti
vetrine dell'arte contemporanea, paragonabile alla nostra Biennale
veneziana. Mi aveva invitato, attraverso la Free International
University di Dublino da lui fondata a tenere una relazione
sull'architettura contemporanea in Algeria, paese dove lavoravo
come docente all'E.p.a.u., la facoltà di architettura
della capitale. Sapevo a malapena chi fosse lui e cosa la F.I.U. Nel
mitico '77, giovanissimo, ho avuto occasione di incontrare Joseph
Beuys, libertario e uno dei più grandi artisti del secolo
scorso, alla Documenta.6 di Kassel, una delle più importanti
vetrine dell'arte contemporanea, paragonabile alla nostra Biennale
veneziana. Mi aveva invitato, attraverso la Free International
University di Dublino da lui fondata a tenere una relazione
sull'architettura contemporanea in Algeria, paese dove lavoravo
come docente all'E.p.a.u., la facoltà di architettura
della capitale. Sapevo a malapena chi fosse lui e cosa la F.I.U.
Ricordo delle ricche giornate di discussione in una sala ricavata
dietro una sorta di abside nel Centro del Museo Fredericianum
dove era stata installata l'opera di Beuys Honigpumpe am
Arbeitsplatz (Pompa del miele). Quest'opera era semplicemente
ciò che il titolo suggerisce: Una pompa alimentata da
un motore elettrico che metteva in circolo in alcune sale sino
al tetto un liquido a base di miele. Chi volesse saperne di
più legga il libro. Infatti questo testo, pubblicato
solo nel 2011 in Germania e l'anno scorso in Italia, non è
altro che la de-registrazione di un seminario con Beuys sul
tema Cos'è l'arte effettuato due anni dopo, nel
1979, su proposta di uno dei partecipanti agli incontri di Kassel
e membro della F.I.U, Volker Harlan, curatore di questo saggio.
La risposta a Cos'è l'arte? (a cura di Volker
Harlan, Castelvecchi Editore, Roma, 2015, pp. 96, € 16,00)
potrebbe essere l'arte è la rivoluzione. E per
Beuys “la rivoluzione siamo noi” - in italiano originariamente
-, come titola la sua famosa serigrafia del 1972 in cui è
ritratto deciso, in cammino verso di noi con la sua divisa d'artista,
il gilet da caccia-pesca, il cappello di feltro, la borsa a
tracolla di cuoio. Feltro, cuoio aggiunti a grasso, metalli
e materiali naturali sono gli elementi della 'scultura sociale'
di Beuys. Beuys intende per scultura sociale, “la formazione
da parte degli individui e con le loro sole forze della società:
l'artista è colui che si dedica a quest'opera”.
“Qual è la necessità che giustifica la creazione
di qualcosa come l'arte?” E così continua: “Comunque
una cosa mi sembra soprattutto chiara: se questa domanda non
diventa centrale nella ricerca e non trova una risposta davvero
radicale, che consideri effettivamente l'arte quale punto di
partenza per la produzione di ogni cosa, in qualsiasi ambito
di lavoro, allora qualunque idea di ulteriore sviluppo è
una perdita di tempo. Se vogliamo ridefinire e riformare la
società, bisogna tenere a mente questa idea – ossia
che ogni opera deriva dall'arte – perché inciderà
anche sulle questioni economiche toccando i diritti umani e
legali. Pertanto, siamo proprio dentro la questione della necessità
dell'arte, che è senza dubbio anche la questione delle
libertà”.
L'interesse di Beuys si concentra sull'uomo come singolo individuo,
per lui l'arte coincide con l'uomo, superando così la
tradizione Dada e Surrealista e in generale delle prime avanguardie
di far coincidere l'arte con la vita. In questa visione ha grande
importanza, oltre alla sua conoscenza dell'opera di Marcel Duchamp,
il suo avvicinarsi al pensiero di Rudolph Steiner, all'Antroposofia
ed alle venature anarchiche kropotkiniane del movimento.
|
| Joseph Beuys (12 maggio
1921-23 gennaio 1986) |
L'agiografia del personaggio racconta che Beuys da giovane
pilota di caccia della Lutwaffe nella seconda guerra mondiale
venne abattuto sopra la Russia e salvato da popolazioni nomadi
che lo ospitarono in una yurta nella steppa. Qui venne curato
con rimedi popolari. Gli venne spalmato del grasso su tutto
il corpo, venne avvolto in calde coperte di feltro e guarito
attraverso riti sciamanici. Da qui la sua nuova nascita, il
suo ripudio della violenza e la sua decisione di cambiare il
mondo attraverso l'arte e l'azione sociale. Da questa esperienza
anche derivano i materiali, feltro, grasso, cuoio e metalli
simbolici che Beuys sempre usa nelle sue opere e performance.
In realtà in questa ricostruzione della sua avventura
sciamanica si mescolano a fatti veri - l'abbattimento ed il
recupero dalla carlinga schiantata nella neve da parte di popolazioni
native - fatti non documentabili tenuti volutamente nel mistero
dallo sciamano - così spesso verrà definito per
l'intensità mistico-materialista delle sue azioni artistiche
- Beuys.
Alighiero Boetti il grande artista italiano che conosceva ed
apprezzava l'opera di Beuys in modo beffardo e ironico si auto-definì
“Shaman-showman”, per sottolineare causticamente
il fatto che ogni artista nel circuito moderno dell'arte cerca
di presentarsi come una sorta di “sciamano” ma viene
costretto, per esistere, a divenire di fatto uno 'showman',
qualcuno che vende molto bene se stesso attraverso le proprie
opere. E retrospettivamente questa definizione si attaglia perfettamente
al nostro Joseph Beuys.
Franco Bunuga
Ana Mladic/
Una storia dentro la Storia
Un equilibrio sospeso tra storia reale e immaginaria realtà.
 Il
ritratto di una famiglia-tipo unita e quasi felice, padre, madre,
figlio e figlia. Il
ritratto di una famiglia-tipo unita e quasi felice, padre, madre,
figlio e figlia.
Quadri di vite apparentemente normali.
E sullo sfondo rumore che cresce come un temporale, all'inizio
percepisci avvisaglie lontane, poi ti ritrovi dentro il vortice
di una delle peggiori tragedie dei nostri tempi – perché
sono nostri più di altri, geograficamente e cronologicamente,
i tempi dell'ultima guerra nei Balcani.
Al di là delle etichette mediatico-erudite (qualcuno
l'ha definita “degna erede di Cechov”), la scrittrice
catalana Clara Usón ci regala un romanzo tragico e bellissimo
che ricorda davvero certi grandi romanzi e soprattutto certi
grandi romanzieri del passato (Clara Usòn, La figlia,
Sellerio, Palermo, 2013, pp. 496, € 16,00).
La genesi parte da un articolo di giornale che l'autrice legge
e che la colpisce come una pallottola, una tragedia dentro la
tragedia, che le guerre poi di questo son fatte, sostanza umana
che si dissolve.
La Usón viene così a conoscenza della storia di
Ana Mladic, figlia del generale Ratko, suicida a ventitré
anni. Si documenta a lungo, setaccia le fonti, cerca, ipotizza,
verifica e ricostruisce.
Il suo lavoro di inchiesta sulle disgrazie di un piccolo nucleo
familiare e su quelle della grande, multietnica e multireligiosa
famiglia orfana del generale Tito, produce il racconto degli
ultimi mesi di vista di Ana, bella, intelligente, promettente
studentessa di medicina.
Il racconto inizia con la breve trasferta a Mosca di Ana e di
alcuni suoi compagni di università: giornate qualunque,
uscite, bevute, la discoteca, discussioni con punti di vista
diversi, come succede.
Parole, frasi, mozziconi di discorsi e poi un incontro che evolve
dal romantico al drammatico, fanno sì che al ritorno
dal viaggio Ana non sia più la stessa.
Silenzi pianti e tristezza cominciano ad abitarla, si fa strada
in lei la lacerazione tra la volontà di riavere la vita
(la fiducia) precedente e la consapevolezza che questo non sarà
più possibile, non per lei soltanto, ma per un intero
paese.
Questa dolorosa certezza finirà per disintegrare il suo
mondo interiore - a quello esteriore ci stanno pensando con
efficacia le bombe di suo padre. Fino al gesto estremo celebrato
con l'arma di Ratko, quella stessa vecchia zastava che avrebbe
dovuto sparare prima o dopo per celebrare l'arrivo di una nuova
vita, così aveva promesso Ana a suo padre, al nonno dei
suoi futuri figli. Uccidendosi con quella pistola, Ana lascia
un messaggio al padre: il rifiuto di mettere al mondo i nipoti
di un assassino.
Sconvolto dal suicidio della sua adorata figlia, nel luglio
del 1995 Mladic compirà il massacro di Srebrenica.
La storia privata e la storia collettiva non smettono di intrecciarsi,
tragicamente.
Sul conflitto nei Balcani si è dibattuto a lungo, tuttavia
molti aspetti non sono stati mai chiariti e chissà se
mai lo saranno; in primis il ruolo o non-ruolo dell'occidente.
Sia quel che sia – la ricostruzione storica di un evento
del genere è materia complessa – resta il fatto
che quella guerra, come ogni guerra e ancor più ogni
guerra civile, non fu esattamente una passeggiata né
un pranzo di gala. Fu una guerra di privazioni sangue sofferenza
massacri e atrocità, che colpì l'opinione pubblica
nostrana soprattutto per il fatto che i protagonisti avevano
più o meno pacificamente convissuto per molti decenni.
La posizione della Usón riguardo ai fatti storici è
esplicita e coincide con la versione più accreditata
della storia, quella che ha decretato la colpevolezza e stabilito
la condanna di Milosevic, Karadži, Mladic e dei loro portaborse
e seguaci. Per raccontarla, l'autrice usa l'espediente di un
narratore “straniero”, Danilo Papo, di origine ebrea,
il ragazzo dai capelli rossi che non fa colpo sulle ragazze
e non riesce a conquistare il cuore della bella patriota Ana;
in tutta questa vicenda la sua è l'unica voce possibile
perché fuori dal coro, più oggettiva in quanto
voce di “ostali”, di straniero. Ana, un pomeriggio
dei primi anni Novanta, chiedendogli spiegazioni circa la sua
identità, si sente rispondere: non sono nè serbo
né croato, né ebreo né musulmano. Sono
straniero. E lo straniero è sempre uno che non c'entra,
anche se si ferma per tanto tempo, perché all'invitato
non si chiede certo di baciare la bandiera.
Ai mattatori della guerra nei balcani Danilo dedica una breve
e magistrale descrizione della storia personale, dell'ascesa
al potere, un ritratto inedito insolito e intriso di sfumature
ironiche (ironia a tinte fosche, non potrebbe essere altrimenti).
A lui tocca il compito dell'autrice, l'inchiesta, la ricostruzione
storica, la descrizione narrata di quel che noi in quegli anni
vedevamo in TV o leggevamo sui giornali, spettatori distratti
della sanguinosa disgregazione di un bel pezzo di continente.
Il resto spetta ad Ana: perché di questo romanzo più
che la guerra, la storia o il giudizio su entrambe, colpisce
il taglio, il cui cuore è il rapporto tra la ragazza
e suo padre. Senza scomodare gli psicanalisti, la lenta dissolvenza
di questo rapporto diventa la dissolvenza di un paese, viaggia
in parallelo a quel che stava insieme da decenni e poi in un
amen non stava insieme più.
Ratko – che bucava i nostri schermi col suo sguardo di
ghiaccio ed il collo taurino – è un padre affettuoso,
orgoglioso di quella figlia con un brillante futuro di medico
davanti a sé; tanto fiero da chiamarla “figliolo”,
come a sottolineare che la stima è la stessa che si potrebbe
riservare ad un maschio. Al confronto di Ana, il fratello appare
figura sbiadita, così come la madre. D'altronde, anche
questo può accadere in una famiglia-tipo... Ana contraccambia
l'affetto paterno con una devozione pressochè assoluta;
del padre ha assorbito gli ideali, il carattere determinato
e una buona dose di innegabile talento.
La scoperta del doppio Ratko non è drammatica, non avviene
di punto in bianco; piuttosto è crudele, perché
succede a tappe, è un continuo sentire, tornare indietro,
ricredersi, rimuginare, scoprire un altro pezzo; fino alla conferma
finale che Ana trova nei diari del padre, annotazioni di pugno
che non lasciano più spazio all'uomo che lei adora.
Il padre che la coccolava è lo stesso uomo che ha mandato
a morire al fronte i suoi pretendenti. L'eroe buono della sua
infanzia è lo stesso eroe dei serbi: il boia di Srebenica.
E il padre che piange disperato sulla sua bara è lo stesso
che osserva soddisfatto la fine di Sarajevo.
Se è vero che nessuno può scegliersi i genitori,
il paese o il tempo in cui vive, è altrettanto vero che
ciascuno può scegliersi il destino che ne deriva.
Con il suo gesto definitivo la bella, intelligente, promettente
studentessa di medicina Ana Mladic non cambierà il corso
degli eventi, non salverà il suo paese e non redimerà
suo padre (che anzi poco dopo, come abbiamo detto, compirà
il massacro di Srebrenica); ma restituirà un po' di dignità
a una storia altrimenti troppo disumana per essere anche solo
raccontata.
Claudia Ceretto
Bakunin/
Uno di noi
 È
mio convincimento, che ogni biografia non possa che essere,
in qualche misura, un'autobiografia. Chi affronta l'esperienza
di ricostruire le vicende, le passioni, il pensiero, di un altro
uomo o di un'altra donna, a meno che non sia un mercenario o
un accademico - ché lo scrivere per la carriera sovente
non è poi troppo diverso dallo scrivere per una mercede
- in realtà vive un dialogo e un incontro. Ciò
vale a maggior ragione se il protagonista della biografia, chiamarlo
oggetto mi sembra molto riduttivo, è personaggio sulfureo,
contradditorio, tellurico quale fu Michail Aleksandrovic Bakunin. È
mio convincimento, che ogni biografia non possa che essere,
in qualche misura, un'autobiografia. Chi affronta l'esperienza
di ricostruire le vicende, le passioni, il pensiero, di un altro
uomo o di un'altra donna, a meno che non sia un mercenario o
un accademico - ché lo scrivere per la carriera sovente
non è poi troppo diverso dallo scrivere per una mercede
- in realtà vive un dialogo e un incontro. Ciò
vale a maggior ragione se il protagonista della biografia, chiamarlo
oggetto mi sembra molto riduttivo, è personaggio sulfureo,
contradditorio, tellurico quale fu Michail Aleksandrovic Bakunin.
Ed è proprio questa, a mio avviso, la caratteristica
più evidente della biografia che Alessio Lega gli ha
dedicato, Bakunin, Il demone della rivolta edita da Elèuthera
nel novembre 2015 (Milano, pp. 192, € 14,00). Lo dichiara
peraltro apertamente quando scrive che conobbe Bakunin leggendo
il famoso o, se vogliamo, famigerato romanzo di Riccardo Bacchelli
Il diavolo a Pontelungo e afferma “ho sempre pensato
che il personaggio gli abbia preso la mano, e io finii per innamorarmi
di quel “Michele” (scritto all'italiana, alla moda
di quei tempi) Bakunin lì, e cominciai a cercarlo anche
altrove, prima nei libri, poi nella realtà. Fu lì
che mi dissi la prima volta: forse sono anarchico, a andai fuori
a cercarmi i compagni”.
Chi è, dunque, il Michail Aleksandrovic Bakunin di Alessio
Lega? lo cito ancora una volta. “Ciò che fa di
Bakunin 'Bakunin' è la fantasia e l'amore, l'ottimismo
e la radicalità, l'arte della rivolta e la vita dei sogni.
Sono caratteri da personaggio letterario, ma era quella un'epoca
nella quale la letteratura abitava per strada. Di quell'epoca,
alcuni ne sono stati i filosofi e i pensatori (Marx, Proudhon),
altri gli scrittori e i poeti (Herzen, Tolstoj, Vallès),
altri i rivoluzionari e i profeti (Mazzini, Garibaldi, Pisacane,
Orsini).
Uno – a mio avviso – è invece la sintesi
caotica di tutte le ragioni, i sentimenti e le azioni dell'epoca,
della sfida lanciata a Dio e allo Stato: Michail Aleksandrovic
Bakunin, il diavolo che si era incarnato nelle speranze e nelle
paure di chi voleva o temeva le rivoluzioni, il demone che si
è fatto di inchiostro nella letteratura: Rudin
di Turghenev (1857), I Demoni di Dostoevskij (1871),
Il Diavolo a Pontelungo di Bacchelli (1927), La sponda
dell'Utopia di Stoppard (1992).”
Bellissima, a mio parere, la frase “quella un'epoca nella
quale la letteratura abitava per strada”, la chiave, credo,
dell'incontro fra l'autore della biografia e il personaggio
del quale si occupa, la caratteristica che ne fa un lavoro,
per molti versi, originale.
Un libro, almeno per quanto mi riguarda, ha preparato la strada
al testo di Alessio Lega e si tratta della pubblicazione nel
2002, da parte di Zero in Condotta, dell'opera di Arthur Lehning
Bakunin e gli altri - Ritratti contemporanei di un rivoluzionario,
una straordinaria raccolta di testimonianze, fra le altre quelle
di Aleksandr Herzen, Vissarion Belinskij, Ivan Turgenev, Friedrich
Engels, Arnold Ruge, Wilhem Weitling, Georg Herwegh, George
Sand, Richard Wagner, Pierre-Joseph Proudhon, Jules Michelet,
Karl Marx, Albert Richard, James Guillaume, Errico Malatesta,
Elisée Reclus, Petr Kropotkin.
Una raccolta che rende l'immagine di un uomo di straordinaria
vitalità e complessità, di un uomo che aveva colpito
profondamente chi aveva avuto la sorte di conoscerlo e di frequentarlo
qualsivoglia fosse il giudizio che ne ha dato. Un libro che,
sempre a mio avviso, dimostra che è stato proprio Bakunin
a costruire, certo non per narcisismo, al contrario, l'immagine
di lui che ci è stata tramandata.
Un Bakunin romanzato dunque quello di Alessio Lega? Al contrario,
siamo di fronte ad una ricostruzione puntuale, fondata su documenti
e sulla loro intepretazione ma certo un Bakunin a tutto tondo.
È vero che quella di Alessio Lega non è un'agiografia
di Bakunin, nè si colloca nella stantia polemica fra
lui e la coppia Marx-Engels che pure è puntualmente ricostruita,
è, al contario, l'individuazione di alcuni passaggi essenziali
della vita di Bakunin, la giovinezza e la prima formazione,
il ciclo rivoluzionario 1848/49 il carcere e l'esilio, la fuga
e il ritorno in campo, il rapporto con la prima internazionale,
i tentativi insurrezionali, il vissuto e la complessa relazione,
per fare il caso più importante con Cafiero. E nel ricostruire
questi momenti, il Bakunin che ci viene consegnato appare nei
momenti di debolezza, di difficoltà, di contraddizione.
Il libro non nasconde il carattere “scandaloso”
del suo rapporto con il denaro, scroccato e dilapidato con la
medesima generosità, la caduta in stereotipi non gustificabili
quali l'uso di luoghi comuni antisemiti, l'incredibile ingenuità,
per non dire di peggio, che manifesta nella relazione Sergej
Gennadievič Nečaev, relazione che tanto ha contribuito a gettare
discedito su di lui.
Basta pensare a quanto scrisse di lui a James Guillaume, che
di Nečaev, aveva un giudizio ben diverso come peratro lo aveva
Aleksandr Herzen, il 13 aprile 1869 “uno di quei giovani
fanatici che non conoscono dubbi, che nulla temono e che hanno
deciso in modo assoluto che molti, moltissimi di loro dovranno
perire sotto i colpi dei governi, ma che non per questo si fermeranno,
sino a quando il popolo russo insorgerà. Sono magnifici
questi giovani fanatici, credenti senza dio, eroi senza frasi”.
Il libro, peraltro, non evita di trattare ampiamente di un altro
degli aspetti “oscuri” della vita di Bakunin, il
rapporto con a moglie che tanto fu invisa a molti compagni del
tempo e che invece Alessio ritiene, e su questo giudizio concordo
pienamente, piuttosto vittima che colpevole di una situazione
certo non ortodossa secondo la morale del tempo.
Un libro insomma godibilissimo dal punto di vista letterario,
che non arretra di fronte alle contraddizioni, che ricostruisce
una vita straordinaria e una passione inesausta per la rivoluzione
e che, proprio non evitando le questioni problematiche, ci consegna
un Bakunin che, proprio per questo motivo, sentiamo ancora di
più “uno d noi”.
Cosimo Scarinzi
La Banda dello Zoppo/
Storia di un maquis toscano
 La
Banda dello Zoppo (“Storie di resistenza armata al
fascismo”, di Angelo Pagliaro, Marco Capecchi e Fabrizio
Poggi, Coessenza Editrice, Cosenza, 2015, pp. 225, € 12,00)
è la naturale prosecuzione del primo libro, edito sempre
da Coessenza nel 2012, dal titolo La famiglia Scarselli.
Volti, idee, storie e documenti di una famiglia anarchica temuta
da tre dittature. Nella prefazione a quel libro Pietro Ferrua,
uno dei massimi studiosi dell'anarchismo, mi invitava a “redigere
un secondo volume corredato da documenti processuali per chiarire
le “ragioni futili” della baruffa, gli atti del
tribunale che giudicò la “Banda dello zoppo”
e altri aspetti politici e anche letterari, come il ritratto
steso dal noto anarco-sovietico Sandomirski cui si fa allusione
e che meriterebbero di essere approfondito”. La
Banda dello Zoppo (“Storie di resistenza armata al
fascismo”, di Angelo Pagliaro, Marco Capecchi e Fabrizio
Poggi, Coessenza Editrice, Cosenza, 2015, pp. 225, € 12,00)
è la naturale prosecuzione del primo libro, edito sempre
da Coessenza nel 2012, dal titolo La famiglia Scarselli.
Volti, idee, storie e documenti di una famiglia anarchica temuta
da tre dittature. Nella prefazione a quel libro Pietro Ferrua,
uno dei massimi studiosi dell'anarchismo, mi invitava a “redigere
un secondo volume corredato da documenti processuali per chiarire
le “ragioni futili” della baruffa, gli atti del
tribunale che giudicò la “Banda dello zoppo”
e altri aspetti politici e anche letterari, come il ritratto
steso dal noto anarco-sovietico Sandomirski cui si fa allusione
e che meriterebbero di essere approfondito”.
Per soddisfare tale richiesta e portare avanti un lavoro di
ricostruzione storica così impegnativo c'è bisogno
di un livello di conoscenze e competenze in vari settori molto
elevato, che difficilmente sono possedute da una sola persona.
Se si è convinti di ciò, e consapevoli dei propri
limiti, non resta altro che cercare dei “complici”.
Il caso ha voluto che tra i tanti lettori del libro sulla Famiglia
Scarselli ci fossero i coautori di questo volume, Marco Capecchi
e Fabrizio Poggi, ambedue originari di Certaldo e profondi conoscitori
della storia del fascismo e dell'antifascismo toscano, nella
quale si rispecchia una parte significativa delle loro storie
familiari.
Abbiamo descritto le violenze delle squadre fasciste e i tragici
scontri tra questi e gli antifascisti del febbraio-marzo 1921
in Toscana, compresi gli omicidi di Spartaco Lavagnini e Gino
Mugnai, i fatti della fiera di Certaldo e quelli di Empoli.
In seguito abbiamo ricostruito, grazie ad un manoscritto di
Tito Scarselli pubblicato in URSS nel 1931, dal titolo “Negli
artigli del fascismo” ritrovato nel 2011 presso la biblioteca
di San Pietroburgo, le vicende della Banda dello Zoppo, gruppo
partigiano comunista-anarchico capeggiato dall'anarchico Oscar
Scarselli, datosi alla macchia all'indomani dei “fatti
della fiera”. Nei cinque mesi in cui questo maquis, che
anticipò la formazione degli arditi del popolo e delle
brigate partigiane, imperversò nelle boscaglie di ben
tre province della Toscana, aiutato, sostenuto e protetto da
decine e decine di famiglie contadine mise a segno varie azioni:
espropri presso le fattorie dei grandi proprietari, tentativi
di rapina, scontri con carabinieri e polizia. Ma il 25 giugno
1921, sulla strada che porta da Montaione a San Vivaldo, si
verificò un fatto che cambiò definitivamente la
storia del gruppo partigiano: nel corso di uno scontro armato
venne ucciso l'ingegnere fascista Mario Filippi. A seguito di
un'analisi della situazione politica e militare creatasi, la
banda dello zoppo decise di sciogliersi e di disperdersi cercando,
in tutti i modi possibili, di espatriare clandestinamente.
Nel libro si raccontano le vicende processuali, politiche e
umane dei singoli resistenti, si analizza il ruolo giocato dalla
stampa dell'epoca, tra informazione e disinformazione, ed il
rapporto città - campagna negli anni '20 in Toscana.
In appendice si pubblicano numerosi documenti e foto inedite,
frutto di ricerche durate un decennio, tra cui quella dei due
fratelli Oscar e Tito Scarselli spedita dall'URSS negli anni
'30 ed una che ritrae, ormai anziani, Ida, Ines Leda ed Egisto
unici sopravvissuti di questa martirizzata famiglia anarchica.
Angelo Pagliaro
angelopagliaro@hotmail.com
“Uomini ignudi”/
Alle radici del pregiudizio e della passività
Re – Provate a guardarli... avete visto che faccia
hanno? Avete mai visto uno di loro che vi sorride? Li avete
sentiti come parlano?
Narratore – Quell'ometto dai corti baffetti neri riteneva
che fossero nemici da combattere quelle persone che avevano
un aspetto diverso dal suo che parlavano una lingua che non
comprendeva.
Con queste parole si apre il testo Uomini ignudi. Bella
(e carsica) la storia di questo spettacolo.
La prima teatrale si è svolta nel novembre 2009, ancora
in fase di completamento, sul vagone Agorà di un treno
per Auschwitz. Due le performance: per gli studenti in visita
al lager di sterminio, la seconda per partigiani, ex deportati,
alcuni sinti e rom, associazioni, gente comune anche loro in
viaggio. In seguito, una decina le rappresentazioni in scuole
e in altri contesti, con due diverse compagnie e regie, nelle
provincie di Brescia e Bergamo.
Il testo della performance, scritto dalla nostra collaboratrice
Claudia Piccinelli, è giunto alla sua terza regia, quella
di Riccardo Colombini.
Ho assistito, lo scorso 25 gennaio, al teatro Lirico di Magenta
(Milano), alla rappresentazione riservata ad alcune centinaia
di studenti delle scuole superiori. Anche la replica serale
aperta a tutti ha registrato un bel pienone.
L'argomento dello spettacolo è principalmente il Porrajmos,
lo sterminio, lucidamente concepito e tragicamente realizzato
dai nazisti, di circa mezzo milione di Rom e Sinti. Ma non solo:
attenzione è dedicata anche agli handicappati psichici,
agli omosessuali, agli ebrei. Gli stermini nazisti sono stati
numerosi, “solo” due quelli contro popoli in quanto
tali (ebrei e zingari). Anche i malati psichiatrici (i primi
ad essere sterminati con il gas), i Testimoni di Geova, gli
oppositori politici, i prigionieri di guerra, gli omosessuali,
le donne “devianti e prostitute, le e gli “asociali”
e altri ancora hanno avuto modo di passare per il camino.
Il Porrajmos: lo sterminio dei Rom e dei Sinti. Un tema di cui
più volte si è parlato su questa rivista, che
nel 2006 ha anche realizzato un doppio Dvd + libretto (”A
forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli Zingari”)
divenuto poi un punto di riferimento e anche un materiale didattico
presente in un numero crescente di scuole italiane. Oltre ad
essere al primo posto nella bibliografia di riferimento per
la stesura del testo di Uomini ignudi.
Lo spettacolo, nella sua nuova regia, mi è parso un po'
sopra le righe, troppo gridato. Non facile da comprendere in
tutti i suoi passaggi, forse anche per qualche problema di acustica,
ma soprattutto per la forte caratterizzazione dell'uomo dai
corti baffetti (Hitler), da parte dell'attore che lo impersonava.
Anche l'uso dei dialetti, a tratti, non ha favorito la comprensione
del testo così denso, preciso. Nitida, intrigante, equilibrata
la recitazione delle due attrici-cantanti. Davvero notevoli
le musiche scritte appositamente da Eugenia Canale e sovrapposte
alle parole, come a sostenerle e a farle meglio entrare in circolo.
Leggendo il copione, mi sono ulteriormente convinto che simili
testi necessitino di un ascolto “pulito”, asciutto,
essenziale. La recitazione non dovrebbe, a mio avviso, rendere
meno comprensibile il testo: dovrebbe fermarsi sulla soglia,
senza strafare.
|
| Magenta (Mi), Teatro Lirico, 25 gennaio 2016.
Spettacolo “Uomini Ignudi”
Da sinistra: Vaninka Riccardi, Matteo Curatella,
Sara Cicenìa, Roberta Villa (attori), Eugenia
Canale.
(Riprese video: Sergio D'Antoni,
estrazione fotogramma: Elisabetta
Bozzi) |
Il lavoro di ricerca e ricostruzione storica e poi l'intelligente
scelta dei temi da trattare, operata da Claudia Piccinelli –
che della memoria delle persecuzioni naziste si è occupata
anche in altri contesti – sono l'elemento di massimo pregio
dell'intera operazione culturale. Il tutto, in una visione storica
che si incrocia con la sua sensibilità personale e sociale.
“Si tratta” – afferma l'autrice – “di
un testo teatrale corale, costruito con fedeltà ai documenti,
ordinanze, circolari ministeriali, testimonianze ai processi.
Ho voluto indagare il rapporto vittima-carnefice, la criminalizzazione
della vittima, il conformismo alla base dei genocidi. Favorire
il coinvolgimento emotivo del pubblico, soprattutto delle giovani
generazioni”.
|
|
Eugenia Canale, pianista
(composizione musiche e loro
esecuzione in scena).
(Foto: Oliviero Trezzi) |
Emerge un messaggio sottotraccia, modesto, non invasivo, che
dallo sterminio di questi popoli nomadi si dilata fino a comprendere
il nocciolo duro dell' esistenza. Coinvolge le nostre singole
esistenze e quelle collettive di cui ci troviamo ad esserne
parte.
Mi riferisco alla responsabilità, innanzitutto quella
individuale. Le nostre responsabilità nella società
e, più precisamente, di fronte al male e alla concreta
esistenza di quanti ne sono vittime. Magari proprio da parte
di quelle strutture e persone che si identificano con lo Stato.
Mi viene in mente quella ricerca sociologica effettuata nell'immediato
dopoguerra negli Stati Uniti da alcuni scienziati sociali (tra
i quali Theodor Adorno), i quali nell'analizzare il fenomeno
dell'antisemitismo (quando i forni dei lager avevano smesso
da poco di funzionare) giunsero alla conclusione che a monte
si trattava di identificare e analizzare la personalità
autoritaria e tale fu il titolo scelto per il libro che raccolse
i dati e le interpretazione del loro lavoro.
E non è un caso che Claudia Piccinelli faccia riferimento
a un esperimento compiuto da uno psicologo sperimentale, Stanley
Millgram, per studiare la genesi dell'obbedienza e del conformismo.
Il suo studio mise in luce che le persone da sole o in gruppo
possono dare attuazione a varie forme di distruttività
e di male. Con o senza la consapevolezza di farlo.
Di questo denso retroterra culturale dell'autrice non si ha
alcun pedante riscontro nella performance. Studi e riflessioni
che però innervano l'intero discorso, al punto che la
apparente frammentarietà tematica che ci si para davanti
agli occhi nell'oretta di durata di Uomini ignudi si
ricompone come un lucido percorso, unico e chiarissimo, che
ha nell'appello corale finale “tu puoi fare” la
logica conclusione e il massimo punto etico. Un radicale contrasto
con lo svuotamento di responsabilità per i carnefici
e di perdizione di se stessi per le vittime, che sono stati
il segno della Shoah, del Porrajmos e di tutti gli stermini
del nazi-fascismo. E non solo di quelli.
Come di tutti gli altri genocidi di massa.
Come – se si va a ben guardare – di tutte le politiche
aggressive degli stati e dei loro epigoni.
Paolo Finzi
|
|
Un momento dello spettacolo (Foto: Marco Cavallarin) |
Lo spettacolo è stato realizzato nell'ambito del
progetto europeo Memoir. Evento locale promosso da Opera nomadi
Lombardia e Anpi Magenta.
Per contatti: www.claudiapiccinelli.it
- Su questo sito è consultabile un estratto del testo
Uomini ignudi.
|