
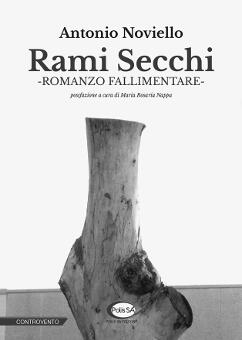 Lavoro/
Meridione, multinazionali e profittoUn libro scritto con tutto il veleno che si può accumulare
dentro per l'ingiustizia subita, ma soprattutto un lavoro redatto
con la consapevolezza (e la lucidità) di voler raccontare
il calvario vissuto in prima persona in una di quelle imprese
del Meridione che negli ultimi anni sono state dismesse, sacrificate
sull'altare di un mercato che come orizzonte (unico) ha la massimizzazione
del profitto.
A narrare la grigia storia della Multinazionale di Battipaglia
nelle pagine Rami secchi (Polis Sa edizioni, Nocera Superiore
- Sa, 2016, pp. 253, € 16,00) è Antonio Noviello,
informatico di Cava dè Tirreni con un'alta specializzazione
in programmi e sistemi di rete. Dopo aver lavorato in varie
parti d'Italia per altre aziende, agli inizi degli anni duemila
Noviello inizia a lavorare con un contratto a tempo indeterminato
alla Multinazionale nel reparto di ricerca e sviluppo. Ma per
lui e i suoi colleghi tecnici il destino è segnato alla
stregua di quello dei compagni della fabbrica annessa allo stabilimento.
Le pagine di Noviello sono dure, la sconfitta che subiscono
le alte e basse maestranze va ben oltre il recinto, i capannoni
e gli uffici della Multinazionale. Quei licenziamenti, quelle
vite (e famiglie) mandate al macero, derubate della propria
dignità in nome di un capitalismo senza scrupoli, vigliacco,
usurpatore sono la testimonianza di una sconfitta per un'intera
generazione e un territorio, quello del salernitano, già
ferito e martoriato.
Il racconto in forma di cronistoria fa altresì da specchio
tanto all'assenza di un blocco sociale di classe quanto alla
debolezza delle istituzioni, della politica, dei sindacati di
fronte alle logiche del management e della finanza; tuttavia,
come scrive nella postfazione Maria Rosaria Nappa, “Rami
secchi non vuole essere un libro semplicemente da leggere,
ma è un'opera di cui parlare. Non importa che il lettore
abbia egli stesso affinità con questi temi, non si deve
essere necessariamente stritolati dal finanzcapitalismo per
sentirne la inevitabile invadente penetrazione in ogni ambito
del quotidiano di ciascuno”.
Mimmo Mastrangelo
Psichiatria/
Franco Rotelli e la chiusura dei manicomi
Parliamo del libro di Franco Rotelli: L'istituzione inventata/Almanacco Trieste 1971-2010 (Alpha Beta Verlag, Merano - Bz, 2016, pp. 328, € 24,00).
Chi è Franco Rotelli, innanzitutto? A Trieste, dal 1971 al 1980, con Franco Basaglia è stato complice di quest'impresa (unica al mondo) di deflagrare un manicomio. Sembrava impossibile, vent'anni prima, 1961, quando Basaglia accettò di dirigere il manicomio di Gorizia, e appena entrato sentì l'odore di urina e di merda che sempre insolentiva i manicomi; sembrava impossibile che un manicomio, e poi tutti i manicomi di un paese, potessero essere messi fuori legge, fuori dalla storia. Eppure questo a Trieste è stato fatto. È stata una grande scuola di libertà: prendere un manicomio, una istituzione totale, e farla diventare niente, svuotarla, annientarla.
La prima volta che ho sentito parlare di Franco Rotelli avevo superato la trentina, mi ero specializzato da pochi mesi e avevo vinto un concorso per esercitare il mestiere di psichiatra a Pordenone. Era il 2002 e i pordenonesi parlavano di Rotelli con un estremo timore, ricordo un'infermiera che lavorava nella mia equipe, e che sul finire degli anni Åe70 evidentemente era accorsa con centinaia di altri volontari a Trieste, che mi racconta di una discussione, a dir poco animata, tra Rotelli e Basaglia, durante la quale Rotelli gli dice: Taci tu, che hai ancora un manicomio da chiudere! Così. Rotelli che dice a Basaglia taci!, e lo rimprovera di non essersi liberato ancora del manicomio di cui è direttore. Di non averlo ancora liberato. Di non averlo ancora distrutto. Abolito. Chiuso.
A me questa frase mi è spesso tornata in mente, ogni volta che risentivo il nome di Rotelli ripensavo a colui che zittiva Basaglia. Che gli metteva pressione. Voglio dire: noi che negli anni 70 non eravamo lì, a Trieste, dove si svolgeva l'eutanasia di un manicomio, ci immaginiamo un Basaglia come massima espressione del radicalismo anti-istituzionale, come colui che aveva trascinato nella sua impresa titanica un manipolo di tecnici radicali, però tutti meno radicali di lui; invece no, a quanto pare, c'era qualcuno più deciso, più radicale di lui. Erano due secoli, dall'invenzione del manicomio a opera del francese Pinel che si attendeva il killer, colui che avrebbe soppresso e seppellito questa istituzione totale che non aveva avuto mai niente di terapeutico, e siamo negli anni in cui l'obiettivo sta per essere conseguito, e Basaglia il killer viene rimproverato di essere attendista, di tentennare, di tergiversare.
Ancora oggi Trieste è un'isola
Ho sentito una volta dire a Rotelli: Fate ciò che
dite e dite ciò che fate.
Se racconti ciò che fai, non ti puoi più tirare
indietro. A Trieste scrissero la nota frase La libertà
è terapeutica sui muri del manicomio, ma lo scrissero
quando il manicomio era ancora vivo, e sembrava una contraddizione,
un ossimoro, ma era un modo per obbligarsi a essere coerenti.
A eliminarlo davvero quel manicomio. Perché se scrivi
ciò che dici poi non puoi tornare indietro.
Devo ai libri di Basaglia, e dopo a chi ne ha continuato il
lavoro, a Franco Rotelli e Peppe Dell'Acqua, se ho compreso
che questo mestiere lo puoi fare se oltre a essere un liberatore,
un inventore di nuove pratiche, riesci a farti anche
narratore di ciò che fai. Di qui la mia decisione
di farmi infiltrato, delatore, narratore dei moderni crimini
di pace di questa psichiatria che sembra tornare al manicomio,
perché troppo ne è affascinata. Perché
è un'attrazione fatale quella della psichiatria col manicomio.
Un patto di sangue. Stesso anno di nascita, 1793. Pochi anni
dopo la rivoluzione francese, il medico Pinel stacca il manicomio
dal carcere, separa i folli dai delinquenti e segna l'atto di
nascita della psichiatria, la cui cura si deve svolgere nel
manicomio. E però sempre là ritorna, la psichiatria.
È davvero l'eterno ritorno della psichiatria nel manicomio.
Ma come è stato affondato, il grande manicomio (i piccoli
manicomi purtroppo li abbiamo ancora) ce lo racconta proprio
L'istituzione inventata. Questo libro.
Cosa possiamo scrivere nel piccolo libro? Basaglia, in
un'intervista, si domandava quale simbolo mostrare a tutti quelli
che andavano a Trieste per vedere “come funziona”
la salute mentale. Cosa potremmo scrivere nel nostro piccolo
libro, quali sono le idee che potremmo stringere, racchiudere,
in poche pagine.
Perché, scrive Pier Aldo Rovatti nel suo Restituire
la soggettività, edito sempre dalle edizioni Alpha
Beta Verlag, se questo piccolo libro non viene scritto, rimane
da dire solo “venite a vedere Trieste”. Infatti
da tutto il mondo moltissime persone, migliaia di operatori,
in questi decenni, sono andate a Trieste per vedere come si
è sviluppato il pensiero pratico di Basaglia e dei suoi
continuatori. Ancora oggi Trieste è un'isola, forse l'unico
luogo dove la legge 180 si è realizzata in pieno. Perché?
Perché la 180 era la fotografia di ciò che a Trieste
già si faceva. Mentre proseguiva la negazione del manicomio,
l'invenzione dell'istituzione era già cominciata a Trieste;
i Centri di Salute Mentale che si sostituivano ai Centri di
Igiene Mentale (la salute che si sostituisce all'igiene) erano
già attivi a Trieste alcuni anni prima della 180.
Sempre Basaglia, in una delle sue conferenze brasiliane, quando
gli si chiede di teorizzare, propone invece una storia
della psichiatria, perché rifugge la teoria? Perché,
ribadisce, la psichiatria è sempre storia di psichiatri
e delle loro definizioni diagnostiche, mai di psichiatrizzati.
A me pare che questo libro non sia il piccolo libro teorico
a sostegno e spiegazione della sua pratica che Basaglia esitava
a scrivere e che, apposta, non scrisse mai, ma sia il grande
libro, dove si fa la cronistoria, passando dagli anni 70 dove
è stato necessario negare l'istituzione manicomiale,
agli anni 80 e 90 quando è stato necessario inventare
altre istituzioni, non per il controllo ma per essere liberi
essendo curati (e dunque per realizzare quella frase scritta
sul muro: la libertà è terapeutica, per
far sì che non fosse solo uno slogan).
Gorizia è stata molto narrata, dal di dentro, mentre
si cambiava il manicomio; quegli psichiatri s'inventarono tecnici
e narratori, abbiamo detto, e pubblicarono, negli anni 60 Cos'è
la psichiatria?, e dopo, soprattutto, L'istituzione negata,
il libro best seller. Con Trieste non c'è stato
forse tempo o bisogno di qualcosa di equivalente, troppa l'urgenza
di dar luogo all'eutanasia di un manicomio.
Per cui a me pare proprio questo il libro della cronistoria
di ciò che si è fatto a Trieste, sia negli anni
di manicomio (71-78), sia nei successivi decenni di non manicomio
(fino al 2010), ma di servizi, unici nel mondo, dove non solo
il manicomio, ma pure la più sottile manicomialità
è stata bandita (non li troviamo a Trieste i SPDC bunker,
le case di cura cronicari, i CSM che chiudono alle 20 e il fine
settimana, le fasce, eccetera).
È arduo scegliere le parti di questo grande libro che
più mi hanno colpito. È un libro collettivo, non
vi sono solo scritti di Rotelli, ci sono contributi di Franco
Basaglia, Peppe Dell'Acqua, Franca Ongaro, Antonin Artaud, eccetera.
All'inizio del libro si contrappongono due foto, una rappresenta
il passato, c'è il direttore del manicomio triestino,
negli anni '50, con le infermiere (gli internati non esistono
– la psichiatria è storia di psichiatri e loro
definizioni, gli psichiatrizzati non compaiono mai), l'altra
racconta il manicomio che viene lasciato alle spalle: c'è
il direttore dell'anti-carriera, senza camice, fuori dal manicomio,
con una specie di sahariana indosso, dietro di lui gli internati
contenti, e dietro ancora un aereo, con cui sorvoleranno la
città.
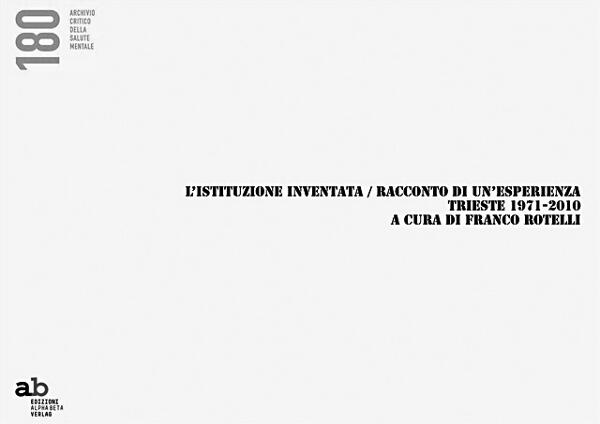
Il buon manicomio è quello vuoto
Rotelli racconta cos'è questa Istituzione inventata, e perché è stato necessario inventarla. Racconta cos'è la deistituzionalizzazione vera, e cosa è quella falsa, che tenta solo di cambiare i luoghi, i look, semplicemente trasportando la manicomialità da una istituzione più grande (e più vecchia), a una più piccola (e più nuova): dai 100 manicomi ai 320 SPDC, per esempio, o dai 6 OPG alle 30 REMS, per esempio. E ci racconta il perché è necessario, oggi, inventare nuove istituzioni. E perché è stato necessario, dalla negazione del manicomio, erigere i Centri di Salute Mentale, luoghi non chiusi e non ostaggio delle psichiatrie, ma fatti di attraversamenti: artisti, uomini di cultura, giornalisti, poeti, pittori, registi, giovani, feste, lavoro, gioco, incontri. E ancora, a chi adopera il nonsenso di sostenere che “il buon sevizio è quello vuoto” Rotelli ribatte: il buon manicomio è quello vuoto, il buon servizio (territoriale) è pieno, come un mercato, è luogo di scambi. Invece si possono vedere (pessimi) manicomi pieni e (splendidi) Centri di Salute Mentale vuoti. E ancora prosegue, Rotelli: strano destino ha la psichiatria, per la quale ha dignità scientifica e terapeutica la parola, e il colloquio, ma non l'azione, ovvero fare un film insieme, cambiare casa, fare teatro, leggere poesie, cambiare lavoro o trovarlo, iscriversi a un partito o uscirne, comprarsi un vestito andare in barca, litigare, avere amici eccetera, senza per questo essere trasformati in casi clinici. Per la psichiatria hard, tutto ciò non ha valore terapeutico.
L'etica minima che ci si può permettere
Ma più avanti Rotelli definisce cos'è la salute
mentale (e cosa è un basagliano). Ora, dire
cos'è la salute mentale non è per niente facile
(non lo è neppure dire cos'è la salute tout
court, figuriamoci; non lo è neppure dire cos'è
malattia), sicché Rotelli propone l'esser folli come
prendersi troppo sul serio, e dunque esercitare la vacuità
significa essere in salute psichica, non prendersi sul serio,
insomma. Ma ecco, a questo punto, la definizione di basagliano
(e chi altri ce la può dare se non colui che –
probabilmente – fu più basagliano di Basaglia?):
“il pensiero sensato ispirato a un'etica minima, la pratica
decente delle istituzioni, la critica della vacuità scientifica
istituita nelle apposite società di cui la psichiatria
forense è l'apogeo”. Ecco cosa è un basagliano:
un tecnico ispirato a un'etica minima, giacché
massima (la purezza agognata dall'antipsichiatra – no
pillole, no ricoveri coatti, solo parole, parole e colloqui)
non te la puoi permettere, se vuoi fare il medico, o lo psichiatra.
L'etica massima è quella anelata dagli antipsichiatri,
che contestano la malattia mentale e qualunque intervento su
chi soffre (Szasz scriveva: no farmaci, no ospedale, solo relazione
e parole), ma forte di quest'etica minima ti devi calare nella
contraddizione e andare là dove c'è la sofferenza:
manicomi, SPDC, OPG, eccetera, non restarne fuori, per preservare
la tua purezza antipsichiatrica
Ma proseguiamo, in questo libro. È il 1993 e Rotelli
fa il punto sulla legge 180. L'Italia si divide in tre,
scrive. Chi lavora per realizzare i principi della legge (la
minoranza egemone, appunto), chi lavora apertamente per combatterla,
e chi, pur aderendovi a parole, nei fatti la stravolge, la svuota
di senso, la rende un vuoto feticcio (è la maggioranza
democratica, la maggioranza passivo-aggressiva). Ma, aggiunge
Rotelli, questa legge è stata una grande impresa riabilitativa,
che ha inteso riabilitare la psichiatria, soprattutto. Dunque
cosa significa attuare la legge 180? Contenuti: porre
enfasi sulla persona e non sulla malattia, enfasi sulla critica
al manicomio, in tutte le sue declinazioni, anche moderne (diagnosi,
farmaci, psicoterapie), enfasi sui bisogni concreti delle persone,
sullo stigma sociale, sulle pratiche quotidiane, su un setting
allargato a famiglia, lavoro, casa, amici, quartiere, reddito,
qualità della vita, tutto questo può essere setting
terapeutico, non il solo colloquio. Quattro contenitori:
centri di salute mentale aperti sempre, notte e giorno,
365 giorni l'anno; gruppi appartamento piccoli e numerosi; cooperative
sociali molte; ospedali e centri crisi pochi, il meno possibile,
e 5% della spesa sanitaria dedicata alla salute mentale.
Mi fermo qui. Adesso, come può continuare questa storia?
In questi ultimi anni si è giunti a una legge che chiude
gli OPG. La 81/2014 che chiude in qualche modo il cerchio della
180. La 180 è stata però una legge quadro, scarna,
che non è riuscita a trovare, per alcuni temi (rei folli,
contenzione meccanica nei luoghi di cura, eccetera), nei suoi
regolamenti applicativi (i Progetti Obiettivi), una sufficiente
forza.
Quel reparto “accettazione” che restava aperto
Il passo successivo, potrebbe essere una legge che esprima, più dettagliatamente, i principi della 180. Ovviamente senza nessun arretramento, una legge che renda più forte i principi di libertà che la 180 porta. Che renda più difficile, alla maggioranza democratica, silenziosa, passivo-aggressiva, di parlar bene e razzolar male. Che abolisca la pratica del legare le persone nei luoghi di cura. Pratica che costituisce l'eredità, più scandalosa, dei manicomi, pratica che si è trasferita ormai in tutti gli ospedali civili. Ecco, potrebbe essere un ulteriore capitolo di questa storia, e di questo grande libro.
Qualcuno obietta: ma come fate? Come fate, voialtri che volete abbattere muri, rispettare i diversi, gli ultimi, i più ultimi degli ultimi: i matti? È, ancora, il momento storico buono per sostenere questa vostra causa, questa battaglia, o non è forse una causa persa, la vostra? C'è Trump, ora, che innalzerà i muri. E poi ce ne saranno altri, a seguirlo.
Rotelli a questa obiezione risponde: noi continueremo a farlo. Perché? Perché siamo dei disperati portatori di speranza, ecco cosa siamo.
I basagliani, quelli dall'etica minima ma anche massima, disperati, ma come gli anarchici, creativi (e mi ritorna in testa la definizione, forse la più stramba eppure più congeniale definizione di anarchia che ne fa Colin Ward: anarchia come disperazione creativa). Grazie a Rotelli ho trovato la sintesi tra le mie due anime: un basagliano anarchico mi sono sempre sentito, o viceversa un anarchico basagliano, dipende dai momenti. Un disperato creativo, portatore di speranza.
Ah. Rotelli mi ha confermato la storia del taci tu che hai ancora un manicomio da chiudere. Nel manicomio di Trieste c'era, dice, ancora il reparto accettazione, che proprio non si riusciva a chiudere, e faceva davvero schifo. “Basaglia mi diede ragione, però si vendicò: il giorno dopo mi ritrovai a dirigerlo. Dovetti chiuderlo io”.
Piero Cipriano
Bakunin/
Il ruolo della principessa Zoè nella vita del rivoluzionario russo
Bakunin è riuscito a fuggire dall'esilio in Siberia
cui era stato destinato dallo Zar, dopo la prigionia nella Fortezza
di Pietro e Paolo. Dalle sterminate solitudini ghiacciate, iniziando
lungo il corso dell'Amur un viaggio che ha dell'incredibile,
pressochè circumnavigando il globo, Mikhail Bakunin è
arrivato in America e da lì in Inghilterra, a Londra.
Entrando di getto nella stanza dove i suoi amici Herzen ed Ogarev,
con le loro compagne, stanno passando il pomeriggio, immaginiamo
prendendo il tè, il rivoluzionario russo riprende l'attività
interrotta nel 1849 sulla barricate di Dresda.
Si sta sviluppando in grande stile e sul piano europeo il conflitto
ideologico-politico tra Marx e Bakunin, già avviato da
quando Marx ospitò sul giornale da lui diretto, La
Nuova Gazzetta Renana alcune maldicenze su Bakunin, peraltro
subito smentite dallo stesso Marx. Queste maldicenze sono state
messe in giro, non è chiaro se dalla polizia segreta
zarista o da alcune fazioni di esiliati polacchi che contendono
a Bakunin la direzione della propaganda e dell'azione per liberare
la Polonia dal dominio zarista. Nell'ambito di questo conflitto
e grazie ad esso, le due anime del socialismo europeo e presto
mondiale, l'antiautoritaria e l'autoritaria, si vanno delineando
con estrema rapidità.
 È
in questo contesto che si sviluppa la vicenda narrata da Lorenza
Foschini (Zoè la principessa che incantò Bakunin
Mondadori, Milano, 2016, pp. 208, € 20,00), giornalista
Rai e scrittrice, che è riuscita ad integrare la storia
di Mikhail Bakunin e quella della principessa Obolenskaja, esempio
russo di aristocratica ribelle alla sua classe di origine, come
fu il caso anche di Bakunin e di altri noti esponenti dell'anarchismo
dell'epoca. È
in questo contesto che si sviluppa la vicenda narrata da Lorenza
Foschini (Zoè la principessa che incantò Bakunin
Mondadori, Milano, 2016, pp. 208, € 20,00), giornalista
Rai e scrittrice, che è riuscita ad integrare la storia
di Mikhail Bakunin e quella della principessa Obolenskaja, esempio
russo di aristocratica ribelle alla sua classe di origine, come
fu il caso anche di Bakunin e di altri noti esponenti dell'anarchismo
dell'epoca.
Notizie sulla vicenda della principessa Obolenskaja e dei suoi
rapporti con Bakunin si trovano nella biografia di Bakunin di
E.H. Carr, nel libro di H.E. Kaminski Bakunin vita di un
rivoluzionario, ma finora nessuno si era provato nel riprendere
dall'oblio della storia, in modo circostanziato, una vicenda
dimenticata. Alla nutrita bibliografia su Bakunin, che fin dal
suo primo biografo Max Nettlau, l'Erodoto dell'anarchismo, ha
analizzato pressochè tutti gli aspetti del suo pensiero
e della sua azione, si aggiunge perciò questo altro libro,
di alta divulgazione storica-letteraria. Uno studio su ipotesi
del vissuto di Bakunin, del quale poco si sa, quando tra Napoli,
Sorrento ed Ischia definisce compiutamente i principi teorici
dell'anarchismo classico e sulla personalità ed il ruolo
avuto dalla principessa Obolenskaja. Ella, oltre a ricopiare
devotamente in bella copia ciò che Bakunin scriveva,
non esitò, grazie alla sua straordinaria ricchezza, ad
aiutare economicamente il rivoluzionario russo, notoriamente
e permanentemente in continue ambasce economiche, e a finanziare
i suoi disegni rivoluzionari, facendo in modo di creargli attorno
un ambiente di serenità e rispetto. Ciononostante le
attenzioni inquietanti della Terza Sezione, la polizia segreta
zarista, molto interessata ad entrambi.
Si conosce di questo periodo la produzione di Bakunin, come
la Situazione italiana I e II. Si tratta degli scritti nei quali
con grande passione, coinvolgimento e acume Bakunin descrive
la miseria e la fame dei contadini, che risultano essere, nella
fase di iniziale industrializzazione del Paese, in assoluta
prevalenza quantitativa, nella composizione delle classi popolari,
sulla componente operaia, l'energia del minoritario strato di
artigiani, efficacemente organizzati nelle Associazioni mazziniane
e l'idealismo, rivolto alla soluzione della Questione Sociale,
dei giovani artigiani, studenti ed operai, che per ragioni anagrafiche
non hanno fatto a tempo a prender parte all'epopea garibaldina.
Ma non era stato ancora illustrato l'ambiente nel quale Bakunin
svolse la sua opera di pensatore, qual era la sua vita, il suo
stato d'animo, quali le relazioni che intraprese per dare seguito
operativo alla sua volontà rivoluzionaria. L'influenza
che Bakunin ebbe sui primi Internazionalisti, che si riunivano
attorno al giornale La Campana e all'Associazione Libertà
e Giustizia e lo shock sociale e politico che il messaggio bakuninista
produsse tra giovani idealisti, inizialmente seguaci di Mazzini
e di Garibaldi, lo leggiamo nella prefazione al libro di Nettlau
Bakunin e l'Internazionale dove Malatesta fra l'altro
scrive: “Un uomo come Bakunin, con la fama di grande rivoluzionario
europeo che l'accompagnava, con la sua ricchezza e modernità
d'idee, con la sua foga e con la forza avvincente della sua
personalità, non poteva non fare forte impressione su
coloro che lo avvicinarono.”
L'atmosfera, che Malatesta ci tramanda, della nascita entusiasta
dell'anarchismo di lingua italiana, è ben resa dalla
Foschini che integra storia e letteratura, senza che la precisione
storica sia sacrificata alla resa narrativa e viceversa. Persone,
ambienti e circostanze sono descritti con simpatia umana e penetrazione
psicologica. Se la figura della principessa Obolenskaja è
oggetto di molta attenzione interpretativa, lo è altrettanto
la figura di Bakunin, nel tentativo di spiegare il tipo di legame
emotivo intercorso tra i due protagonisti della vicenda. L'autrice
formula l'ardita ipotesi che sia stata la principessa a introdurre
Bakunin nell'ambiente cosmopolita di Napoli, ed allo stato delle
conoscenze non vi è motivo per non condividere tale tesi.
Due sono i temi narrativi, ben integrati tra di loro e presenti
nel libro: la vicenda della principessa e la vicenda di Bakunin,
sia nella fase di più immediata e reciproca correlazione,
sia nella fase nella quale la principessa si allontana da Bakunin,
avvicinandosi al gruppo marxista di Ginevra e risultando pressochè
del tutto coinvolta dalla sua sofferta situazione famigliare.
Comunque nulla delle vicende di entrambi, successive al periodo
napoletano, viene trascurato dall'autrice. Inoltre la narrazione
delle vicende dei discendenti di entrambi i protagonisti conferisce
un più largo respiro alla narrazione.
Se osservazioni possono essere fatte al libro, è che
in esso manca la consapevolezza, e quindi non viene interpretata
sul piano narrativo, della chiaroveggenza di Bakunin in merito
ai destini ultimi dello statalismo della sua epoca. In “Stato
ed Anarchia” egli vaticinò che il conflitto tra
gli imperialismi europei nazionali, che si era manifestato nella
guera franco-prussiana, avrebbe dato luogo ad una guerra mondiale.
Come poi puntualmente avvenne.
Enrico Calandri
Pedagogia/
Il tempo di perdere tempo
Conoscere e conoscersi sono azioni che vanno di pari passo
o, perlomeno, così dovrebbero andare. Poiché non
esiste cosa da noi osservata o con la quale entriamo in varia
forma in relazione, che non sia, a ben vedere, quel che noi
vediamo o pensiamo della cosa stessa, è evidente come
il desiderio di conoscere ciò che è fuori di noi
porti con sé la possibilità di conoscere anche
una parte di noi stessi. È una caratteristica che ci
contraddistingue, un nostro modo di fare.
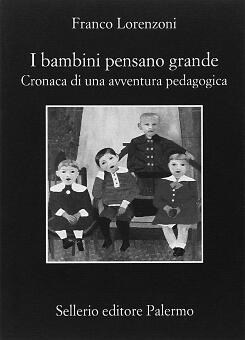 Ed
è così, o così dovrebbe essere, anche e
soprattutto all'interno di un processo educativo che sostanzialmente
è fatto di relazioni, di dialoghi, di domande e scoperte
– altrimenti meglio dire istruzione – che, se usate
al meglio delle loro possibilità creative, fanno della
scuola una circostanza meravigliosa. Ed
è così, o così dovrebbe essere, anche e
soprattutto all'interno di un processo educativo che sostanzialmente
è fatto di relazioni, di dialoghi, di domande e scoperte
– altrimenti meglio dire istruzione – che, se usate
al meglio delle loro possibilità creative, fanno della
scuola una circostanza meravigliosa.
Questo, molto in breve, potrebbe dirsi il fulcro intorno al
quale si dipana il libro di Franco Lorenzoni – maestro
presso la scuola elementare di Giove in provincia di Terni -
I bambini pensano grande. Cronaca di un'avventura pedagogica
(Sellerio, Palermo, 2014, pp. 264, € 14,00) giunto in due
anni alla quattordicesima edizione. Evidentemente quel che di
buono accade nella scuola pubblica suscita attenzione. Bello
sarebbe se si trasformasse in passione pedagogica, cioè
nel desiderio di provare a mettersi in gioco, nonostante la
costante spinta che la classe insegnante subisce a trasformarsi
in demotivati propinatori di nozioni facilmente verificabili
con crocette messe nel quadratino giusto.
Le pagine di questa rivista ospitano spesso resoconti e riflessioni
intorno a temi educativi, sovente dal punto di vista della sperimentazione
libertaria in atto in molti luoghi del nostro paese. In mezzo,
tra la burocrazia della scuola pubblica e le “scuoline”
libertarie, ci stanno esperienze come questa, di chi prova,
per amore del proprio lavoro e dell'infanzia, a restituire al
tempo scolastico la preziosità che lo dovrebbe contraddistinguere.
Perciò un libro così diventa utile anche a derimere
alcuni preconcetti che vedono la scuola pubblica in maniera
solo negativa e non composta da persone tra le quali molte ancora
cercano di difendere e far bene il proprio lavoro.
“Osservando di quali scoperte sono capaci, quando gli
si dà la libertà di fermarsi a lungo su un argomento,
penso che la scuola non dovrebbe inseguire mode e modi del nostro
tempo, ma essere piuttosto un luogo in cui si gioca e si mettono
in gioco le idiosincrasie dell'epoca e della società
in cui ci è capitato di vivere.
Cos'è la cultura, del resto, se non critica e capacità
di discussione di ciò che accade? Che cos'è l'arte,
se non ribellione al proprio tempo e proposta di altri sguardi
sul mondo? Cos'è la scienza, se non il rimettere continuamente
in causa ciò che diamo per scontato e per vero? E la
scuola non dovrebbe essere il tempio di cultura, arte e scienza?”
Bisogna dare ai ragazzi il tempo di perdere tempo è l'importante
suggerimento di Emma Castelnuovo, grande didatta della matematica
a cui Lorenzoni spesso si ispira nel suo lavoro quotidiano e,
in questo tempo veloce, ansioso addirittura, in cui la cosa
più importante sembra sempre quella di raggiungere il
risultato in programma, poter sostare a lungo su un argomento,
lavorare intorno a un'opera d'arte o a un problema geometrico
tutto il tempo che ci vuole è chiaramente sintomo di
qualità. Lenta e meticolosa costruzione di comprensioni
corali che si sviluppano da dibattiti gestiti in classe da un
rispettoso maestro che restituisce ai bambini e alle bambine
il valore della loro voce e del loro pensiero.
Si ha il vizio di separare tutto precocemente mentre –
ci ricorda il maestro Franco – ogni giornata dovrebbe
servire ad arricchire il nostro immaginario e quello dei ragazzi
intorno a quella tensione al conoscere che vede l'unità
di tutto il sapere e che caratterizza la nostra specie. Dovrebbe
essere così anche per noi che i banchi ce li siamo lasciati
alle spalle da un pezzo, invece succede che la scuola strappi
l'imparare a leggere dall'amore per la lettura, il saper contare
dalla meraviglia che la matematica racchiude, senza rendersi
conto che quello che non succede in quegli anni spesso poi non
si recupera più.
La scuola per i più piccoli, ma non solo, è un
grande sforzo; ciò che a noi appare scontato non lo è
per loro e confrontarsi con quelle che sono state le grandi
scoperte dell'umanità, le grandi rivoluzioni che furono,
ad esempio, il calcolo e la scrittura, richiede che vengano
proposte in maniera viva, che li si accompagni a ragionare sull'origine
di queste “comuni” pratiche umane, affinchè
se ne approprino col gusto della scoperta, di ciò che
trasforma il modo vi vedere il mondo.
Il libro si sviluppa alternando la riproposizione fedele di
numerosi dialoghi degli scolari su argomenti di un programma
svolto ponendo questioni e lasciando elaborare soluzioni con
le riflessioni del maestro. L'interrogarsi di bambine e bambini
intorno ad argomenti di matematica, scienze, arte, storia ha
la sorprendente freschezza della nascita di un pensiero che
prova a dare forma al mondo. A spiegarsi il perché delle
cose.
Potrei continuare a lungo intessendo le lodi di questo piccolo
libro scritto da un maestro di scuola assolutamente non perfetto
– sono apprezzabili i punti in cui racconta i suoi limiti
e difficoltà – ma vorrei concludere (dopo aver
invitato alla lettura) andando a quelle pagine dove si ricorda
Socrate, il quale sosteneva che tutto ciò che noi impariamo
ha origine nel corpo e nei sentimenti che il bello suscita in
noi.
Nel corpo e nei sentimenti, quindi è nella relazione
che nasce la conoscenza; relazione che, come ribadito all'inizio,
è fondamento educativo e origine di bellezza.
“È così che si fa una scoperta. Prima devi
prendere tutte le informazioni, poi, mettendole insieme, viene
fuori una storia” precisa Erika. “Così viene
fuori la verità” sostiene Matteo.
“La verità?” domando. “La ricostruzione”
risponde Lorenzo, sempre attento a precisare le cose. “Viene
la verità, non sicura” aggiunge ancora Mattia.
“Una verità non sicura? Perché non sicura?”
domando ancora incuriosito. “Perché sì”,
conclude Mattia. “Tu hai ricostruito tipo un caso, perché
non hai gli accertamenti che sia una cosa precisa, perfetta.
Quindi è una verità, sì, non sicura però”.
Silvia Papi
Donne/
Un bagaglio di coraggio, dignità, ideali
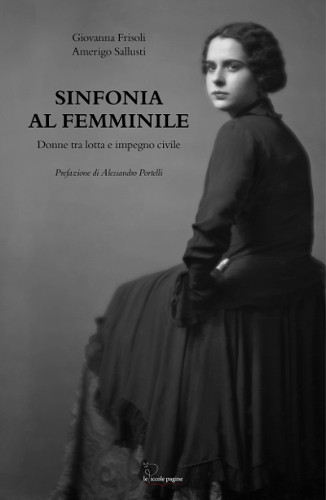 Nella
sua puntuale prefazione al saggio Sinfonia al femminile.
Donne tra lotta e impegno civile (di Giovanna Frisoli, Amerigo
Sallusti, Edizioni Le Piccole Pagine, Piacenza, 2016, pp.118,
€ 10,00) Alessandro Portelli sottolinea che non si tratta
di un “contributo delle donne” alle lotte di liberazione.
Le donne non sono un'aggiunta a un lavoro separato e preparato
da altri. Invece, le loro conquiste sono necessarie a tutti
gli individui, poiché esprimono le ragioni ultime per
le quali vale la pena lottare. Nella
sua puntuale prefazione al saggio Sinfonia al femminile.
Donne tra lotta e impegno civile (di Giovanna Frisoli, Amerigo
Sallusti, Edizioni Le Piccole Pagine, Piacenza, 2016, pp.118,
€ 10,00) Alessandro Portelli sottolinea che non si tratta
di un “contributo delle donne” alle lotte di liberazione.
Le donne non sono un'aggiunta a un lavoro separato e preparato
da altri. Invece, le loro conquiste sono necessarie a tutti
gli individui, poiché esprimono le ragioni ultime per
le quali vale la pena lottare.
La bellezza come fine stesso della battaglia, la ragione stessa
della rivoluzione rappresenta il filo conduttore dei contributi
su Ada Prospero Gobetti, Mother Jones, le donne libertarie nel
ghetto di Varsavia, Emma Goldman.
Per Ada Prospero Gobetti, in prima fila nella IV divisione
Giustizia e Libertà come partigiana combattente, la bellezza
diventa uno strumento di lotta. Uniti agli ideali di giustizia
sociale e libertà, alla base della solidarietà,
anche la passione per il canto, la danza, e la lettura . La
sua vocazione narrativa avrà fasi alterne, influenzate
dagli eventi storico politici. L' attenzione è rivolta
ai bambini. Già nel 1940 esce il suo libro più
conosciuto, “La storia del gallo Sebastiano”, firmato
con lo pseudonimo di Margutte. Ai piccoli lettori offre spunti
di riflessione sulla società per contrastare i conformismi,
il livellamento generato dalla dittatura, ma insiste pure sui
temi della diversità, l'amicizia, la solidarietà.
Nel “Diario partigiano” dimostra altresì
una grande attenzione al rapporto genitoriale con il figlio
Paolo, convinto partigiano. A pochi giorni dalla nascita del
figlio, annoterà: “Ma una cosa è certa:
che noi sapremo rispettare la tua personalità, la tua
formazione. Tu sarai ciò che vorrai e potrai essere”.
Nel dopoguerra fonderà la rivista “Il giornale
del genitore”. E nelle parole di chiusura del primo numero:
“Il genitore ideale insegnerà accanto ai valori
di rispetto della giusta obbedienza, anche quelli della ribellione
e della disobbedienza”. Inoltre, si batterà per
tradurre nel concreto molti aspetti dell'elaborazione resistenziale,
in primis una scuola laica per tutti. Perché una società
nuova necessita di una scuola nuova.
Anche Mary Harris Jones, conosciuta come Mother Jones,
la mamma di tutti i lavoratori, intraprende la via della bellezza
nelle rivendicazioni sociali, con la pratica dell'orazione cantata:
canzoni di protesta per raccontare storie di lotta.
Come nel 1912, contro una legge che stabiliva il non pagamento
delle ore non effettuate, dopo aver ridotto le ore settimanali
di lavoro per le donne e i bambini da 56 a 54, nello stato del
Massachusett guiderà anche lo sciopero del pane e delle
rose.”Bread and rose” titolerà una ballata,
l'inno delle operaie tessili di Lawrence.
Diventata una delle dirigenti dell' IWW -movimento fondato nel
1905 a Chicago legato a socialisti e anarchici- a Greensburg
in Pennsylvania, orchestrerà una lotta dura e non violenta
per la libertà di parola.
Il giorno in cui i minatori, in sciopero per ottenere salari
più alti, si fossero recati in tribunale per difendersi
dalle accuse, le mogli avrebbero portato con sé i propri
figli. Condannate proprio per le urla dei bambini e gli strilli
dei neonati, appena rinchiuse in prigione, Mother Jones: “Cantate
tutta la notte. Dormite di giorno e cantate la notte. Dite che
cantate per i bambini”. Dopo cinque giorni verranno scarcerate.
L'IWW otterrà così la sua vittoria.
Nel 1903, da Filadelfia alla casa di villeggiatura del presidente
Roosevelt, sulle rive del mare a Oyster Bay, la marcia dei bambini
schiavi - oltre 10.000 minori sfruttati nelle industrie tessili
dello stato - accompagnati da tamburi e piffero e da striscioni
con la scritta :”Vogliamo tempo per giocare” conseguirà
un traguardo. Dopo uno sciopero, la Pennsylvania varerà
una legge contro il lavoro minorile, per innalzare a 14 anni
l'età minima d'ingresso in fabbrica.
I bambini rappresentano le prime vittime anche nel ghetto di
Varsavia. Una testimonianza nel componimento poetico “Il
piccolo contrabbandiere”, scritto da Henrika Lazowert,
uccisa a Treblinka, a trentadue anni, con la massiccia deportazione
di 300.000 ebrei, nel 1942. Istituito con decreto del 12 ottobre
1940, rappresenta il più grande ghetto realizzato sul
territorio polacco, in un quartiere di circa 4 chilometri quadrati.
Nel tempo, saranno rinchiusi oltre 70.000 deportati ebrei.
Reti sociali clandestine, coordinate dall' associazione ebraica
di protezione sociale (Ztos) rappresentano forme di Resistenza.
Le donne organizzano corsi di giardinaggio, coltivazione delle
verdure nell'orto, cucine collettive. Attraverso la Yidisher
Arbeter Froy (Yaf), affrontano tematiche sull'educazione dei
figli, la sessualità, la violenza, le discriminazioni
subite ogni giorno.
Ma nel ghetto si attua altresì una Resistenza all'insegna
del bene comune fatta di bellezza: dalla musica, alla poesia,
al teatro, espressioni artistiche seguite da centinaia di persone
ogni sera, in luoghi sicuri. Tra le militanti attive, l'attrice
Pola Lipszyc e la ballerina Mania Katz. Intrattengono bambini
e residenti con corsi di danza, atelier di pittura, scuole di
disegno, fino a trasformare i caseggiati in vere case di cultura.
Anche per Emma Goldman, si può fare politica amando
l'arte e la bellezza. Dirà: “Una rivoluzione che
mi impedisca di ballare non è la mia rivoluzione”.
La bellezza del viaggio verso la libertà è retta
dalla forza sovversiva della parola. La prima oratrice del movimento
anarchico tedesco in America scopre la sua capacità oratoria
persuasiva. A New York in occasione dei festeggiamenti del 1°
Maggio 1891, agli anarchici è vietato montare il loro
palco. Emma comincia il suo discorso issata su un carretto,
procede trascinando con sé la folla. I giornali, in prima
pagina: “Una giovane donna in piedi sopra un carro, agitando
la bandiera rossa, ha esortato alla Rivoluzione”.
Qualche tempo dopo, un suo discorso in Union Square le costerà
un anno di detenzione nel penitenziario di Blackwell Island,
per aver incitato le masse a rubare: “Andate dunque a
manifestare davanti alle dimore dei ricchi. Chiedete lavoro,
e se non ve ne danno, chiedete pane. Ma, se ve li negano entrambi,
il pane prendetevelo. È un vostro sacro diritto”.
La forza della parola, l' impegno antimilitarista, l'attività
di propaganda per il diritto dei lavoratori di organizzarsi,
per il controllo delle nascite, la libertà sessuale,
di parola e di stampa faranno di Emma Goldman l'emblema del
pericolo imminente.
Intanto, le persecuzioni si intensificano, riunioni sciolte
con la forza, molti arresti. A New York, assaltata la redazione
del periodico anarchico “Freie Arbeiter Stimme”,
l'interno bruciato e distrutto.
Con il nome di signorina Smith, istituisce una Lega permanente
per il diritto alla parola. Allo scoppio della prima guerra
mondiale, incita i giovani a disertare. Insieme a Sasha, Alexandre
Berkman, organizza una Lega anticoscrizione. Frutterà
ad entrambi un arresto e una condanna, causa dell'espulsione
dagli Stati Uniti.
Nel giugno del 1917, nell' East Side, davanti ad una folla di
donne e lavoratori, contesterà la legittimità
delle leggi che autorizzavano l'espulsione di stranieri e oppositori.
Verrà incarcerata con l'accusa di cospirazione e sovversione
dell'ordine pubblico, e di trasformare degli umili ignoranti
in una folla di ribelli. Dopo il rilascio, privata della cittadinanza
e deportata come straniera, sarà imbarcata su una nave
diretta verso la Russia rivoluzionaria.
Donne combattive che hanno creduto nella forza sovversiva della
parola e dell'azione. Sostenute, nei loro viaggi di lotta, da
un bagaglio fedele carico di coraggio, dignità, ideali,
e di una tenace passione per la giustizia.
Claudia Piccinelli
Sbirri, anarchici, malavitosi e.../
Marsiglia e Milano
Milieu edizioni ha da poco pubblicato Muffa della città.
Criminalità e polizia a Marsiglia e Milano (1900-1967)
(Milano, 2016, pp. 199, € 17,00) di Luigi Vergallo, assegnista
di ricerca di storia contemporanea presso la Statale di Milano.
Il volume si propone di ricostruire le trasformazioni della
criminalità nella prima metà del Novecento attraverso
i casi di Marsiglia e Milano, concentrandosi in particolare
sulla progressiva “sostituzione delle criminalità
organizzate a quelle di quartiere” e sforzandosi di inserire
ciò all'interno dei processi politici, economici, sociali,
culturali e urbanistici che investirono in questo lungo arco
di tempo le due città prese in considerazione.
 Un'avvertenza
preliminare: non è il libro che ci si potrebbe aspettare
o, almeno, che io ingenuamente mi aspettavo. Chi lo comprasse
per leggere solamente epiche gesta di criminali senza paura
e le carognate di “sbirri” ora spietati ora corrotti
ne rimarrebbe forse deluso. Intendiamoci, nel volume ci sono
sia gli uni sia gli altri, ma non sono l'oggetto principale
della narrazione. Attraverso una ricchissima documentazione
(in particolare giornali dell'epoca e gli archivi italiani,
francesi, inglesi e statunitensi), Vergallo si sforza infatti
di uscire da un'immagine stereotipata del mondo della criminalità
e, mi sembra, finisce per fare una storia di Milano e Marsiglia
da un'angolazione certamente diversa da quelle comunemente proposte
e per questo tanto affascinante. Un'avvertenza
preliminare: non è il libro che ci si potrebbe aspettare
o, almeno, che io ingenuamente mi aspettavo. Chi lo comprasse
per leggere solamente epiche gesta di criminali senza paura
e le carognate di “sbirri” ora spietati ora corrotti
ne rimarrebbe forse deluso. Intendiamoci, nel volume ci sono
sia gli uni sia gli altri, ma non sono l'oggetto principale
della narrazione. Attraverso una ricchissima documentazione
(in particolare giornali dell'epoca e gli archivi italiani,
francesi, inglesi e statunitensi), Vergallo si sforza infatti
di uscire da un'immagine stereotipata del mondo della criminalità
e, mi sembra, finisce per fare una storia di Milano e Marsiglia
da un'angolazione certamente diversa da quelle comunemente proposte
e per questo tanto affascinante.
Il libro descrive dunque i grandi processi che hanno investito
il mondo della malavita, collocandoli all'interno di un rapporto
“triangolare”, mai univoco e unilaterale, tra la
malavita stessa, le istituzioni poliziesche e la popolazione
operaia. In altri termini, il volume intende “descrivere
e analizzare il processo bidirezionale di condizionamento che
all'inizio del XX secolo ha contribuito a trasformare le forze
di polizia da una parte e il milieu malavitoso dall'altra”,
ricostruire “le reciproche contaminazioni avvenute nei
comportamenti e nelle culture, o nelle sub-culture, della classe
operaia e della malavita nei quartieri popolari di Milano e
di Marsiglia nella prima metà del Novecento, interrogandosi
al contempo circa l'esistenza di eventuali sentimenti di solidarietà
«umana» – a più livelli – tra
proletariato, piccola criminalità e forze di polizia”.
Anche gli anarchici fanno la loro comparsa in queste vicende.
Le imprese della banda Bonnot, per esempio, contribuirono alla
progressiva motorizzazione della polizia francese, le cui brigate
mobili ancora nel primo decennio del Novecento si spostavano...
in treno! La persecuzione politica degli anarchici mostrò
inoltre sin dall'inizio del secolo l'importanza dei “processi
di identificazione”. Il 21 agosto 1911 un imbianchino
italiano rubò infatti la Gioconda al Louvre e a lungo
la polizia italiana non seppe dare indicazioni ai colleghi francesi
sul ladro, che venne catturato solo quando scrisse a un antiquario
di Firenze per vendergli il dipinto.
Al contrario pochi anni dopo, durante la Prima guerra mondiale,
la polizia italiana riuscì ad arrestare alcuni contrabbandieri
milanesi che si muovevano tra Italia e Svizzera solo in quanto
già schedati come disertori e anarchici. D'altronde,
osserva opportunamente Vergallo, tutto in polizia è affare
tanto di identificazione quanto di delazione. Inoltre mi ha
stupito il ruolo significativo della riorganizzazione dello
spazio urbano nell'ambito dei rapporti tra istituzioni e criminalità
che mi pare emerga dalla narrazione del libro. Due esempi su
tutti. Nel 1943 i nazisti fecero drasticamente saltare per aria
con la dinamite il quartiere marsigliese del Panier, rifugio
di malavitosi, anarchici e antifascisti. Il sopravvento della
società terziarizzata nel secondo dopoguerra e con questa
della metropoli-vetrina dei servizi e del turismo determina
la scomparsa dei bassifondi e, congiuntamente all'aumento esponenziale
di certi traffici illegali (in primo luogo quello degli stupefacenti),
la radicale trasformazione della criminalità. Questa
congiuntura porta interi quartieri a cambiare completamente
volto, come mostra il caso del Bottonuto a Milano, zona malfamata
che sorgeva un tempo intorno alla centralissima piazza Diaz,
sotto la quale si trovava il collettore delle acque di scarico
di una latrina pubblica.
“Muffa della città” restituisce insomma uno
spaccato particolare, sempre in movimento e mai semplicistico.
Il libro mi è sembrato uno strumento per guardare in
modo diverso alla Milano e alla Marsiglia della prima parte
del Novecento, dicendo molto anche sul modo di agire e sulla
logica propria delle istituzioni poliziesche di oggi. Quello
di Vergallo è uno sguardo documentato, al di là
della pura aneddotica e lontano da rappresentazioni romantiche
e folkloristiche, sulla malavita, piena di contraddizioni e
in un complesso rapporto con la popolazione, stretta tra spinte
contrastanti come la richiesta di più “legalità”
(non suona familiare?) e pratiche solidali come quella del “molla
molla!” milanese. Per saperne di più, non resta
che leggere “Muffa della città”.
David Bernardini
|