
Anne Henriette Estorges (nota come Rirette Maitrejean)/
Anarchica francese della Belle Epoque
Rirette Maitrejean. Vita di un'anarchica parigina negli
anni della Belle Epoque (Arshile booklet, Torino 2015, pgg.
30, € 9,50) è il titolo di un elegante volumetto,
dedicato alla memoria dell'anarchica francese Anne Henriette
Estorges, più nota come Rirette Maitrejean, scritto da
Susanna Fisanotti.
Il testo, semplice ed essenziale, della Fisanotti narra dell'infanzia
della Maitrejean (nata il 14 agosto del 1887 in un piccolo borgo
della Francia, a Saint-Mexant, nel dipartimento di Correze),
delle alterne vicissitudini della sua famiglia (che passa dalla
miseria ad un discreto benessere e poi di nuovo ripiomba nella
precarietà) e della sua volontà di studiare ed
istruirsi per poter, un giorno, andare via, dal luogo natio,
nel quale non vede alcuna prospettiva per il suo futuro. Per
questo, approda a Parigi, all'inizio del '900, nella città,
frenetica e industriosa che per l'Esposizione universale, aveva
ospitato 50 milioni circa di visitatori.
 Qui,
la Maitrejen – ricorda ancora la Fisanotti – trova
alloggio nel Fouborg Saint-Antoin e mentre svolge lavori saltuari,
frequenta i corsi organizzati dalla Coopèrative des
Idées – una sorta di Università popolare,
fondata nel 1899 da George Deherme, un ebanista anarchico e
da Gabriel Séailles, che è professore alla Sorbona
– che saranno fruttuosi per la sua istruzione e che faranno
nascere in lei una libera e convinta adesione ai principi dell'anarchia,
dei quali diventa convinta propagandista. Ai corsi della Coopèrative
des Idées, tenuti da personaggi di gran carisma,
come Albert Joseph Libertad “colui che le ha lasciato
i migliori e i più puri ricordi dell'anarchia”,
incontra Louis Maitrejean, di cui si innamora e che sposa nel
1905, assumendone il cognome. Qui,
la Maitrejen – ricorda ancora la Fisanotti – trova
alloggio nel Fouborg Saint-Antoin e mentre svolge lavori saltuari,
frequenta i corsi organizzati dalla Coopèrative des
Idées – una sorta di Università popolare,
fondata nel 1899 da George Deherme, un ebanista anarchico e
da Gabriel Séailles, che è professore alla Sorbona
– che saranno fruttuosi per la sua istruzione e che faranno
nascere in lei una libera e convinta adesione ai principi dell'anarchia,
dei quali diventa convinta propagandista. Ai corsi della Coopèrative
des Idées, tenuti da personaggi di gran carisma,
come Albert Joseph Libertad “colui che le ha lasciato
i migliori e i più puri ricordi dell'anarchia”,
incontra Louis Maitrejean, di cui si innamora e che sposa nel
1905, assumendone il cognome.
Il matrimonio e i figli che ne nasceranno, pur impegnandola
molto, non le fanno venir meno la passione per l'impegno politico,
che si concretizza nell'organizzazione numerosa di azioni di
lotta e di protesta per i diritti delle donne e degli oppressi
e nella collaborazione al periodico l'anarchie, che ha
sede sulla collina di Montmartre, sul quale scrive evidenziando
le terribili contraddizioni sociali della capitale francese,
in cui c'è chi, ricco e benestante, vive lo splendore
della belle epoque e chi, invece, diseredato e misero,
patisce stenti e sofferenze. “Noi ameremo fare lunghi
vagabondaggi versi i mari maestosi e le salubri montagne, -
scrive la Maitrejean - far riposare i nostri occhi su orizzonti
dove la natura è ancora sovrana, abbiamo invece davanti
a noi i tetti di povere mansarde e gli altiforni, le nostre
prigioni quotidiane. E l'inesorabile vita ci porterà
schiavitù, dolore e perpetua lotta!”
Frequentando la redazione de l'anarchie, la Maietrajean,
conosce Maurice Vandamme, che diventa il suo nuovo compagno,
col quale, fra l'altro, farà un viaggio in Italia, nel
1908; poi, sempre nello stesso luogo, incontra Victor Serge,
figlio di esuli russi, e a lui si lega in un rapporto d'amore
e militanza, che porterà entrambi, nel 1913, in carcere,
per avere dato aiuto e protezione a due membri degli “illegalisti”
anarchici della Bande à Bonnot.
Uscita dal carcere e lasciata da Serge, la Maietrajean, continuerà
a vivere e a lottare per le sue idee anarchiche, a Parigi.
Come annota la Fisanotti, nel secondo dopoguerra, sarà
in amicizia con Camus, continuerà la collaborazione con
testate libertarie, lavorerà come correttrice di bozze
per il famoso editore Flammarion, sino alla morte, a 74 anni,
nel giugno del 1968, “proprio nei giorni in cui a Parigi
esplode il maggio francese, che vede studenti e operai lottare
a fianco nel desiderio di creare una società più
giusta e più libera”; “nulla avrebbe reso
più felice Rirette che vedere le sue idee rinascere in
una nuova generazione”, scrive la Fisanotti, che col suo
libretto (corredato da una ventina di belle e rare fotografie
d'epoca) rende un utile e grazioso omaggio ad una figura di
donna e d'anarchica, forse ancora poco nota ma di certo importante
e interessante.
Silvestro Livolsi
Cancro/
Un ammalato denuncia
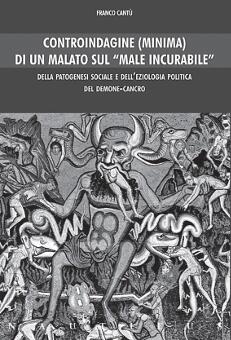 Con
questo contributo, leggero per mole e ponderoso in quanto a
contenuti, l'autore Franco Cantù (Controindagine (minima)
di un malato sul “male incurabile”. Della patogenesi
sociale e dell'eziologia politica del demone-cancro, Nautilus,
Torino 2017, pp. 62, € 3,50) decide di affrontare il più
scomodo degli argomenti, quello della malattia che inevitabilmente
implica anche l'aspetto della morte, e lo fa – come apertamente
dichiarato nel titolo – non dalla parte del tecnico del
morbo, del professionista, ma da quell'altra, quella del paziente
(per la verità impaziente assai) che si rivolta contro
lo specialismo e rivendica la sua possibilità di rigirare
la sua catastrofe contro il sistema che l'ha prodotta, coltivata
e fatta crescere. Perché quella delle patologie di cui
il tumore è solo il più fiero e massmediatico
rappresentante (a volte scalzato da altre emergenze come aids,
ebola, morbillo, meningite e così via a seconda delle
esigenze dei ceti politici lautamente sovvenzionati dalle multinazionali)
è una storia che non può essere compresa neanche
in misura minima se non viene collegata a tutto lo sviluppo
di una società alla quale è funzionale la diffusione
capillare di malati spaventati e remissivi, non certo di critici
radicali dello sviluppo. Con
questo contributo, leggero per mole e ponderoso in quanto a
contenuti, l'autore Franco Cantù (Controindagine (minima)
di un malato sul “male incurabile”. Della patogenesi
sociale e dell'eziologia politica del demone-cancro, Nautilus,
Torino 2017, pp. 62, € 3,50) decide di affrontare il più
scomodo degli argomenti, quello della malattia che inevitabilmente
implica anche l'aspetto della morte, e lo fa – come apertamente
dichiarato nel titolo – non dalla parte del tecnico del
morbo, del professionista, ma da quell'altra, quella del paziente
(per la verità impaziente assai) che si rivolta contro
lo specialismo e rivendica la sua possibilità di rigirare
la sua catastrofe contro il sistema che l'ha prodotta, coltivata
e fatta crescere. Perché quella delle patologie di cui
il tumore è solo il più fiero e massmediatico
rappresentante (a volte scalzato da altre emergenze come aids,
ebola, morbillo, meningite e così via a seconda delle
esigenze dei ceti politici lautamente sovvenzionati dalle multinazionali)
è una storia che non può essere compresa neanche
in misura minima se non viene collegata a tutto lo sviluppo
di una società alla quale è funzionale la diffusione
capillare di malati spaventati e remissivi, non certo di critici
radicali dello sviluppo.
Quello di Cantù non pretende certo di essere un esauriente
trattato sulla relazione tra strutturazione democratico-capitalista
e patogenesi, ma propone una sintesi delle argomentazioni che
conducono necessariamente a una sfiducia sostanziale verso “la
casta sacerdotale medica”, soprattuto carnefice, ma anche
vittima, in quanto i medici: “subiscono una pressione
fortissima attraverso la formazione e l'attività professionale
che li torce più o meno consapevolmente verso la cura
estrema dell'interesse miliardario dell'industria farmaceutica”.
Anche se il testo non si addentra in documentazioni specifiche
– e forse se proprio si vuole trovare un limite al volumetto
è la scarna bibliografia riportata – alcuni passi
forniscono spunti di grande interesse per i lettori desiderosi
di approfondire. In particolare il capitolo Statistiche che
“danno i numeri” descrive con efficacia la qualità
dei dati che vengono diffusi e le strategie informative che
sostengono validamente l'apparato tutto.
Scrive Cantù: “viene definito guarito colui che
sopravvive almeno cinque anni dal giorno della diagnosi. Se
muore dopo cinque anni e un giorno, se alla fine del quinto
anno ha un cancro enorme che lo sta divorando, sempre di paziente
guarito si tratta, grande successo della medicina, proprio perché
non è morto nei cinque anni presi in considerazione per
convenzione, o per meglio dire, per convenienza. Perché
cinque anni?
Perché è stato osservato, storicamente, che la
sopravvivenza media di una persona che si ammala di cancro,
si attesta proprio intorno ai cinque anni dal momento in cui
la malattia si manifesta, tranne le forme più aggressive
e a rapida evoluzione, ma questo vale per tutte le malattie,
che possono esitare anche in conseguenze fulminanti.
L'aspettativa media di vita di un malato di tumore attesa attorno
ai cinque anni si palesa sia nel caso che egli si “curi”
sia nel caso non faccia nulla.”
Le argomentazioni di Cantù non sono certo circoscrivibili
alla questione cancro, ma occupano evidentemente gli infiniti
anfratti della relazione tra istituzioni e corpo, della quale
il potere medico-farmaceutico è solo un aspetto, e il
piccolo passo fatto dall'autore per contribuire alla critica
dell'intero sistema va senz'altro nella giusta direzione, ovvero
di un'opera che ha bisogno di contributi molteplici.
Proprio per questo mi pare doveroso dissentire dalla citazione
di Riccardo D'Este che recita: “Ciò che nessuno
scienziato o filosofo dirà mai, è che l'insieme
delle condizioni sociali, l'insieme mondo, ha una valenza più
rilevante, e assai, della somma delle sue parti”.
Al contrario, ritengo che l'elaborazione di un approccio complessivo
all'interazione tra il corpo-mente dell'individuo con quello
degli altri, sia un compito che riguarda tutti, e chi si occupa
di ricerca scientifica dovrebbe essere impegnato in prima fila.
Anche se è tristemente vero che chiunque abbia avuto
esperienza della sanità industrial-tecnologica sa che
nella sua feroce e sarcastica descrizione della “casta
sacerdotale medica”, Cantù coglie pienamente nel
segno.
Giuseppe Aiello
Sindacalismo/
I sindacati “autonomi” tra corporativismo e deriva politicante
La ricognizione del sindacalismo autonomo nato ancor prima
della rottura del Patto di Roma nel 1948, quando venne sancita
la fine del sindacato unitario, formato oltre che dai sindacati
di massa presenti all'epoca dell'immediato secondo dopoguerra,
anche dagli anarchici attivi nella Cgil (non tutti e fra molte
polemiche interne nel movimento), è la materia del libro
di Myriam Bergamaschi I sindacati autonomi in Italia 1944-1968
(BFS Edizioni, Pisa 2017, pp. 336, € 27,00).
 L'autrice
con passione, competenza storica archivista e bibliografica
non comune riporta alla luce una storia sindacale che ha interessato
una consistente porzione del mondo del lavoro impiegatizio ed
operaio di quegli anni. Si tratta del sindacalismo che si pretendeva
autonomo dalla ideologia dei sindacati di sinistra, in particolare
dalla Cgil, nonchè dalla Cisl, dalla Uil e dalla Cisnal,
ma che si rendeva più direttamente correlato ad alcuni
politici di riferimento che si occupavano della gestione governativa
del lavoro dipendente pubblico e privato. Viene concretamente
descritta la modalità di comportamento del sindacalismo
corporativo, che certamente si differenziava dal sindacalismo
della CGIL, della CISL e della UIL ed era diametralmente opposto
alle esperienze che gli anarchici intrapresero in quegli anni
per incidere nel mondo del lavoro, ma che presentava una presa
di massa fra i lavoratori. L'autrice
con passione, competenza storica archivista e bibliografica
non comune riporta alla luce una storia sindacale che ha interessato
una consistente porzione del mondo del lavoro impiegatizio ed
operaio di quegli anni. Si tratta del sindacalismo che si pretendeva
autonomo dalla ideologia dei sindacati di sinistra, in particolare
dalla Cgil, nonchè dalla Cisl, dalla Uil e dalla Cisnal,
ma che si rendeva più direttamente correlato ad alcuni
politici di riferimento che si occupavano della gestione governativa
del lavoro dipendente pubblico e privato. Viene concretamente
descritta la modalità di comportamento del sindacalismo
corporativo, che certamente si differenziava dal sindacalismo
della CGIL, della CISL e della UIL ed era diametralmente opposto
alle esperienze che gli anarchici intrapresero in quegli anni
per incidere nel mondo del lavoro, ma che presentava una presa
di massa fra i lavoratori.
Questa realtà riportata alla luce dall'autrice certamente
fa meditare su quanto fosse compatta e diffusa la resistenza
di una parte non trascurabile dei lavoratori a cambiamenti radicali
negli equilibri delle forze in gioco nel mondo del lavoro. Come
venisse preferita alla lotta di massa, la trattativa di vertice
dei vari sindacati con il politico di riferimento, spesso a
principale favore dei vertici stessi, ma senza escludere importanti
conquiste contrattuali e normative per i sindacalizzati. Eppure
si trattava di esigenze dei lavoratori che pur incentrate sul
“particulare” e col ricorso allo sciopero quanto
meno possibile, erano pur sempre esigenze di miglioramento,
che da questi sindacati venivano rappresentate, sul piano dei
diritti e sul piano economico. Particolarmente interessanti
sono le pagine dedicate all'esperienza del sindacato corporativo
all'Olivetti, alla Comunità dell'Olivetti che sappiamo
quanto sia stata importante per dare spazio di raccoglimento
creativo al nostro Ugo Fedeli. Le pagine dedicate alla nascita
del SIDA alla Fiat forse ci possono aiutare a capire come sia
stata possibile la “marcia di massa” dei 40.000
quadri FIAT a Torino il 14 ottobre del 1980, comunemente indicata
come una linea di svolta delle relazioni sindacali in Italia.
Nell'insieme il libro ci parla di una realtà, quella
sindacale corporativa, che è sostanzialmente diversa
da quella rappresentata dalla CGIL, CISL ed UIL, che in genere,
sul piano della storiografia, non prendiamo in considerazione.
La penultima scheda del libro è dedicata all'USI, della
quale viene tracciata una breve sintesi dalla sua costituzione
a Parma nel 1912 agli anni '60.
Abituati come siamo a tener presente il dibattito che ad Amsterdam
vide nel 1907 Malatesta e Monatte chiarire i termini della questione,
tenuto conto della nutrita bibliografia che in Italia ha trattato
dell'anarcosindacalismo e del sindacalismo rivoluzionario, ricordando
la gloriosa CNT, siamo spronati da questo libro a riflettere
anche sui problemi più comuni e prosaici, ma fondamentali
del lavoro. Come ad esempio l'orario ed il tempo di lavoro al
quale l'autrice dedicò un libro oltre 20 anni fa, sempre
per le BFS edizioni.
Enrico Calandri
Storia/
L'anarchismo in Calabria
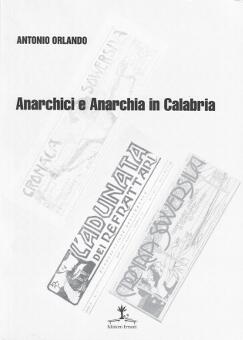 Con
il volume di Antonio Orlando, Anarchici e Anarchia in Calabria
(Cosenza 2018, pp. 352, € 15,00), prefazione di Donatella
Arcuri, la Casa editrice di Emilio Pellegrino, “Edizioni
Erranti” (CS), inaugura la collana Refractaria,
destinata ad ospitare opere che riguardano storie di anarchici
e di anarchismi. Antonio Orlando è uno degli storici
calabresi che ha dato tanto e, conoscendo i suoi progetti futuri,
darà ancora molti contributi alla ricerca storica sulla
Calabria. Avvocato, docente di discipline giuridiche negli istituti
superiori, è socio di varie fondazioni e centri studi
libertari. Terminata con la pubblicazione a cura di Zero in
condotta, la lunga ricerca comune su Francesco Barbieri (Chico
il professore. Vita e morte di Francesco Barbieri, l'anarchico
dei due mondi, 2013) l'autore ha potuto riprendere in mano,
ampliandole ed arricchendole, le storie di vita e di azione
di alcune tra le più importanti individualità
anarchiche calabresi. Dall'impegno eroico di Nino Malara che
scelse di rimanere a Cosenza anche sotto la dittatura, alla
vita avventurosa di Luigi Sofrà a quelle di Cosimo Pirozzo,
Paulino Scarfò, Bruno Misefari, Antonio Pietropaolo e
Alessandro Bagnato è un continuo narrare, “un riannodare
i fili di esistenze spesso sconnesse, in scenari di tribolazione
e disordine, vascelli corsari, non portaerei, diretti non si
sa bene verso quale forma di libertà compiuta o infelicità
personale ineludibile”. Nel volume, oltre agli scritti
scelti sui singoli anarchici su citati, vi sono quattro capitoli
che riguardano la storia collettiva. Il primo di questi racconta
la storia della “presenza anarchica” in Calabria
tra ottocento e novecento, un filo che, come ha scritto Paolo
Finzi nella prefazione al libro di Leo Candela “Breve
storia del movimento anarchico in Calabria dal 1944 al 1953”
Sicilia Punto L, edizione Ragusa 1987, “non si è
mai spezzato”. Il secondo ricostruisce le difficili fasi
della riorganizzazione del movimento libertario dopo la seconda
guerra mondiale, il terzo parla della “strategia della
tensione” e dello strano e misterioso incidente stradale
di Ferentino (FR). Il 26 settembre 1970, in quell'incidente
persero la vita cinque ragazzi, quattro calabresi e una tedesca,
tutti anarchici, che indagavano, oltre che sull'intreccio mafie
- massoneria deviata- neofascisti sulla bomba fatta esplodere
sui binari della ferrovia, nei pressi della stazione di Gioia
Tauro (RC), mentre transitava il treno Freccia del Sud diretto
da Palermo a Torino, che provocò la morte di sei persone
e il ferimento di altre 70. Nel quarto capitolo dal titolo “L'ultima
mazurka”, sull'attentato al Kursaal Diana di Milano del
1921, il racconto di Antonio Orlando si fa quanto mai preciso
e toccante. Apprendiamo ad esempio, dai suoi scritti, che fu
Antonio Gramsci, a seguito dell'impossibilità di Umberto
Terracini ad assumere incarichi legali, poiché in partenza
per Mosca, ad indicare il ventiquattrenne avvocato comunista
Leonida Repaci, calabrese originario di Palmi (RC), già
collaboratore del giornale L'Ordine Nuovo, come difensore
di uno degli imputati minori di tale attentato: il calzolaio
pugliese Federico Giordano Ustori. Dopo 18 udienze, il processo
si chiude e il 1 giugno 1922 viene emesso il verdetto. L'unico
degli imputati che verrà assolto, con formula piena,
è proprio Federico Ustori. Come accadrà all'On.le
Giovanni Amendola, qualche anno dopo, a Leonida Repaci i fascisti
la faranno pagare immediatamente. Il giovane avvocato calabrese
verrà aggredito in Galleria Vittorio Emanuele II°
a Milano dalle squadracce nere e verrà selvaggiamente
bastonato a sangue. Con
il volume di Antonio Orlando, Anarchici e Anarchia in Calabria
(Cosenza 2018, pp. 352, € 15,00), prefazione di Donatella
Arcuri, la Casa editrice di Emilio Pellegrino, “Edizioni
Erranti” (CS), inaugura la collana Refractaria,
destinata ad ospitare opere che riguardano storie di anarchici
e di anarchismi. Antonio Orlando è uno degli storici
calabresi che ha dato tanto e, conoscendo i suoi progetti futuri,
darà ancora molti contributi alla ricerca storica sulla
Calabria. Avvocato, docente di discipline giuridiche negli istituti
superiori, è socio di varie fondazioni e centri studi
libertari. Terminata con la pubblicazione a cura di Zero in
condotta, la lunga ricerca comune su Francesco Barbieri (Chico
il professore. Vita e morte di Francesco Barbieri, l'anarchico
dei due mondi, 2013) l'autore ha potuto riprendere in mano,
ampliandole ed arricchendole, le storie di vita e di azione
di alcune tra le più importanti individualità
anarchiche calabresi. Dall'impegno eroico di Nino Malara che
scelse di rimanere a Cosenza anche sotto la dittatura, alla
vita avventurosa di Luigi Sofrà a quelle di Cosimo Pirozzo,
Paulino Scarfò, Bruno Misefari, Antonio Pietropaolo e
Alessandro Bagnato è un continuo narrare, “un riannodare
i fili di esistenze spesso sconnesse, in scenari di tribolazione
e disordine, vascelli corsari, non portaerei, diretti non si
sa bene verso quale forma di libertà compiuta o infelicità
personale ineludibile”. Nel volume, oltre agli scritti
scelti sui singoli anarchici su citati, vi sono quattro capitoli
che riguardano la storia collettiva. Il primo di questi racconta
la storia della “presenza anarchica” in Calabria
tra ottocento e novecento, un filo che, come ha scritto Paolo
Finzi nella prefazione al libro di Leo Candela “Breve
storia del movimento anarchico in Calabria dal 1944 al 1953”
Sicilia Punto L, edizione Ragusa 1987, “non si è
mai spezzato”. Il secondo ricostruisce le difficili fasi
della riorganizzazione del movimento libertario dopo la seconda
guerra mondiale, il terzo parla della “strategia della
tensione” e dello strano e misterioso incidente stradale
di Ferentino (FR). Il 26 settembre 1970, in quell'incidente
persero la vita cinque ragazzi, quattro calabresi e una tedesca,
tutti anarchici, che indagavano, oltre che sull'intreccio mafie
- massoneria deviata- neofascisti sulla bomba fatta esplodere
sui binari della ferrovia, nei pressi della stazione di Gioia
Tauro (RC), mentre transitava il treno Freccia del Sud diretto
da Palermo a Torino, che provocò la morte di sei persone
e il ferimento di altre 70. Nel quarto capitolo dal titolo “L'ultima
mazurka”, sull'attentato al Kursaal Diana di Milano del
1921, il racconto di Antonio Orlando si fa quanto mai preciso
e toccante. Apprendiamo ad esempio, dai suoi scritti, che fu
Antonio Gramsci, a seguito dell'impossibilità di Umberto
Terracini ad assumere incarichi legali, poiché in partenza
per Mosca, ad indicare il ventiquattrenne avvocato comunista
Leonida Repaci, calabrese originario di Palmi (RC), già
collaboratore del giornale L'Ordine Nuovo, come difensore
di uno degli imputati minori di tale attentato: il calzolaio
pugliese Federico Giordano Ustori. Dopo 18 udienze, il processo
si chiude e il 1 giugno 1922 viene emesso il verdetto. L'unico
degli imputati che verrà assolto, con formula piena,
è proprio Federico Ustori. Come accadrà all'On.le
Giovanni Amendola, qualche anno dopo, a Leonida Repaci i fascisti
la faranno pagare immediatamente. Il giovane avvocato calabrese
verrà aggredito in Galleria Vittorio Emanuele II°
a Milano dalle squadracce nere e verrà selvaggiamente
bastonato a sangue.
L'assoluzione di Ustori fu una piccolissima vittoria giudiziaria
inscritta in una immane tragedia umana. I morti innocenti del
Diana, com'è giusto che sia, peseranno per sempre sulla
coscienza degli attentatori. Nei decenni che seguiranno, il
solo ricordo di quella strage costituirà motivo di riflessione
per tutti coloro che, in qualche modo, cercarono di giustificare
o esaltare tali atti perché, come scrisse Camillo Berneri,
“l'enfatizzazione del “gesto eroico” porta
alla riaffermazione di una cultura del dominio e il dominio,
questa volta, sarebbe quello della violenza assoluta e pura”.
Per l'accuratezza e l'originalità del lavoro, questo
libro rientra a pieno titolo tra le migliori opere sull'anarchismo
calabrese. Due sole critiche mi sento di rivolgere ad Antonio.
Al suo posto avrei riprodotto in copertina immagini di esponenti
del movimento anarchico calabrese o titoli di pubblicazioni
diffuse in questa regione e non le testate di due giornali,
seppur prestigiose, ma editate in America. La seconda riguarda
il titolo il quale, a mio avviso, non è rispondente al
contenuto del libro trattandosi di una miscellanea di scritti
scelti, già pubblicati dall'autore e non di una ricostruzione
della storia del movimento anarchico calabrese. L'augurio che
mi sento di fare ad Antonio Orlando è di continuare su
questa linea di ricerca tesa a far riconoscere la storia degli
anarchici calabresi come una componente importante della nostra
identità regionale, affiancando le pregevoli ricerche
effettuate dagli storici del Dipartimento di Storia dell'Università
della Calabria e quelli degli ICSAIC di Cosenza e di Cittanova.
Angelo Pagliaro
angelopagliaro@hotmail.com
Fumetti/
Quell'uccello rom che vigila sul fumetto
Poter guardare il mondo con occhi più puri, bambini,
non tanto contaminati dall'età adulta e dalla razionalità
- spesso con una vena di cinismo dovuto al mondo che ci circonda
- è un dono prezioso che i fumetti o le graphic novels,
per esempio, regalano. Una narrazione diversa rispetto a quella
stimolata in un libro, che gioca con l'immaginazione, suggerendo
attraverso le immagini e una dialogicità più diretta
e continua, il filo conduttore della storia. I fatti si svolgono
in un milieu fatto di colori, tratti e personalità,
delineati non solo dell'autore dei testi, ma anche del disegnatore,
che dà volto a personaggi, spazi e luoghi contribuendo
ad una connotazione più completa, se vogliamo più
coinvolgente, del senso del racconto.
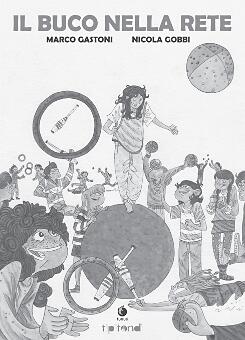 Quando
ho cominciato a leggere Il buco nella rete (di Marco
Gastoni e Nicola Gobbi, edizioni Tunuè, Latina 2017,
pp. 96, € 14,90), lo ammetto, i miei occhi adulti hanno
fatto subito aporia di giudizio sulla possibilità dei
fatti; la classica pallonata che supera i confini della scuola
porta Doriano, un bimbo delle elementari, ad allontanarsi dal
giardino della scuola e a scoprire, nella ricerca della palla,
un campo rom poco distante, dove conosce Miro, un coetaneo che
studia equilibrismo su una palla enorme invece delle solite
materie sui banchi di scuola. I due, dopo un primo approccio
che subito rivela come l'essere bambini travalichi ogni pregiudizio
e stereotipo, instaurano un'amicizia sincera, nutrita di interesse
per l'alterità reciproca che genera curiosità
e dialogo anziché paure e chiusura. Quando
ho cominciato a leggere Il buco nella rete (di Marco
Gastoni e Nicola Gobbi, edizioni Tunuè, Latina 2017,
pp. 96, € 14,90), lo ammetto, i miei occhi adulti hanno
fatto subito aporia di giudizio sulla possibilità dei
fatti; la classica pallonata che supera i confini della scuola
porta Doriano, un bimbo delle elementari, ad allontanarsi dal
giardino della scuola e a scoprire, nella ricerca della palla,
un campo rom poco distante, dove conosce Miro, un coetaneo che
studia equilibrismo su una palla enorme invece delle solite
materie sui banchi di scuola. I due, dopo un primo approccio
che subito rivela come l'essere bambini travalichi ogni pregiudizio
e stereotipo, instaurano un'amicizia sincera, nutrita di interesse
per l'alterità reciproca che genera curiosità
e dialogo anziché paure e chiusura.
La cosa che mi ha subito sorpreso è che nessun insegnante
si arrabbi o si allarmi troppo per la prolungata assenza di
Doriano dalla scuola. I miei occhi adulti suggeriscono un epilogo,
al rientro in classe, con tanto di note, punizioni o richiami.
E invece no, perché Damiano non studia in un normale
istituto ma in una scuola libertaria, dove gli alunni non sono
obbligati a seguire tutte le lezioni ma hanno facoltà
di scegliere le materie e proporre apertamente i propri interessi,
argomentandoli in assemblee collettive dove partecipano studenti
e insegnanti. Primo punto di stimolo per il lettore, a cui viene
ribaltato l'immaginario se abituato a pensare alla scuola come
qualcosa di coercitivo o a cui viene proposta una valida e stimolante
alternativa all'idea di istruzione, se ha la fortuna di non
essere ancora stato fagocitato dal grigio pensare del mondo
adulto. Se avessi letto da bambina questo fumetto non mi sarebbe
affatto sembrato strano che Doriano e Miro potessero instaurare
un'amicizia quotidiana proprio durante le ore di scuola e mi
sarebbe venuta voglia di trovare la scuola libertaria più
vicina a casa.
Per non svelare la trama non dirò altro rispetto alla
sinossi; Doriano condivide con i suoi compagni e con gli educatori
la sua nuova conoscenza e l'interesse dilaga in forma collettiva,
allargata, partecipata. Si stringono nuove relazioni e Miro
ben presto apporterà un grande contributo alla scuola
libertaria, insie-me alla sua famiglia comunitaria e allargata,
ricca di storie da raccontare e abitudini da condividere e la
scuola aiuterà il villaggio rom, perché tutti
hanno bisogno degli altri e perché ognuno è indispensabile
col proprio sapere.
In tutto il fumetto abbiamo un altro punto di vista, che definirei
quasi “animalista”, che è quello di un piccolo
personaggio volatile, presente in quasi tutte le tavole, a volte
come personaggio secondario, altre come trait d'union
visivo e significante della vicenda. Uno sguardo dall'alto che
interagisce con silente sapienza con i vecchi saggi della comunità.
È la cutrettola, uccello simbolo della cultura rom come
spiega poi la nonna di Miro, libero e senza confini come dovrebbero
essere le menti umane. Il lieto e meritato fine del fumetto
dovrebbe farci riflettere sul fatto che non è così
difficile in fondo poter coesistere, abbattere muri e lanciare
palloni alla scoperta di mondi diversi da quelli a cui siamo
abituati, che nascondono meraviglie interessanti e non solo
stereotipi che ci hanno inculcato.
Certo bisogna avere cuori puri, come quelli dei bambini, che
non giudicano né sentenziano chiusure solo perché
si trovano davanti a realtà diverse, ma che da esse anzi
trovano stimolo e alimentano curiosità meticcciando saperi
e culture.
Gaia Raimondi
|