
L'osteria dei soprannomi
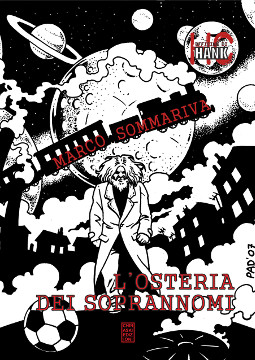 Per
passare attraverso questo libro e arrivare alla fine non ci
si può accontentare di una lettura superficiale. Neanche
questa volta: i libri di Marco Sommariva, già lo sapevo,
non sono roba da portarsi in borsa in spiaggia, né buoni
per passare un'ora buca al caffè. Serve un certo impegno.
È come se tra le righe che raccontano le storie fossero
scritte altre storie, un po' nascoste, un po' che vengono a
galla. Serve una certa attenzione. Serve un certo rispetto,
se vogliamo. Questo è un po' un caso a parte: certo l'autore
è lo stesso, riconoscibilissimo con quel modo tutto suo
di parlarti. Eppure questo libro è un mondo completamente
a parte rispetto al mucchio di cose che di Marco ho già
letto. È quello più sofferto e difficile. È
quello più meditato, come non accorgersi del grande lavoro
di scavo e rifinitura. Ed è quello che somiglia decisamente
meno al resto. Per dirne una, è molto meno racconto e
molto più trascrizioni di dialoghi, che durano pagine
e pagine lasciando poco posto alle fantasie personali di chi
legge. È più facile farsi entrare in testa questa
storia non tanto figurandosela come possa accadere giusto qui
fuori di casa nel mondo reale, quanto in uno spazio teatrale
o come fosse un film, o un qualchecosa che viene più
facile immaginare dentro un televisore. Altra differenza, secondo
me importante, è che qui dentro non sono stato capace
di trovare della musica. Quella musica che, pur se in forme
diverse, ha sempre caratterizzato fortemente tutte le storie
di Marco che ho letto finora. Qua no. “L'osteria dei soprannomi”
(ed. Chinaski, 15 euro) è per buona parte fatto di silenzi,
e attraverso questi silenzi trasuda una parte importante della
storia, quella “vera”, quella che dà il nome
al libro. Silenzio in forma di episodi brevi che a un certo
punto finiscono e lasciano mezza pagina vuota, per ricominciare
daccapo appena a una ditata di distanza. Silenzio in forma di
pagine scritte poco, giusto due righe, una citazione, una manciata
di parole prese da altre bocche, messe lì in alto a guardare
giù tutto il resto del foglio rimasto in bianco. Silenzio,
soprattutto, in forma di puntini di sospensione messi tra una
frase e l'altra, come se la storia si interrompesse un attimo
a guardarsi intorno e cercare parole in testa, o a cercare respiro,
a cercare un po' ossigeno in mezzo all'aria avvelenata. Silenzi
come aggiustamenti del ritmo, oppure come indecisioni, come
disorientamento. Per
passare attraverso questo libro e arrivare alla fine non ci
si può accontentare di una lettura superficiale. Neanche
questa volta: i libri di Marco Sommariva, già lo sapevo,
non sono roba da portarsi in borsa in spiaggia, né buoni
per passare un'ora buca al caffè. Serve un certo impegno.
È come se tra le righe che raccontano le storie fossero
scritte altre storie, un po' nascoste, un po' che vengono a
galla. Serve una certa attenzione. Serve un certo rispetto,
se vogliamo. Questo è un po' un caso a parte: certo l'autore
è lo stesso, riconoscibilissimo con quel modo tutto suo
di parlarti. Eppure questo libro è un mondo completamente
a parte rispetto al mucchio di cose che di Marco ho già
letto. È quello più sofferto e difficile. È
quello più meditato, come non accorgersi del grande lavoro
di scavo e rifinitura. Ed è quello che somiglia decisamente
meno al resto. Per dirne una, è molto meno racconto e
molto più trascrizioni di dialoghi, che durano pagine
e pagine lasciando poco posto alle fantasie personali di chi
legge. È più facile farsi entrare in testa questa
storia non tanto figurandosela come possa accadere giusto qui
fuori di casa nel mondo reale, quanto in uno spazio teatrale
o come fosse un film, o un qualchecosa che viene più
facile immaginare dentro un televisore. Altra differenza, secondo
me importante, è che qui dentro non sono stato capace
di trovare della musica. Quella musica che, pur se in forme
diverse, ha sempre caratterizzato fortemente tutte le storie
di Marco che ho letto finora. Qua no. “L'osteria dei soprannomi”
(ed. Chinaski, 15 euro) è per buona parte fatto di silenzi,
e attraverso questi silenzi trasuda una parte importante della
storia, quella “vera”, quella che dà il nome
al libro. Silenzio in forma di episodi brevi che a un certo
punto finiscono e lasciano mezza pagina vuota, per ricominciare
daccapo appena a una ditata di distanza. Silenzio in forma di
pagine scritte poco, giusto due righe, una citazione, una manciata
di parole prese da altre bocche, messe lì in alto a guardare
giù tutto il resto del foglio rimasto in bianco. Silenzio,
soprattutto, in forma di puntini di sospensione messi tra una
frase e l'altra, come se la storia si interrompesse un attimo
a guardarsi intorno e cercare parole in testa, o a cercare respiro,
a cercare un po' ossigeno in mezzo all'aria avvelenata. Silenzi
come aggiustamenti del ritmo, oppure come indecisioni, come
disorientamento.
Le persone dentro a questa storia -mai così reali, così
concrete, sembra di riconoscerle tutte- sono travestite da “personaggi”:
ognuna ha per maschera un nome finto, un soprannome appunto.
Una maschera a volte così improbabile e bizzarra che,
come nella vita vera, nasconde per iperbole una verità
troppo evidente. La storia si perde, riaffiora, gira l'angolo
camminando veloce, giusto un momento prima che tu riesca a guardarla
bene in faccia. Si arriva frastornati a pagina 228, e si appoggia
il libro lì, a prendere polvere. Ma no, ecco che ritorna
in mente... ma cosa si sono detti? Aspetta. E ti ritrovi poco
dopo a riassaggiare il libro una briciola alla volta. A cercare
un pezzetto di te dentro ogni pagina, disordinatamente. A rileggere
i nomi dei capitoli, che sembrano titoli di canzoni, o nomi
di poesie.
Pino Masi
Vacanze in Salento, quest'anno. Su QuiSalento (acquisto obbligatorio
per chiunque non intenda trascorrere le serate chiuso in casa)
scrivono che in un paese non distantissimo da dove siamo c'è
un concerto di Pino Masi. Quello della ballata del Pinelli.
Quello di “Quella notte davanti alla Bussola”. Quello
di “Compagno sembra ieri”. Quello lì, insomma.
Primo pensiero: ostrega, non ne ho più sentito parlare
da trent'anni (attaccata come una coda a questa frase c'era
una considerazione davvero sconveniente, che non trascrivo).
Secondo pensiero: andiamoci, dai. Il posto è un circolo
dell'Arci, piccolo ma tenuto bene, a Collepasso, circa a metà
strada tra Maglie e Gallipoli. Mi resta impresso anche adesso
il sorriso sorpreso con cui ci hanno accolto all'ingresso: in
fin dei conti Lucia ed io eravamo solo due turisti ficcanaso
capitati lì a chiedere informazioni di pomeriggio, mentre
stavano pulendo il locale. Sì, è qui, è
stasera. Quando ritorniamo c'è gente, la sala si riempie
tutta poco dopo.
Prima di Pino Masi c'è Giuseppe Santagada, un ragazzo
salentino che canta (e pure bene, va detto) le canzoni di “Storia
di un impiegato” accompagnandosi alla chitarra e con la
collaborazione di un flautista. Sono rimasto favorevolmente
impressionato da come, spesso nel corso della sua esibizione,
Giuseppe si sia staccato da quella che poteva essere comunque
un'onesta riproposizione, per metterci dentro un po' meno di
De André e un po' più di se stesso, tirando fuori
quella sua voce così piacevole, adattando le frasi e
i respiri alla propria personalità. Penso sarebbe bello
sentire anche canzoni scritte di suo pugno. Chissà.
 |
| Pino Masi |
Pino Masi è una bestia strana: i suoi occhi hanno guardato
da vicino quasi settant'anni di storia, li tiene spesso socchiusi
ma quando ti guarda in faccia è come se ti passasse sul
viso due punte da trapano. Quei quasi settant'anni di storia
glieli ritrovi tutti in gola: una voce inaspettata e senza tempo,
solida come un quattromila alpino (lui che è siciliano
e cresciuto a Pisa, vai a dire) che contrasta con la carta geografica
accidentata e ruvida che porta in faccia.
Sono i contrasti, le sorprese, gli spiazzamenti che caratterizzano
la serata. Non è un vero e proprio concerto, nel senso
di ripetizione multipla della sequenza introduzione-canzone-applausi,
quanto una specie di spettacolo di saltimbanchi, approssimativo
e gioioso, davanti al quale si fa fatica a restare seduti (si
starebbe meglio per strada). Sono davvero poche, due o tre forse,
le canzoni eseguite per intero: Masi si interrompe, racconta,
riprende la canzone dall'inizio o da una qualsiasi altra parte,
si interrompe ancora, ci pensa sopra, racconta meglio. Immagino
gli sia impossibile essere anche oggi un cantautore normale.
Non lo è mai stato, un cantautore normale: lo direi piuttosto
un sognatore a voce alta, un utopista irriducibile, uno che
non ha mai smesso di avere voglia di provare a cambiare il mondo.
Non me lo vedo né come monumento vivente alla Coerenza,
né come personificazione della Memoria Storica, men che
meno come jukebox del Bel Tempo Che Fu.
Se Pino Masi fosse una cosa sarebbe un albero centenario con
le radici affondate nel terreno e aggrappate ai sassi, alto
coi rami forti che non hanno paura alcuna di vento pioggia o
grandine dove trovano casa tutti gli uccelli canori del cielo.
A fine serata resta a scambiare parole e strette di mano con
tutti. È a un metro da te a sistemare la chitarra nella
custodia con gli stessi gesti di un guerrigliero che ripone
il fucile, mentre con la testa è già là
dove sarà a cantare domani, o dopodomani.
Marco Pandin
|