
Se ti ribelli,
sei matto
I pazzi vengono definitivamente riconosciuti
dagli psichiatri per il fatto che dopo l'internamento mostrano
un comportamento agitato.
La differenza tra gli psichiatri e gli altri psicopatici è
un po' come il rapporto tra follia convessa e follia concava.
Karl Kraus
Per molto tempo, anche nell'ambito delle ricerche sulla repressione
del dissenso e le persecuzioni subite dagli oppositori del regime
fascista, il ricorso sistematico alla psichiatria e alla reclusione
manicomiale è stato un aspetto storiografico sottaciuto
e sottostimato, come se certi “metodi” fossero una
prerogativa di altri sistemi totalitari, quali quello nazista
o quello staliniano. D'altronde, le stesse vittime, una volta
tornate alla cosiddetta normalità dopo la Liberazione,
il più delle volte autocensurarono il racconto delle
loro vicissitudini attraverso l'arcipelago manicomiale, un po'
per evadere anche dal ricordo opprimente di tale esperienza,
un po' perché comunque probabilmente in molti vi era
il recondito timore di essere ancora presi per pazzi.
 Eppure
è proprio durante il ventennio fascista che si registra
l'incremento dei cosiddetti “manicomi criminali”,
con la costruzione di nuove strutture e di nuove sezioni giudiziarie
presso istituti “civili” già esistenti, nonché
l'aumento – davvero esponenziale – del numero degli
“alienati” internati a seguito di sentenza penale
oppure in applicazione della legge n. 36 nel 1904 (rimasta,
incredibilmente, in vigore sino al 1978!) che prevedeva e regolava
l'internamento negli ospedali psichiatrici di quanti, per presunta
pericolosità sociale o pubblico scandalo, vedevano così
le proprie vite in totale balia del giudizio - e del pregiudizio
- di pretori, procuratori, prefetti, questori, podestà
e direttori di manicomi. Eppure
è proprio durante il ventennio fascista che si registra
l'incremento dei cosiddetti “manicomi criminali”,
con la costruzione di nuove strutture e di nuove sezioni giudiziarie
presso istituti “civili” già esistenti, nonché
l'aumento – davvero esponenziale – del numero degli
“alienati” internati a seguito di sentenza penale
oppure in applicazione della legge n. 36 nel 1904 (rimasta,
incredibilmente, in vigore sino al 1978!) che prevedeva e regolava
l'internamento negli ospedali psichiatrici di quanti, per presunta
pericolosità sociale o pubblico scandalo, vedevano così
le proprie vite in totale balia del giudizio - e del pregiudizio
- di pretori, procuratori, prefetti, questori, podestà
e direttori di manicomi.
Nonostante che tale legge fosse stata emanata dal governo del
liberale Giolitti, l'individuo vedeva annullata ogni tutela
delle proprie libertà ed era consegnato inerme all'arbitrio
statale: essa risultava a tutti gli effetti un dispositivo legale
volto a togliere dalla circolazione i soggetti “devianti”;
infatti, la loro “colpa” e la loro “malattia”
discendeva generalmente da una supposta pericolosità
legata all'essere improduttivi oppure ad eventuali turbamenti
dell'ordine pubblico.
Il fascismo, perciò, accolse pienamente questo impianto
ideologico e, soprattutto dal 1927, lo inserì nel suo
stato di polizia, tanto che «fissò nel Testo unico
delle leggi d Ps (prima del 1926 e poi del 1931) le regole da
attivare per il controllo dei degenerati e delle classi pericolose,
oltre che dell'alienazione mentale», mirando a colpire
ugualmente sospetti oppositori politici, omosessuali, oziosi,
nomadi, alcolisti e altri soggetti marginali.
Particolare non secondario, proprio in pieno fascismo, nel 1938
lo psichiatra Ugo Cerletti (tessera n. 0694914 del Pnf) assunse
notorietà mondiale per «l'italianissima invenzione»
dell'elettroshock. Ad essere colpiti, temporaneamente o in maniera
definitiva, da misure di costrizione manicomiale furono circa
un migliaio di uomini e donne, di varia tendenza o appartenenza
politica, ritenuti pericolosi per la dittatura di Mussolini:
se il termine ha un senso, nella stragrande maggioranza dei
casi non si trattava di «malati di mente», ma di
«avversi al regime»; in non pochi casi, invece,
i disturbi psichici erano diretta conseguenza delle violenze
fisiche e delle torture mentali a cui furono sottoposti nel
corso di spedizioni punitive, in carcere, al confino o dentro
i non-luoghi manicomiali.
Il recente saggio di Matteo Petracci I matti del duce. Manicomi
e repressione politica nell'Italia fascista (Roma, Donzelli,
2014, pp. 238, € 33,00) non solo mette in luce questo aspetto
misconosciuto, ma è la più consistente e approfondita
ricerca sull'argomento, non solo per quanto riguarda l'analisi
dei meccanismi burocratici, polizieschi e psichiatrici che gestirono
questi autentici gironi infernali, ma riesce anche, con sensibilità
e rigore, a farci conoscere le r/esistenze umane che sono rimaste
schedate e rinchiuse per oltre settant'anni nei fascicoli del
Casellario politico centrale e nelle cartelle cliniche.
E raffrontando queste due dimensioni, è possibile riscontrare
come i funzionari di polizia ricorressero alle diagnosi pseudo-mediche
e alle categorie lombrosiane, mentre gli psichiatri accettavano
– con rarissime eccezioni – di svolgere un ruolo
di inquisitori politici, così come le figure degli infermieri
e dei secondini tendevano a confondersi dietro sbarre che, purtroppo,
non appartengono ancora al passato. Discorso analogo per quanto
riguarda l'esile confine che separava il trattamento punitivo
da quello terapeutico, con strumenti e pratiche degne dei supplizi
del Sant'Uffizio.
Tra queste storie, quelle che mi hanno maggiormente colpito
sono senz'altro quelle del militante Secondo B., ritenuto «infermo
di mente per mania politica» in quanto «affetto
da “morbo di Lenin”» e dell'ex-ardito Gaetano
M., giudicato pericoloso «per la sua cultura e la grande
passione per le teorie anarchiche», ma soprattutto quella
dell'operaia Isolina M., diagnosticata ovviamente isterica per
le «sue manifestazioni tumultuarie di impulsività»,
ma che alla domanda su cosa intendesse per fedeltà, aveva
maliziosamente risposto che, nell'attività politica (alludendo
a quella sovversiva), significava «non dire quello che
si fa».
Marco Rossi
Economia / botta...
Ma i magazzini sociali sono anti-commons?
Elementi di una teoria economica dell'anarchia: è il
proposito dell'impegnativo e ambizioso libro di Guido Candela
Economia, stato, anarchia. Regole, proprietà e produzione
fra dominio e libertà (Elèuthera, Milano,
2014, pp. 303, € 20,00). In queste poche righe darò
conto di uno snodo della sua ricerca. In un'economia anarchica,
i soggetti possiedono il proprio lavoro e i beni strumentali
che usano, mentre la produzione dei beni finali avviene con
la collaborazione di più soggetti (pp. 172-178). I Magazzini
sociali sono un'istituzione in cui una parte significativa dei
beni finali «rimane proprietà di tutti coloro che
partecipano all'unità produttiva, e quindi [è]
posta “sotto il governo di tutti quelli che la compongono”
(Proudhon)» (pp. 168-69). Candela sostiene una tesi originale:
nei Magazzini sociali i beni sono anti-commons, «poiché
ogni atto di consumo deve acquisire il consenso di tutti i proprietari»
(p. 172). Questa tesi implica che i Magazzini siano inefficienti.
Infatti l'anti-common è un bene sul quale troppi
proprietari vantano diritti d'uso; ciò rende difficile
a chiunque il suo pieno utilizzo, potendo subire parziali proibizioni
da parte degli altri proprietari. In breve, troppi hanno diritto
di esclusione su una risorsa scarsa; da ciò l'inefficienza.
Ma vorrei obiettare: perché, in anarchia, le risorse
condivise dovrebbero essere anti-commons? Come ci ricorda
Carol Rose in The comedy of the commons, la proprietà
non è soltanto, come “proprietà privata”,
il diritto di escludere gli altri dall'uso o dal godimento di
qualcosa; è anche, come “proprietà intrinsecamente
pubblica”, il diritto di non essere esclusi, di partecipare
alla vita e alla ricchezza comuni, di avere accesso gli uni
agli altri. «Al di là della semplice proprietà
privata e della “pubblica proprietà” soggetta
al controllo statale, esiste la categoria distinta della “proprietà
intrinsecamente pubblica”, non controllata interamente
né dallo stato né da soggetti privati. È
la proprietà “posseduta” e “gestita”
collettivamente dalla società in generale, e vanta una
titolarità che si sottrae ai titoli di qualsiasi pretesa
autorità gerente, e anzi prevale su di essi» (Rose,
1986, p. 720).
Candela annota (p. 190) che una proprietà collettiva,
sostituendosi alle tante proprietà individuali, risolverebbe
l'inefficienza dei Magazzini sociali. Ciò però
succede non soltanto, come lui sembra credere, se la proprietà
è pubblica statale, come nel comunismo di stato, bensì
anche se i soggetti rinunciano volontariamente ai (troppi) diritti
di proprietà privata (che genererebbero gli anti-commons)
a favore della “proprietà intrinsecamente pubblica”.
A sua volta, perché i soggetti dovrebbero passare da
un regime di proprietà privata o pubblica a uno di “proprietà
intrinsecamente pubblica”? A mio avviso, una prima risposta,
in linea con la migliore riflessione marxista e anarchica, segnala
che le forze produttive sono ormai direttamente sociali; che
non ha senso né è possibile misurare la produttività
individuale di un lavoratore, e che è “nelle cose”
che la grande parte della ricchezza sociale sia prima appropriata/condivisa
comunitariamente e quindi distribuita secondo criteri differenti
da quelli che stabilirebbe il mercato. Una seconda e complementare
risposta osserva che vi sono beni/servizi il cui valore cresce
al crescere del numero di quelli che li condividono. Sono i
beni/servizi a costo marginale (quasi) zero come la conoscenza,
la formazione, la socializzazione e la partecipazione; ma sono
altresì i beni/servizi che perderebbero il loro valore
economico se avessero un accesso razionato, come le piazze cittadine
o il web. Questi fondamentali beni/servizi centrati sullo sharing
sono, a mio avviso, l'altra ragione decisiva dei Magazzini sociali.
Come scrive l'antropologo Matteo Aria: «potremmo individuare
i primi due tratti distintivi della condivisone nel fatto che
essa non è una forma di scambio, né si costruisce
sulla proprietà privata. Si tratta di un ambito che rispetto
al dono, in cui è stato spesso schiacciato e nascosto,
non implica il possesso e la circolazione dei beni né
ruota intorno all'obbligo di ricambiare e di conseguenza alla
gerarchia, al debito e all'indebitarsi a vicenda. Al contrario,
riguarda quella spinta a condividere che, valorizzando un sé
relazionale diffuso, costruisce, conferma o consolida un gruppo
e una comunità. Azioni e situazioni segnate dal movente
dichiarato o implicito dello stare, del sentire, produrre, agire
e consumare insieme, che piegano l'efficienza, l'utile e l'interesse
economico a funzioni subordinate; dimensioni e impulsi in cui
gli “io” e le affermazioni individuali si dissolvono,
almeno in parte e temporaneamente, nel “noi”».
Pertanto non occorre, come afferma Candela, che nel Magazzino
«ogni atto di consumo de[bba] acquisire il consenso
di tutti i proprietari» (p. 172, corsivo aggiunto). Infatti
il consenso converge su una regola, che è in prima battuta
di condivisione e soltanto in seconda battuta di ripartizione:
siamo d'accordo che lo sharing di una determinata lista
di beni/servizi migliori il benessere di tutti e di ciascuno?
Se lo siamo, come distribuiamo tra noi il contenuto del Magazzino
sociale?
Nicolò Bellanca
All'autore del libro abbiamo chiesto una replica immediata.
La riportiamo qui di seguito.
Economia / ...e risposta
La vera questione è la proprietà privata
 Direi
che conviene partire dal seguente esempio di Proudhon, che purtroppo
non ho pensato di riportare nel libro, mentre rende molto chiara
la sua idea del 1840 sulla proprietà. L'esempio di riferimento
è quello noto come l'obelisco di Luxor. Si parte
dalla constatazione della differenza fra lavoro isolato e lavoro
comune. Un uomo da solo può erigere un piccolo obelisco,
mentre “la forza immensa che risulta dall'unione e dall'armonia
dei lavoratori, dalla convergenza e dalla simultaneità
dei loro sforzi” può erigere l'obelisco di Luxor.
Il tema proudhoniano è: chi ha la proprietà dell'obelisco
di Luxor? Direi
che conviene partire dal seguente esempio di Proudhon, che purtroppo
non ho pensato di riportare nel libro, mentre rende molto chiara
la sua idea del 1840 sulla proprietà. L'esempio di riferimento
è quello noto come l'obelisco di Luxor. Si parte
dalla constatazione della differenza fra lavoro isolato e lavoro
comune. Un uomo da solo può erigere un piccolo obelisco,
mentre “la forza immensa che risulta dall'unione e dall'armonia
dei lavoratori, dalla convergenza e dalla simultaneità
dei loro sforzi” può erigere l'obelisco di Luxor.
Il tema proudhoniano è: chi ha la proprietà dell'obelisco
di Luxor?
Risponde Proudhon (Che cos'è la proprietà?,
cap. 5): “La mia tesi è questa: Il lavoratore
conserva, anche dopo aver ricevuto il suo salario, un diritto
naturale di proprietà sulla cosa che ha prodotto”
(corsivo nell'originale).
Il lavoro comune ha creato un valore, l'obelisco di Luxor, e
questo valore è di tutti i lavoratori che vi hanno partecipato,
conservandone la proprietà. Secondo Proudhon questo principio
si applica a ogni prodotto frutto di lavoro comune: “un
deserto da mettere a coltura, una casa da costruire, una manifattura
da mantenere in esercizio è come l'obelisco da sollevare”.
Allora: il piccolo obelisco (nell'esempio del mio libro, il
pane o il burro) è di proprietà individuale, mentre
l'obelisco di Luxor (nell'esempio del libro, il pane col burro)
ha più proprietari, cioè tutti i lavoratori (anche
l'imprenditore, dice Proudhon) che hanno contribuito a quello
specifico sforzo comune. Cosicché ho proposto di interpretare
i piccoli obelischi come modello di proprietà unica e
quello di Luxor come modello di anti-common à la Heller.
I prodotti del lavoro comune sono collocati nei Magazzini sociali,
governati per questo da un principio di costo (prezzo vero),
e non nell'impresa in cui un capitalista pretende, pagando il
salario, di escludere gli altri lavoratori dalla proprietà
del loro prodotto, assumendosi così il diritto alla massimizzazione
del profitto. In estrema sintesi, tuttavia, l'inefficienza dei
Magazzini sociali è causata da un equilibrio Cournot-Nash,
effetto del residuo di egoismo individuale implicato dalle singole
proprietà private dei lavoratori.
Comprendo la simmetria dei dilemmi del common ed anti-common,
ma mi sembra che questo modello interpretativo si adegui bene
ad illustrare il pensiero di Proudhon, anche se molti altri
modelli di riferimento potrebbero essere proposti; semmai il
limite del mio ragionamento è nell'assumere come benchmark
dell'efficienza proprio la proprietà privata. In questo
senso si può infatti affermare che Hardin e Heller “sono
dentro un approccio liberale”. Tuttavia, ho fatto questa
scelta perché ho voluto contrapporre lo stato e l'anarchia
sia con riferimento al pensiero economico ortodosso sia usando
il metodo del mainstream: infatti ho pensato che, data
la poca conoscenza dei temi dell'anarchismo fra gli economisti
dell'accademia, una critica interna potesse essere più
efficace di una critica esterna. Questa scelta è stata
valutata positivamente da alcuni referee dell'editore.
Solo nella Parte terza si introduce il dubbio che, inserendo
l'ambiente nel modello, si possa motivare un diverso criterio
di benchmark, e quindi sublimare l'inefficienza dei Magazzini
sociali, o che è lo stesso abbandonare la proprietà
privata come criterio di comparazione. Entrando così
in una visione à la Bookchin.
Comunque il riferimento al metodo mainstream mi sembra
sia stato utile nel dimostrare che solo espellendo, con l'altruismo,
dal modello dei Magazzini sociali il residuo di massimizzazione
implicato dalle singole proprietà private individuali
si può recuperare all'anarchia la stessa efficienza della
proprietà privata. L'equità invece è comunque
implicata dalla condivisione, tema su cui tornerò fra
poco.
Come tu dici, ho trascurato l'approccio di Rose, le “proprietà
intrinsecamente pubbliche”, che invece – come sostieni
– sono una categoria di largo interesse in ogni organizzazione
sociale, comunismo, capitalismo ed ovviamente anche in anarchia.
La mia trascuratezza della categoria economica è un po'
dovuta all'ignoranza e per altro verso al metodo assunto. Nel
modello a due dimensioni non poteva esservi differenza tra un
anti-common di Alef e Bet ed una proprietà intrinsecamente
pubblica di Alef e Bet. In modelli di maggiore dimensione, più
agenti e più beni, vi possono essere sia molti
beni anti-common nei Magazzini sociali, come “scarpe,
zappe, tablet, tagli di capelli, prestazioni sanitarie e così
via”, proprietà degli specifici lavoratori che
hanno contribuito a quella specifica produzione (e scambiati
tramite i voucher), sia beni di proprietà comune
di tutti i lavoratori, seguendo gli esempi e le motivazioni
di Rose. L'anarchismo ovviamente comprende ed esalta questi
beni, spesso immateriali, ed è un mio limite averli trascurati.
Infine, è vero che il Magazzino sociale implica la “condivisione”
della ricchezza prodotta. Secondo Proudhon e Bakunin il criterio
di ripartizione è “a ciascuno secondo il suo lavoro”,
mentre per Kropotkin è “a ciascuno secondo i suoi
bisogni”: nel lavoro comune, non è possibile misurare
la produttività individuale di un lavoratore. La soluzione
che propongo nel testo, accennata ma forse troppo poco rimarcata
a livello di penna, è uno sharing “aperto”,
cioè un qualsiasi criterio è valido purché
condiviso in una scelta pubblica espressa dal comitato dei lavoratori
proprietari. A questo proposito, nella Parte prima, richiamandomi
alla teoria delle scelte pubbliche, sostengo che affinché
questa soluzione sia possibile è necessario che i lavoratori
abbiamo preferenze non-autoritarie e non-invadenti: nello specifico
dei Magazzini sociali, ad esempio, non-autoritarie significa
che per la distribuzione dei voucher non vi siano imposti
a priori; non-invadenti significa che alcuni non pretendano
di più solo per impedire ad altri di averlo. Con questa
interpretazione, mi sembra che la condivisione, come tu stesso
sostieni, sia elemento essenziale per l'anarchismo classico
e post-classico.
Guido Candela
Leggere l'ILVA,
vero e proprio disastro ambientale
 Nell'esaminare
i problemi dell'ILVA, come proposti da tre testi significativi
da poco pubblicati (Giuliano Pavone, L'eroe dei due mari; traduzione
in fumetto de “L'eroe dei due mari”, curata da Emanuele
Boccafuso, Virginia Carluccio, Gabriele Benefico, Walter Trono
ed Alberto Buscicchio, con un contributo di Alessandro Marescotti;
i testi e le storie a fumetti di Carlo Gubitosa e Kanjano in
ILVA, comizi d'acciaio) vorremmo ricordare che alcune di queste
problematiche si vanno chiarendo a seguito dei pieni poteri
concessi al commissario ILVA, Enrico Bondi e dal fatto che l'Italia
si è trovata nel mirino dell'UE a causa dell'ILVA. Nell'esaminare
i problemi dell'ILVA, come proposti da tre testi significativi
da poco pubblicati (Giuliano Pavone, L'eroe dei due mari; traduzione
in fumetto de “L'eroe dei due mari”, curata da Emanuele
Boccafuso, Virginia Carluccio, Gabriele Benefico, Walter Trono
ed Alberto Buscicchio, con un contributo di Alessandro Marescotti;
i testi e le storie a fumetti di Carlo Gubitosa e Kanjano in
ILVA, comizi d'acciaio) vorremmo ricordare che alcune di queste
problematiche si vanno chiarendo a seguito dei pieni poteri
concessi al commissario ILVA, Enrico Bondi e dal fatto che l'Italia
si è trovata nel mirino dell'UE a causa dell'ILVA.
 Le
autorità italiane hanno sempre saputo, ma fingono ancora
di non vedere. Al momento, continuano a garantire all'Ilva di
poter produrre come ha sempre fatto negli ultimi 20 anni. Vogliamo
portarvi la testimonianza del fatto che a Taranto la situazione
non è cambiata, e che tutte le presunte misure prese
dalle istituzioni non sono state efficaci e anche se lo fossero
state, esse non sono state messe in opera. Noi - ha spiegato
Antonia Battaglia, portavoce del Fondo AntiDiossina di Taranto
e di PeaceLink al Parlamento Europeo - stiamo morendo di diossina,
di inquinamento, di aria. Si può morire perché
si respira? Sì, si può. Siamo qui per gridare
con tutta la nostra forza il nostro bisogno di aiuto, la nostra
sete di giustizia. Vi portiamo i sussurri disperati delle mamme
all'Ospedale Moscati di Taranto in attesa che i loro bambini
vengano operati di cancro. Vi portiamo la speranza degli operai
dell'Ilva, la speranza di poter lavorare senza morire. Vi portiamo
le lacrime della gente, la voce di una città a lutto
che ha bisogno dell'aiuto dell'Europa, che ha bisogno di ciò
per cui i nostri magistrati a Taranto lottano e che ci è
negato: la giustizia. Le
autorità italiane hanno sempre saputo, ma fingono ancora
di non vedere. Al momento, continuano a garantire all'Ilva di
poter produrre come ha sempre fatto negli ultimi 20 anni. Vogliamo
portarvi la testimonianza del fatto che a Taranto la situazione
non è cambiata, e che tutte le presunte misure prese
dalle istituzioni non sono state efficaci e anche se lo fossero
state, esse non sono state messe in opera. Noi - ha spiegato
Antonia Battaglia, portavoce del Fondo AntiDiossina di Taranto
e di PeaceLink al Parlamento Europeo - stiamo morendo di diossina,
di inquinamento, di aria. Si può morire perché
si respira? Sì, si può. Siamo qui per gridare
con tutta la nostra forza il nostro bisogno di aiuto, la nostra
sete di giustizia. Vi portiamo i sussurri disperati delle mamme
all'Ospedale Moscati di Taranto in attesa che i loro bambini
vengano operati di cancro. Vi portiamo la speranza degli operai
dell'Ilva, la speranza di poter lavorare senza morire. Vi portiamo
le lacrime della gente, la voce di una città a lutto
che ha bisogno dell'aiuto dell'Europa, che ha bisogno di ciò
per cui i nostri magistrati a Taranto lottano e che ci è
negato: la giustizia.
“Noi non vogliamo morire per la produzione, lo abbiamo
fatto per decenni, è ora di cambiare e abbiamo bisogno
del vostro aiuto. Per favore, non lasciate che il nostro appello
cada nel vuoto”. Queste le parole di disperazione dei
cittadini di Taranto contenute anche nei libri di Carlo Gubitosa
e Giuliano Pavone.
Nel suo romanzo L'eroe dei due mari (Marsilio, Venezia,
2010, pp. 304, € 17,00), Giuliano Pavone ci racconta un
divertente e ben impostato imbroglio calcistico che interessa
tutta la città, non solo quindi i tifosi della squadra,
portandoci nello specifico del paesaggio urbano, dell'impianto
siderurgico, dell'insieme del disegno urbanistico tarantino
che potremmo definire “anonimo”. Tra una partita
e l'altra, tra un gol segnato ed uno mancato, si evidenzia il
contesto ambientale del centro siderurgico, a seguito della
morte di tre operai dell'ILVA nel momento in cui tutti stanno
allo stadio impegnati in una tifoseria che può sconvolgere
solo chi non frequenta gli stadi. Il giocatore Cristaldi, il
brasiliano che avrebbe dovuto portare la squadra in serie A,
stordito dall'evento delle morti in fabbrica, diventa inconsapevolmente
l'uomo della denuncia pubblica quando scende in campo con una
maglia, la quale porta una scritta su morti ed inquinamento,
una decisione che costerà cara a lui, alla squadra e
alla città...
A sua volta il testo ILVA, comizi d'acciaio (BeccoGiallo,
Padova, 2013, pp. 192, € 15,00) denuncia come l'ILVA si
collochi al secondo posto, dopo la centrale termoelettrica Federico
Secondo di Brindisi, fra i 10 impianti italiani che più
fanno male all'ambiente (pag. 64) e non dimentica di ricordare
i lavoratori dell'ILVA come “i martiri dell'acciaio”
a causa delle patologie rilevate in rapporto al resto della
popolazione (pag. 118). Interessante anche la traduzione in
fumetto del romanzo di Pavone, arricchita dalla specifica valutazione
di tutte le patologie che colpiscono operai del siderurgico
e popolazione urbana.
Laura Tussi
L'anarchismo di ieri
e l'anarchismo di oggi
La casa editrice Virus ha pubblicato l'ultimo libro di Tomás
Ibáñez Anarquismo es movimiento* (Barcellona,
2014, pp. 152, € 12,00), nel quale – come riferisce
la quarta di copertina – l'autore affronta la “potente
vitalità” di cui gode oggi l'anarchismo “nell'intero
pianeta” e ci invita e “scoprire le ragioni e le
nuove modalità di tale rinascita, che si manifesta in
particolar modo nel neo-anarchismo e nel post-anarchismo”.
In effetti Anarquismo es movimiento è un libro
denso di idee (anche se non è un testo lungo: ha solo
150 pagine) sull'”impetuoso rinascere dell'anarchismo
nel XXI secolo” e sul “processo grazie al quale
si è reinventato sul triplice piano delle pratiche, della
teoria e della diffusione sociale”, che apre “prospettive
eccellenti per tutte le pratiche di resistenza, di sovversione
e di ribellione che si oppongono alle imposizioni del sistema
sociale vigente”. Ma, soprattutto, come sottolinea l'autore,
è un libro “politicamente impegnato a favore dei
nuovi modi di concepire e di praticare l'anarchismo”:
sia per “contribuire a dare impulso al nuovo anarchismo
che si sta sviluppando” sia per “aiutare a riformularlo
nel contesto dell'epoca attuale”.
|
| La prima edizione italiana
del libro di Tomás Ibáñez
è stata recentemente pubblicata
da Elèuthera (pp.
144, € 13,00) |
Il libro di Tomás Ibáñez è qualcosa
di più di un semplice invito a scoprire e analizzare
il motivo che sta alla base di questa “rinascita dell'anarchismo”
(io direi piuttosto della riattualizzazione del concetto e della
pratica dell'anarchia). Di fatto, si tratta anche di una presa
di posizione che abbraccia queste nuove forme “di concepire
e di praticare” l'anarchia. Vale a dire che, oltre a essere
un libro didattico, è anche un libro polemico, dato che
il suo autore afferma che tale rinascita dell'anarchismo “apre,
infatti, la possibilità di moltiplicare e di intensificare
le lotte contro i dispositivi di dominio, di vanificare più
spesso gli attacchi alla dignità e alle condizioni di
vita delle persone, di sovvertire le relazioni sociali improntate
dalla logica mercantilistica, di strappare spazi per vivere
in un altro modo, di trasformare le nostre soggettività,
di diminuire le disuguaglianze sociali e di ampliare lo spazio
aperto all'esercizio delle pratiche di libertà”.
E lo è perché il suo autore, nell'affermare le
possibilità (reali, non chimeriche) che tale rinascita
dell'anarchismo apre per potenziare le lotte di emancipazione,
ci incita a viverle non in un ipotetico e lontano “domani
o dopodomani”, bensì nel presente; perché
“è nel qui e ora che si realizza l'unica rivoluzione
che esiste e si vive realmente, nelle nostre pratiche, nelle
nostre lotte e nel nostro modo di essere”.
Il libro, quindi, è polemico e lo è sin dall'inizio,
e persino sin dal titolo stesso... Ritenere che l'anarchismo
“è movimento” significa già aprire
il dibattito... Che cosa intende dire Tomás Ibáñez
definendolo in questo modo? Intende forse differenziarlo dai
“guardiani del tempio”, da coloro che “vogliono
preservare l'anarchismo nella forma esatta nella quale lo avevano
ereditato, a rischio di asfissiarlo e di impedirne l'evoluzione?”.
Inoltre, definire rinascita questo fenomeno di riattualizzazione
dell'anarchismo è, come riconosce lui stesso, ritenere
che “era più o meno “scomparso” da
qualche tempo”. È così? Era “scomparso”
o si trattava soltanto di una “eclisse provvisoria”?
Per saperlo, per “accertarsi che le cose siano andate
effettivamente così”, Tomás ci invita a
gettare “un rapidissimo sguardo” alla storia dell'anarchismo,
pur tenendo conto, previamente, di “due scenari teorici
in cui la questione di una eventuale eclisse dell'anarchismo
non si porrebbe neppure...”. Il primo di questi scenari
sarebbe quello nel quale della dicotomia “anarchia versus
anarchismo”, si assume come riferimento l'anarchia più
che l'anarchismo, poiché si ritiene che l'anarchia sia
“una entità ontologicamente distinguibile”,
una “delle molteplici modalità possibili della
realtà”; vale a dire: se attribuiamo al termine
anarchia un significato essenzialista e metafisico invece del
suo significato etimologico, cioè senza dirigenti, senza
sovrani, senza governi. L'altro scenario, che non ha neppure
senso porre, è quello che si presenterebbe se si separa
“l'anarchismo in quanto movimento, da un lato, e l'anarchismo
in quanto contenuto teorico, dall'altro”; perciò,
non solo “gli elementi concettuali o assiologici che lo
caratterizzano” non sono separabili “da un pensiero
sociale che prende forma nell'ambito di condizioni politiche,
economiche, culturali e sociali molto precise, e a partire da
lotte sociali determinate”, ma anche perché, per
accettare una simile separazione, si dovrebbe previamente accettare
l'esistenza di due mondi differenti, come postulavano Platone
e i dualisti (di allora e di oggi).
Così, se “anarchia e anarchismo sono due elementi
inseparabili di un tutto”, in quanto espressione di un
desiderio e di una scommessa per la libertà contro l'autorità,
se inoltre è necessario fondere in “un tutto inscindibile
l'anarchismo come corpus teorico e l'anarchismo come movimento
sociale”, come non riconoscere che, fino a questo punto
e nonostante possibili divergenze riguardo la pertinenza semantica
di questa o quella parola, espressione o concetto, è
difficile non concordare con Tomás in questa prima parte
del suo libro se non si è un anarchico essenzialista
o piattaformista dell'ultima ora. Dove l'identità di
opinioni comincia a essere più polemica è a partire
dalle sue “brevi considerazioni storiche” su una
storia, la storia dell'anarchismo, la quale, come l'autore riconosce
“ha riempito migliaia di pagine e continuerà a
riempirne ancora migliaia”.
È logico che, a partire da questo punto, il libro diventi
più polemico, dato che riassumere in poche righe una
storia così ricca e lunga provoca possibili disaccordi,
poiché la storia, nonostante la pretesa di obiettività
degli storici, è un campo nel quale il soggettivismo
l'ha sempre fatta da padrone. Ma, nonostante i possibili disaccordi
e le polemiche che possono suscitare, l'importante è
che Tomás li prenda in considerazione e che non abbia
paura di dire ciò che pensa. Proprio perché preferisce
suscitare il dibattito argomentando le sue posizioni invece
di rincorrere una approvazione non argomentata.
Così, riassumendo la storia dell'anarchismo a partire
dalla “Rivoluzione francese del 1848, con gli scritti
di Joseph Déjacque, di Anselme Bellagarrique e, soprattutto,
di Pierre-Joseph Proudhon” per arrivare alla Rivoluzione
spagnola del 1936, Tomás afferma che “l'anarchismo
nel corso di questi anni fu un pensiero vivo [...] in contatto
con il mondo nel quale è inserito [...], capace di incidere
sulla realtà”. E, sulla storia successiva e fino
alla fine degli anni sessanta, Tomás ci dice che “l'anarchismo
si ripiegò, si contrasse e praticamente scomparve dalla
scena politica mondiale e dalle lotte sociali per numerosi decenni”,
e “invece di essere una pellicola in movimento”
[...], l'anarchismo andò fossilizzandosi dagli anni quaranta
del Novecento sin quasi alla fine degli anni sessanta”.
Si tratta di affermazioni che, senza dubbio, susciteranno discussioni.
Quindi, benché alcuni di noi le accettino come considerazioni
generali di quei periodi per quanto riguarda l'anarchismo “ufficiale”
(quello delle organizzazioni che pretendevano di monopolizzarlo),
non ci sembra che corrispondano all'anarchismo di coloro che
combattevano tale fossilizzazione e si sforzavano di essere
coerenti con un anarchismo vivo e in contatto con il mondo del
suo tempo.
Analogamente, susciterà polemica anche ciò che
afferma sulla “rinascita libertaria”. Non solo perché
colloca tale rinascita alla fine degli anni sessanta, ma anche
perché ritiene che non avrebbe potuto “spuntare
una nuova tappa di fioritura anarchica” senza i “grandi
movimenti di opposizione alla guerra del Vietnam” nei
“campus di Stati Uniti, Germania, Italia o Francia”
e senza “lo sviluppo in una parte della gioventù
di atteggiamenti anticonformisti, sentimenti di ribellione contro
l'autorità e di sfida nei confronti delle convenzioni
sociali e, infine, con la favolosa esplosione del Maggio '68
in Francia”.
E ciò non solo perché colloca l'origine di tale
fioritura in quei movimenti e più particolarmente nel
Maggio '68, ma anche perché non analizza il motivo per
cui quei movimenti riuscirono a provocarla, nonostante fosse
evidente che, come lui stesso ammette, nessuno di quei movimenti
fosse o potesse essere considerato propriamente “anarchico”:
sia per l'obiettivo concreto che li ha suscitati sia per il
numero di anarchici che vi hanno partecipato. E la stessa cosa
si può dire del favore di cui ha goduto ultimamente l'anarchismo
nelle lotte, nelle piazze e persino negli ambienti culturali
e universitari.
Per questi motivi non deve sorprendere che Tomás concluda
questo primo capitolo, dedicato alla “impetuosa rinascita
dell'anarchismo nel XXI secolo”, ammettendo che “la
rinascita dell'anarchismo ha continuamente fatto passare, per
così dire, di sorpresa in sorpresa” sia lui sia
molti altri; quindi è ovvio che se, quando si sono verificate
queste “sorprese”, fosse stato già consapevole
– come lo è oggi – che è “l'importanza
concessa al fenomeno del potere quella che spiega la potente
attualità dell'anarchismo”, allora non si sarebbe
sorpreso del fatto che l'anarchismo ricompaia e si riattualizzi
in tutte quelle occasioni in cui si pone in modo concreto la
lotta contro la dominazione. Non solo perché l'anarchismo
è l'espressione teorica e pratica più in consonanza
con il rifiuto di tutte le forme in cui la dominazione si manifesta,
ma anche perché da tempo la storia lo ha “assolto
dall'accusa di essere rimasto cieco di fronte alle cause principali
dell'ingiustizia e dello sfruttamento, che alcuni situavano
esclusivamente nell'ambito dell'economia”. Né dobbiamo
dimenticare che da molto tempo la storia ha evidenziato il carattere
illusorio delle alternative che promettevano la libertà
attraverso la sottomissione.
Ebbene, non è perché Tomás è consapevole
di ciò né perché ciò costituisce
la base della sua analisi che il terzo e quarto capitolo del
libro, smetteranno di dare adito alla discussione e alla polemica.
Anzi, poiché sia la rinascita/rinnovamento sia il post-anarchismo
sono problematiche che, nonostante siano motivate da un indiscutibile
desiderio di perfezionismo dell'anarchismo che li ha preceduti,
sono necessariamente sottomesse al soggettivismo interpretativo
dei lettori, così come lo sono a quello dei protagonisti
di tali iniziative innovatrici...
Infine, che tale rinnovamento assuma la forma che Tomás
definisce neo-anarchismo, su un piano più pratico, e
post-anarchismo su un piano più teorico, e che entrambe
derivino da “una nuova analisi dei rapporti di potere
e delle caratteristiche assunte dall'esercizio del potere nella
società contemporanea”, non le avalla come forme
definitive dell'anarchismo odierno e ancor meno le esime da
critiche e polemiche. Perché è evidente che una
cosa è integrare nella riflessione anarchica “la
critica post-strutturalista/post-moderna, soprattutto nella
sua variante foucaultiana” e un'altra è ridurre
l'anarchismo a tale critica. Soprattutto perché, come
riconosce Tomás per il post-anarchismo, quest'ultimo
e l'anarchismo classico “si differenziano, di fatto, piuttosto
poco”, e anche perché lo stesso Saul Newman “ha
addolcito, per così dire, la sua critica nei confronti
dell'anarchismo classico, sfumando le recriminazioni contro
i suoi contenuti moderni e prestando maggiore attenzione alle
continuità che alle contrapposizioni tra i due anarchismi”.
Il che trasforma il post-anarchismo in un esercizio di pura
“creatività intellettuale anarchica”.
Da ciò discende il fatto che, consapevole che le sue
convinzioni come le sue ipotesi “possono suscitare adesioni
in alcuni oppure provocare riserve in altri”, Tomás
ci propone, nel quinto e ultimo capitolo del libro, una “prospettiva
libertaria” sulla base di cinque questioni, che lascia
aperte come possibili piste dei “percorsi attraverso i
quali l'anarchismo dovrà imboccare, con passi più
decisi di quelli praticati oggi, per proseguire nella sua espansione
e approfondire il suo rinnovamento”.
Si tratta di piste che sicuramente susciteranno adesioni e riserve,
come quelle suscitate nei quattro capitoli precedenti e quelle
che potranno suscitare le tre Adendas che completano
il libro. Sono Adendas che, poiché riguardano
“la questione del moderno e del postmoderno, il post-strutturalismo
e il relativismo”, possono essere consultate da quanti
desiderano “approfondire più in specifico”
quello che è “l'argomento principale del libro”.
Cosa che, a mio parere, aumenta l'interessa della lettura di
Anarquismo es movimiento.
Octavio Alberola
traduzione dal castigliano di Luisa Cortese
* Questo libro sarà prossimamente pubblicato
in francese, italiano e portoghese e può essere scaricato
al sito www.viruseditorial.net/pdf/anarquismo_es_movimiento_baja.pdf.

Il vescovo
“dimissionato”
Nelle prime competizioni elettorali della nascente Repubblica
italiana, in quelle dal '46 al '49, nei paesi che ricadevano
nella diocesi di Patti (Me), il partito della Democrazia Cristiana
subiva clamorose sconfitte alle amministrative mentre risultava
vincente in quelle nazionali.
La colpa del fallimento, i notabili
locali della D.C., la attribuirono al vescovo, Angelo Ficarra,
che poco o nulla faceva, secondo loro, per propagandare il partito
dei cattolici e i suoi candidati: e se ne lamentarono con la
Santa Sede, richiedendo, peraltro, un duro intervento dell'organismo
preposto al controllo dei vescovi, affinché si convincesse
monsignor Ficarra a “dimettersi”. Cosa che avvenne
nel '53, rendendo la vicenda di Ficarra, nel clima problematico
del secondo dopoguerra, emblematica dell'impossibilità
di dissentire, all'interno della chiesa, dalla gerarchia e di
pensare come distinte le sfere della politica e della religione.
Rimosso in fretta dalla memoria del clero siciliano e poco citato
nelle ricostruzioni delle vicende storiche della chiesa nell'Isola,
il “caso Ficarra” venne scoperto da Sciascia, che
ne scrisse, nel '79, in Dalla parte degli infedeli ed
ora viene ripreso con approfondito acume analitico da Enzo Pace
(Angelo Ficarra. Un vescovo senza chiesa, Morcelliana,
2014, pp. 152, € 15,00) che mostra come, oltre alle ragioni
politiche del “dimissionamento” forzato di Ficarra,
ve ne fossero altre, legate alla sua visione modernista del
cattolicesimo, inaccettabile in quegli anni ma anticipatrice
del Concilio Vaticano II.
Silvestro Livolsi
Sale da ballo
e rivoluzione
La società spesso perdona il criminale
ma non perdona mai il sognatore
Oscar Wilde, Il critico come artista
È da poco uscito anche in Italia (con oltre sei mesi
di ritardo dalla prima mondiale) Jimmy's Hall (2014,
109 min.) ultimo film di Ken Loach. Ultimo nel senso di più
recente, e nel senso che sarà l'ultimo – stando
alle dichiarazioni del regista. Che senso e valore può
avere “la critica da giornale” di un film? Giustificare
una valutazione da 1 a 10? Scrivere quattro righe per orientare
il pubblico? Lasciamo questo ingrato mestiere ai professionisti
salariati che lo fanno per guadagnare la pagnotta, e che hanno
visto in questo film: “un invito alla gioiosità
per la sinistra europea”, “il ruolo repressore della
Chiesa”, “un western politico dove i cattivi vincono
sui buoni”.
Non so che senso possa avere scrivere delle parole riguardo
a un film (quindi soprattutto ad un'emozione); lo faccio per
Loach e per me, per “riflettere”, per un'urgenza
di dire qualcosa in più, perché questo spettacolo
merita di proseguire anche dopo calato il sipario. Perché
non si perda tutto nel senso di straniamento e leggera desolazione
che accompagna sempre la fine di qualsiasi film. Jimmy's
Hall non merita questo.
|
| Una scena del film Jimmy's Hall |
Il genio Stanley Kubrik aveva ammesso di non essersi mai veramente
posto il problema del cinema, ovvero perché uno strumento
tecnico (la cinepresa) dovesse venir utilizzato soltanto (almeno
“artisticamente”) per “rendere” sullo
schermo un racconto, una storia, o ciò che ha sostituito
la pièce teatrale. Lo stesso fa Loach, come tanti
altri registi di successo: non sperimenta, non cerca avanguardismo,
semplicemente accetta le regole del “cinema come spettacolo”
e gioca a quel gioco. Se Loach lo ha fatto sempre bene è
prima di tutto perché ha sempre fatto coincidere l'estetica
con l'etica (e viceversa); la non improvvisabile conditio
sine qua non che (almeno nel contesto contemporaneo di decomposizione
e corruzione artistica), dal cinema alla letteratura, dal teatro
alle arti figurative, differenzia l'artista dalla schiera sempre
più vasta degli intrattenitori, dei professionisti-dilettanti,
di chi ne ha solo velleità. Per questo Loach è
tra i pochissimi che meritano attenzione. Tanto più se
si tratta del film che ne dovrebbe segnare l'uscita di scena.
Già dalle anticipazioni dello show, si può dire
almeno una cosa: l'Irlanda. Loach torna a scegliere l'Irlanda,
dopo l'Agenda Nascosta, dopo il capolavoro The wind
that shakes the barley. Sceglie l'Irlanda per la terza volta,
anche per il suo ultimo film. E questo è già dire
qualcosa, considerando come gli inglesi - al connazionale Loach
- non hanno mai perdonato la sua netta presa di posizione in
favore dell'Irlanda.
Su Jimmy's Hall non ci sarebbe molto da dire, ad un livello
base di “lettura”: è un racconto che può
emozionare alcuni, annoiare altri. La premiata coppia Laverty
(sceneggiatura) e Loach sviluppa una storia dalla trama volutamente
“banale” sulla figura di James Gralton, attivista
sociale irlandese degli anni '20 – '30, realmente vissuto.
Il soggetto non ha la carica emotiva o immaginaria che può
venir data dalla guerra civile spagnola o la guerra d'indipendenza
irlandese, e neanche l'agilità e la godibilità
di un'intelligente commedia. Tuttavia Jimmy's Hall compensa
alla grande offrendo altri livelli di lettura, e infiniti piani
che si intersecano. È impossibile raccontare un film
a parole, stupido dare giudizi, ma è possibile e opportuno
elaborare delle emozioni, condividere delle prospettive.
Scegliendo un tale soggetto (isolato nel tempo, nello spazio,
nella Storia), Loach non poteva fare di meglio per poter parlare
dell'urgenza e della battaglia dei nostri giorni, o se preferite
di un secolo dopo le vicende di Jimmy Gralton. C'è una
crisi finanziaria mondiale che aleggia attorno alla campagna
millenaria irlandese, c'è un ordine fasullo (stato e
chiesa, nelle loro effettive e terribili declinazioni locali)
ri-nato dalla “rivoluzione” e “naturalmente”
imposto sulla vita degli abitanti.
Il ritorno di Gralton in un contesto così piccolo e chiuso
rispetto alla New York in cui si era “andato ad esiliare”,
segna l'inizio della fiction, che ruota attorno alla Hall, un
vero “centro sociale”, nel senso non politicizzato
(quindi veramente politico) di casa del popolo, spazio di tutti.
Il pericoloso “comunista” Gralton (così viene
visto dalle allarmate autorità locali) non riesce a stare
“lontano dai guai”, anche se in realtà sono
gli stessi abitanti del luogo, nella loro parte più ribelle
e innocente, a dar voce alla richiesta di riaprire la Hall di
Gralton. E Jimmy sa bene a cosa si andrà incontro, sa
tutto fin dall'inizio. Ma è impossibile non tentare,
non c'è altra scelta. Come sapranno tutti quelli che,
come Gralton, conoscono un senso del dovere che va ben al di
là della cosidetta “educazione civica”.
Jimmy uscendo dalla Hall abbandonata e sorpreso dai suoi amici
sul “luogo del delitto”, risponde a chi gli chiede
se è pronto a ricominciare: “life's too short”.
La vita è troppo breve, per non lottare, per non rischiare,
anche se si trattasse di giocare il tutto per tutto, anche se
in fondo non è che per una piccola sala da ballo. La
vita è troppo breve per non scegliere la parte della
vera giustizia (che ovviamente non è quella da cui Gralton
dovrà sfuggire), per non tentare neanche di costruire
un vissuto quotidiano non solo più giusto, ma più
divertente, più vivo, più felice. Più umano.
E la Jimmy's Hall, che lui ne sia consapevole o meno,
è una sorta di testamento, che Loach ha voluto lasciare
a tutti, a un destinatario generico che potrebbe essere anche
l'universo.
Magari non troppo volontariamente - così come il poeta
trova la poesia per il solo seguire l'assonanza di un verso,
senza “saperlo” - Loach ha voluto indicare nella
Hall una via da seguire nell' “Irlanda” globale
di questi nostri anni, indicando una via fatta di “semplici”
esseri umani che si unificano in uno spazio e un tempo di vita
grazie al processo di costruzione di un gioco collettivo - o
ancor meglio di una danza collettiva - che profuma di dignità,
di giustizia, di vita.
C'è molto altro nel film, che è giusto non tentar
di rendere a parole. Il ruolo del parroco, con la sua cieca
e folle ma consapevole povertà spirituale; l'amorevole
madre di Jimmy preoccupata che gli stivali del figlio siano
puliti e dignitosamente orgogliosa delle sue scelte, tanto nobili
quanto coraggiose (e quindi discutibili). E tutte le figure
minori, sempre nella “banalità” apparente
della trama, prese singolarmente portano piccoli messaggi e
piccoli insegnementi a sé stanti. Come la figlia ribelle
del fascista, il vice parroco (nella sua lieve evoluzione),
i ragazzi in bicicletta (elemento silenzioso che fa da sfondo
a tutto il film, forse anche questo da inserire nel testamento
di Loach?).
Poi c'è la cosidetta “storia d'amore” tra
Gralton e la sua amata O'onag, inventata da Loach e Laverty
ed enfatizzata dal sottotitolo del marketing italiano (Jimmy's
Hall – Una storia d'amore e libertà). Ancor meno,
se c'è di mezzo l'amore tra donna e uomo, è il
caso di rendere a parole un mix di immagini, musiche, dialoghi.
Però una cosa si può dire: è un altro articolo
del “testamento di Loach”; l'unione tra una donna
e un uomo, unione profonda, fisica ma ancor più unione
spirituale, senza tempo, come elemento fondante, sia individuale
che collettivo, di evoluzione nella lotta e nella danza della
vita. Una “lotta” amorosa su cui, in un livello
diverso, incombono in fondo le stesse minacce che vogliono la
chiusura della Hall.
Alla fine la Hall va in fiamme, il pericolo Gralton viene allontanato
per sempre, perché una semplice sala da ballo può
essere abbastanza per smascherare tanti inganni, tanti autoritarsimi
che mantengono, senza un vero motivo, donne e uomini in catene.
Ma alla fine chi sono i vincitori e chi i perdenti? Si può
dire che Gralton, come tanti altri, perde vincendo o vince perdendo.
Ma poco conta. Di sicuro resta il fatto che, in fondo, tutti
perdono una stessa cosa, un qualcosa di grande, di importante,
di gioioso. E perché? Soltanto per follia, per crudeltà,
per arrettratezza culturale, umana, spirituale, per paura. Ma
i giovani diventano vecchi, e i vecchi muiono, e la battaglia
rimasta in sospeso ritorna e ritornerà di continuo, come
ritorna anche oggi dovunque.
Con il suo ultimo sorriso sincero e lieve ai suoi giovani amici
estimatori, Jimmy Gralton non può che dire anche a ciascuno
di loro: “Quanto stai lottando per la giustizia, per la
felicità collettiva? O forse sei disposto a rinunciare
a ogni lotta, e ritirarti a una tranquilla vita privata, dove
dominano l'indifferenza, l'egoismo, la sottimissione?”.
Senza dubbio Jimmy's Hall è una storia d'amore,
ma non tanto per le pur splendide parentesi di quel surrogato
tanto “pubblicizzato” che è il rapporto uomo-donna,
ma per l'amore come forza universale che unisce e muove tutto
e tutti, e che spinge Jimmy a fare ciò che fa. Quell'amore
che hanno vivo in loro tutti i bambini, gli animali, le piante,
e quell'amore che in padre Sheridan, il parroco nemico di Gralton,
è soffocato e accecato. Quando Gralton dice al parroco
“nel tuo cuore c'è più odio che amore”,
il film ci chiede anche: “Quanto amore c'è vivo
in te? nella tua vita? Quanto ne trasmetti? Quanto odio? Quanta
paura? Quanto coraggio?”.
Un'altra parola chiave del testamento di Loach: il coraggio.
Tutta la figura di Gralton è costruita secondo il cliché
dell'eroe: innazitutto perché è solo, pur essendo
parte di un gruppo (infatti solo lui verrà arrestato,
solo lui scapperà). L'eccezzionalità di questo
eroe, non sta in abilità fisiche, nel maneggio delle
armi, e nemmeno in una particolare elevazione culturale o capacità
oratoria. È eccezzionale perchè ha coraggio, e
in più - in quanto simbolo - ha la capacità di
trasmetterlo agli altri. Il coraggio di Gralton è autentico
coraggio, capacità e forza morale di agire nonostante
la paura (delle conseguenze, del giudizio). Uno stato dell'essere
umano, alla portata di tutti, e un bene prezioso in una società
che lo reprime nella stessa misura con cui “incoraggia”
alla passività e al conformismo.
C'è chi ha voluto vedere similitudini un po' campate
in aria con altri registi, o altre pellicole dello stesso Loach
come Terra e Libertà, o il più recente
Angel's share, oltre all'ovvio richiamo a Il vento
che accarezza l'erba. A me è venuto spontaneo ritornare
a Kes, il primo lungometraggio di Loach (del lontano
1969). Lì si racconta la vicenda di un ragazzino (Billy)
che nello squallore umano e ambientale di un sobborgo industriale
inglese, trova un falchetto. Gli dà un nome, Kes
appunto, e se ne innamora e impara ad addestrarlo, e trova in
Kes l'amore, la gioia e la richezza che né la famiglia,
né la scuola, né niente altro di una vita povera
e crudele riescono a dargli. Fino a quando Kes verrà
barbaramente ucciso, dal “malvagio” fratello maggiore
di Billy.
Ben 45 anni dopo Loach ripropone in fondo lo stesso tema, con
al posto del falco una sala da ballo, al posto di un bambino
un attivista socialista, segnando il passaggio da una dimensione
di individualità e di innocenza, ad una evoluzione che,
per forza di cose, deve essere collettiva. Forse il nucleo del
messaggio di Loach è questo: la battaglia è (deve
essere) collettiva. Solo unendosi gli uni agli altri si può
ottenere una casa dignitosa per tutti, che nessuno venga sfruttato,
che ciascuno abbia il sacrosanto diritto di dedicare la vita
a un falco, a una sala da ballo o a ciò che il suo cuore
più desidera. In una rete di fratellanza, in cui ognuno
corre in soccorso dell'altro; dove non c'entra niente la “politica”
(l'esser “politicizzati”), dove non c'entra niente
né Marx né il Vaticano; dove non c'è nessun
fratello che uccide un altro fratello, nessuna divisione, ma
ci sono protestanti e cattolici che manifestano a Belfast gli
uni a fianco agli altri.
Resta sul film “l'idiozia” di fondo del cinema:
perché spendere energie per ri-creare questa Hall in
una finzione impalpabile e non nella realtà quotidiana?
Se non c'è un giudizio, non è tanto per il sacrosanto
diritto-dovere all'inutilità dell'arte, ma per la speranza
che questo messaggio universale possa essere anch'esso una piccola
scintilla che faccia divampare un fuoco benefico, e che questo
fuoco si propaghi dovunque.
Non so quante persone hanno visto e trovato bello o gradevole
questo film, ma certo sarebbe sufficiente che poche persone
si unissero per fare cose tanto piccole quanto enormemente ammirevoli
e stra-ordinarie; specialmente per chi le crea e chi le vive,
proprio come la Hall di Jimmy.
Ricordando che, non c'è (o almeno non ci dovrebbe essere)
bisogno di nessun Jimmy Gralton per aprire dovunque delle sale
da ballo un po' speciali (anche solo - tanto per iniziare -
come spazi mentali e di relazioni umane), dove possano danzare
gli spiriti, i desideri, i sogni delle persone. Perché
la vita è breve per tutti noi, non solo per Jimmy Gralton.
E come nel film è evidente quanto siano stupidi e malvagi
“i cattivi”, così deve essere evidente quanto
sia stupido e malvagio arrivare un giorno a rimpiangere di non
aver fatto tutto quel che si poteva provare a fare per una vita
più giusta e felice; per tutti, ma prima di tutto per
se stessi, per ciascuno di noi, nell'individuale che può
trovare piena richezza solo nella condivisione collettiva.
Michele Salsi
Donne dietro le sbarre/
Più consapevoli che vittime. E ribelli
 La
ricerca qualitativa (Recluse. Lo sguardo della differenza
femminile sul carcere, Ediesse, Roma, 2014, pp. 315, €
16,00), condotta nel 2013 da Susanna Ronconi, formatrice, Grazia
Zuffa, psicologa, in collaborazione con la Società della
Ragione, nei carceri di Firenze Sollicciano, Pisa e Empoli,
raccoglie e analizza interviste a donne detenute - in gran parte
tra i 26 e 35 anni - personale educativo e agenti di polizia
penitenziaria. La finalità: contenere la sofferenza e
prevenire gesti di autolesionismo e suicidi, con attenzione
alla differenza femminile in un sistema carcerario pensato e
strutturato su un modello maschile. La
ricerca qualitativa (Recluse. Lo sguardo della differenza
femminile sul carcere, Ediesse, Roma, 2014, pp. 315, €
16,00), condotta nel 2013 da Susanna Ronconi, formatrice, Grazia
Zuffa, psicologa, in collaborazione con la Società della
Ragione, nei carceri di Firenze Sollicciano, Pisa e Empoli,
raccoglie e analizza interviste a donne detenute - in gran parte
tra i 26 e 35 anni - personale educativo e agenti di polizia
penitenziaria. La finalità: contenere la sofferenza e
prevenire gesti di autolesionismo e suicidi, con attenzione
alla differenza femminile in un sistema carcerario pensato e
strutturato su un modello maschile.
Lontano da stereotipi, l'analisi rivela che le donne si dimostrano
più consapevoli che vittime, sono le prime nella ribellione
verso l'autorità della pena. Avanzano richieste di forme
alternative alla carcerazione, dimostrando l'estraneità
della donna alle strutture di coercizione. Come sottolinea Susanna
Ronconi, la ricerca rivela l'inganno che attribuisce una minorazione
della donna carcerata a “deficit del femminile”,
anziché addebitarla all'istituzione totale, che di questa
minorazione è costante riproduttrice.
Le narrazioni biografiche denunciano la dimensione della spersonalizzazione,
del corpo percepito come oggetto di controllo, e una forte dose
di sofferenza aggiuntiva per l'attesa protratta senza risposte
alle richieste, seguita da una percezione di impotenza e abbandono.
Soprattutto dalle biografie materne si coglie l'ambivalenza
dell'essere madre in carcere: i primi ad essere sacrificati
sono gli affetti familiari, i figli. La madre carcerata si sente
oppressa da ulteriori sensi di colpa per il ruolo di figlia,
costretta a dover demandare a madri-nonne l'azione di cura dei
propri figli.
Ma essere madre e figlia carcerata può voler dire, allo
stesso tempo, avvertire un debito di cura nei confronti della
propria madre malata. Inoltre, sapere che le relazioni a casa
vengono intessute dalla donna e la sua assenza può determinare
rottura definitiva degli equilibri, già precari, genera
un senso di perdita del ruolo affettivo.
Tuttavia, Grazia Zuffa vede nella rete familiare delle “madri
che curano le madri” un'altra faccia del materno, non
ancora valorizzata. Così come andrebbe ripreso il lavoro
sulla retorica pervasiva e pericolosa della funzione riabilitativa
del carcere: il maschio deve diventare un “onesto cittadino
e lavoratore”, la donna tornare a essere o diventare una
“buona madre” plasmata su un modello liquido, confuso
e molteplice. Tuttavia le donne recluse - solo il 4% di tutta
la popolazione carceraria - diventano un cristallo attraverso
il quale la società cerca di ristabilire una norma. La
maternità incarna ancora oggi la “onestà
e virtù” femminile: con il reato si tradisce la
maternità, e la perdita dei figli ne è la punizione.
Come suggerisce la riflessione di Maria Luisa Boccia, teorica
della differenza, - riportata nella conversazione a tre nel
settimo capitolo - bisognerebbe rinnovare anche lo sguardo sulla
maternità, prestando attenzione a come è veicolata
attraverso il carcere. Costruire un nuovo discorso sulla maternità
sarebbe fondamentale non solo per le donne detenute, ma per
tutte le donne.
Paradossi, ostacoli burocratici rappresentano inoltre gli impedimenti
di un'istituzione totale che dichiara di puntare alla riabilitazione.
Al contrario, invece, ne replica le diseguaglianze sociali,
soprattutto quando non fornisce adeguate risposte e beni necessari
per la vita quotidiana. Smarrimento, solitudine, scoramento,
rabbia, dolore trovano lenimento nel suicidio o sfogo in gesti
autolesivi. Al riguardo, uno studio nel carcere di Padova, riportato
sulla rivista “Nuovi orizzonti” e i dati di questa
ricerca nei carceri toscani riferiscono di un maggior rischio
di suicidio per le donne, e minori atti di autolesionismo da
taglio, da ricondurre a una maggior cura e rispetto del proprio
corpo. Ma emerge altresì che le donne sanno mettere in
atto strategie specifiche di resilienza, orientate a coltivare
il domani. Comportamenti di protezione dalla sofferenza si collocano
in un processo personale fatto di riconoscimento, valorizzazione,
attivazione di risorse anche pregresse, per far fronte al cambiamento.
Così le donne scoprono una loro identità percepita
come molteplice e in mutamento, capace di reagire all'immobilismo
consolidato del carcere.
Tra carcerate, le donne suppliscono alle figure interne con
il compito di sostegno personale, in prevalenza nella dimensione
dell'ascolto. Ricercano solidarietà in relazioni individuali
scelte per affinità e rispetto, inclini alla dimensione
intima e affettiva in grado di lenire solitudini, liberare vissuti,
portare all'autoriflessione. Ma per andare oltre e approdare
al riconoscimento di competenze e valore: Ognuna di loro
mi ha insegnato tanto, oppure: Era la persona che quando
la vedevo mi dimenticavo di tutto, mi sentivo a casa e a mio
agio. Ancora: L'unica vera amica, per me lei è
una sorella, un'amica, una confidente, lei sopporta me, io sopporto
lei, si sta facendo progetti per il fuori.
I piccoli gesti quotidiani di cura mettono in moto un circolo
virtuoso che rinforza autostima e autoefficacia: Se una mattina
ti svegli e la tua compagna di cella dice - lo faccio io il
caffè - ti senti accudita. È molto importante
sentirsi qualcuno; poi automaticamente anche tu fai sentire
così l'altra persona.
Riordinare, pulire lo spazio angusto della cella, mettersi il
rossetto è cura di sé.
Il rispetto di se stesse rappresenta anche la scoperta di essere
cittadine in grado di prendere parola e di partecipare a momenti
collettivi che restituiscono senso e autostima, promuovono un
riconoscimento sociale: È una gioia sentire dire:
- un saluto da tutte le ragazze detenute di Empoli che hanno
aderito allo sciopero della fame per il sostegno delle altre
- Abbiamo aderito ad uno sciopero della fame dal 26 per cinque
giorni perché ascoltiamo Radio Radicale.
Investire bene e promuovere un uso diverso del tempo, sfruttando
al massimo le poche risorse offerte e soprattutto producendone
di nuove in modo autonomo, rappresentano altre energie di resilienza.
Le donne dimostrano di sapersi adattare per dare significato
all'esperienza: Ho iniziato a fare il corso di muratura,
anche; con altre due mie compagne, di là ci sono cinque
uomini. Abbiamo fatto anche la teoria: sicurezza sul lavoro,
sicurezza sui cantieri, pari opportunità. Poi a settembre
(speriamo di non esserci) si dovrebbe iniziare a ristrutturare
la palestra sopra. E di saper valorizzare le proprie competenze
in maniera informale: Adesso c'era il teatro, mi sono offerta
volontaria per cucire i vestiti da teatro; in cucina sono senza
grembiuli, mi sono offerta volontaria per cucire i grembiuli.
Che mi invento io se una mia amica mi dice - aggiustami una
gonna - gliela riparo.
Il tempo vuoto è tempo di occasioni, tempo di scoperta
di inclinazioni e di passioni. Diventa tempo per sé:
l'attività fisica, lo sport, la danza impegnano il tempo.
Restituiscono al corpo i suoi diritti: esprimersi, percepirsi,
curarsi. Insieme a musica, scrittura, lettura: per le donne
piaceri intimi e opportunità espressive.
Inoltre, la detenzione è una cesura nel tempo. Ma l'esperienza
carceraria può diventare opportunità per ripensare
quel passato che si vorrebbe lasciare alle spalle, per ricucire
legami interrotti, acquisire maggior consapevolezza anche per
immaginare un futuro possibile.
Nei carceri misti, possono germogliare nuove relazioni affettive,
anche se a distanza, fatte di occasioni fugaci di incontri,
di scrittura o di comunicazione muta e a distanza, dalle finestre:
È un panno bianco che o muovi o batti (a,b,c,d) è
complicatissimo, io ci ho messo tre giorni ad impararlo perché
mi interessava chiacchierare con lui.
Per approfondire i significati dello “sguardo della differenza
femminile”, Maria Luisa Boccia pone l'attenzione sull'ambiguità
del femminile come terreno della cura e della relazionalità.
Se la cura è offerta dalle operatrici e operatori dell'istituzione
carceraria, sull'assunto della dipendenza, vulnerabilità,
debolezza, non responsabilità, e improntata a precisi
modelli adottati nelle istituzioni totali, costruiti per soggetti
deboli e vittime, la relazione di cura diventa costitutiva del
controllo. Quindi occorre trovare la mediazione giusta tra chi
ha bisogno di cura e chi la esercita, per favorire una relazione
evolutiva, che accompagni verso l'autonomia.
La ricerca inoltre mette in luce l'opportunità di “attivare
la soggettività delle donne detenute per cambiare la
quotidianità del carcere”. Una sfida che va oltre
il riconoscimento di un diritto. Non si può prescindere
da una riflessione sulle pratiche del carcere da parte di chi
lo vive: detenute, operatrici, volontarie. Se non c'è
consapevolezza soggettiva sulle prassi da mettere in atto, non
ci sarà riforma, perché nemmeno la miglior legge
saprà cambiare la realtà. Boccia sottolinea che
“lo sguardo della differenza” da adottare implica
dare spazio alle soggettività, alla presa di parola in
prima persona, da parte di detenute e operatrici, e alle loro
pratiche. Solo così si potrà dare centralità
a un'istanza di liberazione.
Claudia Piccinelli
Errico Malatesta
e la Signora
 Il
18 maggio 1901 Errico Malatesta scrisse una lettera, intercettata
dalla polizia, in cui accennava a trattative con una «Signora»
disposta a finanziare progetti sovversivi in Italia. La signora
era l'ex-regina di Napoli Maria Sofia di Baviera e la lettera
ha dato la stura a innumerevoli illazioni, a cui in buona parte
è rimasta a tutt'oggi impenetrabile. Il libro di Enrico
Tuccinardi e Salvatore Mazzariello, Architettura di una chimera:
Rivoluzione e complotti in una lettera dell'anarchico Malatesta
reinterpretata alla luce di inediti documenti d'archivio
(Universitas Studiorum, Mantova, 2014, pp. 184, € 16,00),
poggia su un'idea felice: a partire da questo singolo documento,
seguire tutti i fili che da esso si dipartono per ricostruire,
attraverso una paziente e minuziosissima ricerca, l'universo
di persone, contatti e progetti che ruotano attorno ad esso. Il
18 maggio 1901 Errico Malatesta scrisse una lettera, intercettata
dalla polizia, in cui accennava a trattative con una «Signora»
disposta a finanziare progetti sovversivi in Italia. La signora
era l'ex-regina di Napoli Maria Sofia di Baviera e la lettera
ha dato la stura a innumerevoli illazioni, a cui in buona parte
è rimasta a tutt'oggi impenetrabile. Il libro di Enrico
Tuccinardi e Salvatore Mazzariello, Architettura di una chimera:
Rivoluzione e complotti in una lettera dell'anarchico Malatesta
reinterpretata alla luce di inediti documenti d'archivio
(Universitas Studiorum, Mantova, 2014, pp. 184, € 16,00),
poggia su un'idea felice: a partire da questo singolo documento,
seguire tutti i fili che da esso si dipartono per ricostruire,
attraverso una paziente e minuziosissima ricerca, l'universo
di persone, contatti e progetti che ruotano attorno ad esso.
Ne esce l'affascinante affresco di una rete transnazionale e
transpartitica che si dipana attorno all'oceano Atlantico, da
Londra a Parigi, Napoli, San Paolo, New York, L'Avana, coinvolgendo
anarchici, socialisti eterodossi, nostalgici borbonici, ex-rivoluzionari
ora al servizio degli americani, i quali nell'arco di decenni
si muovono da un continente all'altro, si incontrano, si separano,
si scrivono, si ritrovano, si scambiano informazioni, condividono
amicizie, fanno progetti, in un reticolo di contatti tanto mutevole
e inafferrabile quanto fitto e persistente. Altrettanta attenzione
è dedicata all'«altra rete», quella di ministri,
poliziotti, questori, ambasciatori, spie, indaffarati a seguire
i primi nelle loro peregrinazioni, a carpire le loro intenzioni,
a impedire le loro iniziative.
È questo il tipo di ricerca di cui ha bisogno la storia
dell'anarchismo per andare oltre le apparenze. Come diceva E.
P. Thompson riguardo al Luddismo, l'anarchismo è un movimento
«opaco»: su di esso scarseggiano le fonti, perché
così volevano i suoi protagonisti. Mettendo in luce la
continuità nel tempo e nello spazio di quel fiume carsico
che è l'azione anarchica, questo tipo di ricerca contribuisce
a dissipare il luogo comune di un anarchismo millenarista e
irrazionale – fatto di rivolte effimere e sempre in balia
degli eventi – così congeniale agli storici che
trovano comodo fermarsi alle apparenze per trovare una facile
conferma ai loro pregiudizi.
Il quadro transnazionale che emerge è tanto più
efficace quanto più gli autori lo dipingono senza enfatizzarlo,
come se esso si dipanasse dalla loro ricerca quasi involontariamente,
senza che essi lo cercassero e ne facessero il loro obiettivo.
Ciò che interessa agli autori è piuttosto fare
luce «su un appassionante intrigo d'inizio '900»,
identificarne i personaggi chiave e chiarire l'intreccio di
eventi. Gli eventi in questione sono l'attentato di Gaetano
Bresci a Umberto I, con l'annessa vexata quaestio del
coinvolgimento di Malatesta, e soprattutto il progetto di evasione
di Bresci, che gli autori sostengono, documenti alla mano, essere
stato al centro delle trattative fra Maria Sofia e Malatesta,
e che nelle intenzioni di quest'ultimo doveva essere la scintilla
che avrebbe potuto dare inizio a una rivolta anti-monarchica.
L'esistenza di questo progetto, frettolosamente liquidato da
gran parte della critica come pettegolezzo storico, spiegherebbe
anche il «suicidio» di Bresci, la più radicale
misura che il governo potesse escogitare per prevenire quel
progetto.
Tuccinardi e Mazzariello svolgono un egregio lavoro «investigativo»,
dando un nome ai vari protagonisti, scoprendone di insospettati,
soppesando tutte le ipotesi e talvolta rivalutandone di screditate,
non lasciando alcun sentiero inesplorato, argomentando con scrupolo
e cautela in sostegno delle tesi avanzate. Essi gettano così
nuova luce su una pagina della vita di Malatesta rimasta finora
in ombra.
Consci del valore del loro lavoro, gli autori auspicano che
esso possa indurre «ad una rilettura e forse persino ad
una revisione storiografica di primaria importanza» e
in tale ottica inquadrano l'azione di Malatesta nel 1901 all'interno
di una più ampia svolta tattica inaugurata dall'opuscolo
Contro la Monarchia, del 1899.
Tuttavia, la parte interpretativa – la quale, va detto,
rimane comunque soltanto abbozzata – è quella più
debole del libro. Contro la Monarchia fu sicuramente
una svolta fondamentale, ma non nel senso che gli autori suggeriscono.
Nel fare riferimento a quell'opuscolo essi inseriscono l'intesa
fra partiti rivoluzionari in esso propugnata e i contatti con
l'ex-regina all'interno di una stessa svolta, consistente nell'apertura
a forze esterne all'anarchismo. In realtà questi due
tipi di alleanze appartengono a filoni, fra di loro indipendenti,
che si ritrovano in Malatesta in tutte le epoche. Basti pensare,
rispettivamente, al fronte unico e al tentato accordo con D'Annunzio,
durante il biennio rosso. In estrema sintesi, lo schema interpretativo
proposto è questo: fino al 1898 Malatesta inseguì
una chimera, la rivoluzione puramente anarchica; preso atto
della realtà, si adattò pragmaticamente ad architettare
complotti con chiunque fosse disponibile. Ritorna insomma lo
stereotipo impossibilista della dicotomia fra utopia e realtà.
Tuttavia, Contro la Monarchia non fu una svolta rispetto
a un presunto esclusivismo anarchico, che mai appartenne a Malatesta,
ma rispetto all'esperimento di «lavoro lungo e paziente»
chiuso brutalmente dalle cannonate del 1898; e la svolta consistette
nella nuova coscienza che l'insurrezione precede, non segue,
il progresso graduale.
Più in generale, credo sia vano aspettarsi di fare scoperte
sensazionali sulle idee che guidavano l'azione degli anarchici.
Tutt'al più si sfondano porte aperte. Tanto opaca era
la loro azione quanto trasparenti le loro idee, che la coerenza
tra mezzi e fini preservava da qualsiasi machiavellismo. Per
capire quelle idee non c'è da scavare negli archivi,
ma da leggere i loro scritti. Da essi si capirà bene
quanto, all'interno della coerenza tra mezzi e fini di Malatesta,
ci fosse tanto posto per accordi perfino con ex-regine, quanto
poco ce ne fosse per farsi anche solo nominare candidato-protesta.
Concludo notando alcune bizzarrie del libro. Una è che
il disegno in copertina, rielaborazione di una foto, viene presentato
come «probabile autoritratto». Un'altra è
che al lettore vengono inflitti lunghissimi estratti, fino a
cinque pagine, in lingue straniere. Le traduzioni sono relegate
in appendice, ma sarebbe stato meglio fare il contrario, magari
condensando. Ottimo invece l'apparato iconografico, ulteriore
segno di esemplare accuratezza e completezza.
Il libro non costituisce l'ultima parola sugli eventi. Le tesi
svolte, per quanto ben documentate, rimangono in parte congetture.
Tuttavia, il libro alza di molto l'asticella. Gli storici che
vorranno dire qualcosa di nuovo sul tema dovranno lavorare sodo,
e ciò è quanto di meglio ci si possa augurare:
anche questo è un modo per riconoscere all'anarchismo
la dignità culturale che gli spetta.
Davide Turcato
Le cose che vengono
da dio
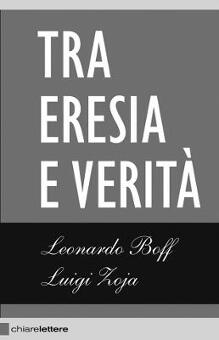 Se
c'è un argomento ostico da introdurre in “ambiente
anarchico” è proprio quello riguardante la “religione”.
Se, giustamente, questa ostilità è motivata dalla
storia – qui da noi leggi storia della Chiesa cattolica,
con l'influenza che ha sempre avuto nel determinare vite ed
eventi – non lo è altrettanto quando in questione
è il senso religioso della vita, inteso come ricerca
etica, come orientamento rispetto alle molteplici direzioni
che si possono prendere lungo il cammino. Se
c'è un argomento ostico da introdurre in “ambiente
anarchico” è proprio quello riguardante la “religione”.
Se, giustamente, questa ostilità è motivata dalla
storia – qui da noi leggi storia della Chiesa cattolica,
con l'influenza che ha sempre avuto nel determinare vite ed
eventi – non lo è altrettanto quando in questione
è il senso religioso della vita, inteso come ricerca
etica, come orientamento rispetto alle molteplici direzioni
che si possono prendere lungo il cammino.
Si compie spesso, secondo me, il fatidico errore di buttar via
il bambino insieme all'acqua sporca. Da parte mia, che certo
non sono anarchica d.o.c. ma solo una che insiste ad andare
ostinatamente in direzione contraria, o quantomeno ci prova,
penso sia un gran peccato. Che quell'acqua sia molto sporca
non lo mette in dubbio nessuno, che quel bambino sia da salvare
è altrettanto certo. Soprattutto in questi tempi, nei
quali la fede islamica è nell'occhio del ciclone per
tutti i fatti più recenti, è necessario operare
delle distinzioni nette e ragionare su chi e perché può
essere detto religioso.
Introduco con questa premessa la conversazione intercorsa, nell'agosto
2013, tra Leonardo Boff e Luigi Zoja - il primo conosciutissimo
teologo della liberazione, il secondo altrettanto conosciuto
psicanalista junghiano - raccolta nel libro Tra eresia e
verità (Chiarelettere, Milano, 2014, pp. 145, €
10,00). Conversazione che termina con una domanda e una risposta:
«Nel 2011 la teologia della liberazione ha celebrato il
suo quarantesimo compleanno. Cosa rispondi a chi sostiene che
è superata?»
«Rispondo che è ormai diffusa in tutti i continenti
e rappresenta un modo diverso di fare teologia, a partire dai
reietti della Terra e dalle periferie del mondo. [...] Nel 2008
c'erano 860 milioni di poveri al mondo, oggi sono prossimi al
miliardo. [...] Fino a quando ci saranno persone discriminate
e oppresse avrà sempre senso, partendo dalla fede, parlare
e agire in nome della liberazione. [...] La nostra sfida non
è quella di accrescere le schiere dei cristiani, ma di
creare persone oneste, umane, solidali, compassionevoli, rispettose
della natura e degli altri. In questo modo si realizza il progetto
di Gesù.»
Detta la fine, cito anche dall'inizio: «Nel suo approccio
originale alla psicoanalisi Boff ha avuto il merito di far coincidere
l'idea junghiana di archetipo con quella indigena della Pacha
Mama, la grande Dea Madre o Madre Terra. [...] si può
dire che la dimensione psicologica sia diventata sempre più
importante nel corso della tua vita?»
«Sono cresciuto in un mondo in cui primitivo e moderno
si sono incontrati e contaminati. [...] Il rispetto per la Terra
come sistema vitale unitario è un archetipo da riattivare
e appartiene alla dimensione del sacro. [...] La nostra cultura
ha separato l'uomo dalla natura e l'ha spinto a dominarla, distruggendo
quel senso di totalità che contraddistingue ogni visione
spirituale della vita. Le religioni venerano le Scritture, l'ostia
consacrata, lo spazio del tempio, ma non riescono ad aprirsi
al mistero del mondo e all'energia che alimenta l'intero Universo.
Questa lacuna spirituale è uno dei più gravi problemi
della modernità. La teologia sostiene che tutti gli aspetti
del Creato sono simboli e segni del creatore, sacramenti naturali.
Ma sono parole morte perché noi non viviamo questa dimensione.
Abbiamo avvicinato le popolazioni indigene per sterminarle perché
non avevano il senso della proprietà privata ...»
È facilmente immaginabile come nel mezzo a questi due
brani si sviluppi una conversazione dove il termine religioso
è sempre sotteso ad un'autentica ricerca di verità,
ricerca che non ha interesse nel difendere un credo in particolare
ma, al contrario, è consapevole che la religione può
essere usata per addomesticare e invitare la gente alla rassegnazione,
oppure per mobilitarla nella prospettiva della liberazione.
Liberazione che per essere reale non può dirsi solo umana,
ma deve coinvolgere la Terra con tutti i suoi abitanti, allo
stesso modo continuamente sfruttati e sterminati. Nell'auspicio
di una democrazia socio-cosmica dove ad alberi, acqua, montagne
e animali possa venir riconosciuto il diritto di cittadinanza
perché, se - come anche Jung aveva intuito, già
a suo tempo - lo sfruttamento della terra avrebbe causato una
crisi globale, il cambiamento necessario ad uscire dalla stessa
può avvenire solo riallacciando legami profondi con ciò
che ci circonda
“Tra eresia e verità” è un libro leggero
e di piacevole lettura - anche se il titolo inviterebbe ad intendere
il contrario - dove lo spessore umano di chi parla riesce a
toccare con leggerezza mai superficiale temi profondissimi e
imprescindibili e dove il dialogo è intercalato da ricordi
e aneddoti. Così possiamo immaginare un Leonardo Boff
bambino, con nonni veneti emigrati in Brasile alla fine dell'Ottocento,
vivere in una zona selvaggia e abitata da pochi indigeni, e
riusciamo a vedere un giovane studente di teologia nella Germania
della seconda metà degli anni Sessanta, con tutti gli
incontri che incominciarono a formare la sua personalità.
La loro riflessione, dopo aver visto da più angolature
e dati alla mano le problematiche di miseria materiale di tanta
parte della popolazione mondiale, ci ricorda come per altri
oggi la miseria sia mancanza di senso critico, docile disponibilità
a trasformarsi in consumatori, e che quindi - nel cercare soluzioni
autenticamente praticabili - non abbiamo a che fare solamente
con un problema economico ma anche educativo e psicologico.
Anche qui, come in altri libri da me recensiti (evidentemente
il tema mi sta a cuore), viene auspicata un'economia del
sufficiente, rispettosa di ogni cosa che vive, e si sottolinea
come l'opposto della religione non sia l'ateismo ma la mancanza
di connessione con il Tutto.
In ultima analisi possiamo dire che quella che ci viene mostrata
è una teologia della liberazione integrale, che comprende
tutte le dimensioni dell'essere umano, quella sociale, quella
politica e quella personale, una teologia che vede il nostro
dramma più grande nell'essere sradicati, nell'aver perso
la nostra spiritualità, che non è adorazione di
immagini o parole ma, ripeto, capacità di vivere un sentimento
di appartenenza.
Convinta come sono che recuperare questa dimensione interiore
sia indispensabile oggi per tutti, anarchici e non, voglio concludere
questo mio invito alla lettura riportando le parole di una donna
- anarchica e religiosa come fu Simone Weil - parole che, in
qualche modo, vengono a completare i temi toccati nel libro:
«Il criterio delle cose che vengono da Dio è che
esse presentano tutti i caratteri della follia, eccetto la perdita
dell'attitudine a discernere la verità e ad amare la
giustizia. [...] Devono esserci [...] momenti in cui [...] la
follia d'amore solamente è ragionevole. Questi momenti
non possono essere che quelli dove, come oggi, l'umanità
è divenuta folle a forza di mancanza d'amore.»
Silvia Papi
La grande storia
del surrealismo
 Quest'ultimo
(ed ennesimo) volume di Arturo Schwarz (Il Surrealismo. Ieri
e oggi. Storia, filosofia, politica, Skira, Milano 2014,
pp. 540 + cd, € 59,00), frutto di oltre dieci anni di lavoro,
si propone di presentare il Surrealismo non solo come movimento
letterario e artistico, ma come filosofia di vita. Schwarz,
storico, saggista e poeta, surrealista militante curatore di
mostre e appassionato collezionista nasce nel 1924 ad Alessandria
d'Egitto, come Marinetti, non ama quest'ultimo, e con lui il
Futurismo, magari adora Leda Rafanelli che (fra Ungaretti, Pea,
e gli anarchici lì emigrati), in un reale o immaginato
passaggio dalla città, ha, come lei, amato la kabbalah.
Biograficamente coinvolto nel clima alchemico di quel luogo
immaginista ha, come loro, inventato la propria esistenza. In
quella mitica biblioteca il libro troverà posto. Quest'ultimo
(ed ennesimo) volume di Arturo Schwarz (Il Surrealismo. Ieri
e oggi. Storia, filosofia, politica, Skira, Milano 2014,
pp. 540 + cd, € 59,00), frutto di oltre dieci anni di lavoro,
si propone di presentare il Surrealismo non solo come movimento
letterario e artistico, ma come filosofia di vita. Schwarz,
storico, saggista e poeta, surrealista militante curatore di
mostre e appassionato collezionista nasce nel 1924 ad Alessandria
d'Egitto, come Marinetti, non ama quest'ultimo, e con lui il
Futurismo, magari adora Leda Rafanelli che (fra Ungaretti, Pea,
e gli anarchici lì emigrati), in un reale o immaginato
passaggio dalla città, ha, come lei, amato la kabbalah.
Biograficamente coinvolto nel clima alchemico di quel luogo
immaginista ha, come loro, inventato la propria esistenza. In
quella mitica biblioteca il libro troverà posto.
“Quando, nel 1898, Freud scrive L'interpretazione dei
sogni, crolla il concetto che vede l'essere umano padrone della
natura e di se stesso. Freud fa prendere coscienza del fatto
che il nostro vivere quotidiano non è determinato soltanto
dalla coscienza, ma da un inconscio che occupa in realtà
i nove decimi dell'attività mentale dell'individuo”,
Schwarz al Convegno sulla Storiografia del maggio scorso a Reggio
Emilia continua: “il Surrealismo non si limita ad essere
nichilista ma vuole essere una nuova filosofia della vita i
cui elementi essenziali saranno esplicitati nel Primo Manifesto
del Surrealismo (1924), aggiungendo che il Surrealismo, ripetiamolo,
è una filosofia libertaria della vita e non semplicemente
una nuova corrente artistica o una nuova scuola letteraria.
È uno strumento di conoscenza che ambisce a cambiare
il mondo e cambiare la vita.”
Questi i parametri dell'opera che si sviluppa su tre livelli,
o libri, due di carta, il terzo (apparati) ricco cd in tre sezioni.
Il primo è il repertorio ragionato dei periodici, il
secondo, l'elenco completo delle collettive, il terzo la bibliografia
sintetica. Di particolare pregio l'elenco degli autori e la
periodizzazione (1924-65, Breton vivo - 1966 -, la fase successiva).
Strumenti fondamentali, specie il repertorio dei periodici dal
1919 al 2010, che include gli “affini” coevi o di
filiazione.
Superfluo elencare, risultando ineludibile la consultazione
per chiunque voglia approcciare in modo approfondito il tema.
Il criterio cronologico delle adesioni e filiazioni dà
il senso della permeazione del fenomeno, dal 1919 ad oggi, come
in un film, in ordine di apparizione. Francia, Spagna, Belgio,
ex Iugoslavia, Perù, Giappone, Cecoslovacchia, Inghilterra,
Norvegia, Stati Uniti, continuando con America latina, Svizzera,
Nord Africa, Portogallo, Austria. L'analogia, la psicanalisi
e Freud inondano la pubblicistica surrealista, meno l'Italia
che ne resterà solo scalfita, come più volte ha
notato l'autore, il quale sarà prima condirettore (pseud.
Tristan[!] Sauvage) e poi direttore fra 1959 e 1960, di una
rara rivista milanese. A seguire Olanda, Hawaii, Islanda, Germania
e Canada. Formazione e sviluppo del movimento, quindi evoluzioni
recenti, specie internazionali.
Nel libro il movimento attuale è considerato continuazione
e non post, perché col surrealismo, qualcosa è
successo per sempre (ready made, automatismo, superamento
dei limiti), come è accaduto anche per il Futurismo.
Si afferma che il Surrealismo si trova in J. Johns, Rauschenberg,
Baj, Dangelo, Kaprow, Serra, Celant, fino alla transavanguardia.
L'impulso romantico è già nella prima fase (1916-22)
a fronte del nichilismo dadaista, come più volte ribadito,
mantenendo distinti i movimenti e anticipando la nascita del
S. al 1916 con Freud e Jarry e coevo nei fatti a Dada, e in
divenire. Da psichiatra, Breton coglie appieno le potenzialità
di Freud, e le usa, specie nel senso della rottura dei freni
inibitori, trasformando il sub in-conscio. L'humor
nero e la funzione dell'inconscio sono modelli interpretativi
che superano la periodizzazione. Breton percorre e precorre
fra sensibilità e incontri (Vaché e Jarry) il
Surrealismo e cavalcando Wilhelm Reich riconosce la rivoluzione
sessuale come Rivoluzione. Il trionfo del principio del piacere
sul principio di realtà,sostanzia la differenza. Nel
'17 Breton incontra Soupault e Aragon formando così il
primo gruppo.
Nella prima parte pone i distinguo, le differenze fra movimenti
troppo spesso ritenuti simili, ne antepone le sensibilità
ne traccia il percorso. L'Arte si sente e si vive e ciascuno
trae ciò che vive entrando in contatto. Ma una cosa è
il pubblico altra l'artista. Il secondo può rivendicare
per il gruppo, il primo,definire per se medesimo. Poi, come
sempre, c'è chi, sia politicamente che eticamente,ha
poco a che vedere col movimento,come nel caso di Avida-dollars
(Dalì), che ci è comunque caro per Un chien
andalou e L'ge d'or di Buñuel. Dada e Surrealismo
si intersecano occasionalmente distinguendosi immediatamente
poi.
Questa è la sintesi cara a Schwarz che rivendica con
orgoglio l'attività politica rivoluzionaria costante
nel lungo periodo. Il sogno ad occhi aperti dei surrealisti
non fece mai perdere loro di vista la realtà nella quale
lottavano, furono contro carceri, esercito, stato. Un sentire
forte e marcato in Artaud, autenticamente anarchico, che connota
se non l'intero, almeno parti contaminanti del Movimento. Nel
libro-archivio si trovano connotati libertari e anarchici che
Schwarz con successo indica e fa emergere. Tratteggia in particolare
il trotskijsmo che è parte significativa, ma Buñuel,
Péret o Mirò già aderente a gruppi anarchici
spagnoli e ancora Baj e precise figure dell'anarchismo internazionale
sono presenza documentata. Col '51 inizia una collaborazione
con «Le Libertaire» della Federation Anarchiste
Française, attraverso una Dichiarazione preliminare del
12 ottobre (31 testi specie di Péret, che lì si
trovava a suo agio, e Breton).
Il Surrealismo non è scuola o corrente è un modo
di agire libero, scrive Schwarz, per trasformare il mondo cambiare
la vita. E la vita si trasforma con l'amore fisico e l'amour
fou, l'amore come illuminazione, anche se è facile notare
la presenza, fra i teorici del surrealismo, di soli maschi.
Il trionfo del piacere non solo fisico e il gioco, si trasferiscono
nella parola scritta erede del verso libero luciniano e nella
scrittura automatica. L'arte, l'anarchia, e anche il surrealismo,
sono internazionali e per l'autore, senza tempo. Attinge dalle
culture del passato e grazie all'espansione non si conclude,
e ciascuno è libero, nell'alveo disegnato, di seguire
il proprio percorso. Dopo il '69 vi è anche rilettura,
storicizzazione, ristampa, amplificazione, valutazione degli
effetti, ma il movimento resta vitale perché condannato
a innovare.
Così si apre il secondo libro post-Breton, e/o in continuità,
paese per paese, con sintesi storiche, percorsi, analisi, principali
pubblicazioni, gruppi ecc., di volta in volta segnalati curati
da uno o più autori o gruppi e collettivi. Scorrono così
Belgio Cecoslovacchia Danimarca, Francia e Gran Bretagna con
numerosi gruppi. Ed ancora Grecia, Jugoslavia, Paesi Bassi,
Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, quindi America
latina, Argentina, Brasile, dove Péret sarà fra
'29 e '31, Caraibi, Cile (S. Matta), Colombia, Messico, Perù,
e Asia, specie Giappone, dove nel '20 alcuni anarchici fondano
il Partito comunista anarchico al quale aderiscono tutti
i dadaisti. La disamina prosegue con l'Africa - movimento
surrealista arabo in esilio a Parigi -, che, inizialmente marxista,
tenderà all'anarchismo con la rivista «Le désir
libertaire». Per chiudere: Stati Uniti. A Chicago il gruppo
della Roosevelt University si ispira agli anarchici di Haymarket
ed all'IWW, apre la libreria Solidarity (1964), conia “fate
l'amore non la guerra”, a Parigi incontra Debord e a Londra
fa nascere la rivista anarco-surrealista «Heatwave»
e si relaziona al pedagogista anarchico Sakolsky ed a Löwi
che nel 2009 accosta e include anarchia e surrealismo.
Alberto Ciampi
 Un
po' provo
un po' staffetta partigianaCon gli occhi, le parole e la bici di Luigi Chiarella, seguiamo
le trasformazioni d'inizio secolo di Torino; gli anni dieci
per il capoluogo piemontese sono gli anni delle illusioni targate
olimpiadi invernali, sono gli anni della manifestazione più
dura della crisi. Leggendo Diario di Zona (Edizioni Alegre,
Roma, pp. 320, € 16,00) viene naturale l'accostamento alla
letteratura operaia di un altro grande autore calabrese, Vincenzo
Guerrazzi, che negli anni settanta fece epoca con il suo: il
Nord e Sud uniti nella lotta. Nel fluire del racconto di Chiarella,
non si parla più della fabbrica, di catene di montaggio,
di classe operaia, il profilo è diverso, lo sfruttamento,
se possibile più duro da sopportare se hai studiato,
hai una coscienza politica matura e nessun contratto definitivo.
Ma Yamunin, così si firma l'autore nel suo blog, https://yamunin.wordpress.com
va ben oltre, perché il suo è un vero e proprio
oggetto narrativo indefinibile.
Il libro tra l'altro è inserito in una collana molto
interessante diretta da Wu Ming 1, che rientra in un progetto
editoriale di Alegre che potete approfondire qui: http://www.ilmegafonoquotidiano.it/news/10x10-mi-abbono-ad-alegre-e-racconto-altre-storie.
Un flusso di citazioni letterarie, musicali, sembra che per
ogni zona nella quale è impegnato a lavorare, scorra
una colonna sonora, si alternano a slogan letti sui muri e alle
targhe in memoria dei partigiani uccisi, patrimonio comune che
abbiamo cominciato a disperdere. L'autore-protagonista porta
con sè un doppio fardello, che per certi versi lo accomuna
ad Alberto Prunetti, un altro narratore di vaglia dell'Alegre
edizioni; Yamunin è un operatore della cultura, recita
e scrive per il teatro, ma per sopravvivere si cala nei tombini
e nelle cantine di Torino per leggere da precario letturista
i contatori dell'acqua.
È in questo scendere nel ventre molle della metropoli
che il racconto si fa più vivo e fotografa con le parole
luoghi e persone.
Mi sorprende della narrazione la massa di riflessioni alle quali
induce, pur nella semplicità quotidiana del lavoro, mi
sorprende la gentilezza e la calma con la quale si ribella,
s'indigna con le domande e le parole; ecco Yamunin mi sembra
in sella alla sua bicicletta, così provos, una staffetta
partigiana delle lotte di oggi. Anche quando lo sguardo è
più distaccato, come nel passaggio della sua escursione
in solitaria sulla collina di Superga, si coglie la capacità
dell'autore di cogliere prospettive diverse: così dalla
collina più alta di Torino traccio una linea che passa
dalla basilica di Superga, attraverso lo stivale e arriva al
santuario della Madonna di Polsi a San Luca, sembra Saba in
Trieste: potente!
Fabio Cuzzola
|