
Architettura/
Riflessioni stimolanti di un “capomastro” di Emergency
 Va
da sé che ogni architettura sia funzionale rispetto al
suo mandato d'origine: lo sviluppo dell'idea e l'espressione
strutturale ne costituiscono forse l'elemento più denso
di significati. Per concetto di “funzione” in architettura
si intende non solo un adattamento logico della forma all'uso-
come la definizione stessa vorrebbe- ma qualcosa di più
che attraversi la condizione “umana” di questo adattamento. Va
da sé che ogni architettura sia funzionale rispetto al
suo mandato d'origine: lo sviluppo dell'idea e l'espressione
strutturale ne costituiscono forse l'elemento più denso
di significati. Per concetto di “funzione” in architettura
si intende non solo un adattamento logico della forma all'uso-
come la definizione stessa vorrebbe- ma qualcosa di più
che attraversi la condizione “umana” di questo adattamento.
“L'architettura è, e resta, un meraviglioso processo
di sintesi in cui sono coinvolte migliaia di componenti umane:
essa rimane pur sempre “architettura”. La sua missione
è ancora di armonizzare il mondo materiale con la vita”,
disse Alvar Aalto, uno delle figure più intuitive del
XX secolo, nel novembre del 1940. È proprio in seno a
questa dimensione dell'architettura – come trama e spazio
di legami sociali – che si pone Raul Pantaleo, architetto
e realizzatore di diversi centri sanitari per Emergency.
Nella stesura del suo ultimo libro La sporca bellezza
(Elèuthera, Milano 2016, pp. 127, € 13,00), Pantaleo
narra delle proprie cronache di capomastro in terre sfigurate
da guerra e da povertà nelle quali portare costruzioni
di pace significa rivolgersi con fiducia a coloro che transiteranno
in questi spazi. Così l'architettura supera il suo valore
oggettuale per diventare simbolo del possibile dove “il
luogo pubblico, in quanto tale, diviene luogo della condivisione
dove il patto sociale si costruisce giorno per giorno”
(p.78).
La creazione di ospedali, di cliniche, di centri di cura in
luoghi dove la bellezza si inzozza, si infanga di morte e di
eccidi, diviene atto protettivo per la condizione di malattia,
rispettandone la necessità e l'urgenza, pur senza rinunciare
ad una progettistica virtuosa e ad una fisionomia creativa,
scongiurando così il pericolo della serialità
dell'edificazione.
Le planimetrie di Raul Pantaleo, nella sfida di Gino Strada,
diventano “il manifesto di un'idea di bello radicata nel
pensare all'architettura come un'arte eminentemente sociale”
(p.124) secondo un'ipotesi peraltro già avanzata da Giovanni
Muzio, nel 1921, come reazione alla confusione e all'esasperazione
di individualismo dell'architettura moderna. Per “sociale”
allora qui si fa riferimento al superamento dell'inospitalità
di alcuni ospedali, della sterilizzazione del loro aspetto,
“macchina anonima per riparare corpi fallati, tanto efficiente,
quanto disumana” (p. 20) dove gli spazi non rispondono
più alla domanda delle comunità che li abiteranno,
quanto alla logica del costo ridotto e della validità.
Ecco allora che l'ospedale a Kabul, la clinica pediatrica a
Port Sudan, il reparto maternità a Busengo, il centro
chirurgico a Goderich, il centro pediatrico a Bangui, la scuola
cinema e l'Istituto di Ricerca Sociale dell'Università
di Makerere a Kampala, il centro Salam a Khartoum, mostrano
tutti, nelle loro diversità strutturali, il volto umano,
il piacere di stare intra moenia. Anche le misure, le
geometrie portano il loro equilibrio, nella poetica dei numeri
poiché nell'efferatezza dei Paesi che li ospitano, rappresentano
“un piccolo gesto di normalità, di sollievo ilusorio”
(p. 31). Il banco di prova della poetica dei numeri è
proprio questo, vivere la normalità nonostante tutto,
preservando negli edifici anche quegli elementi distintivi della
cultura architettonica di provenienza: prestare ascolto alle
comunità resistenti dell'Africa dona senso nuovo ad un
pensiero occidentale urbanistico più impositivo rispetto
a valori e stili.
Costruire in molti parti dell'Africa, inoltre, impone il confronto
con la crudezza di considerare che tutto possa precipitare,
e appaiono quanto mai necessarie la prudenza e il compromesso
tra aprire e proteggere: “le finestre devono essere piccole
per poterle facilmente mascherare e per evitare, in caso di
esplosione, di generare troppe schegge, mentre i muri devono
essere massicci per proteggere dagli urti e gli edifici per
essere chiusi all'occorrenza” (p. 98).
È così difficile allora ripensare l'architettura
all'interno di un processo di “umanizzazione edile”
che possa trasformare squallidi stanzoni in spazi per accogliere
persone che soffrono oppure questo ripensare è troppo
radicale nella sua percezione dello spazio?
Il problema è senza dubbio legato al profitto, “poiché
la bellezza ha un costo che non genera alcun utile e per questo
è trascurata” (p. 51), ma è altresì
legato all'assetto culturale per il quale si fa fatica a comprendere
che se nei luoghi di cura non c'è affetto nella
realizzazione, non ci sarà nessun effetto che
produca benessere né per i degenti né per i curanti.
In questo disvelamento psico-geografico, il lavoro dell'architetto
può diventare davvero prezioso, poiché, come scrisse
nel 2004 James Hillman, straordinario analista junghiano, “l'architetto
ha il potere di essere il vero psicologo archetipico delle comunità”,
dato che un progetto d'architettura comincia proprio come una
fantasia desiderata, come possibilità di bellezza immaginata.
È su tale inciso che Raul Pantaleo offre una visione
attuabile e fattibile di architettura promotrice rivoluzionaria-
secondo lo stesso- di “bellitudine” più che
di “bellezza”, poiché se la seconda riporta
ad un esercizio di stile, anche un po' vuoto, è proprio
la prima che si fa drammaticamente reale, quindi fruibile. Solo
in tale direzione, forse, l'etica estetica dell'abitare si può
incarnare nell'appartenenza ad una serie di luoghi che circoscrivono
l'essere e l'agire.
Daniela Mallardi
L'anarchia all'opera/
Quando la rivoluzione va a teatro
 “Il
mondo, per Ruggero Balestrieri, si divideva in due parti nette
e ben distinte. Da una parte il tenore Ruggero Balestrieri,
da quell'altra i restanti abitanti del pianeta”. “Il
mondo, per Ruggero Balestrieri, si divideva in due parti nette
e ben distinte. Da una parte il tenore Ruggero Balestrieri,
da quell'altra i restanti abitanti del pianeta”.
Facile a dirsi, e a capirsi, se il soggetto in questione è,
per l'appunto, cantante lirico, ovvero persona abituata a stare
sulla scena da protagonista tanto in teatro quanto nella vita.
(La qual cosa – si capirà poi quanto curiosamente
– ne avvicina parecchio la figura a quella di un qualsiasi
re.)
Facile, si diceva. Ma già meno immediato se il suddetto
si professa, negli atti e nei pensieri, fiero seguace dell'Idea
che, in piena Belle Epoque, incendia gli animi e i popoli:
l'anarchia.
Protagonista, sia da vivo che da morto (anzi, forse più
da morto che da vivo, essendo la vittima dell'omicidio) del
penultimo libro di Marco Malvaldi: Buchi nella sabbia (Palermo,
2015, pp. 256, € 14,00), il tenore Ruggero Balestrieri
è l'ago della bilancia ideale di tutta la vicenda, perché
in lui si incontrano e si scontrano i due mondi opposti che,
all'inizio del secolo XX, si contrappongono come duellanti alla
pistola: la rivoluzione e l'ordine costituito, lo Stato e il
ribelle, il monarca e l'anarca.
Ma non solo: il magnifico tenore è, per l'appunto, anche
l'ottimo rappresentante di quella che, al sorgere del secolo,
è l'arte regina: l'opera lirica.
Anarchico e pieno di sé, rivoluzionario e prepotente,
re della scena e libertario del costume: è piuttosto
inevitabile che in parecchi facciano a gara per avere l'onore
di farlo fuori.
Ma come i piani della Storia si intersecano spesso nel punto
di un singolo uomo, così le direzioni dalle quali è
partita la pallottola fatale possono essere altrettante.
Tutto accade durante la rappresentazione della Tosca di Puccini
al teatro di Pisa, in occasione delle vacanze estive (a San
Rossore, oggi luogo di villeggiatura del Presidente della Repubblica)
di Vittorio Emanuele III e famiglia. L'augusto figlio del trapassato
(in tutti i sensi) Umberto assisterà alla recita in musica
– un re coronato sul palco di fronte a un re anarchico
sulla scena – e il pericolo di un attentato è,
anch'esso, reale. Perché il destino vuole che, per un'opera
considerata già di per sé sovversiva (il protagonista
Cavaradossi -ovviamente impersonato per l'occasione dal Balestrieri-
recita: «L'alba vindice appar/ che fa gli empi tremar!
Libertà sorge/ crollan tirannidi!»), vi siano anarchici
anche fra le maestranze (tecnici abilissimi, ça va
sans dire) e, naturalmente, fra il pubblico (cavatori carrarini,
per giunta). Così come anarchico è anche il giornalista
incaricato di raccontare l'evento alla stampa nazionale, ovvero
il realmente esistito Ernesto Ragazzoni, funambolico giocoliere
delle parole in rima (nel quale lo stesso Malvaldi pare immedesimarsi).
Insomma, una bella gatta da pelare per la Guardia Regia, corpo
scelto dei Carabinieri incaricato di vegliare sull'incolumità
del sovrano, prima del delitto, e delle indagini poi.
Guardia regia che però rischia fino all'ultimo di fare
la fine del topo... perché se l'anarchico porta, inevitabilmente,
scompiglio, il carabiniere dell'ordine è spesso la forza,
ma non sempre l'intelligenza. Anche se, alla fine, c'è
sempre qualcuno più “scelto” degli altri
che salva la categoria.
Comunque, trattandosi di “giallo”, e di dimensione
“lettura in giornata”, non è necessario dire
oltre.
Basti sapere che anche l'anarchico, così come il re,
è un uomo, e come tale non sempre è nobile, né
di statura né nell'animo. Ma anche l'anarchia, spesso
e volentieri, è femmina (signora o signorina...), e si
sa: la donna, è mobile!
Andrea Babini
La notte degli zingari/
La notte dell'umanità, la notte dei nomi
Libere? E cosa si fa quando si è liberi?
Cosa significa essere liberi?
Il pensiero le balenò nella testa facendole sentire freddo
Miriam
Spesso accade quando si termina un libro di avere una mancanza, si trattiene
dentro di sé quel “sentire ancora il bisogno di
avere accanto quei compagni o compagne che hanno nutrito per
giorni la propria immaginazione, il proprio mormorio interiore”.
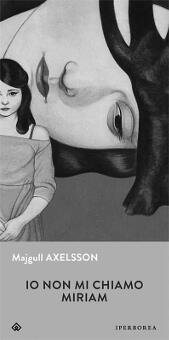 Quando
si giunge alla fine di Io non mi chiamo Miriam di Majkull
Axelsson (Iperborea, Milano, 2016, pp. 562, € 19,50) resta
una mancanza più intensa, dolorosa quasi commovente:
quella di non aver ricordato mai abbastanza, quella di non aver
capito mai abbastanza, quella di non aver saputo mai abbastanza.
Miriam è Malika, o almeno quello che di Malika è
rimasto dopo Ravensbrück, e Malika è Miriam o almeno
quello che ne è rimasto dopo Auschwitz. Due donne che
cercano per tutta la vita di dimenticare, rimuovere, seppellire
negare il diritto alla propria storia; senza tuttavia, fortunatamente,
riuscirci sino in fondo, ma lasciando al futuro il senso della
responsabilità e non solo della memoria. Quando
si giunge alla fine di Io non mi chiamo Miriam di Majkull
Axelsson (Iperborea, Milano, 2016, pp. 562, € 19,50) resta
una mancanza più intensa, dolorosa quasi commovente:
quella di non aver ricordato mai abbastanza, quella di non aver
capito mai abbastanza, quella di non aver saputo mai abbastanza.
Miriam è Malika, o almeno quello che di Malika è
rimasto dopo Ravensbrück, e Malika è Miriam o almeno
quello che ne è rimasto dopo Auschwitz. Due donne che
cercano per tutta la vita di dimenticare, rimuovere, seppellire
negare il diritto alla propria storia; senza tuttavia, fortunatamente,
riuscirci sino in fondo, ma lasciando al futuro il senso della
responsabilità e non solo della memoria.
Malika è una giovanissima Rom per nascita, Miriam è
una donna ebrea per necessità, il corpo è il medesimo,
la vita anche, la lingua no. Il loro corpo soffrirà la
violenza dei campi di concentramento, la vista della soluzione
finale, le torture inflitte a Didi il fratello e Anuscha la
cugina da un assassino che ribalterà la logica della
cura: Mengele, che sorrideva e offriva caramelle ai bambini
e alle bambine per poi farli sparire nelle più atroci
sofferenze. Io non mi chiamo Miriam è un libro
importante, è una storia, un racconto, che ci riporta
alla memoria ciò che sono stati i campi di sterminio
e la soluzione finale che ci impone il ricordo e la consapevolezza
di come, ancora oggi, possano essere presenti notti dell'umanità.
Malika ha una lingua materna, il romanes, che sarà obbligata
a tenere segreta tutta la vita, Miriam imparerà lo svedese
per avere un futuro. Il suo confine, l'esilio da se stessa,
lo trova a partire dal giorno in cui quasi casualmente indosserà
la stella gialla e abbandonerà il triangolo marrone (alcuni
dei simboli che nel lager identificavano le origini culturali,
religiose, sessuali e di condizione sociale) e modificherà
irrimediabilmente la cicatrice sul braccio (tatuata indelebilmente
ad ogni persona entrata in campo di concentramento), cancellando
quella Z che il nazismo le ha tatuato sulla pelle per far scomparire
tutte le tracce del suo essere zingara.
Quel giorno nasce Miriam Goldberg e questa nuova identità
inizierà a scricchiolare e a imporsi come verità
solo dopo molti anni, il giorno del suo ottantacinquesimo compleanno
in una confidenza a sua nipote Camilla. Malika la Rom sopravvive,
ma può farlo solo come Miriam Goldberg. Sopravvive alla
notte del 2-3 agosto 1944 in cui circa 3000 persone fra Rom
e Sinti furono prima gassati e poi bruciati nel settore dei
Zigeunerlager di Ravensbrück, in quella notte degli
zingari, come ricorda in un'intervista Pietro Terracina, sopravvissuto
ai campi di sterminio: «si passò da una confusione
totale fatta di grida, latrati, pianti e ordini al silenzio
definitivo, alla scomparsa di tutti e tutte: bambini, bambine,
donne, uomini, non vi era più nessuno, solo il vento
faceva sbattere le porte delle baracche deserte, di lì
il silenzio, e la prova che furono uccisi era data dalla forza
con cui erano stati accesi i forni crematori».
In merito si veda il documentario (libretto+div) edito da A-Rivista
Anarchica: “A forza di essere vento”, che rende
testimonianza di questi fatti sconosciuti, in esso è
contenuta un'intervista a Marcello Pezzetti che ricorda un evento
fondamentale di resistenza da parte del popolo Rom e Sinti nel
Zigeunerlager qualche mese prima della reazione efferata
e organizzata che li condusse allo sterminio totale.
Malika non è fra quei 2897 ma per sopravvivere perde
il suo nome, la sua identità, diviene Miriam, diviene
ebrea, e non potrà più tornare indietro; il mondo
odia gli zingari, ancora nel 1948 nella sua “democratica
Svezia” a Jönköping, nella notte degli zingari,
si diede la caccia ai “tattare”, una notte di xenofobia,
discriminazione, razzismo.
Questo racconta Miriam-Malika. La lunga notte. Ci fa
chiedere se oggi, di fronte a razzismo, xenofobia, discriminazione,
espulsione, gommoni affondati, centri di “accoglienza
temporanea”, siamo disposti e disposte a liquidare ancora
gli eventi con un'alzata di spalle, se siamo consapevoli dell'atrocità
“di quel che resta dopo Auschwitz” se ne
abbiamo conosciuto l'orrore, se abbiamo da qui il coraggio nell'opporci
alla connivenza, a non essere parte dell'ingranaggio di questa
banalità del male come l'ha definita Arendt.
L'autrice Majgull Axelsson, scrittrice drammaturga e giornalista,
magistralmente, con una scrittura diretta, asciutta e chiara
ci porta di fronte a questa fatica della memoria come se volesse
in fondo invitarci a fare ancora un volta i conti, oggi, nella
nostra quotidianità con queste problematiche che circondano
ancora le nostre esistenze, dalle quali non possiamo prendere
distanze, verso le quali il sapere, il conoscere e capire divengono
scelte etiche, un impegno a lottare ancora contro oppressione,
violenza, sterminio e una capacità di calarsi ancora
nel destino e nel futuro di chi accanto a noi esiste.
Ricordando, come suggerisce Hetty Hillesum nel suo Diario, il
19 febbraio 1942, che «il marciume che c'è negli
altri c'è anche in noi [...] » e per troppo tempo
si è pensato che i campi di sterminio e la soluzione
finale siano una notte superata dell'umanità e che si
sia trovata di esse l'aurora; una presunzione che non ci possiamo
concedere né permettere.
Si può decidere che il rapporto con questa memoria possa
essere retorico oppure farlo divenire una pratica politica (quotidiana)
che riporta sempre dentro alle nostre esistenze l'idea della
lotta al dolore, alla violenza e alla sottomissione che uccidono
la vitalità in ogni tempo e luogo.
Silvia Bevilacqua
Antispecismo/
Scegliere la libertà, divenire mostri
Mostri si nasce o si diventa? Qual è il motore immobile
posto al centro di ogni cosa che determina l'inestimabile valore
o, al contrario, la marginalità, di ogni aspetto del
vivente conosciuto? Anche questa volta la risposta di Massimo
Filippi è una sola, ribadita con forza: tale motore,
semplicemente, non esiste.
 L'invenzione
della specie. Sovvertire la norma, divenire mostri (Ombre
corte, Verona, 2016, pp. 120, € 13,00) è un libro
inconsueto, forse addirittura un libro mostruoso, fatto
di parti assai diverse tra loro, cucite insieme a comporre un
esperimento visionario e di là da venire. Una sfida,
lanciata a chi deciderà di immergersi in queste pagine
dense, a lasciarsi alle spalle ogni tassonomia e tentativo di
categorizzazione: a partire dal testo stesso, dalla pretesa
di una coerenza interna che a prima vista potrebbe apparire
fuggevole. L'invenzione
della specie. Sovvertire la norma, divenire mostri (Ombre
corte, Verona, 2016, pp. 120, € 13,00) è un libro
inconsueto, forse addirittura un libro mostruoso, fatto
di parti assai diverse tra loro, cucite insieme a comporre un
esperimento visionario e di là da venire. Una sfida,
lanciata a chi deciderà di immergersi in queste pagine
dense, a lasciarsi alle spalle ogni tassonomia e tentativo di
categorizzazione: a partire dal testo stesso, dalla pretesa
di una coerenza interna che a prima vista potrebbe apparire
fuggevole.
In realtà, chi ha familiarità con gli scritti
di Filippi, filosofo antispecista per incontenibile passione,
non faticherà a riconoscere il percorso di una parabola
intellettuale e politica in costante divenire, che a partire
da un solido inquadramento teorico spicca il volo verso i territori
dell'indistinzione e della molteplicità inesauribile.
La questione animale è da sempre al centro delle riflessioni
dell'autore, ma in questa sua ultima fatica risulta evidente
come non sia possibile rimettere in discussione la categoria
dell'“animale” senza riconsiderare anche quella
di “umano”; umano che, proprio a partire dalla differenza
dall'animale, ha posto le basi per costruire tutto quel complesso
e stratificato sistema di dominio e oppressione che informa
la società capitalistica e tutte le sue istituzioni di
controllo dei corpi.
Un libro coraggioso, senza ombra di dubbio, e sorprendente,
che prendendo le mosse da un fine lavoro di decostruzione del
concetto stesso di categoria – conditio sine qua non
della messa a valore di ogni aspetto del vivente – e utilizzando
sinergicamente gli strumenti messi a disposizione non solo dai
suoi puntuali riferimenti filosofici (da Foucault a Deleuze,
passando per Agamben, Adorno e Derrida, tanto per citare alcuni
dei più noti), ma anche dalla teoria femminista e queer
(attingendo a piene mani dal lavoro di Butler), alla domanda
«Che cosa è l'“Uomo”?» che ci
aveva già costretto ad affrontare nei precedenti saggi,
Crimini in tempo di pace (elèuthera), Corpi
che non contano (Mimesis) e Sento dunque sogno (Ortica),
risponde con un deciso: «Nulla».
L'“Uomo”, così come lo conosciamo è
infatti un'invenzione recente, che ha tuttavia provato con tutte
le sue forze a cancellare le tracce di altri modi di vivere-con
il resto del vivente. Il saggio, allora, dà conto, attraverso
numerosi esempi, di come, in altri tempi ed in altri luoghi
– al di fuori cioè del cosiddetto “Occidente
moderno civilizzato” – siano esistite società
umane capaci di uno sguardo più fluido e meno antropocentrico,
uno sguardo capace di posarsi sul non umano con stupore, rispetto
e attenzione. L'invenzione della specie spiazza chi sia
ancora alla ricerca del proprio posto all'interno di un sistema
che divide allo scopo di dominare e, al contrario, è
capace di aprire orizzonti di libertà e possibilità
per chi abbia riconosciuto – o sia disposto a riconoscere
– l'inconsistenza e l'arbitrarietà di questo movimento
di esclusione e di contemporanea appropriazione dell'esistente.
In coerenza con questa posizione, le tappe seguenti si (ci)
spingeranno ben oltre, smascherando i meccanismi di speciazione,
tanto arbitrari quanto efficaci nel disegnare confini funzionali
allo sfruttamento di chiunque ricada in quelle categorie considerate
“marginali” – confini che, a ben vedere, spesso
si rivelano più porosi di quanto si sia indotti a pensare,
rendendo il vivente tutto (umano compreso) estremamente vulnerabile
alla presa del potere.
Così anche la specie, come è già avvenuto
in passato per i concetti di “razza” e di “genere”,
si rivela per quello che è: un termine solo apparentemente
neutro che, ad un esame più attento, mostra inequivocabilmente
la sua più intima essenza di costrutto politico volto
alla produzione di categorie di valore strumentali allo sfruttamento
di chi si trova nella posizione dell'oppresso. Con la dissoluzione
del concetto di specie non può che seguire il disvelamento
di quel calcolo crudele e inesorabile che porta il vivente,
umano, meno-che-umano o non umano che sia, sulla strada del
mattatoio.
É in questo modo che si scopre la forza della norma
sacrificale, norma che designa quali corpi e quali esistenze
possano essere sacrificate impunemente – violenza che,
da tempo immemore, si appropria delle vite di umani e non umani
per nutrire la propria brama di potere, prelevando dalla carne
e dal sangue di chi si trova nella categoria “sbagliata”
il plusvalore necessario per far prosperare pochi a scapito
di tutti gli altri. In questo senso riusciamo a comprendere
meglio l'esortazione del sottotitolo a sovvertire la norma e
a scegliere, consapevolmente, di offuscare i confini che, imprigionando
la vita sensuale, ci condannano, volenti o nolenti, al ruolo
di oppressori – e al rischio continuo di diventare, a
nostra volta, vittime dell'oppressione. E altrettanto chiara
si fa anche l'espressione divenire mostri: siamo chimere
dai tratti sempre meno netti e sempre più aperte alle
infinite possibilità di gioire e di desiderare (con)
l'altro da noi.
É questo il momento di rottura di un saggio che, da qui
in poi, ci condurrà in un viaggio fantasmagorico –
e fantasmatico – attraverso quello che si potrebbe definire
un vero e proprio bestiario di “casi”, tanto
mostruosi quanto affascinanti, ibridazioni di reale e immaginario:
un museo zoologico ricolmo di esseri mutanti nei quali si liquefano
i confini esistenti tra umano e non umano, normale (normato)
e mostruoso, e che, come ogni esposizione che si rispetti,
stimola quella curiosità voyeuristica di scoprire la
prossima stranezza, la prossima mostruosità; illudendoci,
ma solo per poco, che in un simile labirinto di specchi non
saremo proprio “noi” a trovarci, infine, messi in
mostra tra questi stessi casi, poiché quella che credevamo
essere la nostra “normalità” altro non era
che un'illusione, tanto potente quanto fragile.
I ventisei casi del terzo capitolo, fantasiosi quanto meticolosi
assemblaggi di corpi, esperienze ed esistenze in cui Filippi
cancella, consapevolmente, i confini esistenti tra filosofia,
racconto, referto clinico e autoptico, rapporto di polizia e
sogno – e nei quali crollano al medesimo tempo le categorie
che separano in maniera così netta l'umano dal non umano,
il normale dal patologico, il freddo resoconto del terapeuta
dal punto di vista di chi viene analizzato – rappresentano
un esperimento riuscitissimo capace di mostrare l'arbitrarietà
delle categorie e la continua necessità di sorvegliare
quei confini che separano chi può e deve vivere, da chi
invece può, e spesso deve, morire.
L'ultima parte del libro ripercorre, da un punto di vista altro
e attraverso un lirismo intenso ed onirico, quei calcoli tanto
efficaci a dividere (e smembrare per possedere, appropriarsi
e distruggere), ma nonostante tutto ancora capaci di addizionare
e moltiplicare impressioni, percezioni sensibili, movimenti
impercettibili e imperscrutabili di tutto ciò esiste
e r-esiste, contro ogni umano sforzo, alla riduzione in elementi
intelligibili e manipolabili – e, infine, di sottrarre
al fine di lasciar spazio a nuove vite, a nuovi mondi, a nuove
esistenze.
Quasi una metempsicosi, in cui il disfacimento di quanto conosciamo,
e soprattutto riconosciamo, come umano, si apre al radicalmente
altro (alghe mute che sinuose ondeggiano all'unisono adattandosi
ai moti marini, uccelli migratori sorpresi nel penoso ma allo
stesso tempo irresistibile momento della partenza) per tornare
infine – spogliati e inermi – nuda vita,
corpo ridotto alle sole funzioni vitali e forse proprio per
questo, finalmente e autenticamente animale, e pertanto (anche)
umano.
In questo perdere ciò che si è, così spaventevole
e terrificante, si scopre il modo per liberare ciò che
si potrebbe essere: un desiderio mai sopito, un desiderio refrattario
a costrizioni e imposizioni. Un desiderio di assoluta, irrefrenabile
libertà.
feminoska
Noam Chomsky/
Ma natura umana e anarchia sono legate
 Ma
“noi”, noi umani intendo, che genere di creature
siamo? Nelle sue Tre lezioni sull'uomo (Ponte alle grazie,
Firenze, 2017, pp. 128, € 13.50) Noam Chomsky tenta una
risposta a questa domanda mettendo ordine nel suo pensiero e,
verrebbe da dire, preparandosi a lasciarlo alla scienza e all'anarchia
che verranno dopo di lui. Ma
“noi”, noi umani intendo, che genere di creature
siamo? Nelle sue Tre lezioni sull'uomo (Ponte alle grazie,
Firenze, 2017, pp. 128, € 13.50) Noam Chomsky tenta una
risposta a questa domanda mettendo ordine nel suo pensiero e,
verrebbe da dire, preparandosi a lasciarlo alla scienza e all'anarchia
che verranno dopo di lui.
Scienza e anarchia, infatti, ancora una volta connesse: la struttura
del linguaggio e quella della conoscenza sono intrinsecamente
connesse all'organizzazione politica autonoma e dal basso. Chomsky
riparte dalle basi, quelle che chiama “ovvietà”
ma che hanno anche il grande lusso di essere vere ma sconosciute
ai più: dalla non contraddizione di un'anarchia che nel
contingente preferisce le democrazie alla dittature, da un linguaggio
come universale della nostra specie, e da un'idea di impresa
conoscitiva come limitata e per questo interessante.
La lezione di Chomsky, qualsiasi valutazione si possa fare del
suo pensiero politico, è in fondo che la conoscenza,
solo la conoscenza, generi libertà: al di là delle
presunte differenze esiste una matrice comune, importante e
distintiva, che rende tutti gli umani legati a doppio filo a
una corda tesa tra limite e risorsa. Nello scenario attuale,
quello di crisi irreparabile del modello di democrazie occidentali,
Chomsky vede quasi una risorsa per la teoria anarchica (anche
se un rischio, enorme, per la nostra pace): ripartire dall'organizzazione
di microcomunità e dall'idea che essere impossibilitati
a conoscere tutto non generi scetticismo (“misterismo”)
ma impresa culturale futura.
Ciò che in Chomsky diventa evidente, limpido come in
nessun altro autore, è il legame intrinseco tra filosofia,
linguistica, e teoria politica: una triangolazione che genera
progresso e in cui ogni vertice, come si giri-giri il triangolo,
è indicazione necessaria per programmare il poi. Studiare
il linguaggio, nel senso della sua ricorsività, permette
di comprendere il proprio specifico della nostra di vita che
non è mai comunque “speciale” ma, appunto,
“specifico” e porta dritti al ponte immenso che
riguarda la struttura della conoscenza: possiamo sapere alcune
cose, non altre, ma questo non deve generare postmoderno o pensiero
debole ma comprensione che la forma, ogni forma, è data
proprio da quel limite (come un corredo genetico).
Affascinante, anche se ormai messa in discussione da più
parti, questa idea maestosa che natura umana e anarchia siano
legate: l'autonomismo morale e la comunità come principi
e parametri di una specie che sembra ormai impossibile pensare
in assenza di Stato. Tutte le volte che avviene, questo emerge
dalle tre lezioni, l'impresa della filosofia è fallita.
Ma è alle alternative che Chomsky, anziano ma più
nuovo della scienza e della politica “giovane” e
contemporanea, continua a guardare: come il linguaggio è
un insieme discretamente infinito di elementi, così la
nostra vita e le possibilità della nostra conoscenza
combinate in nuovi modi genereranno altrove inaspettati.
Se fossero le ultime lezioni di Chomsky potremmo riassumere
così il senso della sua vita: “ognuno faccia la
sua parte, servirà ad ogni atro ognuno di questo mondo”.
Leonardo Caffo
Psicoterapia e Scienze Umane/
Mezzo secolo di critica in Italia
Il 1967 è l'anno di fondazione della rivista Psicoterapia
e Scienze Umane che rappresenta in Italia un'esperienza
unica sia per longevità sia per l'importanza culturale
e politica da essa rappresentata. La sua storia è legata
al Gruppo Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia,
si trattava di un nucleo di giovani studiosi che a latere dell'università
iniziarono a sperimentare “seriamente” quanto di
più aggiornato ruotava attorno al mondo della psicoterapia:
nuove forme di psicoterapia individuale, familiare, gruppale,
istituzionale. In particolare si sperimentava la terapia delle
“psicosi” che sfidava l'impianto teorico-tecnico
della psicoanalisi, aprendola a nuovi ed inesplorati territori.
Si metteva l'accento sulle capacità trasformative della
psicoanalisi piuttosto che su quelle adattive e conservatrici.
Alla psicoanalisi era legata l'intera esperienza di Pier Francesco
Galli, animatore del Gruppo. Medico e psicologo, originario
di Nocera Inferiore, studente a Milano e poi in Svizzera, Galli
fa parte di quella schiera di intellettuali italiani che a partire
dagli anni Cinquanta hanno cercato di cambiare e democratizzare
la cultura e le istituzioni italiane con una intensissima attività
organizzativa1.
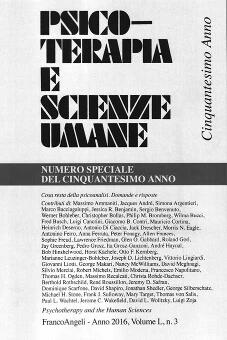 Grazie
all'attività del Gruppo in Italia è penetrata,
senza censura, la cultura psicoterapeutica più innovativa.
Si trattava quindi di una sorta di controcultura rispetto alle
posizioni paludate sia della psichiatria che della psicologia
istituzionali. Il Gruppo viene poi frequentato da una
nucleo di giovanissimi “psi” che faranno la storia
della psichiatria anti-istituzionale e della psicoterapia italiana
(tra gli altri, Mara Selvini Palazzoli, Fabrizio Napolitani,
Franco Basaglia, Giovanni Jervis). Grazie
all'attività del Gruppo in Italia è penetrata,
senza censura, la cultura psicoterapeutica più innovativa.
Si trattava quindi di una sorta di controcultura rispetto alle
posizioni paludate sia della psichiatria che della psicologia
istituzionali. Il Gruppo viene poi frequentato da una
nucleo di giovanissimi “psi” che faranno la storia
della psichiatria anti-istituzionale e della psicoterapia italiana
(tra gli altri, Mara Selvini Palazzoli, Fabrizio Napolitani,
Franco Basaglia, Giovanni Jervis).
Negli anni Settanta il Gruppo si trasformò nell'associazione
Psicoterapia e scienze umane, dopo aver dato vita ad
una rivista con lo stesso nome (1967). Negli anni la rivista,
oggi condiretta da Marianna Bolko e Paolo Migone, ha aperto
dibattiti critici su vari aspetti degli sviluppi teorici o sociali
della psicoterapia ed è sempre stata indipendente da
ogni associazione o istituzione e non ha mai ricevuto alcun
finanziamento esterno. La rivista, inoltre, non contiene mai
pubblicità, non ha interessi “di scuola”
(per scelta, non ha fondato istituti o scuole private di psicoterapia),
ma si propone solamente di essere uno strumento al servizio
dello sviluppo della psicoterapia in Italia, allo scopo di stimolare,
dall'esterno, altre iniziative, scuole o associazioni.
Una caratterizzazione della rivista è, quindi, lo stimolo
critico proprio per le associazioni professionali e i servizi
di salute mentale, soprattutto riguardo ai temi della formazione,
della teoria della tecnica e del rapporto tra psicoterapia e
scienze umane, nel confronto tra colleghi di formazione diversa.
A cinquant'anni dalla fondazione e a cura di Bolko e Migone,
la rivista presenta un numero speciale in forma di inchiesta
sullo stato dell'arte della psicoanalisi nel mondo (n. 3, 2016).
Sono state sottoposte 12 domande “fondamentali”
a 62 psicoanalisti, per lo più internazionali e fra i
più famosi ed impegnati scientificamente o culturalmente2.
Ne emerge un quadro molto particolare che per certi aspetti
è “sconosciuto” agli stessi psicoanalisti;
questo numero monografico è dunque una sorta di raccolta
di materiali “per la psicoanalisi della psicoanalisi contemporanea”.
In linea con la tradizione culturale del gruppo, questo numero
celebrativo di Psicoterapia e Scienze Umane tratteggia
così una disciplina in “crisi”.
È probabile tuttavia che le scienze psi siano
in crisi dalla nascita e che questa crisi corra parallela alla
crisi del soggetto che dall'emergere dell'individuo e della
massa, dalla fine dell'Ottocento condiziona la realtà
psichica e materiale dell'individuo. Dalla morte di Sigmund
Freud, la psicoanalisi ortodossa è stata certamente il
tronco da cui si sono evolute varie scuole che criticamente
hanno rielaborato il pensiero del fondatore sia dall'interno
delle istituzioni psicoanalitiche classiche sia per mezzo di
nuove vie, nuove psicoterapie, nuovi approcci, nuovi “territori”
anche molto distanti dalla creatura freudiana. Per giunta, ci
sono state schematicamente psicoanalisi conservatrici ed altre
radicali; Reich, Marcuse e Guattari (fra gli altri) ancora oggi
sono incommensurabili alla psicoanalisi tradizionale.
Come hanno risposto gli psicoanalisti e gli psicoterapeuti di
fronte alla “crisi”, sollecitata dalle domande dei
redattori di Psicoterapia e Scienze Umane?
Ciò che colpisce nelle risposte è la deriva dalle
idee del fondatore e la mancanza di coordinamento fra i rispondenti.
Fra questi spiccano coloro che, utilizzando la copertura della
ricerca scientifica, accentuano alcune cose della psicoanalisi,
svalutandone delle altre.
La questione è seria perché le interviste confermano
i timori di certi studiosi, specialmente storici (ad esempio
Dagmar Herzog in Cold War Freud: Psychoanalysis in an Age
of Catastrophes, 2016), che attualmente notano una sorta
di snaturamento della psicoanalisi ad opera degli stessi psicoanalisti
che, ad es., operano come se la loro disciplina non avesse subito
condizionamenti storico-ideologici (ad es. durante la guerra
fredda) oppure generalizzano agli adulti teorie e pratiche nate
per contrastare certi stereotipi positivisti e la vaga teoria
psicologica del bambino, sostenute dal padre della psicoanalisi,
scotomizzando così una serie di sfide lanciate da Freud
all'inizio del Novecento.
Dall'insieme delle interviste fatte ad analisti, che tra l'altro
hanno decine di migliaia di ore di psicoanalisi alle spalle
e sono responsabili dei maggiori centri di formazione mondiale
alla stessa disciplina, emerge un quadro impoverito della psicoanalisi
che via via si è trasformata in una tecnica accademica
di cui la ricerca contemporanea mette in luce l'efficacia, ma
che paradossalmente ha perso di “profondità”.
In tal senso la maggioranza degli interlocutori lamentano una
marginalizzazione della psicoanalisi contemporanea. Merito degli
intervistatori è stato far emergere alcuni motivi di
tale marginalizzazione nel senso di spaesamento degli intervistati
di fronte ai temi classici come il sogno o l'Edipo che, soprattutto
nell'alveo della tradizione psicoanalitica classica, sono rimasti
al palo e sostituiti da modelli teorici alternativi, molto circoscritti,
nati dalla ricerca psicofisiologica ed empirica che ha, via
via, colonizzato la creatura freudiana, trasformandola da ricerca
sui limiti della natura umana, anche in rapporto alle altre
scienze umane politico-sociali, a territorio marginale, astrattamente
psicologico e medico-psichiatrico, che vorrebbe sopravvivere
venendo a patti con una ricerca profondamente condizionata da
prioritarie istanze biopolitiche e biocapitaliste.
Renato Foschi
- Nel suo Liberi Tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento (2009) Valeria Babini ha chiamato, con felice intuizione, l'attività editoriale di Pier Francesco Galli, l'“Università dei Libri”. Si tratta di una intensissima attività culturale con traduzioni di centinaia di opere riguardanti la psicoanalisi e la psicoterapia in collane di psicologia, psichiatria e psicoterapia edite da Feltrinelli, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, e successivamente da Boringhieri.
- 1-Quale aspetto della psicoanalisi la colpisce di più o su cui vorrebbe esprimere un commento? 2-Vi è un autore che ritiene particolarmente importante oggi in psicoanalisi e, nel caso, per quali motivi? 3- A suo parere cosa caratterizza la cosiddetta “psicoanalisi contemporanea”, e quando si può dire abbia avuto inizio? 4- Cosa pensa della proliferazione di “scuole” psicoanalitiche?; 5- Identità della psicoanalisi e psicoterapia: come può essere impostato questo problema? 6- Il training psicoanalitico è certamente una questione importante e spinosa. Nella storia dell'istituzione psicoanalitica, sono cambiati alcuni aspetti del training? Se ritiene che il sistema del training non abbia subìto sostanziali modifiche, pensa che potranno esservi cambiamenti? Quali cambiamenti ritiene indispensabili? 7- Il concetto di Edipo ha ancora un significato e, nel caso, quale? 8- Cosa resta della teoria freudiana del sogno e, più in generale, che ruolo hanno i sogni nel processo terapeutico? 9- Come vede il rapporto tra teoria psicoanalitica e ricerca empirica sul risultato e sul processo della terapia? 10- Come valuta i recenti sviluppi delle neuroscienze e della neurobiologia rispetto alla psicoanalisi? Come vede il rapporto tra psicoanalisi e ricerca psicologica e, più in generale, tra la psicoanalisi e le altre discipline? 11- Quali concetti centrali della psicoanalisi hanno mantenuto una loro validità, e quali sono le loro evidenze empiriche? 12- Come spiega la crescente marginalizzazione della psicoanalisi?
Scuola/
Quando si insegnavano militarismo e obbedienza (ma anche oggi...)
Nello spazio chiuso delle aule come in piazza, nell'associazionismo
scolastico e extrascolastico, la scuola rappresenta un ambiente
privilegiato per il controllo, la nazionalizzazione e militarizzazione
dell'infanzia.
Il saggio divulgativo e ben documentato di Gianluca Gabrielli
(Educati alla guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione
dell'infanzia nella prima metà del Novecento, Edizioni
Ombre corte, Verona, 2016, pp. 127, € 13,00) accompagna
una mostra curata dallo stesso autore e distribuita da Pro Forma
Memoria. Il percorso attesta il coinvolgimento di bambini e
bambine, adolescenti, presidi, insegnanti e famiglie attingendo
a fonti iconografiche, giornalini e quaderni con copertine illustrate,
carteggi epistolari gestiti dalle scuole, riviste per docenti,
registri personali, resoconti, circolari ministeriali, libri
scolastici prodotti nella prima metà del Novecento.
 A
partire dalla guerra di Libia, la rivista laica “I diritti
della scuola” recepisce il messaggio degli insegnanti
pronti alla sottoscrizione per donare aeroplani, sollecitati
dal mito tecnologico della guerra aerea, e la posizione dei
docenti favorevoli alla solidarietà patriottica e inclini
a sollevare dubbi negli allievi. A
partire dalla guerra di Libia, la rivista laica “I diritti
della scuola” recepisce il messaggio degli insegnanti
pronti alla sottoscrizione per donare aeroplani, sollecitati
dal mito tecnologico della guerra aerea, e la posizione dei
docenti favorevoli alla solidarietà patriottica e inclini
a sollevare dubbi negli allievi.
Nel “Corriere dei piccoli” la guerra è presentata
come giusta, ma cosa da grandi. Tuttavia, nell'ultimo anno della
Grande guerra l'interventismo condiziona l'infanzia, destinataria
delle storie. Il personaggio Italino ne è il protagonista.
Viene istituita l'ora settimanale dedicata al conflitto in corso,
ma si sollecita anche il conforto ai soldati con lettere, e
l'elaborazione collettiva del lutto.
Comitati di organizzazione civile, patronati, maestri volontari
e associazionismo femminile si occupano della tutela e assistenza
dei bambini nel periodo estivo.
Con l'avvento del fascismo al potere, l'etica della violenza
e la celebrazione della guerra fondano la pedagogia politica
e sociale del nuovo stato. La propaganda entra nello spazio
della vita scolastica quotidiana. Circolari ministeriali e richiami
in ogni libro di testo trasmettono ai piccoli balilla il modello
delle squadre fasciste. Nel 1923, l'applicazione della riforma
della scuola di Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo Radice
è piegata ai fini propagandistici del fascismo, a partire
dall'alzabandiera e dalla esaltazione della morte eroica.
La politica di potenza e di conquista territoriale premia nuzialità
e natalità, e tassa i celibi. Un intervento eugenetico
per migliorare la stirpe istituisce colonie estive ed elioterapiche.
Più tardi, nell'ambito di simbologie infantili, la pubblicità
di ricostituenti e integratori alimentari come Nucleon e Ovomaltina
riprodotta sul “Corriere dei piccoli” richiama lo
svago e la cura del corpo dei piccoli italiani.
Nel 1928, in stretto rapporto con il ministero dell'educazione
nazionale e le competenze affidate all'Opera nazionale balilla,
le due ore di educazione fisica sono propedeutiche all'uso pubblico
di esercitazioni coreografiche. Il controllo totale del tempo
libero contrasta eversioni dell'ordine sociale.
Bellicismo e militarismo nei curricoli scolastici sono proiettati
oltre le discipline tradizionali. Nel testo unico per la scuola
elementare la simbologia machista e guerriera infantile è
rappresentata dai balilla in divisa. Il gioco della guerra,
richiamo alla virtù guerriera, viene istituzionalizzato.
Nel 1934, sfumano i confini tra scuola e caserma. Con la nuova
svolta militarista nei nuovi programmi di storia della scuola
elementare, la voce conclusiva è dedicata alle forze
armate. Un anno dopo, per la scuola secondaria, viene introdotta
la materia cultura militare. Si intensifica la militarizzazione
dei curricoli maschili: un nuovo decreto equipara gli ufficiali
responsabili dell'istruzione ai membri del corpo insegnante.
Per la difesa della società civile dagli attacchi nemici,
nelle scuole arrivano le maschere antigas e l'immaginario di
guerra muta velocemente. Seguono esercitazioni antiaeree nelle
scuole, documentate da foto di maschi in divisa militare e femmine
vestite da crocerossine.
Nelle nuove adozioni del libro di testo di stato per la scuola
elementare (1935- 36) il concetto di razza e di civiltà
veicola quello della gerarchizzazione dei popoli. Sulle nuove
copertine dei quaderni della serie “Abissinia” la
pubblicistica propaga l'ostilità razzista contro il nemico.
Ogni apprendimento allude alla marcia, alle armi, alla gerarchia
della caserma. In materie come la fisica, dominano metafore
in cui un plotone militare in marcia è accompagnato dalla
didascalia “il passo romano di parata è un esempio
di moto uniforme”.
La scuola è il primo settore della vita pubblica ad essere
colpito dall'offensiva razzista del regime. Tra il 1936 e il
1938, la polarizzazione amico-nemico viene sancita dall'integrazione
dell'educazione guerriera con lo sviluppo della coscienza “razziale”.
Una circolare del ministro Bottai, in merito alla corrispondenza
scolastica degli alunni italiani con indigeni dell' Africa orientale,
ammonisce: con i “sudditi inferiori” non si deve
fraternizzare “perché i fratelli degli italiani
sono solamente gli italiani”.
L'anno scolastico1938-39 inizia con l'espulsione dei nemici
di razza interni per eccellenza, gli ebrei, biologicamente diversi
e cospiratori ai danni della nazione. Libri di testo, carte
geografiche, nomi delle scuole vengono bonificati dalla presenza
di autori e personaggi ebrei. Durante il secondo conflitto mondiale,
alta la mobilitazione quotidiana dei docenti impiegati nei nuclei
di propaganda per attività di censura sulla posta ordinaria
di cittadini e militari. A partire dal 1941, circolari ministeriali
inducono le scuole a mantenere sostegno morale ai combattenti
e la tenuta della società civile: lotta contro gli sprechi,
raccolta di rifiuti per riutilizzarli, rivolta a maschi e femmine.
Una marcata connotazione di genere riguarda le attività
degli orti di guerra richieste ai maschi, alle femmine invece
la “giornata del fiocco di lana”, per assicurare
una sovrabbondante confezione di indumenti caldi.
Ma il mito di potenza della guerra è infranto. Con lo
sbarco alleato, i bombardamenti colpiscono le scuole. A Gorla,
nel milanese, il 20 ottobre 1944 morti oltre 200 bambini con
le loro maestre. E non si contano gli orfani di guerra. In triste
aumento i bambini mutilati per gli ordigni inesplosi. Nel secondo
dopoguerra, anche le forze politiche più determinate
accetteranno un silenzioso ripiegamento. I programmi di storia
si fermeranno al 1918, anche autori ed editori sceglieranno
la strategia del silenzio. La parentesi fascista poteva essere
ignorata senza inficiare la comprensione del presente ignorando
le responsabilità italiane nel secondo conflitto mondiale
e i vent'anni di regime.
Ancora oggi la scuola di stato, attraverso le riforme, le linee
guida, i programmi scolastici frutto di scelte politiche, condiziona
l'immaginario collettivo e conferma la sua struttura piramidale
e gerarchica, dalle dinamiche aziendalistiche, sempre più
meritocratica, laddove invece si dovrebbero sperimentare dal
basso spazi di democrazia, per promuovere piena autonomia e
favorire la libertà dell'individuo.
Claudia Piccinelli
Ribolla 1954/
La più grande tragedia mineraria in Italia
Se è stato immmediato l'impulso di proporre alla Rivista
la recensione del volume di Silvano Polvani, dirigente della
CGIL in prima fila per la tutela sindacale dei lavoratori del
Grossetano fin dal 77, che per la sicurezza dei lavoratori si
è battuto con l'attività sindacale e con la penna,
non è stata altrettanto immediata la predisposizione
della recensione stessa. Infatti il volume Ribolla 1954-2014
La tragedia mineraria nella cronaca dei quotidiani (di Silvano
Polvani, Edizioni Effigi, 2014, pp. 240, € 18,00) pubblicato
a cinquantanni dalla tragedia di Ribolla, la più grande
strage del lavoro accaduta in Italia in quegli anni, nella quale
il 4 maggio del 1954 perirono nell'esplosione in miniera 43
minatori, non è un libro di storia della sicurezza del
lavoro come tanti.
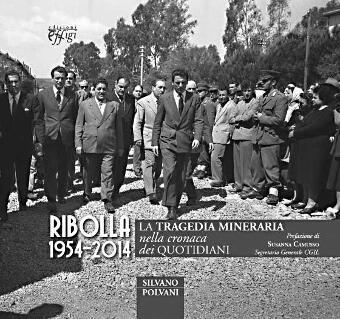 La
somma del dolore e dello strazio che emerge sia dalle pagine
dei quotidiani, dove sono anche conservate e tramandate alla
memoria le testimonianze raccolte dalle voci dei minatori sopravvissuti,
che dal corredo iconografico che, insieme alla cronaca giornalistica,
definisce e delinea il contesto nel quale si svolgeva la vita
della comunità, imperniata sull'attività nella
miniera, rende perfino difficile la lettura del volume. Lettura
che rimanda anche alla constatazione dell'impegno speso dal
curatore del libro, nell'affrontare i temi dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro nei suoi aspetti più crudi e più
aspri. La
somma del dolore e dello strazio che emerge sia dalle pagine
dei quotidiani, dove sono anche conservate e tramandate alla
memoria le testimonianze raccolte dalle voci dei minatori sopravvissuti,
che dal corredo iconografico che, insieme alla cronaca giornalistica,
definisce e delinea il contesto nel quale si svolgeva la vita
della comunità, imperniata sull'attività nella
miniera, rende perfino difficile la lettura del volume. Lettura
che rimanda anche alla constatazione dell'impegno speso dal
curatore del libro, nell'affrontare i temi dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro nei suoi aspetti più crudi e più
aspri.
Quando, negli anni 50, le lotte dei lavoratori per la costituzione,
nei posti di lavoro, degli idonei requisiti preventivi contro
gli infortuni e le malattie professionali, si esprimevano in
Italia in controtendenza rispetto alla sensibilità generale
dell'opinione pubblica, ben meno avvertita su questi temi di
quella odierna, la tragedia di Ribolla rappresentò nella
storia del lavoro, il punto di svolta fondamentale. Infatti
essa costituì una potente sollecitazione nel far pervenire
a conclusione l'elaborazione della normativa prevenzionistica
che fu emanata nel 1955 e 56 e che durò fino al Dlgs
626 del 1994.
È un libro prodotto non da specialisti di storia del
lavoro sui minatori dell'Area Grossetana, ma dalla volontà
di dare ai lavoratori sopravvissuti ed alle loro famiglie vittime
della sciagura, la voce che, a distanza di oltre 50 anni, risuona
con tutta la verità con la quale fu espressa allora.
Fin dalla Presentazione e dall' Introduzione del volume sono
chiariti i termini economici, politici, sindacali e igienico-
lavoristi del contesto entro il quale si consumò la tragedia,
le cui cause sono spiegate nella I parte.
L'autore, nella II parte, in modo chiaro e piano, mette a disposizione
del lettore ciò che fu scritto sui giornali dell'epoca
con abbondanza di particolari e nel dettaglio, senza nulla tralasciare,
sia dell'evento che del processo che ne seguì. Oggi si
direbe che fu assicurata una copertura mediatica completa per
l'accaduto, che ebbe risonanza nazionale. Fra le firme giornalistiche,
fra le altre, si trovano quelle di Carlo Cassola, di Giorgio
Bocca e di Luciano Bianciardi, che in diversi modi avrebbero
continuato l'impegno per lo sviluppo democratico della società
italiana.
A proposito di Luciano Bianciardi, del quale viene riportato
un articolo eloquente sulle condizioni di lavoro nella miniera
scritto sull'Avanti prima della tragedia, non è a tutti
noto come il suo capolavoro “ la vita agra”, affondò
le sue radici creative nella riflessione che elaborò
sull'evento, dal quale egli fu segnato profondamente.
La III parte, che raccoglie la testimonianza di chi fu presente
il 4 maggio del '54, da conto della dura vita che si viveva
nelle miniere del Grossetano e di quanto la lotta sindacale
e politica per l'affermazione delle misure preventive, nell'attività
lavorativa, sul posto di lavoro sia stata legata alla lotta
per la democratizzazione della società.
Dall'Albo dei minatori caduti nelle miniere delle Colline Metallifere
dal 1892, che conclude l'opera, si evidenzia la terribile casistica
dell'infortunistica sul lavoro, aggravata in miniera dal rischio
di esplosione, che ricorre ancor oggi nella rilevante infortunistica
mortale che si verifica in Italia, nonostante l'impegno che
i diversi soggetti previsti dal Dlgs 81/08 sviluppano. In conclusione
si condivide pienamente e per questo si suggerisce la lettura
del volume, ciò che l'autore pone alla fine nella sua
Nota per chiarire che si tratta di “ Un volume dedicato
alle nuove generazioni affinchè attraverso la memoria
riscoprano, per praticarli, i veri valori che sono a fondamento
della propria esistenza: solidarietà, dignità
e giustizia”.
Enrico Calandri
Giordano Bruno/
Ma l'ordine umano è anarchico
L'ultimo libro di Aldo Masullo contiene quattro brevi saggi,
due già pubblicati in altri volumi, due inediti, che
compongono e propongono, nell'insieme, un'acuta riflessione
su Giordano Bruno, maestro d'anarchia (Saletta dell'Uva,
Caserta, 2016, pp. 118, € 10,00).
 Vive un XVI «secolo confusissimo», Bruno - come
spiega bene Masullo - d'enormi sconvolgimenti: la scoperta dell'America,
la conseguente rivoluzione dei prezzi in Europa, la riforma
protestante, la formazione delle monarchie nazionali sulle ceneri
del dissolto regime feudale, l'imporsi di spiazzanti scoperte
scientifiche, che inaugurano peraltro un nuovo metodo e una
nuova logica, sperimentale, nel fare ricerca.
Vive un XVI «secolo confusissimo», Bruno - come
spiega bene Masullo - d'enormi sconvolgimenti: la scoperta dell'America,
la conseguente rivoluzione dei prezzi in Europa, la riforma
protestante, la formazione delle monarchie nazionali sulle ceneri
del dissolto regime feudale, l'imporsi di spiazzanti scoperte
scientifiche, che inaugurano peraltro un nuovo metodo e una
nuova logica, sperimentale, nel fare ricerca.
È un tempo di crisi che produce sopraffazione e violenza,
denuncia Bruno in diverse sue opere (nel suo Spaccio della
bestia trionfante, nella Cena delle ceneri, ne L'asino
cillenico, etc.), dove critica aspramente la forzata sottomissione
dei selvaggi d'America ai ‘civilizzati' conquistatori
europei e i cruenti e sanguinari contrasti confessionali in
ragione della difesa o della messa in discussione del monopolio
del cristianesimo da parte della chiesa cattolica. Ma nel suo
“mondo rinversato”, nella società del suo
tempo che gli pare abbia rovesciato i veri e buoni valori, Bruno
scorge segni e movimenti d'idee moderne e profetiche d'un possibile
cambiamento e organicamente vi si inserisce, come acutamente
documenta Masullo nel suo libro, facendosi interprete e promotore
della pace come ideale assoluto, della ragione come guida sicura,
delle leggi come strumenti atti a rendere possibile “la
pacifica convivenza e la libertà del comunicare”;
leggi che devono essere basate, ovunque, sulla salvaguardia
imprescindibile e obbligatoria di quei ‘diritti universali'
che sostanziano e caratterizzano gli uomini prima delle loro
etnie, storie, culture. Lucidamente consapevole che, dopo la
conquista dell'America, l' Europa s'apprestava a dar vita ad
un dominio coloniale vasto e duraturo che avrebbe creato sfruttamento
e disuguaglianze tra gli uomini, Bruno, difensore dei diritti
naturali di ogni uomo, che devono essere preservati e rispettati
in qualsivoglia condizione storico-sociale, ci appare, come
fa notare giustamente Masullo, “nel suo tempo, un compagno
del nostro tempo”, del nostro presente, nel quale
aleggiano diffidenze e intolleranze verso le ‘diversità',
che sempre più spesso diventano vero e proprio razzismo.
Ma ancor di più, Masullo - filosofo di vaglia, autore
di importanti saggi, intellettuale meridionale da sempre partecipe
nella vita politica e pubblica - con un'avvincente disamina
della vicenda di Bruno, filosofo di Nola, che fu vittima, come
è noto, dell'opprimente e terribile Inquisizione, rintraccia
nei nuclei principali della sua filosofia, cioè “l'idea
cosmologica e il principio etico” i motivi fondanti “della
modernità politica e della forma democratica dell'ordine
civile”.
“La filosofia di Bruno” afferma Masullo “secondo
cui ogni luogo dell'infinito universo è centro, e ogni
uomo, in quanto vita di ragione, dunque libero, ha pari dignità
con ogni altro, è la base speculativa dell'idea politica
della democrazia”.
“Per lui” continua Masullo “ogni individuo
umano, in quanto centro irriducibile tra infiniti centri irriducibili,
con cui non può non essere sempre aperto a comunicare,
è portatore di responsabilità piena. Ma proprio
perciò nessun capo è assoluto. L'ordine umano
è anarchico”.
Silvestro Livolsi
Antifascismo/
Gli Arditi del Popolo della “ribelle irriducibile Civitavecchia”
“La lotta antifascista a Civitavecchia [...] Molti
lavoratori edotti del fatto si recavano dinanzi la sede del
fascio protestando e chiedendo la liberazione del loro compagno.
Ne nacque un corpo a corpo violento con scambio di bastonate
e revolverate e lo scoppio di una bomba che frantumava i vetri
del locale fascista”. («Umanità Nova»,
14 ottobre 1922).
 Contrastare
le squadre di Mussolini, fin da subito e manu militari, erano
gli intenti generosi di quel movimento che aveva ereditato,
certo in forma spuria, il cameratismo di trincea. Nell'arditismo
popolare si era in parte ricomposta la frattura della guerra
con la convergenza strategica nelle formazioni militarizzate
sia di ex interventisti divenuti anti-mussoliniani, sia di antimilitaristi
libertari e anarchici. Contrastare
le squadre di Mussolini, fin da subito e manu militari, erano
gli intenti generosi di quel movimento che aveva ereditato,
certo in forma spuria, il cameratismo di trincea. Nell'arditismo
popolare si era in parte ricomposta la frattura della guerra
con la convergenza strategica nelle formazioni militarizzate
sia di ex interventisti divenuti anti-mussoliniani, sia di antimilitaristi
libertari e anarchici.
A Civitavecchia oltre seicento Arditi del popolo (portuali,
cementieri, ferrovieri, operai e artigiani di varie tendenze
politiche e ideali) opposero in armi strenua resistenza fino
al terribile ottobre 1922. Il “fascio spezzato”
(scure che frantuma il simbolo littorio) era ricamato sulle
bandiere di quei primi combattenti proletari, in contrapposizione
al tricolore nazionale sempre usato dagli squadristi.
Lo Stato, la guerra, il lavoro industriale e la Nazione: il
sistema valoriale del Novecento ha racchiuso tutto il suo potenziale
totalitario e tossico in questi poli ideologici. Il nazionalismo,
fenomeno strutturale, profondo e di lunga durata nelle società
occidentali, ha via via riformulato e aggiornato le proprie
prassi superando le apparenti sconfitte e marcando impensate
continuità perfino nelle cesure più decisive dell'ultimo
secolo. Così le declinazioni istituzionali e, appunto,
la dimensione “nazionale” hanno pervaso ogni possibile
rappresentazione sovversiva e antifascista. Così l'opposizione
armata al primo fascismo in Italia è stata, e per troppo
tempo, una pagina volutamente dimenticata in quanto non conforme,
episodio rimosso della storia proletaria e internazionalista.
Questo libro (Enrico Ciancarini, il fascio spezzato. Gli
arditi del popolo nella “ribelle irriducibile Civitavecchia”.
19 maggio 1921 – 28 ottobre 1922, Red Star Press,
Roma, 2016, pp. 172, € 15,00) ci espone, in forma di incalzanti
cronache quotidiane e con ritmi narrativi da fiction,
diciassette mesi di guerra civile nella città portuale
laziale – durante il cosiddetto “Biennio nero”
– in uno dei luoghi mitici dell'arditismo popolare, insieme
a Parma, Bari, Sarzana.
L'autore Enrico Ciancarini (classe 1965), presidente della Società
storica civitavecchiese, serio e affermato studioso, prolifico
storico locale (nell'accezione nobile e antica del termine),
confida ai lettori: “fino al 1997 non sapevo nulla degli
arditi del popolo e della loro attiva presenza a Civitavecchia,
la mia città natale” (p. 27). L'affermazione, onesta,
è l'ennesima riprova di come certe vicende salienti novecentesche,
e quelle in particolare dell'antifascismo, siano state trasmesse
e trattate solo superficialmente nei vari passaggi generazionali.
Nel secondo dopoguerra i partiti, fattisi imprenditori politici
della memoria, hanno di fatto prestabilito metodi e “luoghi”
deputati alla ricerca contemporaneistica, hanno a lungo e con
protervia presidiato le scienze storiche (con somma ignoranza
e autoreferenzialità), quasi paventassero imminenti invasioni
di alieni.
A tale proposito il racconto di come sia nata l'idea di questa
pubblicazione è chiarificatore, avvincente al pari del
contenuto vero e proprio del volume. In assenza dunque di un'affidabile
e consolidata storiografia locale su un tema così peculiare,
l'autore ha tratto ispirazione dai lavori di due precursori:
Marco Rossi e Eros Francescangeli, quest'ultimo fra l'altro
autore di una suggestiva prefazione a questo stesso volume.
L'interessamento in ambito locale per i risultati delle prime
ricerche effettuate dallo stesso Ciancarini ha portato, nel
2013, all'intitolazione di una strada agli Arditi del popolo
proprio nel centro storico di Civitavecchia; tappa intermedia
verso una definitiva ricostruzione di una bella memoria popolare.
Lo studio – che purtroppo non si avvale di note a piè
di pagina – è basato su due formidabili tipologie
di fonti: le carte di polizia e le cronache del quotidiano anarchico
«Umanità Nova» (redatte da un puntuale e
misconosciuto corrispondente, Augusto Milo, a cui l'autore rende
giustamente onore e merito). L'incrocio intelligente di informazioni
siffatte, provenienti da attori protagonisti che hanno avuto
ruoli opposti sullo scenario dell'allora incipiente guerriglia
sociale, ci fornisce una narrazione leggendaria e verosimile
al tempo stesso di quei fatti. Sconfitto l'arditismo popolare,
nei decenni successivi il regime mussoliniano esaltò
le imprese del primo squadrismo fascista dopo che i tribunali
avevano fatto largo uso della vendetta politica per saldare
i conti sociali rimasti aperti. Nel secondo dopoguerra poi la
memoria di quell'antifascismo armato rimase invece vittima del
revisionismo storiografico di destra e di sinistra, di un uso
pubblico della storia unicamente finalizzato al meschino agone
partitico.
Le ombre di tanti sovversivi dimenticati, persi nei gorghi della
guerra civile, rivivono oggi anche grazie a questo studio, bello
e “ardito”, di Enrico Ciancarini.
Giorgio Sacchetti
Mille pagine/
Vent'anni di controcultura
Dopo aver raccolto e conservato per oltre cinquant'anni il
materiale documentario – e dopo aver invitato un'ampia
gamma di testimoni a dire la loro –, Ignazio Maria Gallino,
nella doppia veste di autore e di editore, pubblica un'opera
monumentale dedicata al periodo 1965-1985 Vent'anni di controcultura
(Milano, 2016, pp. 908, € 180,00). Si tratta di mille pagine
che – scevre da interpretazioni – rendono giustizia
ai tanti protagonisti dell'unico momento del secondo Novecento
in cui la cultura vigente – nel suo senso più ampio,
comprensivo degli stili di vita, del sapere, della manutenzione
dei corpi e delle loro relazioni, degli oggetti d'uso e dei
segni che caratterizzavano gli ambienti stessi – è
stata sottoposta ad una critica radicale.
Due i punti delicati sui quali Gallino ha dovuto effettuare
le sue scelte: la periodizzazione e la categorizzazione del
punto di vista da cui guardare gli eventi. Per quel che concerne
il primo problema, va detto che da qualche parte occorreva pur
cominciare – e poi finire; è ovvio che la matrice
di certi comportamenti vada ricercata ancora prima – si
pensi alla “gioventù bruciata” degli anni
Cinquanta, al rock, ai “giovani al doppio gin”,
ai bluson noir, alla “nouvelle vague” ed all'evoluzione
dei costumi sessuali postbellici -, ma è altrettanto
ovvio che, nel proprio lavoro, uno storico deve pur porre delimitazioni.
Forse, nel volume, una premessa in tal senso non sarebbe stata
inutile.
Per quel che concerne l'uso del termine “controcultura”,
anche qui, si tratta di capirsi. Da un lato, resta il fatto
che la categorizzazione è già stata utilizzata
in ambito di storiografia – per esempio da Pablo Echaurren
e da Claudia Salaris – e, dall'altro, resta l'ampiezza
della sua designazione – la cultura intesa come l'insieme
delle pratiche con cui gli esseri umani risolvono i propri problemi.
Che da ciò rimanga fuori gran parte dell'ambito multiforme
e ricchissimo delle arti – fatto comunque da considerare
– è la conseguenza di una scelta metodologica e,
come tale, comprensibile.
Va da sé che a quei mutamenti abbiano contribuito non
poco le avanguardie artistiche – letterarie, pittoriche,
plastiche, musicali, cinematografiche, senza dimenticare il
design -, ma va anche da sé che se quelle evoluzioni
hanno potuto usufruire di fior di storiografia (e anche di fior
di autorappresentazioni), non è il caso di quanto raccontato
dalla miriade preziosa dei documenti raccolti da Gallino –
mai cementati così per qualità e per quantità.

Oltre al sottoscritto, al volume hanno contribuito Alessandro
Bertante, Italo Bertolasi, “Bifo”, Riccardo Bertoncelli,
Guido Blumir, Franco Bolelli, Antonio Caronia, Gianni De Martino,
Beppe De Sarlo, Pablo Echaurren, Matteo Guarnaccia, Gigi Marinoni,
Giancarlo Mattia, Lea Meandri, Gianni Milano, Primo Moroni,
Andrea Pasquino, Marco Philopat, Giorgio Pisani, Fernanda Pivano,
Franco Quadri, Angelo Quattrocchi, Lidia Ravera, Edoardo Re,
Marisa Rusconi, Franco Schirone, Andrea Sciarné, Clara
Sestilli, Gianni E. Simonetti, Vincenzo Sparagna, Myriam Sumbulovich
e Andrea Valcarenghi.
Felice Accame
“A”/
Noi della redazione diamo i numeri
Da
molti anni abbiamo un sito – arivista.org –
giudicato con forte polarità. Molti lo ritengono
statico, noioso, per niente interattivo, a volte difficile
da usare per gli acquisti, ecc. Altri lo giudicano chiaro,
ne apprezzano l'an-archivio e la doppia possibilità
di scaricare gratis qualsiasi numero di “A”
e di poter fare ricerche per nomi all'interno di tutti
i 414 numeri finora usciti. Preannunciamo qualche simpatica
novità e miglioramento, alla quale stiamo lavorando.
Dal punto di vista della fruizione, gli “accessi
unici” al nostro sito (cioè le visits)
negli ultimi 12 mesi sono passati da 25.000 a 40.000 al
mese. Significa che sono quasi raddoppiate le persone
che raggiungono il nostro sito, vi entrano e leggono almeno
qualcosa: da 1.000 a 1.300 accessi medi al giorno, con
punte di 2.000. Si tratta di persone tra loro, nel corso
di una giornata, diverse.
Abbiamo dato un'occhiata – per curiosità
– ai dati Audiweb relativi a periodici ben più
noti di noi, carichi di pubblicità (che noi non
ospitiamo) e di finanziamenti o comunque agevolazioni
pubbliche (di cui noi non godiamo), e li abbiamo visti
più “avanti” di noi, ma non in maniera
così significativa.
Un altro indice di miglioramento lo abbiamo riscontrato
nel numero degli abbonati cartacei e delle copie spedite
agli individui, collettivi, centri sociali, gruppi anarchici
diffusori, botteghe del commercio equo e solidale. Niente
di travolgente, ma “A” negli ultimi mesi ha
cominciato a crescere.
Diamo qui qualche ulteriore numero, per chiarire le nostre
“dimensioni”. Mensilmente stampiamo da 4.300
a 4.500 copie, due terzi delle quali consideriamo vendute
(il calcolo è necessariamente presuntivo, perché
gran parte dei diffusori non ci segnala il dettaglio delle
vendite). Gli abbonati si avvicinano al migliaio, tra
italiani ed esteri: con una lenta tendenza all'aumento
E intanto, tornando alla rivista online, su twitter ci
seguono oltre 3.400 follower. Che crescono in continuazione.
Una pagina twitter asciutta e non invasiva, la nostra.
Secondo un nostro stile non-gridato, che è una
precisa scelta in questo mondo di superficialità,
prepotenza e scompostezza.

|
|